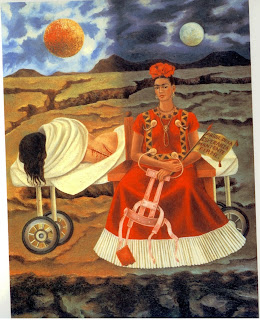LA PIGNA ALCHEMICA
di Giuliana Poli

Figura 1
Ottaviano di Martino Nelli
di Gubbio (1370-1448-49) rappresenta uno dei maggiori pittori e maestri
dell’Italia centrale. Protagonista assoluto del gotico internazionale, fu coevo di Gentile da Fabriano e Beato
Angelico, per fare qualche nome. Fu artista prolifico e di alto profilo,
inserito nel contesto urbano e politico di Gubbio di cui sarà più volte
console. La sua formazione avvenne tra la sua città natale, Fano, Urbino, Perugia,
Foligno, Pietralunga, Costacciaro, Rimini. Pittore umoristico e spregiudicato
per l’epoca, affrescò nel 1403, (1)
la Madonna Belvedere nella Chiesa di
Santa Maria Nuova a Gubbio. Un capolavoro importante del Centro Italia, che
rappresenta un momento di passaggio dalla cultura gotica medievale alla
rinascimentale, in Umbria; il suo stile ambivalente, interprete del suo tempo,
della sua gente e del suo paese si incardina in un periodo di grande vitalità,
in cui si consolida una borghesia mercantile ed artigiana. Nella Madonna
Belvedere è presente il contrasto tra il mondo divino abbigliato in maniera
sfarzosa e il mondo terreno abbigliato in maniera essenziale, protetto dal
mondo arcano del suo paesaggio misterioso, dalle sue storie e dalle sue
leggende. Roberto Longhi dirà di lui che il suo narrare facile e coloratissimo
di stampo naturalistico fu troppo sbrigativo e asintattico (anche se un’opera
di Nelli fu presente nella sua collezione privata). Forse l’elemento di
interesse è proprio il suo narrare contrastato adeguato al rapporto tra lo
spirito e la terra, tra il sublime ed il volgare, tra la dolcezza del viso e
figure volgari. Nelli si trova a vivere artisticamente e frequentare famiglie
che dettarono l’inizio del Rinascimento italiano in Centro Italia. Ha in sé il
seme della perfezione e dolcezza dei visi delle Madonne che poi germoglierà e
diverrà pianta in Raffaello, ma anche il senso della derisione giocosa di visi grotteschi
e posture erotico-goliardiche, che ritroveremo in Michelangelo della Cappella
Sistina. In origine sia la testa della Vergine che quella del bambino erano
corredate di corone di argento, che vennero rubate nel 1823, inoltre c’era
anche un gioiello anch’esso in argento che pendeva dal collo della Vergine. Per
secoli l’affresco fu dimenticato fino alla rivalutazione della figura di
Ottaviano Nelli da parte di Luigi Bonfatti e Giovan Battista Cavalcaselle.

Figura 2
L’affresco di Ottaviano Nelli riflette
un’espansività ed una nobiltà senza eguali. I visi dei personaggi sono calmi,
sorridenti, avvenenti e bonari. L’immagine del Cristo lo fa sembrare un uomo
del popolo preso dalla strada o dall’osteria. Nel Medioevo in generale
prevaleva la satira che ironizzava su persone che amavano bere, amare, cantare
e fare la bella vita e per questo venivano raffigurate doviziose e ben nutrite.
La Madonna con il bambino ha delicate
curve, fascino dolce che indica come doveva essere la “donna dei sogni”
dell’epoca. Il bambino è paffuto e sereno, così come gli angeli che suonano e
cantano. Niente esprime sofferenza. I santi dipinti ai lati dell’affresco,
Sant’Emiliano con il libro chiuso e la palma a sinistra e Sant’Antonio Abate a
destra, hanno una figura virile e sana, nulla e nessuno ha l’aspetto emaciato e
questo dimostra come Ottaviano Nelli fosse uomo positivo riconosciuto e
ammirato, che ebbe incarichi di responsabilità politica nel governo di Gubbio e
che descrisse una realtà che nulla ebbe a che vedere con il deprimente
spettacolo delle miserie umane.
L’affresco può essere suddiviso in
parti geometricamente simmetriche: in alto il cielo stellato con le sue
costellazioni e le sue santità e in basso il piano terreno, con figure oscure
non leggibili per via del deterioramento dell’affresco. A latere del dipinto,
mediatori tra i Santi e la Madonna con in alto Gesù Cristo tra gli angeli, ci
sono i committenti. I
lati dell’affresco sono uno l’antitesi dell’altro: sulla destra è dipinto il
Conte e sulla sinistra, probabilmente la moglie o la figlia. Dal fatto che
dietro la donna c’è un angelo custode femminile si evince che molto
probabilmente, questo dipinto è collegato ad una sepoltura femminile della
famiglia. Forse per questo il lato delle
donne è chiaro e cristallino, mentre il lato dell’uomo che molto probabilmente
è Antonio Pinoli (1390-1460) è tetro e si perde, divenendo un unicum, tra le
stoffe, anch’esse oscure, di Sant’Antonio Abate, il santo di riferimento per
via del nome. I lati estremi dell’affresco sono
racchiusi da una cornice, dove si stagliano delle colonne tortili sulle quali
Ottaviano Nelli esprime la sua satira medievale molto vicina a quella di
Giovanni Boccaccio, dove l’eros giocoso a tratti irridente vince su tutto.
A differenza di falsi luoghi comuni su
questo periodo storico, il pensiero medievale è stato scientifico e la sua
missione è stata quella di tradurre simbolicamente ciò che aveva ricevuto
dall’antichità e verso il quale era rimasto fedele custode. Per l’uomo medievale
la verità è nel simbolo ed è rivelatrice di un insegnamento segreto, di un
pensiero superiore vero, concreto e immutabile.
Nella Madonna Belvedere la
scienza e la conoscenza sapienziale dominano su tutto. Al centro del quadro c’è
la nascita di una stella simbolicamente rappresentata dal drappo di stoffa
color rosso ed oro che orna la Madonna.
La sua formula matematica, evidentemente già conosciuta dal Nelli, tesse
le trame del cielo stellato sulla parte alta dell’affresco (fig. 1). Nel cielo stellato sono dipinte anche le costellazioni del leone,
del cigno e dell’orsa. (2).

Figura 3
Ottaviano Nelli la dipinge un po’
ovunque sull’abito della Vergine e simboleggia il logos della Madre dalla cui
idea nascerà il Cristo-Sole-Re della Luce. Nell’affresco si rappresenta quindi
“il verbo” che dalla forma-pensiero si trasformerà in realtà attraverso la
nascita del bambino di Luce. Molto probabilmente l’artista eugubino dipinge la
ghiandola pineale con la forma di pigna, anche per omaggiare in senso
metaforico il suo committente, il Conte Pinoli, il cui cognome e stemma del
casato derivano proprio dalla pigna, il cui significato originale è
sapienziale. I Conti Pinoli furono notoriamente ghibellini, legati al sapere e
alla scienza e sicuramente appassionati del gualdo,
un colorante azzurro di origine vegetale, molto richiesto all’epoca,
pensiamo ad esempio a Sant’Angelo in Vado che deriva da Sant’Angelo in Gualdo. Questo colorante
ha una storia particolare in Europa: estratto dalla isatis tinctoria, usato dai guerrieri celti per dipingersi il viso
prima delle battaglie, rappresentò per parecchio tempo una fonte di ricchezza
per la regione compresa tra Tolosa, Albi e Carcassonne, patria dei Catari. Il
blu pastello estratto da questa pianta, denominato anche blu di Carcassonne,
era molto ricercato sia per la tintura dei tessuti, che come cosmetico e come
colorante per i pittori. In Italia venne coltivato in particolare
nell’appennino umbro-marchigiano e nel Montefeltro: Benedetto de' Franceschi, padre di Piero della Francesca era ai suoi tempi
un famoso commerciante di guado (o gualdo).
Dall’immagine della pigna con
all’interno il Cristo, che è dipinta con il color rosso fuoco si manifestano
sei onde dalla forma di sei esseri angelici di color azzurro, i quali
rappresentano la permutazione della forma mediante il suono raffigurato dagli
angeli che suonano l’arpa ed il violino, strumenti le cui corde simboleggiano
le griglie dell’universo. Il pensiero che è fuoco spirituale, attraverso le
vibrazioni forma la materia, e questo principio scientifico è raffigurato dal
colore azzurro che dall’alto scende verso il basso lungo il manto della
Vergine. Il corpo della Madonna come specchio dell’immagine dipinta sopra la
sua testa ha nel centro il fuoco e all’esterno il color azzurro con all’interno
ricami in oro. La fusione di fuoco ed acqua è evidente dal fatto che il Nelli
ha disegnato sul manto fregi che rappresentano la ghiandola pineale a forma di
pigna dal quale deriva il Cristo-Sole, proprio per evidenziarne la sua origine.
Sulla veste azzurra della Vergine vicina alla crosta terrestre ci sono nuvole
bianche e anche questo dettaglio svela profonde conoscenze scientifiche
dell’artista eugubino. Il calore e la luce si creano dall’urto delle vibrazioni
fredde e oscure, che arrivano dall’universo, contro l’atmosfera gassosa e,
poiché man mano che ci avviciniamo alla terra la resistenza aumenta in maniera
proporzionale alla densità del mezzo, il calore, la luce e la luminosità sono
più forti sulla superficie terrestre perché gli strati d’aria sono più densi.
Il velame gassoso, oltre ad essere presente nell’abito della madre, è
nell’abito velato del Bambino.

Figura 4
Le mani dell’angelo sostengono la
donna, quasi sollevandola dalle figure sottostanti, così come la mano di
Sant’Antonio sembrano “estrarre” la testa dalla massa sottostante, in una posa
che sembra andare ad attivare la pineale del Conte premendo con il pollice
sulla nuca.
Se rovesciamo la parte d’immagine in
cui è dipinto sia il Santo che il Conte, Ottaviano Nelli nasconde più immagini
affastellate l’una sopra l’altra. In particolare sul tessuto color della terra
appaiono dei Daimon che sembrano emersi da una grande caverna rappresentata dal
tessuto più interno dell’abito del Santo. (fig.2-5)
La sua mano anch’essa lunga regge la testa del Conte, sul cui cappello si nasconde un altro viso uguale e contrario a
quello in evidenza sull’affresco. (fig.
3) Sullo stesso particolare il Nelli nasconde anche il profilo (fig. 3.a) L’artista ripete anche in
questa occasione lo stesso principio espresso con il capo di Maria. Abbiamo
quindi sia la ghiandola pineale della Madre celeste che ha partorito
l’universo, sia il capo del Conte Pinoli tirato fuori dal mondo degli inferi,
dalla mano di Sant’Antonio Abate.
Se andiamo ad analizzare i simboli del
Santo, il primo è il fuoco che sancisce l’origine e la fine dell’universo. Non
dimentichiamo che questo elemento è il simbolo di comunicazione tra l’uomo e il
misterioso manifestarsi di Dio. È il TAU che vediamo impugnare da Sant’Antonio
nelle iconografie più diffuse. Secondo la tradizione il Santo sarebbe sceso
agli inferi e, dopo aver acceso il suo bastone, sarebbe tornato sulla terra per
donare il fuoco di vita agli uomini. Una specie di Prometeo cristianizzato. Il
simbolo del Tau richiama la croce egizia e sta ad indicare l’immortalità,
ovvero la memoria celeste che è scesa agli inferi, ha generato la vita, ma che
poi ritorna sempre alla sua Fonte primaria: il Sole, poiché il TAU che è la
diciannovesima lettera dell’alfabeto greco coincide con il diciannovesimo
arcano maggiore che è il Sole. Quindi il bastone di Antonio è il meteorite di
fuoco celeste simbolicamente rappresentato dalla spada, dal tirso, dalla ferula
della tradizione pagana o il pastorale nel cristianesimo, ovvero l’asse del
potere che mette in relazione i due mondi: la luce e l’ombra, il sacro ed il
profano. Altro simbolo è la campanella che rappresenta il suono armonico di
creazione: il famoso canto degli angeli presenti nell’affresco (3).
Il corpo del Santo, quindi, rappresenta
il divino che scende negli inferi (l’abito scuro costellato da demoni) dal
quale tira fuori colui che metterà in relazione i due mondi perché legato al
culto del Sole che simbolicamente è evidenziato dal lato sinistro dell’affresco
dove Sant’Emiliano, che è pieno di luce, regge in mano il verbo divino
rappresentato dal libro, e la donna committente della famiglia Pinoli, anche
lei luminosa. È evidente come anche questa famiglia ghibellina seguisse la
religione eretica notoriamente definita catara legata al cristianesimo
gnostico, che vedeva nel Sole il simbolo del Cristo-Re della Luce. Le due
colonne tortili nascondono figure che giocano nell’eros e nella voluttà dei
corpi, che si divertono a fare giochi d’amore come era nello spirito
contadino. Il suo significato potrebbe
essere legato al Risus Pascalis, un
rito pagano legato alla Pasqua in cui il parroco durante l’omelia si fermava ed
iniziava a dire sconcezze e raccontare storie sordide sulla figura di Gesù e
tutti ridevano. La Madonna Belvedere è un quadro dal significato
sapienziale e profondo, il riso quindi, deve essere visto come un atto magico
liberatore, utile a conoscere un’altra realtà. Il principio generatore
dell’universo avviene attraverso la vitalità del fuoco. L’eros attiva le
vibrazioni, il movimento e la vita a seguito di quelle metamorfosi che, grazie
alla voluttà erotica dell’Amore muovono, il Sole e le altre stelle.

Figura 5
Note
1. Secondo la Enciclopedia it. Treccani, vol. XXIX,
pag. 535, la Madonna Belvedere fu commissionata ad Ottaviano Nelli da
Venturuccio de’ Conte Pinoli nella chiesa di Santa Maria Nuova in Gubbio nel
1403, considerata da tutti classico esempio dell’arte gotica in Italia. Nelle Belle Regioni d’Italia edito nella Banca
Nazionale del lavoro dell’Umbria nel 1970, pag. 332, si afferma che l’opera è
datata 1408. Nella Guida d’Italia Umbria
nel 1966 4° edizione pag. 161 si afferma che nel 1510 la soave Madonna del
Belvedere, Madonna col bambino, angeli, musicanti e Santi Emiliano, Antonio
Abate, fu commissionato dalla Famiglia Pinoli; un affresco di Ottaviano Nelli
del 1408-1413. Bonfatti L. nelle sue
Memorie Storiche di Ottaviano Nelli Gubbio 1847 a pag. 5,6,7, 20 scrive che
i due allocatori sono Venturuccio e
Pinolo padre e figlio del Casato Pinoli viventi in quell’epoca nel 1403,
anche se Pinolo era già grande all’epoca e non poteva essere così infantile e
femminile.Vincenzo Armanni (1663, Vol. I°, pag. 710),
Bonaventura Tondi (1684), Oderigi Lucanelli (1888, pag. 618), Pio Cenci (Guida
di Gubbio, 1912, pag. 32, 33), Quirico Rughi (Guida della Città di Gubbio,
1972), Lanzi, Lord Layard, Crowe, Cavalcaselle.
2. Vedi Poli G., Il Dio Madre in Piero della Francesca. Dal libro segreto della Famiglia
Montefeltro la verità sulla Sacra Conversazione o Pala Brera, Luoghinteriori,
Città di Castello 2022.
3. Vedi Poli G., Velame italico, la dottrina dell’origine
nella Divina Commedia, Luoghinteriori, Città di Castello 2021.
Ringrazio il Comune di Gubbio per la
collaborazione e l’invio della foto della Madonna Belvedere ad alta
risoluzione.
di Giuliana Poli
 |
| Figura 1 |
 |
| Figura 2 |
L’affresco di Ottaviano Nelli riflette un’espansività ed una nobiltà senza eguali. I visi dei personaggi sono calmi, sorridenti, avvenenti e bonari. L’immagine del Cristo lo fa sembrare un uomo del popolo preso dalla strada o dall’osteria. Nel Medioevo in generale prevaleva la satira che ironizzava su persone che amavano bere, amare, cantare e fare la bella vita e per questo venivano raffigurate doviziose e ben nutrite.
La Madonna con il bambino ha delicate curve, fascino dolce che indica come doveva essere la “donna dei sogni” dell’epoca. Il bambino è paffuto e sereno, così come gli angeli che suonano e cantano. Niente esprime sofferenza. I santi dipinti ai lati dell’affresco, Sant’Emiliano con il libro chiuso e la palma a sinistra e Sant’Antonio Abate a destra, hanno una figura virile e sana, nulla e nessuno ha l’aspetto emaciato e questo dimostra come Ottaviano Nelli fosse uomo positivo riconosciuto e ammirato, che ebbe incarichi di responsabilità politica nel governo di Gubbio e che descrisse una realtà che nulla ebbe a che vedere con il deprimente spettacolo delle miserie umane.
L’affresco può essere suddiviso in parti geometricamente simmetriche: in alto il cielo stellato con le sue costellazioni e le sue santità e in basso il piano terreno, con figure oscure non leggibili per via del deterioramento dell’affresco. A latere del dipinto, mediatori tra i Santi e la Madonna con in alto Gesù Cristo tra gli angeli, ci sono i committenti. I lati dell’affresco sono uno l’antitesi dell’altro: sulla destra è dipinto il Conte e sulla sinistra, probabilmente la moglie o la figlia. Dal fatto che dietro la donna c’è un angelo custode femminile si evince che molto probabilmente, questo dipinto è collegato ad una sepoltura femminile della famiglia. Forse per questo il lato delle donne è chiaro e cristallino, mentre il lato dell’uomo che molto probabilmente è Antonio Pinoli (1390-1460) è tetro e si perde, divenendo un unicum, tra le stoffe, anch’esse oscure, di Sant’Antonio Abate, il santo di riferimento per via del nome. I lati estremi dell’affresco sono racchiusi da una cornice, dove si stagliano delle colonne tortili sulle quali Ottaviano Nelli esprime la sua satira medievale molto vicina a quella di Giovanni Boccaccio, dove l’eros giocoso a tratti irridente vince su tutto.
A differenza di falsi luoghi comuni su questo periodo storico, il pensiero medievale è stato scientifico e la sua missione è stata quella di tradurre simbolicamente ciò che aveva ricevuto dall’antichità e verso il quale era rimasto fedele custode. Per l’uomo medievale la verità è nel simbolo ed è rivelatrice di un insegnamento segreto, di un pensiero superiore vero, concreto e immutabile.
Nella Madonna Belvedere la scienza e la conoscenza sapienziale dominano su tutto. Al centro del quadro c’è la nascita di una stella simbolicamente rappresentata dal drappo di stoffa color rosso ed oro che orna la Madonna. La sua formula matematica, evidentemente già conosciuta dal Nelli, tesse le trame del cielo stellato sulla parte alta dell’affresco (fig. 1). Nel cielo stellato sono dipinte anche le costellazioni del leone, del cigno e dell’orsa. (2).
 |
| Figura 3 |
Ottaviano Nelli la dipinge un po’ ovunque sull’abito della Vergine e simboleggia il logos della Madre dalla cui idea nascerà il Cristo-Sole-Re della Luce. Nell’affresco si rappresenta quindi “il verbo” che dalla forma-pensiero si trasformerà in realtà attraverso la nascita del bambino di Luce. Molto probabilmente l’artista eugubino dipinge la ghiandola pineale con la forma di pigna, anche per omaggiare in senso metaforico il suo committente, il Conte Pinoli, il cui cognome e stemma del casato derivano proprio dalla pigna, il cui significato originale è sapienziale. I Conti Pinoli furono notoriamente ghibellini, legati al sapere e alla scienza e sicuramente appassionati del gualdo, un colorante azzurro di origine vegetale, molto richiesto all’epoca, pensiamo ad esempio a Sant’Angelo in Vado che deriva da Sant’Angelo in Gualdo. Questo colorante ha una storia particolare in Europa: estratto dalla isatis tinctoria, usato dai guerrieri celti per dipingersi il viso prima delle battaglie, rappresentò per parecchio tempo una fonte di ricchezza per la regione compresa tra Tolosa, Albi e Carcassonne, patria dei Catari. Il blu pastello estratto da questa pianta, denominato anche blu di Carcassonne, era molto ricercato sia per la tintura dei tessuti, che come cosmetico e come colorante per i pittori. In Italia venne coltivato in particolare nell’appennino umbro-marchigiano e nel Montefeltro: Benedetto de' Franceschi, padre di Piero della Francesca era ai suoi tempi un famoso commerciante di guado (o gualdo).
Dall’immagine della pigna con all’interno il Cristo, che è dipinta con il color rosso fuoco si manifestano sei onde dalla forma di sei esseri angelici di color azzurro, i quali rappresentano la permutazione della forma mediante il suono raffigurato dagli angeli che suonano l’arpa ed il violino, strumenti le cui corde simboleggiano le griglie dell’universo. Il pensiero che è fuoco spirituale, attraverso le vibrazioni forma la materia, e questo principio scientifico è raffigurato dal colore azzurro che dall’alto scende verso il basso lungo il manto della Vergine. Il corpo della Madonna come specchio dell’immagine dipinta sopra la sua testa ha nel centro il fuoco e all’esterno il color azzurro con all’interno ricami in oro. La fusione di fuoco ed acqua è evidente dal fatto che il Nelli ha disegnato sul manto fregi che rappresentano la ghiandola pineale a forma di pigna dal quale deriva il Cristo-Sole, proprio per evidenziarne la sua origine. Sulla veste azzurra della Vergine vicina alla crosta terrestre ci sono nuvole bianche e anche questo dettaglio svela profonde conoscenze scientifiche dell’artista eugubino. Il calore e la luce si creano dall’urto delle vibrazioni fredde e oscure, che arrivano dall’universo, contro l’atmosfera gassosa e, poiché man mano che ci avviciniamo alla terra la resistenza aumenta in maniera proporzionale alla densità del mezzo, il calore, la luce e la luminosità sono più forti sulla superficie terrestre perché gli strati d’aria sono più densi. Il velame gassoso, oltre ad essere presente nell’abito della madre, è nell’abito velato del Bambino.
 |
| Figura 4 |
Le mani dell’angelo sostengono la donna, quasi sollevandola dalle figure sottostanti, così come la mano di Sant’Antonio sembrano “estrarre” la testa dalla massa sottostante, in una posa che sembra andare ad attivare la pineale del Conte premendo con il pollice sulla nuca.
Se rovesciamo la parte d’immagine in cui è dipinto sia il Santo che il Conte, Ottaviano Nelli nasconde più immagini affastellate l’una sopra l’altra. In particolare sul tessuto color della terra appaiono dei Daimon che sembrano emersi da una grande caverna rappresentata dal tessuto più interno dell’abito del Santo. (fig.2-5) La sua mano anch’essa lunga regge la testa del Conte, sul cui cappello si nasconde un altro viso uguale e contrario a quello in evidenza sull’affresco. (fig. 3) Sullo stesso particolare il Nelli nasconde anche il profilo (fig. 3.a) L’artista ripete anche in questa occasione lo stesso principio espresso con il capo di Maria. Abbiamo quindi sia la ghiandola pineale della Madre celeste che ha partorito l’universo, sia il capo del Conte Pinoli tirato fuori dal mondo degli inferi, dalla mano di Sant’Antonio Abate.
Se andiamo ad analizzare i simboli del Santo, il primo è il fuoco che sancisce l’origine e la fine dell’universo. Non dimentichiamo che questo elemento è il simbolo di comunicazione tra l’uomo e il misterioso manifestarsi di Dio. È il TAU che vediamo impugnare da Sant’Antonio nelle iconografie più diffuse. Secondo la tradizione il Santo sarebbe sceso agli inferi e, dopo aver acceso il suo bastone, sarebbe tornato sulla terra per donare il fuoco di vita agli uomini. Una specie di Prometeo cristianizzato. Il simbolo del Tau richiama la croce egizia e sta ad indicare l’immortalità, ovvero la memoria celeste che è scesa agli inferi, ha generato la vita, ma che poi ritorna sempre alla sua Fonte primaria: il Sole, poiché il TAU che è la diciannovesima lettera dell’alfabeto greco coincide con il diciannovesimo arcano maggiore che è il Sole. Quindi il bastone di Antonio è il meteorite di fuoco celeste simbolicamente rappresentato dalla spada, dal tirso, dalla ferula della tradizione pagana o il pastorale nel cristianesimo, ovvero l’asse del potere che mette in relazione i due mondi: la luce e l’ombra, il sacro ed il profano. Altro simbolo è la campanella che rappresenta il suono armonico di creazione: il famoso canto degli angeli presenti nell’affresco (3).
Il corpo del Santo, quindi, rappresenta il divino che scende negli inferi (l’abito scuro costellato da demoni) dal quale tira fuori colui che metterà in relazione i due mondi perché legato al culto del Sole che simbolicamente è evidenziato dal lato sinistro dell’affresco dove Sant’Emiliano, che è pieno di luce, regge in mano il verbo divino rappresentato dal libro, e la donna committente della famiglia Pinoli, anche lei luminosa. È evidente come anche questa famiglia ghibellina seguisse la religione eretica notoriamente definita catara legata al cristianesimo gnostico, che vedeva nel Sole il simbolo del Cristo-Re della Luce. Le due colonne tortili nascondono figure che giocano nell’eros e nella voluttà dei corpi, che si divertono a fare giochi d’amore come era nello spirito contadino. Il suo significato potrebbe essere legato al Risus Pascalis, un rito pagano legato alla Pasqua in cui il parroco durante l’omelia si fermava ed iniziava a dire sconcezze e raccontare storie sordide sulla figura di Gesù e tutti ridevano. La Madonna Belvedere è un quadro dal significato sapienziale e profondo, il riso quindi, deve essere visto come un atto magico liberatore, utile a conoscere un’altra realtà. Il principio generatore dell’universo avviene attraverso la vitalità del fuoco. L’eros attiva le vibrazioni, il movimento e la vita a seguito di quelle metamorfosi che, grazie alla voluttà erotica dell’Amore muovono, il Sole e le altre stelle.
 |
| Figura 5 |
*
“DUX FEMINA FACTI”
di
Laura Margherita Volante
Il
titolo della mostra riporta un verso famoso dell’Eneide, simbolo che in
modo chiaro, ci illumina sul filo conduttore della suggestiva esposizione delle
opere di Tonina Asci. Un susseguirsi di dipinti e sculture che si articolano
oltre il tempo e lo spazio, in un altrove, luogo di saggezza di risoluzione di
libertà. Ecco che emerge Didone - chiave di lettura della mostra- per
accompagnarci per mano alla figura femminile descritta da Virgilio, donna
umile, modesta, sola, nobile, passionale, padrona di sé stessa, ma allo stesso
tempo solidale e benevola. Allora la regina, pur di non cedere, preferì
sacrificare la sua vita, immolandosi sul rogo funebre al cospetto del suo
popolo che, da quel momento, la venerò come una divinità. Nome femminile
fenicio Didone, che significa “donna virile”.
Lei,
che nutre e dà la vita, paga con la vita stessa, anche nelle società ritenute
civili, per la discriminazione e per il maschilismo più volgare e violento.
È
veramente una bella mostra tra il mito lo spirito la realtà trasfigurati in un
ideale di libertà. La figura femminile esprime il concetto di donna libera,
perché accogliente anche del grande mistero della maternità, che trascende
nella figura della Madre di tutti, come simbolo universale sia dei credenti sia
dei non credenti, nella sacralità della madre, presente in tutte le culture.
Dando
uno sguardo d'insieme emerge il dialogo interculturale delle immagini
femminili, la cui storia è il cammino di ogni popolo verso la liberazione dai
vincoli del pregiudizio, dove la donna assume un ruolo primario, fecondatrice
di vita. Naturalmente il tema ricorrente, sul piano reale al di là delle
diverse simbologie umane trascendentali e trasfigurate, è la donna oggi, in un
clima sociale, i cui retaggi culturali riemergono in un degrado di valori
etici, dovuti ad una crisi morale in tutti i campi delle relazioni
socioculturali.
Tonina
Asci, oltre ad essere un artista e maestra d'Arte di indiscutibile valore e
talento, è una persona di grande carica umana, nella sua continua ricerca e
approfondimento di fronte agli interrogativi, al senso stesso della vita e
della sua condizione di donna. Seppure senza risposte assolute, si affida alla
fede con umiltà, e questa è la grandezza degli umili, nella dimensione dell’amore
e della libertà universale. Universo, quindi nella sua specificità, verso l’Uno,
verso l’unicità della famiglia, della grande famiglia umana.
Tonina
Asci è dotata di forza interiore, che la caratterizza da sempre.
Dolce
e determinata, razionale e pratica, dignitosa e ironica, in un
equilibrio
dove i sentimenti giocano in campo, nel ruolo di arbitro giusto, senza pietismo
o buonismo.
È
la verità che si fa largo fra inutili orpelli come un pugno in guanto di
velluto, per impugnare il pennello come una spada lucente a illuminarne la fede
e la speranza, in un continuo essere vitale fra luci e ombre, fra sfumature e
linee dai contorni irrinunciabili di giustizia e di pace.
Per
concludere esprimo la mia vicinanza al popolo ucraino per la devastante guerra,
che sta subendo.
Allora
ci si chiede se l'arte sia importante in questi tragici momenti.
È
più che mai vitale. Essa è una medicina, una cura dell'anima per non perdere la
nostra umanità, per ricordarci la dignità di esseri umani, per non farci
coinvolgere da emozioni negative, in sentimenti di odio. Solo l'amore, la
coesione e la speranza possono tenerci uniti e solidali.
L'arte
attraverso i diversi linguaggi espressivi in immagini, testi scritti e
musicali, ma non solo, evidenzia la potenza creativa dell'essere umano, teso
alla creazione e alla costruzione della civiltà, attraverso l'uguaglianza, la giustizia,
la fratellanza, portatori di Pace.
L’arte
tutta è una medicina che cura, sussurrando i pensieri dell’anima, che si fa
bellezza e parole di amicizia e coesione. In ogni dipinto e ogni scultura di
Tonina Asci la poetica si staglia nell’assioma "Ci sono anch’io con voi, siamo
noi, insieme".
*
ALDO MONDINO
di Giorgio Colombo
 |
| "Turcata" |
La presenza in due gallerie milanesi, Gallerie
Gracis (piazza Castello 16) e Matteo Lampertico Arte Antica e Moderna (via
Montebello 30) dal 3 aprile al 17 marzo 2019, di un artista importante ma un
po’ tenuto in disparte come Aldo Mondino (Torino 1938-2005), è l’occasione di
ripensare la sua complessa figura nella quale si matura una ricca ironia schernitrice.
Dopo una prima esperienza parigina, rientrato nel ’61 in Italia per il servizio
militare, apre varie mostre con Enrico Crispolti, Gian Enzo Sperone, Christian
Stein. La sua opera Mamma, Agnelli e Porcòdio esposta a Brescia nel ’69 viene
sequestrata per blasfemia. Con il ritorno a Parigi si avvicina a suggestioni
orientali con la serie dei sultani 1200-1920: ‘Turcate’ (anche come omaggio
all’amico Giulio Turcato). “Il mio orientalismo - scrive - è un po’
l’orientalismo delle agenzie di viaggio”. Il materiale usato come fondo è in
prevalenza industriale: masonite, eraclite, linoleum = lino - olio. Per le
immagini usa sovente, oltre i colori a pennello, cioccolato, zucchero,
conchiglie… Nel suo
viaggio negli USA la scoperta della sua origine ebraica lo porta ad affrontare
uno nuovo tipo di soggetto. Queste poche righe non sono che cenni di una
personalità ricca di volute contraddizioni e sberleffi in un mondo troppo
spesso imperativo e serioso.
ALBUM MONDINO
 |
| "Prière" |
 |
| "Lufthansa" |
 |
| "La mamma" |
 |
| "Granada e Hong Kong" |
 |
| "Caramello" |
 |
| "Sit-in a Mea Shearim" |
***
Di Piero Guccione, morto quest’anno nella sua casa
siciliana di Quartarella, si è aperta una bella mostra al Museo d’arte di
Mendrisio, visitabile sino al 30 giugno ’19 con il titolo suggestivo di “La pittura come il mare”, un
movimento/fermo. I grandi azzurri pacificati esposti sono una sorpresa, un
cambiamento, piuttosto che il compendio di una vita ricca, varia, movimentata. Il
giovane Guccione inizia negli anni ’60 con la partecipazione ad una spedizione
per il rivelamento di pitture e graffiti rupestri di civiltà preistoriche
sahariane. Contemporaneamente a Roma, ammiratore di Munch, si dedica ad una
attività di pittore. Partecipa alle Biennali di Venezia con una varietà
d’interessi che lo accompagnerà nella prima parte della sua pratica artistica:
illustratore, citazionista, scenografo, riflettente (forme riflesse sulle
carrozzerie), insegnante... infine, folgorato da Caspar David Friedrich, scrive
un “Viaggio intorno a C. D. Friedrich”: nebbie, solitudini, mari, scogliere,
ruderi. È il momento della svolta. Nel 1979 decide di lasciare Roma, il chiasso
della città, e ritornare solitario nella natia Sicilia in zona Scicli, davanti
al mare, però con la casa e lo studio un po’ discosti, sulla obliquità
collinare, a Quartarella. Sì, perché non si ferma a dipingere copiando, non
cerca il realismo, ma la concentrazione, il sogno del mare-cielo, le
impercettibili sfumature dell’azzurro, i sussurri dello spazio, le minacce
della morte. Lunghe passeggiate sulla
spiaggia e poi il silenzio dello studio.
 |
| Linee del mare |
L’inserzione di alcuni elementi rigidi scompare poco per volta.
Qui, nel mio breve riassunto, a parte la penultima immagine, un pastello su
carta, mi occupo dei grandi oli su tela dove però, nella riproduzione stampata,
si perde la cura sottile delle pennellate, il loro levarsi, o appiattirsi
seguendo, spingendo o interrompendo l’onda in quella fragile pace che secondo
Claudio Magris è “il senso dell’infinito presente”.
 |
| Il nero e l'azzurro |
L’opera “Il nero e l’azzurro” 150 x 278 cm
(terza riprod.) verrà esposta nel 2006 nella Sala Italia di Palazzo Madama a
Roma.
Spesso sul bordo Guccione, oltre la firma, aggiunge
osservazioni e brevi aneddoti. Per esempio alla base di un pastello del 1978
scrive: L’opera d’arte veramente tragica/
ne è una testimonianza/ sarà quella dell’uomo felice,/ benché quest’opera/ sarà
intensamente suggerita/ dalla morte. Ecco, apparizione e sparizione,
felicità e morte si accompagnano, a rendere quella luce affascinante fragile,
preziosa, nello sforzo di resistere a
quella oscurità che la minaccia, così come ne “Il nero e l’azzurro”.
ANTONELLO, L’AMBIGUITÀ CREATIVA
di Giorgio Colombo
19 opere (su 35) di Antonello
da Messina (1430-1479) in mostra a Palazzo Reale di Milano, 21 febbraio-2
giugno, prestiti da Palermo, Palazzo Abatellis, ma pure da Londra, Washington,
Philadelphia, Berlino, Sibiu (Romania). Pittore di successo, dall’Italia
meridionale a Venezia, cade poi nel dimenticatoio, sin quando lo riscopre il
Cavalcaselle, che ne ridisegna le opere in quaderni conservati alla Biblioteca
Marciana di Venezia, e ora parte della odierna esposizione. Sovente si
conservano due opere dalle stesso soggetto, come la Crocefissione del ’65 in
mostra (39,4 x 23,19 cm) e quella del ’75, di Anversa, non presente.
 |
| Crocifissione (1465 c.) |
Dalle
lontane acque, forse del Mar Morto, alla città di Gerusalemme, al colle del
Calvario o Golgota, dall’aramaico
gūlgūtā, ‘Luogo del teschio’ teschio di Adamo, il primo uomo peccatore accanto
cui cresce quel legno che diventerà la croce del suo
Salvatore, il
Cristo. I due ‘Ladroni’ sono legati a due tronchi d’albero. Cinque donne in
piedi ammantate in vesti fiamminghe, si lamentano, ciascuna con gesti diversi.
La stessa scena, dipinta dieci anni dopo, subisce una profonda semplificazione:
le punte dei monti si appiattiscono, la città quasi sparisce, piccoli passanti
di schiena, ignari, in basso, due donne accanto alla croce pregano, una seduta,
l’altra in ginocchio, i due ladroni si dimenano, in contrasto con la mortuaria
fermezza di Gesù. La semplificazione è insieme concentrazione e mistero. Per
questo la ‘Annunciata’ (1975-76, 45 x 34,5 cm ) rappresenta il culmine di
questo rapporto.
 |
| Annunciata (1475-1476) |
Ha interrotto
la lettura. I fogli sono alzati forse per una corrente d’aria o per la rigidità
della pagina. Con una mano chiude il velo, copre il corpo, un alt con l’altra
apre, accoglie, indica, o, al contrario protegge, allontana, vorrebbe una distanza.
Gli occhi si volgono di fianco, per il guardante a sinistra, la mano e il
leggio a destra. Lo spazio scuro, nascosto ignora ogni locazione. Attrazione,
riconoscenza e respingimento dell’annuncio?
Vorrei
terminare con uno dei numerosi ritratti. Qui il personaggio imperioso, visto dal basso in
alto, è tagliato dall’oscuro cappello, immerso nell’oscuro del fondo. La luce
mette in rilievo il viso, il collo fermato dal taglio bianco della camicia e il
busto con regolari segni d’ombra nella stoffa. Lo sguardo è sempre laterale
(come negli altri ritratti), i segni intorno alla bocca e il movimento delle
sopracciglia indicano un leggero sorriso. Un’ironia, un comando? Anche nel
nostro caso il carattere enigmatico del soggetto è insieme suggerito e
sfuggente.
Certo, il
lavoro di Antonello è più complesso e vario di queste poche immagini che ho
scelto. Per esempio il ‘San Girolamo
nello studio’ (presente in questa mostra), piccola opera della maturità,
riprende, nella cura dei numerosi dettagli (libri, piante, animali), nella
moltiplicazione dei piani, nello sfondo delle finestre, gli elementi propri
della tradizione fiamminga, presente nell’Italia meridionale dove Antonello si
era formato. In ogni caso la sua firma era ben conosciuta se il figlio Jacobello
s’impegna a terminare quei quadri che il padre alla sua morte aveva lasciato
incompiuti.
La
semplificazione della scena, la cura dell’ambiguità espressiva, la singolarità
del personaggio dipinto, con tecniche multiple, che mescolano il colore ad olio
con quello ad acqua, individuano una personalità complessa, capace di suggerire,
in un tempo pur ricco di grandi pittori, una via anche per l’arte a venire.
Klee il segno sapiente
di Giorgio Colombo
 |
| P. Klee "Autoritratto" 1919 |
La mostra ‘Paul Klee alle origini dell’arte’ aperta
al Mudec di Milano sino al 3 marzo 2019 mi offre l’occasione per alcune
osservazioni che esulano dalla singola mostra:
un artista prolifico ma non facile nella sua sottile unicità in un
periodo, quello tra ottocento e novecento, pur ricco di presenze culturali rilevanti.
Non posso evitare alcune indicazioni biografiche. Nasce vicino a Berna nel 1879.
Inizia presto a disegnare e a conservare, datare e firmare le opere migliori,
accompagnandole con memorie diaristiche. Suona il violino in modo professionale.
Mozart è il suo preferito. Si sposta a Monaco, impara le tecniche
dell’acquaforte e si iscrive all’Accademia. Incontra la pianista Lily Stumpf
che sposerà e dalla quale avrà un figlio, Felix. 1901-2 viaggio in Italia. 1906
al Salone della Secessione di Monaco espone una serie di acqueforti, le ‘Inventionen’: “Sono riuscito ad
adeguare la natura direttamente al mio stile. Il concetto studio è superato.
Tutto sarà Klee, sia che tra impressione e riproduzione passino giorni o solo
pochi istanti”. Partecipa alla esposizione del Cavaliere Azzurro fondato da
Kandinsky. A Parigi incontra Robert Delaunay: i problemi della luce. 1914 parte
per il Sud, la Tunisia, con August Macke. Scoppia la guerra: Macke e franz Marc
vengono uccisi. Klee è trasferito ad una scuola militare presso Augsburg, dove
rimane sino alla fine del conflitto. 1920 Gropius gli offre l’incarico di
docente al Bauhaus prima a Weimar e poi a Dessau. Professore all’Accademia di Düsseldorf,
incontra Braque e Picasso. Inquisito dalla polizia nazionalsocialista, nel ’37
è incluso con 17 opere nelle mostre dell’Arte
degenerata’. Un centinaio di lavori di proprietà pubblica gli vengono
confiscati. Ritornato a Berna, già malato, segue l’apertura di importanti personali
a New York, Parigi, Zurigo. Muore nel 1940.
Ora
passo ad alcuni esempi. Comincio con una incisione di un Klee venticinquenne, ‘Attore’:
Il
viso con pennacchio è trattato nello stesso modo della maschera. Viso=maschera.
Ma c’è ancora troppa rappresentazione, troppo già avvenuto, già visto.
L’universo si espande, si assottiglia, si mescola, umano, animale, vegetale,
terrestre, cosmico, passato, presente, futuro… un filo, una lettera, uno
sguardo, un battito, una direzione…
 |
| "Attore" II inc. 1904 |
 |
| "Mister Z" 1934 |
 |
| "Paesaggio con uccelli gialli" 1923 |
La
scena ‘cinguettante’ è rigida, spoglia, metallica: volatili senza ali, tutto
becco, coda, lunghe zampe poggiano su di un filo molle che si unisce alla
manovella della macchina musicale il cui secondo filo, connesso a due
triangoli, forse altoparlanti, corre rigido ad angoli retti. Pittura colta e
liberamente fantastica, senza evitare il sorriso della mescolanza: gli uccelli - solo testa - e la manovella della macchina, costituita dallo stesso
cinguettio animale.
 |
| "Macchina cinguettante" 1922 |
 |
| "Città di sogno" 1921 |
Un sogno che si scandisce, nelle sue fasce ripetute, come una composizione musicale. Eppure è anche una città giocattolo, con i suoi alberi, le sue case, le sue luci, il suo occhio come una mezza luna. Il gioco infantile-adulto sembra una invenzione leggera, con un dubbio: mescolanze, ripetizioni, forme parzialmente riconoscibili, il moltiplicarsi delle punte, dei bordi taglienti conducono verso un fondo scuro di libertà o di minaccia, consueta sapiente ambiguità. Mi rendo conto che queste poche righe possono soltanto avvicinasi ad un lavoro svolto in continuità e continui arricchimenti, le cui onde creative si richiamano e rafforzano sino agli ultimi risultati.
***
MAX
BECKMANN A MENDRISIO
In
Italia conosciuto di nome, poco per la sua pittura, Max Beckmann
è in mostra con dipinti, disegni e grafiche nei limpidi locali del
Museo (ex convento) di Mendrisio, sino al 27 gennaio 2019.
L’artista,
nato a Lipsia nel 1884, viaggia, frequenta Parigi, espone con
successo. Nel 1914, scoppiata la guerra, si arruola come infermiere
volontario. In crisi per gli orrori a cui assiste, viene congedato
per un grave tracollo psico-fisico. Dedicandosi all’incisione,
realizza la serie ‘Die Hölle’ (Inferno) e
‘Jarmarkt’ (Fiera). Srcive ‘Lettere dalla guerra’
accompagnate da 22 disegni, s’interessa di Cabala e
filosofia. Il secondo colpo arriva nel 1937: a Monaco il nazismo apre
la mostra ‘Entartete Kunst’ (Arte degenerata). Vi sono
esposti 8 suoi quadri. In seguito 600 opere vengono rimosse dai
musei. Alfred Rosenberg definisce “bolscevica” la sua pittura.
Beckmann emigra ad Amsterdam. Non ritornerà più in Germania.
Partecipa alla mostra londinese ‘20th Century German Art’,
organizzata in opposizione all’iniziativa nazista. Vita difficile
in Olanda dopo l’occupazione tedesca del Paese. Terminata la
guerra, dopo aver rifiutato gli inviti da parte di alcune Gallerie
tedesche, deve rimandare la partenza per il desiderato ‘Nuovo
Mondo’ perché gli mancano i documenti necessari. Finalmente nel
1947 riesce a trasferirsi negli USA con un incarico di insegnamento a
Saint Louis e poi a New York dove continua l’attività
universitaria e termina gli ultimi due trittici ‘Beginning’ e
‘Argonauti’. Muore a 66 anni nel 1950.
Pochi
elementi per una vita movimentata, segnata dalle nefandezze delle
guerre e delle dittature. Provo a indicare, anche con le immagini,
alcuni punti del personaggio e della sua opera: 1) sicurezza del suo
lavoro, concentrazione su di sé, numerosi esempi di autoritratti, e
insieme crisi ricorrenti. 2) Uso insistito del colore nero,
solitamente marginale in pittura. Un buio inquieto che segna persone
e cose. La Valchiria preoccupata dietro le quinte teatrali (dipinto
del 1948), una doppia finzione, (il suo travestimento e il suo essere
pittura), che esprime timore più che conforto dall’ometto che le
sta accanto.
3)
L‘affollamento delle scene, la mancanza di spazio libero, il senso
claustrofobico, entrambe dalla serie ‘Die Hölle’
.
 |
| Gli ultimi (sparano) 1919 |
 |
| La notte (1919) |
4)
Slogamento dei corpi, smorfie, scompiglio delle proporzioni.
Le
scene più drammatiche si riferiscono allo schock provocato dalla
guerra (sono del ’19). Un retaggio che non l’abbandonerà più,
nonostante i riconoscimenti, le amicizie anche dei collezionisti, i
Musei che espongono le sue opere.
Sì,
una figura rispettabile di professionista, aiuta la pipa e la
sicurezza del proprio valore, ma un animo sconvolto: occhio
penetrante, severo, mano/segno forte e insieme impaurito. Una
immagine, quella dipinta (1939), che ti guarda ma non può sorridere.
PICASSO
E LE METAMORFOSI
di
Giorgio Colombo
Una
delle sue metamorfosi: l’arrivo dal mare, lui, lo stesso artista
nelle forme del Minotauro (uomo-bestia), accecato dalla passione,
guidato dall’innocenza. “Picasso Metamorfosi” s’intitola una
mostra di circa 200 opere al Palazzo Reale di Milano dal 18 ottobre
2018 al 17 febbraio 2019, in collaborazione con ‘MondoMostre
Skira’.
Ora
faccio un passo indietro. All’inizio del ‘900 gli artisti più
innovativi si sono ritrovati tra Parigi e Monaco a cercare come
liberarsi da un esausto accademismo. Le strade furono varie e fanno
la storia della modernità: si rompe l’immagine unitaria, lo
stereotipo della bellezza e della posa classica, le regole della
prospettiva, il prestabilito rapporto dei colori ecc. Un lontano
precedente è costituito dall’entusiasmo per le stampe giapponesi
da parte degli Impressionisti. Qui si tratta di un fenomeno più
vario e generalizzato. Gli artisti sentono che un mondo è finito e
il modo per continuare a creare immagini è mettere da parte i
maestri,buoni o cattivi che fossero, e saltare altrove. Picasso
ricorda come “E’ stato disgustoso il Trocadéro (Musée
d’ethnographie)… Il mercato delle pulci. Puzzava. Ero solo” Ma
scopre che “le maschere non erano sculture come le altre… I negri
(autori di quelle maschere congolesi) erano degli intercessori…
Erano armi”, davano forma agli spiriti: “Gli spiriti, l’inconscio
e l’emozione sono la stessa cosa…’Les Damoisells d’Avignon’
devono essere state concepite quel giorno” (A. Malraux
‘…Meditazione sulla morte di Picasso e sulla vita delle forme’).
Ecco, la via per trovare le nuove strade era passare per gli
interccessori, quelli che occupavano il posto della cosiddetta ‘Arte
popolare’ o selvaggia o primitiva o negra che, in un significato
esteso, si estende dall’Africa coloniale ai paesi dell’Oceania e
Polinesia e che viene ad interessare almeno tre generazioni di
artisti, da Brâncuşi a Nolde, Derain, Mirò, Arp, Kirchner, Ernst,
Dubuffet…. attratti dal “lato segreto e oscuro dell’esistenza”
(‘Je suis l’autre’ Electa 2018), ciascuno con la sua storia
differente. Picasso vive una lunga vita di 92 anni e una altrettanto
lunga furia creativa, facendo, disfacendo, modificando, riprendendo,
usando i materiali e le tecniche più diverse. A vent’anni si reca
a Parigi che diventerà il luogo permanente del suo lavoro. Persino
le prove per il risultato finale, come ‘Nudo seduto’, in mostra,
studio per ‘Les Damoisells d’Avignon’ ha ben poco da vedere con
il risultato finale, che segna l’inizio di una fortunata
modalità’cubista’ in varie fasi, a cui si uniranno Braque e
Apollinaire. La guerra, la visita di Pompei, la partecipazione ai
Balletti russi di Londra, il ritorno a un certo naturalismo di grandi
corpi femminili, l’incontro con Breton... Allo scoppio della guerra
civile spagnola scrive un testo poetico e stampa delle incisioni
‘Sogno e menzogna di Franco’ . Nel 1937 partecipa alla
esposizione francese delle Arti e delle Tecniche con un capolavoro,
la grande tela (m. 3x8) di Guernica, esposta eccezionalmente
nella Sala delle Cariatidi di Milano nel 1953. E qui mi fermo. Ho
indicato certe note tappe del lavoro di Picasso per ricordare i suoi
legami con il corso della storia da lui vissuta, dimenticando i quali
si perde una parte dello stesso lavoro. La mostra sulle ‘Metamorfosi’
organizza i “molti amori” del pittore in 6 sezioni, 6 tappe che
uniscono o separano tempi e luoghi diversi del suo strepitoso
operare.
 |
| Il bacio pericoloso |
Un
esempio: “Il bacio” pericoloso del 1929 non ha nulla a che vedere
stilisticamente con “Il bacio” amoroso del 1969.
 |
| Il bacio amoroso |
Ecco un altro
caso sorprendente nella sua diversità al termine della mostra: il
grande ferro dipinto in bianco di ‘Donna in giardino (primavera)’
1930 (cm 117x 85), pensato e montato nel progetto con pezzi di carta
ritagliati. Un divertimento, un sorriso, una sorpresa.
 |
| Donna in giardino |
Non solo ferri, ma anche l’argilla dell’impastatore. Prendo dalla presentazione: "Nell’estate del 1946 Picasso scopre l’atelier Madoura a Vallarius e conosce la ceramista Suzanne Ramié. Nascono piatti, piastrelle, pignatte, portafiori…”.
Il gioco continua.
 |
| Anatra portafiori |
 |
| Gufo rosso |
 |
| Volti di donna |
L'antica produzione della ceramica è ripresa con ironia e compiacenza: la manona-pancia dell'anatra, lo stupore del gufo che ti fissa, i quattro occhi della donna. Il modo di ripensare il passato è sempre un modo di reinventare il presente, un nuovo antico.
***
MILANO. CARAVAGGIO ALLA PERMANENTE
 |
| Macrofotografia dell'autoritratto di Caravaggio da "Il martirio di San Matteo" |
Le proiezioni ‘immersive’ e multimediali di questo ‘oltre’,
accompagnato da una voce narrante, sono il risultato di un lavoro
interdisciplinare di 50 professionisti di 5 diverse nazionalità. Il racconto,
sviluppato in quattro atti (gioventù, trionfo, bassifondi, fuga) comincia dalla
fine: “Il 18 luglio 1610 Michelangelo Merisi detto il Caravaggio muore solo e
in povertà, a neanche 39 anni”. Si tratta di un nuovo modo di proporre pitture
(riscoperte solo all’inizio del ‘900) che ora fanno parte della più illustre
storia dell’arte. Nuove le tecniche, vecchio e legittimo il costume della
riproduzione. Ricordo che nella mia lontana giovinezza i Musei erano pressoché
vuoti e le mostre circolanti quasi inesistenti. I libretti dei ‘Fratelli
Alinari’, ‘Piccola collezione d’arte’ anni ’20, erano in bianco e nero. Solo
nel dopoguerra le Case editrici introducono pagine a colori, spesso pessimi
colori. Non mi riferisco agli specialisti che frequentano e frequentavano Musei
e Convegni, pubblicavano libri rivolti a un ristretto numero di lettori. Questo
è per dire che la conoscenza diretta delle opere, persino quando fossero pale
d’altare, era e continua a essere scarsa. Io stesso ho abitualmente comperato
pubblicazioni, molto migliorate nel tempo, per riflettere su opere mai viste
negli originali, a volte collocate in luoghi difficili da raggiungere e di
scarsa illuminazione. Oggi poi, con l’uso imperante dei PC, non si penserebbe
mai di faticare per raggiungere gli originali, a meno che non siano gite
collettive guidate oppure impegni di lavoro. Rimane la questione relativa alle
varie tecniche riproduttive. Quest’ultima, detta ‘immersiva’, propone delle
novità: sei seduto, al buio, su di una poltroncina, come al cinema. Sedici
proiettori su di un grande schermo animano le ‘scene’, (la totalità del dipinto
o/e un suo particolare), immagini ad alta risoluzione con effetti
tridimensionali accompagnate da una voce
narrante e dalla sonorità di musiche composte appositamente. Uno vero spettacolo insomma, certo più affascinante di
una pagina illustrata o di una proiezione standard. Un invito alla nostra
pigrizia facile alla tentazione di non muoversi, pur con occhi attenti, da una
comoda poltrona.
[Fino a Gennaio 2019]
***
CARLO CARRÀ A MILANO
di Giorgio Colombo
È la terza mostra di
Carrà a Palazzo Reale, dopo le prime due nel 1962 e del 1987 a cura di Roberto
Longhi e quella alla Pinacoteca di Brera del 1942, triste anno di guerra.
L’attuale esposizione, ricca di 130 opere, curata da di M.C. Bandera, si divide
in sette sezioni: Tra Divisionismo e Futurismo, Primitivismo, Metafisica,
Ritorno alla natura, Centralità della figura, Gli ultimi anni, Ritratti. Ovviamente è impossibile seguire in una breve nota i
dettagli della ricca esposizione milanese,
né riassumere con poche righe una varia, intensa e produttiva vita di 85
anni (1895-1966). Mi limiterò a brevi cenni: firmatario nel 1910 del Manifesto
dei pittori futuristi (con Marinetti, Carrà, Boccioni, Russolo, Severini) autore nell’11 della grande tela 198,7 x 259,1
cm. “I funerali dell’anarchico Galli” (oggi al MOMA di New York), e nel ’15
‘Guerra pittura’ (disegni e parole in libertà), partecipa con entusiasmo alle
provocazioni futuriste. Ma l’anno dopo,
nel ‘16, l’atteggiamento cambia radicalmente: rilegge gli antichi e pubblica su
“La Voce” “Parlata su Giotto” e “Paolo
Uccello costruttore”. Non più graffi, velocità, capogiri, spazi multipli, ma un
sogno giocoso dove ritornano le immagini ben segnate, figure di un incantato,
infantile primitivismo: “Fanciullo prodigio”, “Bambina” (indicata anche come
‘Antigrazioso’), “I romantici” (con, tra
gli adulti in cappotto e guanti, il piccolo bimbo ‘incoronato’) e, infine, il “Gentilom briaco”.
“Sono
le ‘cose ordinarie’ che operano sul nostro animo in quella guisa così benefica
che raggiunge le estreme vette della grazia, e chi le abbandona crolla
inevitabilmente nell’assurdo, cioè nel nulla, sia plasticamente che
spiritualmente… Sono ‘le cose ordinarie’ che rivelano quelle forme di
semplicità che ci dicono uno stato superiore dell’essere, il quale costituisce
tutto il segreto fasto dell’arte… In codesto modo noi veniamo dalle profondità
alle superfici alla maniera dei pesci volanti” (“Il nostro carattere antico”
citato da P.Vallecchi 1918). Soldato
nella prima guerra mondiale, sofferente di una depressione nervosa, viene
aiutato da Soffici ad ottenere un’esenzione per malattia e a raggiungere i due
fratelli De Chirico (di cui il più giovane aveva assunto il soprannome di
Savinio) isolati a Ferrara e attivi nell’ospedale detto del ‘Seminario’, il
luogo dove Giorgio De Chirico sta elaborando la sua ‘Metafisica’e dove accoglie volentieri lo spaesato Carrà (gli
dedica una poesia, “…E tu ingegnere piemontese costruttore di nuove / strade
ferrate, perché sei così mesto oggi?”). L’ospite riconosce subito una
parentela: la sua “Musa Metafisica” del 1917, pur riprendendo suggerimenti
dechirichiani ( l’affastellamento incongruo, quel particolare di carta
geografica incorniciata), mantiene una sua propria semplicità nella figura
principale che diventerà più netta in quell’anticipo di ‘ritorno all’ordine’ espresso in quei dipinti
marini, solitari, che rimarranno una costante della sua pittura dagli anni ’20
in poi, come “Verso il tramonto”, “I
nuotatori”, Laguna Veneziana”, “Capanne al mare” ecc.
Il pino sul mare 1921
Marina
misteriosa, non c’è anima viva. Con l’ingresso scuro delle grotta, l’alberello
spoglio, quel cavalletto con panno che è quasi un sorriso sul cavalletto e la
tela dell’artista. Il
paesaggio si semplifica dagli anni ’30 in poi, scarsi i personaggi, in
particolare il mare di Forte dei Marmi dove si reca d’estate, spesso in
compagnia di Roberto Longhi. Collabora
alla rivista ‘Valori Plastici’ e al gruppo ‘Novecento’ della Sarfatti. Dal ’21
si occupa di critica d’arte sul quotidiano milanese “L’Ambrosiano”. Nel ’43, consigliato da Longanesi, scrive “La
mia vita”. Negli ultimi anni riprende spensierati teatrini con figurette (in questo
caso col titolo ‘Mistici, sensuali, contemplativi’) ritagliate in libertà. Quasi un divertimento.
Al Palazzo Reale di Milano
dal 4.10. 2018 al 3. 2. 2019
***
A Venezia Biennale di Architettura 2018: scampoli
Titolo
‘FREESPACE’
SPAZIOLIBERO,
“spazi liberi e supplementari a coloro che ne fanno uso” anche attraverso
“desideri inespressi”, come scrivono le due curatrici Yvonne Farrell e Shelley
McNamara. Alle ‘Corderie’ dell’Arsenale il lungo corridoio centrale dispone ai
due lati le opere degli artisti, singoli o in gruppo, allungandosi all’esterno
con luoghi separati tra i quali lo spazio ‘Italia’, dove prevale l’uso del legno grezzo (tavoli e seggiole), mattoni
alle pareti e tetto in vista e due proiezioni continue. Ai ‘Giardini’, oltre al
padiglione centrale, ricco di suggerimenti e proposte, 30 luoghi dedicati ai
singoli Paesi, a cui si aggiunge il Padiglione della Santa Sede, dislocato in
un silenzioso boschetto dell’isola di San Giorgio: quasi nascoste nel verde, le
piccole costruzioni brillano nelle invenzioni, tra gli altri, di Norman Foster
e Terunobu Fujimori.
Ritorno
al ‘FREESPACE’ e alla introduzione
delle due curatrici, “l’abilità dell’architettura di trovare una nuova e
inattesa generosità in ogni progetto, anche nelle condizioni più private,
difensive, esclusive o commercialmente limitate… l’opportunità di enfatizzare i
doni gratuiti della natura come quello della luce – luce del sole, quella
lunare, l’aria, la forza di gravità, i materiali – le risorse naturali e
artificiali”. Qui, mi pare, si danno per scontate le alleanze tra ‘natura’ e
‘artificio’, quando invece è forse uno dei nodi più difficili da districare.
Tra gli animali la specie umana si è distinta per un uso illimitato delle
‘risorse naturali’, a volte stravolgendole, avvelenandole, piegandole spesso
ad usi sconsiderati. Prendiamo lo spazio come un luogo ‘dato’, c’è e c’era
anche prima dell’animale ‘uomo’, dove si scatenano a volte forze che diciamo
‘distruttive’. L’equilibrio è difficile, ma considerare onnipotente l’azione
umana è forse il maggior pericolo. L’architettura abbraccia a volte questo
pericolo, perciò può certo provvedere
“al benessere e alla dignità di ogni abitante di questo fragile pianeta”
, tenendo però conto di una doppia fragilità, quella nostra e quella del
pianeta che abitiamo, un equilibrio estetico-funzionale-ambientale
dell’oggetto, dell’edificio, della metropoli, dello spazio, di uno spazio
aperto, di uno spazio libero come indicano le curatrici.
Ora vorrei toccare due
punti della Esposizione ai Giardini: l’ingresso maestoso e l’ultimo padiglione,
il finale premiato con il ‘Leone d’oro’, l’House
Tour della Svizzera, un appartamento vuoto. Il salone che ci accoglie, con
i grandi specchi in basso e l’alta cupola dipinta che in parte vi si rispecchia, ricordano l’entusiasmo con cui venne accolto questo eccezionale sforzo
espositivo dedicato all’arte, contiguo alle grandi esposizioni rivolte alle
acclamate conquiste delle scienze e della tecnica. Al contrario la casa nuda,
spoglia, angoli, ombre, volumi diversi, non è una vera casa
Il Padiglione Francese
***
Le pietre veneziane
di Jhon Ruskin
Autoritratto 1873-74
La mostra doppiamente veneziana di Ruskin, al Palazzo Ducale di Venezia
dal 10.03 al 10.06, che ha per riferimento uno dei suoi testi più noti, ‘Le
pietre di Venezia’ 1851-1853, ripropone, con una ricca esposizione di
acquarelli e disegni, una figura molto interessante e non sufficientemente
valorizzata, di un grande e complesso
personaggio (1819-1900). Figlio unico di una ricca famiglia, lunga vita,
scrittore infaticabile, madre possessiva, amori e sogni di giovanissime
fanciulle, crisi nervose, osservatore attendo ai particolari della natura e
delle antiche costruzioni, disegnatore e pittore di raffinatezza rara, appunti,
taccuini, rilievi architettonici, calchi in gesso, albumine, planotipi…. A 66
anni si ritira in una solitaria villa sul lago di Coniston, dove intende essere
seppellito. La grandezza artistica del passato, quello italiano specialmente,
non più in là del XV secolo, e in seguito il gotico francese, costituisce il
modello di paragone nei confronti dir una modernità che si autodistrugge nei
suoi feroci antagonismi e nella smodata avidità di meccaniche conquiste. Uno
sguardo ammirato, incantato da un preciso passato e una condanna del presente. Nel 1851, in favore degli amici Preraffaelliti (Millais era stato suo allievo), contro le critiche della stampa ufficiale,sceive due elegie e un
saggio in cui li annovera tra i veri esponenti della pittura moderna al seguito
degli esempi di William Turner – che muore nel ‘50 -, di cui ammira “un’immaginazione
selvaggiamente bella” e del quale è nominato esecutore testamentario.
Ed è quindi
giusto che la mostra inserisca alcuni pezzi veneziani splendidi di Turner. Qui
Punta della Dogana e Chiesa della Salute 1843, scena di trasparenza e di luce,
“spazio a vortice, un’infinita distanza dalle apparenze del mondo...(Ruskin, Pittori
Moderni (Modern Painters), Einaudi).
Dunque
Venezia. la Venezia di metà ottocento, una magnifica città sulla via del
disfacimento, il banco di prova del più
giovane allievo di Turner, il luogo delle sue preferenze e condanne.
Ammirazione e rimpianto. Vi soggiornerà undici volte, dal 1835 al 1888. E’ la
Venezia bizantina e gotica, quella “che sorse dallo squallore della laguna e
dal dolore di un popolo, una città dalle logge aggraziate, dalle mura lucenti,
venate d’azzurro e tiepide d’oro, variegata da candide sculture simili ai rami
della foresta che il gelo ha volto in marmo”
(“Le pietre di Venezia” Mondadori 2011 p. 97).
“[Venezia] giace
ancora davanti ai nostri sguardi come era nel periodo finale della decadenza:
un fantasma sulle sabbie del mare, così debole, così silenziosa, così spoglia
di tutto all’infuori della sua bellezza, che qualche volta quando ammiriamo il
languido riflesso nella laguna, ci chiediamo quasi fosse un miraggio quale sia
la città, quale l’ombra. Vorrei tentare di tracciare le linee di questa
immagine prima che vada perduta per sempre, e di raccogliere, per quanto mi sia
possibile, il monito che proviene da ognuna delle onde che battono inesorabili,
simili ai rintocchi della campana a morto, contro le pietre di
Venezia” ( The Stones of Venice, vol. I, ch. I, § 1).
Cà d’Oro 1845
Ponte e S. Giorgio dei
Greci
Pilastro Acritano (da
Acri)
Ma la
decadenza di Venezia, anche nelle mani di chi vorrebbe ricostruirla, è il segno
del suo fascino. Il lamento di Ruskin si ripete ad ogni sorpresa della sua
grandezza: “Il potere che era stato affidato a Venezia si corruppe in mille
modi miserandi al massimo del suo fulgore”… E quando nelle sue ultime ore
allontanò da sé ogni senso di vergogna e
di freno, e la follia del mondo intero riempì la grande piazza della città, ricordiamoci
che la sua colpa fu più grave di ogni altra perché fu commessa al cospetto
della casa del Signore, fiammeggiante delle lettere della Sua Legge” (“Le
pietre di Venezia” p. 75).
‘NOVE VIAGGI NEL TEMPO’ è il titolo di nove opere site specific presentate
nell’Appartamento del Principe di Palazzo Reale di Milano, ingresso gratuito, terzo
episodio proposto negli anni con la collaborazione di Alcantara, a cura di D.
Quadrio e M. Torrigiani, dal 5 Aprile al 13 Maggio.
Inutile dire che ‘viaggio’ e ‘tempo’ sono due termini che
coprono un campo semantico molto esteso il cui abbinamento crea una vicinanza
imprevista: il viaggiare è un andare, uno spostamento prolungato; il tempo è un
riferimento a qualcosa, impalpabile, di passato e attesa di qualcosa di futuro.
Ogni opera ‘artistica’ è il frutto di indagini, scoperte, sorprese: un
risultato che sta in qualche posto, come in questa occasione, gli oggetti esposti
- chiamiamoli così -, nove invenzioni ambientate nelle sfarzose camere
(decorazione ottocentesche) del principesco appartamento. I materiali con i
quali sono costruite tali ‘oggetti-sculture’ambientali sono in gran parte
prodotti di Alcantara. Indicherò
soltanto alcuni esempi lasciando al visitatore la sorpresa dei restanti
ambienti. La prima stanza ospita l’opera Desiderio
di Aaajiao (vive tra Berlino e
Shangai) ,una grande forma
tondeggiante trasparente che contiene un materiale marroncino indefinibile.
Alla trasparenza e chiarezza del contenitore si contrappone la rudezza del
contenuto, una specie di foresta in miniatura.
Nel sogno di Chihau
Shiota (Osaka-Berlino) una fitta ragnatela scura avvolge uno spazio nel
quale s’illuminano due costumi bianchi che si riflettono sugli specchi
circostanti.
Anche i titoli hanno un tono mistico-poetico: Tempio di reverenza per la conoscenza oltre
la comprensione umana di Li Shurui,
cinese, uno spazio i cui segni si riflettono tutt’intorno, progettato per
supplicare la comprensione della quarta dimensione e di tutti quei regni che
oltrepassano le nostre quotidiane capacità conoscitive.
Come si può facilmente capire le descrizione scritte degli
ambienti dei nove viaggi sono appena scarse indicazioni dei differenti
contenuti delle camere. Al lettore il piacere della scoperta.
aprile 2018
***
VERBANIA
PAESAGGIO VERO E DIPINTO
In basso il lago è liscio come uno specchio;
siamo diretti al Museo del Paesaggio di Verbania, ben restaurato anche nelle
decorazioni dei soffitti, dove si è aperta, sino al 30 settembre di quest’anno,
la mostra ‘Paesaggi dalla Scapigliatura
al Novecento’ composta di una cinquantina di opere divise in tre sezioni: Scapigliatura, Novecento Italiano, Oltre il Novecento. L’argomento
‘paesaggio’ è un carattere ricorrente nella pittura di fine ‘800, la ricerca di
una serenità che la città rischia di perdere (o ha già perduto), dove la
prevalente ‘naturalità’ di cieli, acque,
alberi e
monti pare risarcire le persone dalla fretta, dai rumori, dai fumi,
dalle macchine in cui è immersa la nuova realtà cittadina.
Francesco Gnecchi, Fondo Toce, Lago Maggiore 1884
Carlo Fornara I due noci 1920
Il tardo
divisionismo di Fornara raggiungendo la luminosità astratta della accurata
divisione della pennellata e della spatola, mantenendo una freschezza che è
propria della grande stagione precedente, di cui è testimone in mostra, insieme
a Cesare Maggi e a Guido Cinotti, anche il vecchio Vittore Grubicy. Ora passo a
tempi diversi, quando sono ormai lontani gli scoppi del ‘Futurismo’, appena
alle spalle le riflessioni del ‘Novecento’ e del ‘Ritorno all’ordine’, per
arrivare a due esempi più recenti e opposti, anni ’30 entrambi: il primo, la tranquillità inquieta di Siro Penagini con
la sua milanese ‘Piazza Santo Stefano’,
i due aeroplani, fermi in aria, sopra una città muta, disabitata, tre alberi
spogli, unica attività il fumo di un comignolo.
Il
secondo esempio, col quale vorrei terminare, un bel pezzo di Filippo De Pisis, Temporale del 1933, un tema ripreso
anche in un’altra opera simile dello stesso anno. Una ghiandaia ferita cade, un
temporale minaccioso spaventa piccoli uccelli in volo, lontano un edificio
bianco si allunga tra due alberi, poche pennellate e sgraffi di spatola.
L’animale colpito, una sprezzatura nervosa, un bagliore.
Il
paesaggio ha perso la sua tranquillità campestre, il sogno di un riposo antico,
di un abbraccio naturale consolatorio. Anche senza il rumore del traffico,
senza la rigidezza delle lamiere, senza la forza e l’incubo della città, il
campo desolato è il segno di un turbamento, di una ferita che l’uomo moderno
porta con sé, ovunque si trovi. La nostra naturalità è parte di questa natura
incerta. La città, nel nostro primo esempio, è vuota e silenziosa, la natura,
secondo esempio, è piena e inquieta. No, non una fotografia del reale, ma una
trasposizione, una fantasia ir-realistica, una libera sensibilità dell’arte. La
diversità tra aree di riposo e di natura e luoghi di affanno meccanico pare si
stiano mescolando. Ecco, le vicende del paesaggio vero e di quello dipinto
conducono anche a queste riflessioni.
marzo 2018
***
COLLEZIONISMODAL PHILADELPHIA MUSEUM OF ART
Impressionismo e Avanguardia, Milano Palazzo Reale 8 marzo - 2 settembre
Mary Cassat ‘Donna in
un palchetto’ 1879
Il
collezionismo americano degli Impressionisti comincia proprio con la famiglia
Cassat. Mary Cassat, pittrice, in contrasto con i genitori, arriva a Parigi nel
1877 e conosce Degas che aveva organizzato nel ’74 la prima mostra di questi
giovani pittori presso lo studio del fotografo Nadar. Lei stessa parteciperà alle mostre collettive degli Impressionisti.
Edgar Degas ‘La classe di
danza’ ca.1880
Non posso
mancare di sottolineare la meravigliosa indifferenza della figura in primo
piano intenta a riposarsi e leggiucchiare un giornale. Altro che esaltazione della danza!
Collezionista
è il ricco fratello, dirigente della Pensylvania Railroad, che nell’82 la
raggiunge con la moglie, e rimane a Parigi diversi mesi iniziando l’acquisto di
opere di Manet, Monet, Degas, Pissarro, e incoraggiando alcuni amici a fare altrettanto. Il
Gallerista Paul Dourand-Ruel, sorpreso dalla passione dei collezionisti di
Philadelphia, anche con l’aiuto della Cassat, invia duecento opere di
impressionisti a New York, suscitando grande interesse negli americani e un
ragguardevole numero di vendite, tanto che apre una Galleria d’arte in questa
città che durerà per i sessant’anni successivi. Il trionfo della nuova pittura
francese è più rapido in America che in Francia. Anche i quadri di Cezanne e di Van Gogh arrivano a Philadelphia.
Van Gogh ‘Ritratto di Camille
Roulin, 1888
Singolare l’attività
collezionistica di un particolare soggetto: non l’intellettuale saccente, ma un
massiccio lottatore tutto muscoli, Samuel Stockton White, erede di una famiglia
rinomata per prodotti di odontoiatria. C’è di lui una grande fotografia in
mostra. Durante una vacanza a Parigi nel 1901 Rodin gli chiede di posare per
lui, “un atleta americano” (la piccola statua è in mostra).
Le storie dei collezionisti, come la maggior parte delle storie, sono sorprendenti. Louis Stern nasce nel 1886 nella comunità ebraica di Balta, oggi in Ucraina, allora parte dell’impero russo, si sposta da ragazzo negli USA, ama il confronto tra la pittura moderna e l’archeologia delle più diverse provenienze. Coltiva l’amicizia con Marc Chagall in fuga dall’Europa nazista: comunicano in russo e yiddish. Pare che il dipinto del 1943, ‘Nella notte’, ora in mostra, ricordi la prima notte di nozze del pittore con la moglie Bella. Stern lascerà alla sua morte più di trecento opere al Philadelphia Museum of Art di cui era stato amministratore.
E terminerei queste brevi note con i coniugi Arensberg, lui poeta e traduttore di Dante, lei pianista. Il momento centrale è il 1913, la mostra dell’Armory Schow a New York e l’amicizia con Marcel Duchamp che li guida verso le scomposizioni cubiste e i sogni del Surrealismo.
I passaggi di proprietà, l’arrivo al Museo, la presentazione di opere europee recenti che in Europa sono ancora messe in dubbio, e che lo saranno ancora di più in seguito, con l’affermarsi delle dittature, ci mostrano un mondo di variegati e appassionati collezionisti, diversi nelle occupazioni, spesso estranei alle Accademie, liberi nelle preferenze, e proprio perciò garanti di valori estetici nuovi, che così segnano la storia dell’arte presente e futura.
marzo 2018
***

A.D. 1500
DÜRER E ILRINASCIMENTO MILANO
PALAZZO REALE
21 febbraio – 24 giugno
Albrecht
Dürer (Norimberga 1471-1528) avrebbe visitato Venezia due volte, nel 1495
(di cui mancano i documenti) e nel 1505-1507, dove esegue opere importanti tra
le quali ‘Ritratto di giovane veneziana’, che è stato scelto come emblema
della mostra, curata da Bernard Aikema.
I
A
Norimberga, una città ricca di stampatori e di artisti, il giovane Albrecht,
avviato come orafo nella bottega del padre, viene poi affidato all’insegnamento
del pittore Michael Wolgemut…. No, non intendo ripercorrere le vicende
biografiche, le amicizie, le fortune, i capolavori, i viaggi del grande
artista, cinquantasette anni di una attività intensa e di qualità eccezionale. Mi limito ad alcune osservazioni marginali, alla “rete dei dettagli” (Didi-Huberman).
Prima
osservazione, il suo marchio di fabbrica, AD,
sempre nelle sue opere grafiche, con
l’aggiunta, a volte, nelle pitture, della firma . Non doveva esserci dubbio sulla identità del
pittore.
.
Secondo punto, la concentrazione su di sè, sulla propria figura
e quindi la frequenza del proprio autoritratto, a partire dalla ‘punta
d’argento’ a 13 anni, a seguire l’incisione non ancora vent’enne, il dipinto a
22 anni con il fiore d’eringio in mano, e poi nelle vesti di un tamburino più avanti e via via all’interno delle scene più diverse, come in quella, qui riprodotta, l’arrivo dei Magi e lui stesso nei ricchi panni
di un ‘Mago’,
.
i lunghi capelli ondulati, carico di gioielli
e collane, in mano la coppa più grande. Non manca la fantasia burlesca, il
raglio dell’asino nella stalla, la pelata del vecchio stanco a toccare la
manina di Gesù appena nato, sporto dalla madre (il vecchio e l’infante), il
servo accovacciato alla turchesca, gli insetti, uno con le chele aperte, i
cavalieri e le rovine in lontananza, mare e monti ancora più in là…..
Ultima
osservazione l’importanza della stampa, dei libri stampati, delle
illustrazioni, di cui Norimberga era una delle capitali insieme a Colmar,
Strasburgo e Basilea, tutti centri visitati dal giovane Dürer, il quale si dedicherà per tutta
la sua vita alla creazione di ‘incisioni’, in particolare xilografiche, che
infatti costituiscono la parte principale dell’attuale mostra . La possibilità
di ‘tirare’ su carta molte copie dalla stessa lastra rendeva il lavoro
particolarmente redditizio e di facile trasporto.
Ora vengo a
due esempi:
.La Melancolia, una delle immagini più note, è
un’incisione a bulino siglata e datata 1514. Il titolo si riferisce alla bile
nera o atrabile (dal greco Melaine Chole ), uno dei quattro
elementi basilari della natura umana secondo le teorie alchemiche di ispirazione
platonica: il furor melanchonicus diventa furor divinus, capacità creativa. Forse
la stessa che l’artista sentiva in se stesso. La Melanconia è comunque una
immagine femminile. In un ambiente notturno, illuminato da un arcobaleno lunare
è seduta la figura alata, pensosa, corona vegetale sul capo,viso in ombra ma
occhi luminosi, con il compasso che impugna e il braccio posato su di un grosso
libro, aspira a riportare la massa confusa alla forma, tra le pieghe
dell’abbondante sottana un mazzo di chiavi (per aprire alle verità), circondata
dagli arnesi e simboli dello sforzo creativo: in alto una campana sotto la
quale è appeso il quadrato magico
(dove la diversa disposizione dei numeri interi dà sempre lo stesso risultato),
una clessidra, una bilancia, un putto
alato (Mercurio?) seduto su di una vecchia macina, una scala a pioli (sforzo di
salita o incompiutezza?), un grande solido poliedrico dietro il quale
s’intravede un vasetto per la calcificazione, in terra un martello, un cane
scheletrico, una sfera tornita, una tenaglia che spunta sotto la sottana. In
fondo, sopra uno specchio d’acqua, un arcobaleno (illuminazione) e una cometa
(guida). Il pipistrello dietro la scritta si leva al crepuscolo, la ribadita
ambiguità tra ombra e luce. Da
Panofsky a Calvesi molti studiosi hanno cercato di interpretare il complesso
intrigo di questa Melancolia. Che tra i significati possibili si nasconda,
secondo la traccia alchemica, la dolorosa trasmutazione della materia non
elimina la sua intenzionale ambiguità, la cui oscurità illuminata è parte del
suo fascino.
La Melanconia fa parte di un trittico, il Meisterstiche, le incisioni magistrali,
insieme al San Girolamo che legge in
un ambiente affollato di cose, a cominciare dalla grossa lampada a soffitto, a
finire con il primo piano dove, accanto ad un paio di pantofole, riposano
pacificamente insieme il leone ammansito e un cane, e, a ‘Il
cavaliere, la morte e il diavolo, la terza scena con la quale vorrei
chiudere questo breve commento.


Il Cavaliere procede impavido (o incosciente), ben corazzato sul suo altrettanto impavido animale, nonostante i mostri che lo minacciano: la morte, il cui cavallo mogio sembra spinto controvoglia a incrociargli la strada, gli mostra con la clessidra il poco tempo che gli è rimasto e il diavolo grottesco, con quel corno esagerato cresciuto su due orecchione, che lo segue quasi incerto impugnando una scadente alabarda. Il cane da caccia procede festoso, sotto la pancia del cavallo, in direzione contraria alla piccola salamandra. Per terra un teschio fracassato si appoggia su di una piastra col monogramma AD, la data 1513 e una S: Salus ? Una natura invernale, massi fessurati, rami secchi, e il paese in cima al colle definiscono, rinchiudono la scena. La obliquità delle linee, la spada, le due lance, il profilo delle rocce e dei monti, il corno arcuato del diavolo, sottolinea l’asprezza dei contrasti. La diversità dei trattamenti e dei soggetti, figure realiste e fantastiche, la cura dei particolari, anche minimi, ribadisce le capacità e forse anche la sottile ironia dell’artista.
Nelle vetrine della mostra sono conservati alcuni volumi relativi agli ultimi studi di Dürer, un trattato sulla geometria, un secondo sulle fortificazioni e un terzo, incompiuto, De symmetria partium, sulla simmetria e le proporzioni del corpo umano, accompagnato da disegni sulla figura maschile. E qui si può intravedere una vicinanza con Leonardo. All’esercizio delle più diverse tecniche, alla creazione di scene bibliche, di ritratti, di pale d’altare, di schizzi ed appunti, anche le astrazioni degli studi architettonici e dei rapporti matematici applicabili alla figura umana. Non una curiosità ma l’indagine sulle più diverse possibilità di trasformare le esperienze umane, tutte, il visibile e l’immaginabile, senza esclusioni o preconcetti, in un fermo immagine, in un linguaggio, in strumenti di espressione e comunicazione.
marzo 2018
***
ARTICO. ULTIMA FRONTIERA
s’intitola la mostra
fotografica alla Triennale di Milano
dall’8 febbraio al 25 marzo: foto in bianco e nero di Ragnar Axelsson,
islandese, Castern Egevang, danese e Paolo Solari Bozzi italiano.
Il bianco
accecante, la grandezza dello spazio che avvolge e quasi annulla la presenza
dell’homunculus, i pochi Inuit rimasti,
l’assenza di ogni rumore meccanico, la forza dei venti e dei vortici nevosi,
tutto contribuisce ad un piacevole spiazzamento: anche la eliminazione del
colore e la riduzione alla essenzialità del bianco/nero.
La minaccia
del riscaldamento globale, le poche costruzioni abbandonate ci ricordano la
sconsiderata ingordigia dell’animale ‘uomo’ e il rischio di risultati
catastrofici. La fragile pace dell’abito ne(r)voso è sempre accompagnata dall’attività
inesauribile dell’Homo (in)sapiens. Il futuro rimane incerto.
***
Rivoluzione!
La
mostra è accompagnata da un bel catalogo la cui copertina è qui sopra
riprodotta; inaugurata a Gorizia il
21 dicembre 1917, a cent’anni dallo scoppio della Rivoluzione Sovietica in
Russia, aperta sino al 25 marzo 2018, è curata da Silvia Burini e Giuseppe
Barbieri con la collaborazione di Faina Balachovskaja. Le opere provengono
dalle principali Istituzioni moscovite e dalla Fondazione G. Feltrinelli. La
vicenda inizia nel 1898 con la
associazione “Mondo dell’arte”
diretta da Djagilev - che nel 1906, prima dei più noti Balletti Russi, organizza
una esposizione di artisti russi al Salon
d’Automne a Parigi - per giungere alla fondazione della Unione
Sovietica nel 1922.
Si tratta di un periodo ricco di proposte e discussioni politiche e culturali,
ben noto attraverso figure conosciute e apprezzate anche in Europa, alcune
delle quali, come Chagall e Kandinkij, già attive tra Parigi e Monaco, sono
costrette a far ritorno in Russia allo scoppio della guerra nel 1914. Viceversa
alcuni artisti russi come la Gončiarova e Larionov, si trasferiscono nello
stesso anno a Parigi. Rientra in questi utili scambi, il viaggio di Marinetti a
Mosca e a San Pietroburgo nello stesso 1914 e i suoi importanti incontri con i
futuristi russi. Tra gli artisti la presenza femminile, “le scite Amazzoni”
come le definisce il poeta Livšc , è particolarmente significativa. Molti
sono i nomi dei vari gruppi che si moltiplicano (costruttivismo,cubo-futurismo ecc.) : ne nomino almeno uno, il Suprematismo di Malevič e il suo noto ‘quadrato
nero’ esposto nel 1915 alla ‘Last Futurist Exhibition’, ma una bella immagine dell’anno precedente, esposta in mostra, illustra un testo di
Majkovskij. Felici contraddizioni.
Quello
che mi sembra caratterizzi questa esposizione è la presenza di alcune parti che
sono proprie delle cosiddette arti applicate. La prima si riferisce alle
stoffe, progetti firmati di tessuti (Mosca, Putnikov family Collection). La
seconda i costumi schizzati da Larionov per i ‘Balletti russi’. La terza i
manifesti, le carte stampate, i volantini, gli oggetti di uso quotidiano. In
genere si tratta di na produzione spicciola di propaganda politica, spesso di
particolare qualità, aspetto che si inserisce in quelle spinte al rinnovamento,
a tutti i livelli, che caratterizzano il movimento rivoluzionario:l’artista,
come qualsiasi altro operaio, è una persona politica, lavora, crea non per una
soddisfazione personale e per gruppi ristretti di intenditori, ma per il
benessere della società, della nuova società. Pur in questa prospettiva, spesso
lo stile della illustrazione popolare russa ritrova l’eleganza, la compostezza
dei risultati ‘colti’.
La
figura più conosciuta dei disegnatori-scrittori è quella di Vladimir Majakovskij,
di cui scelgo dal manifesto: “…Nessun
signore sarà più sopra l’operaio” 1920:
Il manifesto di M.
Ĉeremnych, nella sua raffinata semplificazione delle forme, è accompagnato dal testo
di V. Majak ovskij: “Chi è contro la fame, chi è per i mucchi di pane:
afferrate il martello con allegria e aria giovanile, affinché nessuna
locomotiva a vapore sia da riparare” 1920.
E
per finire, tra gli oggetti decorati, piatti, tazze, scatole, scelgo il vassoio
di A. Vol’ter Perekop 1920, che si firma vistosamente nella parte bassa della
scena: una pittura tradizionale, ma curiosa, dove, nel bordo, una sequenza
floreale, con immancabile falce e martello, incornicia i fumi delle lontane
ciminiere, quasi a sostenere il salto del cavallo, intrecciati con i raggi del
sole (dell’avvenire?); alla grande bandiera rossa mossa dal vento, in fondo,
lontano, si intravede la vecchia, mogia bandiera zarista. Quattro fusti di
cannoni proteggono il balzo dell’eroe comunista. Nel cielo scuro volano, quasi
giocattoli, i piccoli aerei. Un racconto fitto, agitato, sul nero irreale del
vassoio, un arredo casalingo diventato espressione ingenua di un sogno
universale.
febbraio 2018
***
FRIDA KAHLO, QUALE MITO ?
Con Diego
abbraccio l’universo, 1943
“Frida.
Oltre il mito” intitola la bella mostra aperta al MUDEC (Museo delle
Culture), Milano, 1 febbraio-3 giugno, dedica all’artista messicana Frida Kahlo
(1907-1954), 70 dipinti, 40 disegni e150 fra lettere, fotografie e oggetti vari.
“Oltre il mito” sarebbe, secondo la presentazione di Diego Sileo, il
superamento della sua vicenda personale, “i suoi oscuri traumi familiari, la
sua tormentata relazione con Diego Rivera, il suo desiderio frustrato di essere
madre, la sua tragica lotta contro la malattia… L’opera si è vista quindi
radicalmente rimpiazzata dalla vita e l’artista irrimediabilmente ingoiata dal
mito”. Ora, in generale, ogni scelta professionale è connessa alle condizioni
famigliari e personali. Tanto più quando
si tratta di una scelta vaga, incerta come la pratica artistica. Ora prendendo
il caso di Frida Kahlo, la scelta è condizionata da una situazione molto
particolare, ben conosciuta: già indebolita da una poliomelite nella gamba
destra, a diciott’anni è vittima di uno scontro tra l’autobus su cui viaggiava
e un tram: un corrimano le entra nel fianco e esce dalla vagina, la colonna
vertebrale si spezza in tre punti nella legione lombare, si frantumano le
costole e il collo del femore, la gamba sinistra subisce undici fratture,
l’osso pelvico si spezza in tre, il piede destro è schiacciato…. E’ costretta ad una lunga permanenza a letto,
dove, per passatempo, inizia a dipingere. Con un cavalletto apposito e lo specchio
comincia i suoi autoritratti, “il soggetto che conosco meglio”.
Guarita solo parzialmente, ma l’impossibilità di
aver dei figli, nonostante i suo vari tentativi, e i continui dolori l’accompagnano
per tutta la vita. Subisce 32 operazioni chirurgiche. Nel ’44 deve indossare un
busto d’acciaio. Inizia un diario
personale dove si mescolano immagini e scrittura. Le difficoltà del suo corpo,
le sue aspirazioni, le sue paure diventano un mescolanza creativa.
Tralascio i due
matrimoni con il protettivo ma incostante Diego Rivera, l’incontro con Andrè
Breton, la prossimità con Lev Trotsky e Tina Modotti. Dall’Europa disastrata
vanno e vengono artisti e intellettuali.
Sulla nuda schiena la ferita sanguina. Anche la terra è nuda, spaccata, ferita. Con una mano Frida tiene il busto, ma con l’altra, al contrario, un proponimento: “L’albero della speranza ti mantiene stabile”,1946. Nel 1951 inizia ad usare la sedia a rotelle. Accentua la sua identità messicana nel vistoso vestiario tradizionale Tehuana e negli sfarfallanti copricapo. Il velo bianco è ancora più scenografico.
Sulla nuda schiena la ferita sanguina. Anche la terra è nuda, spaccata, ferita. Con una mano Frida tiene il busto, ma con l’altra, al contrario, un proponimento: “L’albero della speranza ti mantiene saldo”,1946. Nel 1951 inizia ad usare la sedia a rotelle. Accentua la sua identità messicana nel vistoso vestiario tradizionale Tehuana e negli sfarfallanti copricapo. Il velo bianco è ancora più scenografico.
Sulla fronte il viso dell’amato Diego Rivera. Il
suo volto, incorniciato da fiori, plisettature, scialli, una fastosa
ambientazione, è volutamente ambiguo: le soppraciglie esagerate e la pelosità
su e sotto le labbra indicano un cenno di mascolinità, una voluta ambiguità sessuale. Dalla testa escono
filamenti elettrici, sensi prensili, collegamenti
misteriosi. I suoi travestimenti, i gioielli, le ferite del suo corpo martoriato, la
ripetizione del viso, sono il segno doloroso del suo essere sé e fuori di sé,
del suo amore tradito e traditore, della ambiguità tra uno specchio che la
restituisce sempre a se stessa, e i contrasti, i dolori che la rompono, la
interrompono, la collegano dolorosamente alla terrestre e fragile totalità, che
però ritorna sul proprio sguardo, interno ed esterno, sulla sua complessa soggettività.
Forse che questo è ‘un mito’ che
nasconderebbe, oscurerebbe la sua capacità pittorica? “Una leggenda che si è
creata attorno alla vita…servita
solo a offuscare l’effettiva conoscenza della sua poetica”? Forse le sue capacità di vestirsi, di truccarsi, di
protestare (si iscrive al partito comunista), di soffrire si possono separare
dal suo ritrovarsi nello specchio, dal ripetere, dipingendosi, le proprie
sembianze, dal riconoscersi sempre e ancora, esserci nella gioia e nella
sofferenza? Non per riprendere con la pittura un soggetto qualsiasi, non per
adeguarsi ad una moda diffusa, fosse pure il ‘Surrealismo’.”Ho dipinto la mia
propria realtà” scrive. “Un colore biologico” scrive M. Cristina Secci. La sua
pittura non si separa dalla sua ‘vita’, la sua propria realtà. La forza della
sua pittura è parte della sua difficile sopravvivenza. L’ambiguità in
quell’abbraccio universale del ’43 (vedi 1° immagine): il petto squarciato, lo
scuro, la notte, da un lato, e il chiaro, la luce, dall’altro, la veste Tehuana, in braccio Diego, il grande
infante che, con l’occhio in fronte, vede lontano.
E ancora soffrirà al termine della sua
giovane vita, con l’amputazione della gamba destra e l’embolia polmonare che la
condurrà alla morte nel 1954 a 47 anni. La salma viene esposta al Palacio de
Bellas Artes coperta dalla bandiera rossa comunista.
Un’ultima sorprendente ambiguità:
“Spero che la fine sia gioiosa e spero di non tornare mai più”.
febbraio 2018
***
CUNO AMIET A
MENDRISIO
Cuno Amiet e la moglie
Tra fine Ottocento e primi Novecento lampi di luci e
fantasie simboliste attraversano anche un piccolo e ricco paese, ricco anche
linguisticamente come la Svizzera. Al Museo
d’arte di Mendrisio, sino al 28 di gennaio, è la volta di Cuno Amiet (Solothurn 1868), amico della famiglia Giacometti e del più anziano Ferdinand Hodler (Berna
1853). I punti di riferimento sono Pont Aven in Bretagna, da dove Gaugin era
già partito per Tahiti, e, più tardi, i tedeschi del ‘Die Brücke a cui si aggiunge la
lettura de ‘Lo spirituale nell’arte’
di Kandinskij che lo invita ad un rinnovato rapporto tra colori e musica.
Rapporti, connessioni e significati.
La raccolta delle mele 1907
L’immagine degli alberi e delle figurine è doppiamente stilizzata, nelle forme, la rotondità degli
alberi, il tronco azzurro dei tronchi, l’ingenuità delle figurine, i mucchi
delle mele, e nei colori, la punteggiatura astratta.
Tarda estate in Oschwand 1952
Sia le forme dei tronchi e dei rami, che i colori punteggiati
dei cespugli e del fogliame hanno una allegra libertà di movimento e accostamento.
Quasi un omaggio a Monet e a Signac.
Paradiso 1894-95
Un Paradiso, non un peccato. Da Eva, che offre la mela ad
Adamo, quasi un dono desiderato, sembra crescere il tronco dell’albero del bene
(e del male), dal quale si sporge il serpente. Intorno i prati fioriscono e il
cigno apre le ali al volo. Manca qualsiasi segno di minaccia e di trasgressione.
Paradiso 1958
Tra il primo precedente Paradiso, anche un omaggio alla
amatissima moglie Anna, morta nel ’51, e l’ultimo Paradiso dell’anziano pittore,
le differenze sono evidenti. Ora, in questo sogno luminoso, i contorni sono
svaniti, nella leggerezza delle sfumature le figure sono appena riconoscibili: non il grande albero ma le protettive ali
dell’angelo. C’è un fremito e una
speranza.
L’immagine è sempre il risultato di unità e divisioni. L’insieme
è pure un rimando, una alterità, un racconto. Mi sembra che pur nella voluta indipendenza
delle unità, delle note, dei punti colorati, Cuno Amiet non abbia mai
rinunciato ai racconti, alle storie.
Gli uni e gli altri, gli uni con gli altri ci hanno
affascinato.
gennaio 2018
***
I GESSI DELLA
PRODUZIONE LENCI
Termini come decorazione,
eleganza indicano qualcosa di piacevole, sovente in molti esemplari, per
molti dunque, ad un livello meno impegnativo di ciò che pretende la più seriosa,
costosa e unica opera d’arte. Ne
avevo già accennato su ‘La necessità
dell’ornamento’. L’Arte con l’A maiuscola da una parte e l’artisticità
diffusa dall’altra. Si tratta di realtà diverse: esemplari unici o invece moltiplicabili,
forme estese o ridotte , immobili o mobili, cattedrali, grandi pareti
o anelli, spille, collane, vestiti. Come ogni distinzione, sono
differenze di comodo, che certo non distinguono valori e qualità. E ora giungo
al nostro argomento: le sculture dei
gessi non sono prodotti per la vendita, ma modelli che si perderanno nella
cottura e colorazione delle ‘ceramiche’: un gesso per molte ceramiche. Ecco
perchè ‘Prima delle ceramiche’, come
si intitola la mostra ‘i
gessi dell’archivio Lenci’, 40 pezzi scelti tra i 1122 della collezione Vaccarino-Listro, esposti
sino al 4 febbraio al Museo della
Ceramica di Mondovì.Gli autori
sono i pittori piemontesi degli anni ’20, Mario Sturani, Gigi Chessa, Felice
Tosalli, Giovanni e Ines Grandi. Sculture d’arredo, come si diceva, di largo
consumo, busti, figure, fermalibri, centri tavola, candelieri, “stile Lenci”, meglio
si potrebbe dire “gusto Lenci”, una garanzia di qualità piuttosto che un modo
uniforme di scultura.
Giovanni Grande, Il
trionfo di Bacco
Mario Sturani, Scalata
alle stelle




Anche a casa nostra un
bianco San Sebastiano serve da fermalibri. Utilità ed eleganza. Una
modernità discreta, facilmente raggiungibile e accettabile, come dimostra il
suo largo successo, estranea alle polemica delle avanguardie, ma pure
svincolata da vecchie abitudini ripetitive, curata nella sua veste artigianale,
allegra e libera nella sua fantasiosa creatività. Un gusto discretamente
diffuso nel quale una borghesia in crescita s’incontrò felicemente con una
offerta raffinata, capace di soddisfare esigenze molteplici e diverse senza
scadere nell’ovvio della ripetizione.
gennaio 2018
***
Alla Farnesina, Roma,
Ministero Affari Esteri,
MEDITERRANEO
40 scatti di
MIMMO JODICE
La mostra sarà ospitata nell’anno in corso 2018 presso gli Istituti Italiani di Cultura che
operano nell’area Mediterranea a partire dall’Eretz Museum di Tel Aviv. Con il
doppio delle opere la mostra era stata organizzata nel 2016 al Mart di Rovereto.
Raramente mi sono occupato di mostre fotografiche senza una
particolare ragione che non sia la mia scarsa conoscenza di un mondo
sconfinato, declinato in mille modi diversi e spesso opposti. Ho provato con
queste immagini di Mimmo Jodice, rigidamente in bianco e nero, con tagli
sapienti di ombre e luci: resti monchi, muri scrostati, finestre vuote e silenzio, tanto silenzio. Una inquietudine
tra una irrimediabile lontananza e, al contrario, un senso di ambigua
appartenenza: acque immobili, pietre corrose, ma pure gesti, sguardi, richiami, però incompleti, monchi, residuali. Soggetto e modo di inquadrarlo e poi
stamparlo, il compito del fotografo, la voluta mancanza dei colori, il
confrontarsi con una realtà già morta, ingoiata nel tempo - anche il tempo di
un mare di scogli - ma ancora ricca di attese, in paziente aspettazione di un
riconoscimento. Frammenti, un viso, un braccio, un muro, un’ombra, cosa vedi,
cosa senti, cosa ricordi, cosa sogni .
Frammento di scultura romana, Museo Archeologico, Sperlonga (Latina)
Scultura bronzea romana da
Ercolano, Museo Archeologico Nazionale, Napoli
LAMPI DI
MATERIA
Così
s’intitola, Lampi di Materia,
l’azione mimico-musicale di Rosalba Quindici svoltasi il 29 dic. 2017al Museo
di Capodimonte, Napoli, sala BURRI, dove è esposto il Grande Cretto nero. Ed è proprio alle opere di questo tipo che
vorrei imbastire qualche osservazione.
Alberto Burri si era laureato in medicina che aveva continuato a
praticare come cura dei soldati malati anche nel periodo di prigionia, 1943-44,
durante la guerra, prima in Africa e poi negli USA, per poi dedicarsi alla
pittura. La sua prima mostra a Roma risale al 1947. Vorrei sottolineare una
analogia tra il medico che si occupa di una realtà esterna, autonoma, il corpo
del malato e ‘la materia’ di cui
Burri artista sollecita la forza, il respiro, la mutabilità.
Al calore del fuoco la materia plastica si muove, si raggrinza,
si buca, si gonfia. Non ferite, dolori, ma respiri, passaggi, mondi, nuove galassie.
E il cretto è la terra argillosa e umida, scura o chiara, che si
secca e seccandosi si crepa suggerendo percorsi e profondità. La mano
dell’artista prepara il materiale che poi si modifica per proprio conto.
Un medico cura una malattia, una
mancanza, un artista scopre un percorso, una forza, una capacità. Un gesto
simile e insieme opposto: simile, non una soggettività, ma una alterità, non se
stesso ma un corpo estraneo; diverso, non una negatività, un dolore da
estirpare, ma una positività, nuove forme da liberare, un respiro autonomo, strade
impreviste, un di più.
Questi sono le osservazioni
in base alle quali il Grande Cretto di Gibellina, il paese siciliano distrutto
nel 1968 dal terremoto e ricoperto da forme ‘costruite’ a somiglianza di un
vero cretto (pur firmato dall’artista sarà terminato nel 2015 dopo la sua morte avvenuta vent’anni prima!), ritorna al consueto
intervento ‘artistico’, una
rappresentazione, una ricostruzione tutta umana, non quel gesto, quella
sollecitazione del primo i Burri che aveva stimolato la materia in se stessa, liberandone la forza e la imprevedibilità.
gennaio
2018
***
ARCIMBOLDO
Faccio seguito a quanto già stampato nell’annuncio qui sopra
riprodotto.
La mostra, organizzata a Roma dalle Gallerie Nazionali di
Arte Antica e da Mondo Mostre Skira, con relativo catalogo, a cura di Sylvia
Ferino-Pagden, ripropone uno dei personaggi più popolari della storia
dell’arte, riscoperto, dopo una lunga
dimenticanza, negli anni Trenta del Novecento, il milanese Giuseppe Arcimboldi - rimasto con la finale in o, Arcimboldo - (1526-1593).
Non sto a riprendere le vicende biografiche e neppure le varie
attività intraprese dal pittore a Milano, nella prima metà del 1500. L’ambiente
è vario e vivace: l’eredità delle caricature leonardesche, l’Accademia dei facchini, i Rabish
in dialetto facchinesco, di Paolo
Lomazzo (ammiratore dell’Arcimboldo), gli interessi per la natura, nella misura
cosmica e nel particolare minimo, la coltivazione del fantastico, il piacere
delle feste, la regola e l’eccezione … e la fondamentale attività di questo
ARCIartista presso gli Absburgo di Monaco,Vienna e Praga dal ’62 in poi.
Vorrei rimanere ai profili, alle teste ‘composte’ da frutta,
fiori, foglie, tuberi, verdure e animali ( anche ferri di guerra per il ‘fuoco’)
in coppia con le differenti stagioni, Primavera/Aria,
Estate/Fuoco, Autunno/Terra, Inverno/ Acqua:
Terra Autunno
Già negli accoppiamenti l’Arcimboldo lavora sulle
corrispondenze, come Galeno con i ‘temperamenti’e gli alchimisti con i legami tra
i singoli elementi e gli influssi cosmici . Le corrispondenze devono chiudersi
all’interno di una totalità definita. La nostra percezione si muove per punti,
già partendo da alcuni presupposti: il
profilo di un viso. Però l’occhio è continuamente preso dai numerosi
depistaggi, eseguiti con acuta precisione.
Occorre passare dal singolo particolare che indica un punto
riconoscibile e passeggiare con la vista qui e là, per raggiungere il significato
della totalità, o al contrario, un’idea generica della totalità, tutto il viso,
e un’analisi divertita sui singoli particolari, oppure i due movimenti insieme.
Alcune scoperte più facili, i fiori, la Primavera, altre più difficili, i
volatili, l’Aria. Risultato: una
confusione intrigante, uno stupore, una conquista, una soddisfazione.
L'ortolano Verdura (L'ortolano capovolto)
Un’altra sorpresa: basta capovolgere un’immagine e compare
un'altra scena. Non è solo un divertente gioco di prestigio ma una connessione
paradossale e significante. Gli oggetti fatti di più parti sono come un mondo: stabiliti
i punti di partenza, tutto si richiama, tutto ha un senso, come pure affermano
e dimostrano le discipline ‘scientifiche’ e le collezioni di rarità proprie
delle Wundernkammern care a Rodolfo
II d’Auburgo, qui effigiato nel 1591dall’Arcimboldo nelle vesti fruttiformi di
Vertunno, dio delle stagioni e delle metamorfosi. L’aspetto paffutello, allegro
è forse un buon augurio di una vita difficile dell’imperatore, terminata in
tragedia.
Alla morte dell’artista a Milano, fine ‘500, l’ambiente
stava cambiando velocemente. Il potere spagnolo e la onnipresente devozione
religiosa di Carlo Borromeo cancellano
quella pluralità creativa che aveva caratterizzato il passato. Il nome
dell’Arcimboldo scompare, ma il divertimento, la scommessa, la sorpresa di
mescolare dentro l’immagine nobile per eccellenza, quella del viso umano, altre
e diversissime figure, anche scurrili, si ripresenta nei più diversi tempi,
tecniche e contesti. E qui mi sposto non solo nel tempo, ma anche in un Paese
rimasto a lungo separato dall’Europa, il Giappone ottocentesco, di cui mi sono
già occupato in questa stessa rubrica, là dove la censura colpiva sovente la
rappresentazione del nudo. L’artista è Utagawa Kunijoshhi: La donna porta
capelli/chimoni, viso/nudi, mano/gambe; il vecchio, composto di nudi,
accompagna il titolo “Fa paura, ma è davvero una brava persona”. Se queste
immagini siano a seguito di stampe di origine europea, non è stato possibile
documentare.
VISO - VISTO - VIA, il passaggio dall’esterno al mondo
interiore e viceversa, un transito, una mescolanza, una vibrazione, un segreto,
una scoperta. L’Arci m boldo è stato
una guida preziosa.
dicembre 2017
***
Solo un
pensiero sull’ultimo Caravaggio: realismo?
Il
quadro del Caravaggio1610, uno degli ultimi, esposto a Milano alle Gallerie
d’Italia, fa uscire dal buio cinque personaggi, uno di fianco, con elmo e
corazza, uno dietro con la bocca aperta, forse l’autore, un altro soldato al
centro, mezzo in ombra, guarda di traverso, al lato sinistro il militare con
ricca corazza, gialli scintillanti, l’arco teso, ma a sfiorare il mantello
della vittima senza la distanza per ‘il tiro’ (non sarebbe stato nello spazio
ristretto) e un’espressione non si capisce se di rabbia o rincrescimento (lo
stesso soggetto di B. Strozzi, di alcuni
anni più tardo, pure nella stessa esposizione, il soldato, di fianco, tiene
l’arco con un’unica mano e guarda la santa con una bella freccia in mezzo al
petto); in mezzo la santa, Sant’Orsola, , che
osserva calma, con curiosità la punta che si è infilata nel proprio seno. La
dimensione del quadro richiede il taglio del gruppo, l’assembramento, la
mancanza di spazio tra i personaggi, gli armati, il profilo forse del pittore
che riprende il precedente del 1602, ben otto anni prima, nella ‘Cattura di Cristo’. E’ difficile pensare
ad un insieme più irrealistico, un teatrino che racchiuda, avvicinate, tutte le
figure necessarie, una scena
realizzata con cura, dagli intensi colpi di luce immersi nel buio più profondo:
quasi apparizioni, ciascuno per conto suo, coi propri gesti, bocche, sguardi, dettagli, usciti dal nulla, al
comando del direttore. Non un dolore, non un sacrificio. Piuttosto pose
individualmente studiate, lasciando all’osservatore la interpretazione del
tutto, meglio, le interpretazioni, gli interrogativi, le curiosità.
dicembre 2017
***
ACHILLE CALZI, la necessità dell’ornamento
“Tra Simbolismo e
Liberty: Achille Calzi” al Museo Internazionale delle Ceramiche in
Faenza (MIC), dal 5 novembre 2017 al 18 febbraio del 2018, giunge a conclusione
un lungo lavoro di ricerca condotto da Ilaria Piazza, avviato dal fondo donato
dagli eredi dell'artista.
Nel periodo, quello tra fine ottocento e primi novecento, il
termine ‘Simbolismo’ si riferisce prevalentemente alla scrittura e Liberty (Art
Nouveau, Jugenstil , Secessionstil,) agli oggetti e all’architettura. Nel
dopoguerra, dal ’45, questo ‘Liberty’ aveva
assunto un significato confuso, confondendosi con il cattivo gusto ‘floreale’,
esagerazione decorativa, variazione puramente di superficie (=superficialità),
roba di nonne e uncinetti, a cui
contrapporre i valori strutturali, la semplicità delle superfici e degli
ambienti, la ‘modernità’, a sua volta compromessa però con le affrettate
costruzioni postbelliche, rimpiazzi svelti delle distruzioni precedenti, spesso
connesse ad una selvaggia corsa speculativa. Da qui, negli anni ’50, un
ripensamento aggiornato del passato, una specie di ‘neoliberty’ a Torino per
esempio (Gabetti e Isola), a Milano(Studio BBPR), la rivista Casabella-Continuità
ecc.
Rientra in questa più attenta lettura della storia la
ripresa di una figura come quella di Achille Calzi, 1873-1919, la cui
complessità, conoscenze e larghezza di
interventi si dimostra un buon esempio anche nel lungo periodo.
Leggo dalla presentazione:"Calzi
incarna la moderna figura dell’artista progettista, facendosi interprete del
principio modernista dell’arte in tutto, attraverso le numerose
collaborazioni con le principali manifatture faentine attive nei settori della
ceramica, dell’ebanisteria e dei ferri battuti e nell’impegno profuso nel campo
della grafica. A questo si aggiunge la multiforme ricerca nelle arti
figurative, dalla decorazione al 'bianco e nero', dalla pittura da cavalletto
alla caricatura, dove recepisce alcune delle più avanzate tendenze artistiche
nazionali e internazionali. Se da un lato le visioni macabre, intrise di
suggestioni misteriosofiche ed esoteriche, segnano l'adesione al Simbolismo,
dall'altro il suo linguaggio pittorico accoglie sperimentazioni d’impronta
divisionista". Discendente da una antica famiglia di vasai faentini,
sviluppa le sue conoscenze e pratiche attività in una molteplicità di settori: pittore,
caricaturista,
Eppure muore a 46 anni ucciso dal virus della spagnola.
La figura femminile è prevalente sia come parte della natura, foglie e acqua, sia in versione angelica (nella ceramica),
sia nelle due immagini notturne di tentatrice, strega, misteriosa e serpentina:
Nella ceramica sono le forme animalesche volatili a prevalere. Il dramma è contenuto nel ritmo, nella danza.
Un mondo composito nel quale animalità visionaria, anche quella umana, e lussureggiante vegetazione si intrecciano, si incastrano, sibilano, volteggiano: colpi d‘invenzione che sorprendono e arricchiscono la nostre capacità percettive. L’ornamento non è una aggiunta ma una necessità.
dicembre 2017
***
DAI BEATLES A
WOODSTOCK
La mostra REVOLUTION
, già presentata a Londra, ora a Milano alla ‘Fabbrica del vapore’, dal 2
dicembre 2017 al 4 aprile 2018, accompagnata da un volume di SKIRA, porta una
citazione dei Beatles del 1968: “You say you want a revolution. Well, you know,We all want to change the world”. Noi
siamo abituati a pensare la Rivoluzione come un fatto collettivo di armi e di armati,
di politici, di molti morti, uno scontro
tra contrapposti gruppi di potere, di vincitori e vinti. Qui la Revolution è
un’altra faccenda: quattro anni, dal ’63 al ’68, uno scontro di generazioni,
una controcultura che investe il modo di (s)vestirsi, la minigonna femminile
inventata da Mary Quant e i capelli lunghi maschili, nuovi selvaggi, il nudo
liberato, la sessualità trionfante, la
droga, la musica, i grandi raduni
giovanili, dalla londinese Carnaby
Street agli hippy di Haight-Ashbury, all’isola di Wight, al festival americano
di Woodstock, al maggio francese. Swinging London, San Francisco
passando per New York (e un salto a Parigi). Anche in Italia gli studenti sono
i primi a raccogliere la spinta libertaria nata nei paesi anglosassoni. La
vecchia famiglia scompare, i figli, i giovani figli, autonomi, spavaldi, anche provocatori, saranno d’ora in poi
un’altra cosa.
No,
non è tutta una festa, il mondo è complicato. Il presentatore Alberto Tonti
ricorda “la morte di Papa Giovanni,
l'assassinio di JF Kennedy, la guerra del Vietnam e l'uccisione di Che
Guevara.” L'uccisore di Kennedy, o il mandante, rimarrà sconosciuto. Non roba da poco.
Ma anche il « Che » diventa una bandiera dei
giovani, insieme a Mao Tse Tung (!), Martin Luther King, Malcom X. C’era
bisogno di bandiere, di simboli, di slogan, di riunioni, di assemblee. E la
musica, quanta musica! anche quella orientale. Per restituire il senso di
quegli ambienti la mostra accumula manifesti, fotografie, manichini,
proiezioni, colpi di luce e ti accompagna con suoni, canzoni, voci, tutto
registrato ad alto volume, “un giro emozionante su una sorta di ottovolante -
leggo nella presentazione – storditi da segni, colori, suoni, immagini,
memorabilia”.
Le parole, qui, non
servono più. La mostra è un insieme di passaggi sonori e colorati,
un’esperienza.
dicembre 2017
***
Felice Casorati “Gli
scolari”
UN REALISMO QUASI MAGICO
Al Mart di Rovereto Il titolo della mostra, ‘REALISMO MAGICO - L’INCANTO NELLA PITTURA
ITALIANA DEGLI ANNI VNTI E TRENTA’ (3 dicembre 2017-2 aprile 2018), indica
una affascinante contraddizione tra magia e realtà. Riprendo dalla
presentazione:” Nel difficile clima del primo, aspro dopoguerra, gli artisti
europei si confrontano con le proprie disillusioni e con un rinnovato ma non
semplice contesto. Dopo il dinamismo delle Avanguatdie storiche, tra gli anni
Venti e gli anni Trenta, si impone una tendenza artistica segnata dal recupero
della tradizione pittorica e scultorea, ma allo stesso tempo erede delle
ricerche sepolte dal conflitto”. Viene citato Maurizio Fagiolo dell’Arco degli
anni ’80: “L’ansia dei cubismi e dei fauvismi, dei futurismi e degli
espressionismi si è tramutata in una effettiva angoscia esistenziale. Ora si
tratta di scavare nelle macerie, di fermarsi un momento, di cercare qualche
punto di riferimento”. La difficoltà delle vicinanze e lontananze in una
definizione suggestiva che mescola la durezza di una pesante realtà con
l’ineffabile cenno alla misteriosa, sfuggente magia, sta pure in una varia
collocazione degli artisti di quel periodo, figure di lungo tragitto e di forte
carattere, come Sironi, De Chirico, Savinio, il ”Novecento” di Margherita
Sarfatti, grandi isolati come Morandi, una fascia di mezzo come Casorati,
Severini, Carrà, Mafai, De Pisis, Carlo Levi, e infine la quotidianità incantata dei Donghi, Oppi,
Cagnaccio di San Pietro. La mostra si concentra sulla fascia di mezzo e sul
terzo gruppo.
Casorati dunque, a Torino nel 1918, “dove – scrive – ho potuto trovare la mia casa”, dopo una lunga permanenza a Verona , già attivo partecipante a importanti mostre a Venezia e a Roma (e soffre pure per il suicidio del padre). “Gli scolari” del 1927-28 sono un campionario di altezze, di pettinature e di sguardi. Gli oggetti, il libro aperto, il righello, il mappamondo, la tovaglia, i segni geometrici sulla pagina e sulla lavagna, le piastrelle del pavimento hanno tutte una limpida definizione, ma i piani sono sfalsati: mentre le figure sono frontali, l’ambiente invece è visto dall’alto, corre altrove, gli spazi, congelati, si contraddicono nel silenzio e nella immobilità. Tutto è evidente come è evidente l’artificialità: l’insieme sfugge, l’inquietudine si espande nel silenzio.
Casorati dunque, a Torino nel 1918, “dove – scrive – ho potuto trovare la mia casa”, dopo una lunga permanenza a Verona , già attivo partecipante a importanti mostre a Venezia e a Roma (e soffre pure per il suicidio del padre). “Gli scolari” del 1927-28 sono un campionario di altezze, di pettinature e di sguardi. Gli oggetti, il libro aperto, il righello, il mappamondo, la tovaglia, i segni geometrici sulla pagina e sulla lavagna, le piastrelle del pavimento hanno tutte una limpida definizione, ma i piani sono sfalsati: mentre le figure sono frontali, l’ambiente invece è visto dall’alto, corre altrove, gli spazi, congelati, si contraddicono nel silenzio e nella immobilità. Tutto è evidente come è evidente l’artificialità: l’insieme sfugge, l’inquietudine si espande nel silenzio.
In “Beethoven”
dello stesso periodo, si presentano gli stessi caratteri con l’aggiunta dello
specchio e così la molteplicazione degli spazi: le figura, ragazza (fronte e
schiena) e cane, sono frontali, gli spazi, spezzati dallo specchio, sono
rappresentati dall’alto. Il riferimento a Beethoven indica anche la vicinanza
dell’artista alla musica: Casorati, nel suo studio, interrompeva la pittura e
il rapporto con gli allievi con frequenti suonate al pianoforte.
Torno al 1919 con “Le
figlie di Loth” di un Carrà che,
abbandonato il periodo “metafisico” ritorna all’ordine a modo suo. Il racconto biblico delle due sorelle e del
vecchio padre è solo il pretesto di un titolo. Un soggetto che riprenderà anche in seguito. Si
tratta di un teatrino appena infantilizzato nel ricordo di un ingenuo, sognato
trecentismo giottesco. L’ambiente, le montagnole, i verdi ciuffetti, la
prospettiva, le figure sono volutamente artificiali e incongrue. Sorpresa e
simpatia.
Dalla simpatia della ingenuità colta al realismo stralunato
di Cagnaccio di San Pietro. “Ritratto della signora Wighi” 1930-36. Vestito
spieghettato, giocattolini, poltrona,
capelli, occhi preoccupati, cuscini variopinti, tutto luccica sinistramente,
tutto è artificiale, tutto è materia plastica o qualcosa di simile. Un gioco
sinistro.
Del romano Antonio
Donghi è nota la divertita ironia in una compassata, attenta esecuzione. In
“Battesimo” del 1930 la scala degli sguardi
(come ne ‘Gli scolari’ di Casorati) e la posizione dell’infante accompagna la disposizione
delle figure: occhi a destra, sinistra, semichiusi, di nuovo a destra. Seguono in
basso la rotazione delle scarpe. La compattezza dei personaggi si stacca dal
vuoto dello sfondo. Tutti muti, diritti, immobili sembrano attendere il flash
della fotografia.
E, da ultimo, forse una delle più note figure del suo
teatro, “Il giocoliere” del 1936. Farfallina
al collo, vestito impeccabile, maniche arrotolate per seguire meglio gli eventuali
movimenti del cappello: di profilo, immobile sul palco, incanta con la sua
capacità di tenere in equilibrio in un punto, sul bastoncino infilato in una
rossa boccuccia, un bel cilindro nero (come i capelli dell’equilibrista) che la
mano destra è pronta a accogliere. Unica presenza un tavolino a tre gambe sul
quale si appoggia un vaso con quattro fiori. Equilibrio pressochè impossibile
del cappello, accertato invece perentoriamente dalla sicurezza della
rappresentazione. Luogo chiuso, Silenzio, vuoto, paradosso. Nessuna tragedia,
nessun tempo.
Questo ‘Realismo
magico’ era anche un modo, un suo modo per escludere i difficili problemi
che si erano aperti con l’avvento della dittatura fascista. Dopo i fuochi
d’artificio delle Avanguadie e il potere successivo, non solo in Italia, delle
dittature, una musica da camera (Casorati) e la freschezza infatilizzante
potevano costituire uno spazio di sicurezza estraneo ai pesanti comandi della
‘politica’.
Questi pochi cenni ad una Mostra naturalmente ben più
esauriente, introducono ad alcuni aspetti sovente trascurati di un periodo che,
seppure politicamente difficile, si è dimostrato ricco di risultati artistici
sia nella fase torinese sia in quella milanese della Sarfatti, sia nel periodo
romano.
[dicembre 2017]
***
SALVATORE GREGORIETTI MEZZO SECOLO DI PROGETTI
Tra i vetri
trasparenti e riflettenti del nuovo Centro Culturale Feltrinelli è stato
presentato il volum(on)e di 448 pagine, bilingue (italiano-inglese), SKIRA
editore, sulla molteplice attività di designer Salvatore Gregorietti, mai solo
su di un lavoro complesso e di per sè multidisciplinare, e così, in fila, con
un pizzico di autoironia, si presenta l’Autore:
Con una penna particolare, dall’interno, col sorriso, ne
scrive una sua collaboratrice, presente anche in questa pubblicazione dei cinquantanni, Lucia Mosca Vecchia,
Student’s Last Name:
“La relazione tra “art” e “copy” in
pubblicità è paragonabile a quella tra
Musicista e paroliere. Con la
complicazione che i temi non si possono scegliere
e spesso i contenuti dell’oggetto da
comunicare non contengono motivi di
ispirazione.
Ma il risultato dev'essere una
comunicazione attraente e immediatamente
seduttiva.
Cosa si fa? Si parla e si fanno segni su
un foglio bianco. Si traccheggia, si
fuma, si dicono cazzate e si spera che
scatti qualcosa. È un momento critico
che può portare alla depressione.
Si avvilisce il copy quando si accorge
che la parola trovata con tanta pena
diventa un segno quasi decorativo, e che
per motivi di simmetria si accorcia
una frase felice.
Salvatore rispetta le parole. Perché le
conosce. Il suo linguaggio è sempre
essenziale e pulito, dove forma e
sostanza coincidono senza sbavature. Se
Salvatore suggerisce un taglio non è per
salvare l’equilibrio grafico, ma per
aggiungere efficacia.
È un uomo silenzioso, Salvatore
Gregorietti, che non spreca le parole.
……….
Non ricordo di averlo mai visto in
divisa da pubblicitario (jeans, camicia bianca
e blazer blu). E nemmeno in divisa da
rivoluzionario (eskimo e sciarpona
arrotolata) . Ma Salvatore Gregorietti
in mantella nera e cappello a larghe tese
a cavallo del suo Solex era una presenza
ironica e elegantissima.
Non gli conosco molte giacche, eppure le
ha, ma le tratta come pullover.
Chissà se ha uno smoking? (gli starebbe
benissimo)
Gli attribuisco colori grigioverde o
celestini fané. E senza dubbio scarpe
inglesi.
…………………..
A dire la verità qualche volta fa paura.
Quando tace e l’occhio gli parte
lontano. In quello spazio vuoto è facile
infilare sciocchezze.
O quando ridacchia per gentilezza. Ma il
massimo del terrore l’ho sempre
provato con lui in autostrada. L’occhio
celeste diventa di ghiaccio e non
vorresti mai essere quello che gli sta davanti.
***
Anche se non è proprio il suo mestiere,
anche se non aveva tempo, anche se
l'argomento non conteneva particolari
stimoli professionali, Salvatore ha
disegnato la mia casa. E poi è venuto a
indicare la posizione delle prese
elettriche e la posa della beola in
bagno. Ha più dirent’anni, la mia casa. E se
non si è sformata sotto i colpi del mio
disordine è solo perché poggia
sull’impianto solido, elegante e
razionale che Salvatore Gregorietti dà a tutto
quello che fa.”
L’esperienza viva, ravvicinata di Lucia Mosca introduce il mio
‘racconto’, il fatto che
il padre palermitano Guido è chiamato a Milano per dirigere il Museo Poldi
Pezzoli nel 1947 - il figlio Salvatore ha sei anni – e che nella presente
pubblicazione il figlio adulto termini proprio con la cura grafica dello stesso
Museo. E Milano diventa il luogo definitivo della sua vita e attività, una
città che nel dopoguerra svolge in Italia una funzione di guida nel settore
della editoria e, più in generale, della modernizzazione tecnico-industriale. Nel
’60, Terminato il Liceo artistico di Brera, Salvatore si reca a Zurigo come
studente della Kunstgewerbeschule,
erede della tradizione Bauhaus, forme geometriche semplici, impersonalità,
antidecorativismo: Max Bill è il nome più noto. Vi incontra i giovani Oliviero
Toscani e Antonio Tabet, amici e collaboratori futuri. Nel 1965, assistente
nello studio di Massimo Vignelli, disegna la copertina di Linus:
L’ideatore
della rivista Linus è il marito di Annamaria Gregorietti, sorella di
Salvatore e fondatrice del negozio Milano Libri. Il giro di parenti e
amici impegnati nello stesso lavoro o in campi attigui facilita le
collaborazioni, indispensabile in un lavoro di gruppo. Il grafico-designer è
simile al regista, deve guidare un insieme di fatti diversi: la forma delle
lettere, le immagini e la loro disposizione, i marchi, gli spazi, i manifesti, i
cataloghi, il packaging, le vetrine… Nel ’64 lavora per la Rinascente: usa la
fotografia in tutta pagina, l’alterazione del colore e delle forme.
Considerando
l’importanza delle ‘lettere’ ho scelto, tra i numerosi esempi, tre tipi, uno
lineare, il secondo lineare-inventivo (marchio), il terzo, anche perché in copertina,
più libero e inventivo:
logotipo Istituto Bancario S. Paolo, Torino ‘79
Non sto a seguire Gregorietti in tuttte le sue molte
tappe e risultati, come, con i Vignelli e i Noorda (entrambi in coppia, mariti
e mogli), la ‘Unimark International’, anche se il centro operativo è sempre
stato Milano. Vorrei sottolineare due tappe, l’insegnamento e l’editoria.
Nel 1970-80
è invitato all’Accademia di Belle Arti di Carrara per un corso di Aspetti
propedeutici, storici ed economici della progettazione. Perché venga istituito
un corso di laurea universitario autonomo dedicato al Disegno industriale
occorre attendere il 1993 presso il Politecnico di Milano. Si trattava di
ridurre ogni vaghezza di artisticità che
invece stranamente e per fortuna rimaneva
parte del bagaglio del nostro grafico. Salvatore partecipa al Movimento
studentesco, scrive su Abitare, Ottagono, Casa Vogue, Furniture design.
Altra
attività frequente la collaborazione con le mostre e le Case editrici quali
Einaudi, Adelphi, Boringhieri, Feltrinelli, Sellerio, Franco Maria Ricci, et al.
/ EDIZIONI.
Dopo titoli
specifici come “Colore, libri-manifesto e collane editoriali” il numeroso e
stipato materiale, prevalentemente
librario, è organizzo per date decennali dal 1960 al 2010. Avrei incontrato
volentieri qualche immagine grande, a tutta pagina, un respiro. Ma vorrei anche
pensare ai cambiamenti, dagli anni sessanta ad oggi. Leggo l’incipit di P.
Interdonato su ‘La copertina di Linus’:
“L’edicola è, per il giornalaio, il centro del mondo. Da quel punto controlla
tutto: vede le novità editoriali, sente l’odore della politica internazionale,
tocca le mode e i costumi del paese… Nelle edicole sono apparse riviste
meravigliose capaci di raccontare il senso del mondo… sono dei luoghi
meravigliosi che riforniscono gli acquirenti di osservatori cartacei del mondo…
di accompagnare le modifiche della società nel momento stesso del loro
accadere” (p. 39). Ripassiamo da un’edicola oggi. Molte sono scomparse. I pochi
acquirenti sono persone di mezza età, comprano i programmi TV, guardano senza
curiosità libri esposti a prezzi
ribassati… Il mondo è cambiato, l’edicola di allora è scomparsa. E deve essere
cambiato anche il mondo del lettore, del grafico, del designer, dell’art
director. I cinquant’anni di Gregorietti sono anche la storia complessa di
questo cambiamento. Chiudo come avevo
cominciato, con l’ultimo lavoro grafico riprodotto nei ‘cinquant’anni, ‘Le dame del Pollaiolo’: che siano di buon auspicio
di un presente incerto.
novembre 2017
***
INDIA TRA VICINANZA E LONTANANZA
Due mostre:
quella della quale ho fatto già un pezzino, una piccola mostra, un flash
illuminante,“Memoria napoletana”, quindici opere di Lista, presentazione
affettuosa di Rosa Cuccurullo, e qui di seguito, al contrario, quella, a Lugano, del Museo d’Arte della Svizzera
Italiana, una mostra su due piani, 797 opere (di cui mancano purtroppo le
misure), un catalogo di 669 pagine: ‘Il mito dell’India nella cultura
occidentale’ 1808-2017, aperta
sino al 21 gennaio 2018, curatore Elio Schenini, Skira Editore. Di fronte a un
panorama così vasto non potrò che limitarmi solo ad alcuni punti. Ogni società si appoggia ad un passato che ne garantisce la validità, antenati gloriosi, discendenze illustri. Per la cosiddetta civiltà occidentale quel passato si è coagulato intorno alla cultura greco-romana, integrata dalla tradizione ebraico-cristiana. Nell’800 i cambiamenti radicali della organizzazione tecnico-scientifica producono sconvolgimenti, crisi e insoddisfazioni che cercano sbocco in una alterità radicale, una diversa Lebensreform: lo spiritualismo e, al femminile, la spiritualità. Se già i filosofi tedeschi avevano spostato in Asia la fuga verso un superamento dei contrasti (il velo di Maya di Schopenhauer) e l’origine dell’umanità , F. M. Müller, scrive in ben in 50 volumi “The Sacred Books of the East” e F. Schlegel “Sulla lingua e la sapienza indiana” rilegge il sanscrito non cugino ma antenato del greco. I nomi di Gandhi, Nehru e Tagore sono popolari ovunque, ben al di là dei loro Paesi: pacifismo, non allineamento, anticolonialismo (anti-inglese in particolare), ma anche nazionalismo, radicamento, fedeltà alle origini, reali o presunte: la svastica nazista e la razza (indo)ariana, indo/tedesca. In una conferenza orientalista a Berlino del 1881 un giornale scrive che “L’India è la culla originaria della razza tedesca” (p. 48).
Un corpo separato dello spiritualismo, la Teosofia,
è fondata a New York dalla russa Helena Blavatsky, seguace dell’occultismo, che
si trasferisce in India e in seguito a Londra, dove morirà nel 1891. Figura
controversa , avev pubblicato “Iside Svelata” e “La Dottrina Segreta”. La
segue l’inglese Annie Besant che, dopo varie e impegnative esperienze
politiche, dirigerà la Società Teosofica In India, dove morirà. Un ramo
particolare della teosofia viene sviluppato da
Rudolf Steiner in Svizzera con la Società
Antroposofica e la costruzione del Goetheanum. Goethe è un nome che ritorna spesso nello
spiritualismo.
Nella divulgazione libraria spiccano i nomi di
Pierre Loti, Guido Gozzano, Ruyard Kipling, Emilio Salgari, e specialmente di
Hermann Hesse con il Siddhartha (1922)
e successivo Il gioco delle perle di
vetro: la via indiana, buddista, verso la conoscenza/coscienza.
Ho
inserito, sulle tracce del catalogo(ne) – ben trenta capitoli - questo breve
elenco per ricordare come tra ‘800 e ‘900 si sviluppano vari sentieri di
analisi psicologica che entrano ed escono dal riconoscimento ufficiale, sempre
sospettoso, ma che dimostravano l’estrema vivacità di una vita mentale e
insieme di una creatività artistica che faticherà a mantenere il seguito
impantanato in ben due guerre mondiali, e che guerre! Scelgo, tra i molti artisti, Gustave Moreau (1826-78), che mai si recò in India: ci troviamo in un Paese sognato, conosciuto tramite le esposizioni del Musée oriental, le miniature della Bibliothèque Impériale e la sua ricca biblioteca personale. Alle miniature persiane si ispira la Péri, solitaria, casco d’oro, collane, gioielli, anelli, o sull’elefante sacro, ispirata alle miniature Moghul.
Le triomphe d’Alexandre, al di là del titolo è una scena chiaramente indiana, dominata dalla fantasiosa architettura.
Un altro sognatore di vaghi orienti Henri Rousseau, detto per sprezzo (dal suo impiego daziario) ‘il doganiere’ , incontra gli entusiasmi di un giovane pittore, Robert Delaunay, il quale a sua volta, persuade la ricca madre, contessa Berthe, di ritorno da un viaggio in India – di cui si dilunga con il pittore -, di commissionargli un quadro che diventerà ‘La charmeuse de serpents’ (1907):
Una donna in controluce suona il flauto che sembra guidare le mosse dei serpenti che le danzano intorno. Paesaggio onirico, India fantastica, anche eco delle molte curiosità - esposizioni universali e stampa popolare - del pittore, la cui creativa ingenuità affascinerà gli artisti d’avanguardia.
Tutt’altra
figura quella del russo Diaghilev, raffinato uomo di cultura e grande
organizzatore, che con i suoi Ballets
Russes aveva già incontrato il
favore dei parigini, quando nel 1917 presenta ‘Le Dieu Bleu’ ricavato da un’antica leggenda indu. Il coreografo
Fokine, il ballerino Niinsky e il costumista Bakst si richiamano alle sculture
di Krsna e Visnu:
La mostra continua con artisti quali Kirchner, Jawlensy, Pechstein , Matisse, i fotografi, gli architetti, il cinema… gli Hippies, i Beatles…. Ma anche il mondo, le fantasie stavano cambiando.
Io vorrei chiudere con Brancusi che nel 1933 riceve dal maharaja di Indore, già suo collezionista, l’incarico di progettare un Temple de la meditation, mai realizzato, con grande disappunto dell’artista. Tracce di un desiderio, di un sogno, di un progetto sfumato. Ma le tracce sono rimaste, hanno fruttificato. Anche questo era l’India.
Muse endormie
Sonno, sogno, ispirazione; l’India insomma per la cultura occidentale.
novembre 2017
***
Memoria napoletana
Pietro Lista espone Memoria alla SAACI/Gallery di Napoli
sino al 30 novembre quindici opere connesse all’esperienza dell’Arte Povera che
negli anni ’60 con questo termine era stata indicata dall’allora giovane
critico Germano Celant in un articolo su Flah Art per indicare un particolare
atteggiamento di alcuni artisti di allora, atteggiamento di riduzione
dell’opera a una semplificazione di elementi estranei alla tradizionale pratica
pittorica: materiali comuni, terra, legno, ferro, scarti, residui, spesso
accompagnati da gesti, azioni, accadimenti, installazioni. Le figure
interessate si collocavano da Roma alle aree del nord, Bologna, Milano e in
particolare Torino. I nomi fanno parte della storia consolidata dell’arte: Piero
Manzoni, Jannis Kounellis, Alighiero Boetti, Gilberto Zorio ecc. Pietro Lista, nato a Castiglione del
Lago nel 1941 era una dei pochi artisti del sud che operò in quel particolare
contesto artistico (nel 1968 Celant aveva organizzato ad Amalfi ‘Arte
povera + azioni povere’). Ora, con lui stesso ancora attivo, un
interessante ritorno a quegli anni.
Si tratta di un teatrino fragile. Le frange del sipario
impediscono la vista di una qualsiasi scena: un gioco, un nascondimento.
Le vecchie tre chiavi si conservano in una cassetta di
legno deteriorato. Non si sa quali porte potranno aprire. Il teatrino non si
apre alla rappresentazione, le chiavi non aprono nessuna porta.
Altra vecchia
s/cassetta: “Le scarpe di mio padre”. Dunque si tratta di memorie personali.
Consunte come il loro contenitore. Sto parlando di me.
Ma certo, anche ‘il mio’ viso, già chiuso nella immagine
della morte,
nella fantasia della morte. Tutto appartiene al passato,
tutto dorme nella memoria, nella mia memoria.
Anche il busto statuario è un residuo archeologico. Già,
la memoria, non più leggera, mutevole, ma fissa, pesante, mutila. Se il
presente si è rifugiato nel passato, il passato è una collezione di frammenti
mal conservati. No, nessun dramma. Persino una certa capovolta compiacenza.
Ho provato a riprendere una lontana esperienza, un
momento importante per la riflessione artistica che si allargava anche a nomi
come Richard Long e Joseph Beuys, prima che calasse il conformismo della Transavanguardia e le porte aperte dei
‘liberi tutti’.
novembre 2017
***
KUNIYOSHI ANCORA
Una aggiunta a quanto ho già indicato nella nota precedente su questo grande artista giapponese. Dicevo che siamo sul declinare di una importante tradizione xilografica. Uno dei tratti che notavo su questo autore non è tanto la maggiore influenza dell'arte occidentale, lungamente ignorata e censurata, e oggi riconosciuta, specialmente attraverso le stampe e la pur scarsa diffusione libraria straniera. Il cavallo che scalcia è un esempio ricordato di frequente. No, non mi sembra un gran risultato.
Piuttosto il divertimento della esagerazione, del tutto pieno, stipato, mosso. Di qualcosa che fatica a stare nella misura della scena, vorrebbe uscire dai bordi, invade tutta la nostra capacità di ricezione. Un eccesso di vita.
Gli antichi guerrieri giocano tra onde e mostri. Non c'è riposo, non c'è angolo vuoto, tranquillo: gorghi, schiume, dentacci, spade. Sono i mirabili sforzi di un tono massimo che vorrebbe allontanare, respingere la fine intravista, temuta. Un presagio, un timore, uno scherzo, una risata.
***
GIOVANNI BATTISTA PIRANESI
UN MUSEO PARTICOLARE
Ritratto di G. B.
Piranesi di P.Labruzzi 1779
Giovan Battista Piranesi (1720-1778), nato in Veneto, dove
ammira il Palladio e legge Vitruvio, si reca ventenne a Roma dove si fa
conoscere e ammirare come incisore di antichità romane (Vedute di Roma in quattro volumi) sino alle invenzioni
capricciose e visionarie delle Carceri.
Ora esce con SKIRA un ampio e dettagliato studio, 557 pagine, di Pierluigi Panza, Museo Piranesi, sul
lavoro dell’artista-architetto nella sua casa-bottega-museo romano di Palazzo Tomati, dove raccoglie “marmi
antichi o all’antica, integrati, rifatti, creati, collezionati, venduti o anche
solo incisi a scopi promozionali” (p.17). Panza indaga la composizione mista
dei pezzi, le copie, va alla ricerca dei compratori, dove sono andati e dove si
trovano oggi, venduti o incisi per pubblicità sui fogli dallo stesso Piranesi. Un
prezioso inventario, indispensabile per gli studiosi degli stili. I Paesi
esaminati, con riproduzioni e ampie note, sono, oltre l’Italia, la Svezia, La
Gran Bretagna, la Russia, la Francia, la Germania, l’Olanda, la Polonia, la
Spagna, gli Stati Uniti.
G.B. Piranesi, ‘Veuta
di Campo Vaccino’ in ‘Vedute di Roma’ 1748-78
E’ noto che l’Italia era la meta del Grand Tour e che i nobili inglesi e i loro fiduciari erano in
maggioranza, ma il caso di Gustavo III di Svezia, con i 150 pezzi inviati dal
figlio di Piranesi, Francesco, rende il Nationalmuseum di Stoccolma il luogo
fuori d’Italia più piranesiano esistente.
Dopo le fantasie
trionfali del barocco si era diffusa il gusto di una maggiore semplicità e
praticità, quella del neoclassicismo,
dove il passato greco e romano ne garantivano la serietà per una elegante
aristocrazia che non disdegnava gli affari e un artigianato colto e
tecnicamente capace. E’ lo stesso Giovanni Battista Piranesi a chiamare la sua
grande casa romana il mio Museo.“I
diversi avanzi di opere antiche, che si vedono disposti in alcuni camini del
mio Museo – scrive - sono stati da me ivi collocati con simmetria tale, che il
lavoro moderno da me intrapreso, e che racchiude il lavoro antico, forma una
connessione che ci fa sembrare il tutto prevenire dalla stessa antichità” (cit,
p. 62). Non basta copiare con diligenza: “Un artefice, che vuol farsi credito,
e nome, non dee contentarsi di essere un fedele copista degli antichi, ma su le
costoro opere studiando mostrar dee altresì un genio inventore, e quasi
creatore; e il Greco, e l’Etrusco, e l’Egiziano con saviezza combinando
insieme, aprir si dee l’adito al ritrovamento di nuovi ornamenti, e di nuovi
modi” (p. 75). Ecco delle chiare affermazioni: il genio deve essere in grado di
mescolare l’antico col moderno, antichizzare il moderno e modernizzare l’antico
riconosciuto nella produzione romana/etrusca,
meglio che in quella greca,pretesa da Winckelmann.
G. B.
P. Frontespizio delle ‘Antichità Romane’
1756
Non solo ciò che resta dei grandi monumenti, ma la
quotidianità, la sorpresa dell’antica invenzione rinventata.
Vasi, candelabri, cippi,
sarcophagi, tripodi, lucerne ed ornamenti antichi 1778
Il Museo di Palazzo Tomati era uno dei tanti luoghi di
raccolta, restauro, vendita. A Roma, con
un approssimativo controllo della Reverenda Camera Apostolica, “si contano
almeno 64 cave con licenza di scavo per i soli inglesi e molte altre meno
regolari. Si scavava ovunque per riportare alla luce antichità da collezionare
e che, appena scoperte, venivano portate nelle botteghe degli
scavatori-antiquari per essere restaurate o servire per i pastiches” (p. 131). Ma la figura del Piranesi presenta una
prospettiva particolare: ogni passato illustre, forte,come quello della
romanità, sopravvive in quel presente che lo sa riconoscere, in quel presente
che non si consuma nell’attimo. I tavoli su cui mangiamo sono (come) quelli sui
quali mangiava Cesare. Non la riesumazione curiosa di cadaveri, ma la vicinanza
parentale di autorevoli amici. Il contrario della freddezza, il distacco
dell’archeologo, che scruta con eguale interesse la pietruzza e il tempio, ma la convinzione dell’abitare ampio,
confortato dal gusto austero dei collezionisti raffinati e dei colleghi
architetti. Eppure quel passato così vicino rischia di scomparire. Sono
numerose le tavole incise con edifici prossimi all’estinzione:
‘Avanzi del Tempio ’
Villa Adriana’,Vedute di Roma 1748-78
Veduta delle Terme di
Tito
Sopravviene perciò il dubbio che accanto alla fortunata
bottega, ormai apprezzata a livello internazionale, nonostante le molte cariche
e i riconoscimenti ufficiali, la protezione di nobili e cardinali, crescesse,
al contrario, accanto a quelle antiche costruzioni sventrate, a quei resti
mutilati, un senso generale di consumazione, di minaccia che si esprimeva nelle
catene, nei chiodi, nelle scale infinite delle ‘Carceri d’invenzione’. Ma, forse si tratta di una minaccia
scherzosa, un coup de théâtre,
così, vedete, questo è il contrario della abitazione confortevole, elegante che
il mio Museo vi offre: quella dove il presente si rafforza sull’elegante
passato e il nobile passato si ritrova nell’accoglienza intelligente del
presente.
La minaccia
Ioan. Bap. Piranesius
Venetus Architectus ‘Antichità Romane’
Ottobre 2017
***
ARTE COME CRITICA DELL'ARTE Fernando De Filippi
ARTE RIBELLE 1968 - 1978
Alla Galleria del Credito Valtellinese di Milano sino al
9-12- immagini e gesti decennali di un vicino passato, quello della
insofferenza giovanile caustica, sprezzante, divertita, anche politica, certo. Grande varietà di
esempi: dalle provocazioni fotografiche di Vaccari (1), al realismo e
cartellonismo di De Filippi, Spadari e Schifano (2, 3, 4), ai grotteschi di
Guarnaccia (5), al fumettismo di Echaurren.
F. Vaccari 1969
‘Esposizione in tempo reale’ (Il fotografo distribuisce ai presenti una stessa
maschera di un uomo qualunque; poi al buio ne rifotografa a caso alcuni e ne registra
le reazioni)
S. Spadari 'Costruttori con bandiera rossa' 1971
M. Schifano ‘Compagni’
1968
Naturalmente la mostra è ben più ricca di questi esempi, vari,
tutti piuttosto tra loro eterogenei. E’ una mostra di gruppi, in prevalenza
attivi nel milanese. In ogni caso sembra,
mi sembra di incontrare un mondo lontano, scomparso, quasi una
archeologia. Cosa facevano i giovani allora? Cosa rischiavano? Come si
divertivano? In quale passato (non) si riconoscevano? E oggi? Cosa rimane del
loro sorriso?
Dunque ‘Arte’ di allora è ‘ribelle’, magari ingenuamente
‘ribelle’ ai significati, ai comportamenti, agli obbiettivi con i quali ci muoviamo nel presente. Giusto perciò
ripensarci e confrontarci con il nostro passato. Il passaggio non è
confortante.
G.C. ottobre 2017
***
IL GENOVESINO
NON PRCHE' FOSSE PICCOLO
La valorizzazione di Caravaggio e i Caravaggeschi 1951
era stato merito di Roberto Longhi, ma l’interesse specifico verso il seicentesco
Luigi Miradori detto il Genovesino si deve ad una sua allieva, Mina Gregori, già nella sua tesi di
Laurea e poi nello studio dettagliato del 1954, che delinea il profilo del
pittore, dalle origini genovesi al suo spostamento a Piacenza e infine a
Cremona dove, anche con l’appoggio del Governatore don ‘Alvaro de Quiñones, si afferma con
successo sino alla sua morte nel 1656, a circa cinquant’anni.
Ora si apre, con un bel catalogo, la prima mostra monografica sul pittore presso il Civico Museo di Cremona, a cura di F. Frangi,
V. Guazzoni, M. Tanzi, aperta sino al 6 gennaio 2018. L’esposizione è il frutto
di studi approfonditi sulle attribuzioni, con importanti restauri e scoperte. Naturalmente
in questa breve nota non mi addentro nei ricchi percorsi che la mostra offre.
Mi limito a sottolineare l’ironia, le bizzarrie, le felici stranezze anche
nelle opere impegnative di grande formato.
Comincio con La suonatrice di liuto che, elegantemente
vestita, le pieghe esagerate delle stoffe, pizzica lo strumento guardando lo
spartito, gioielli sparsi sul tavolo accanto al sacco dei rifiuti, il teschio
in alto, foglio bianco sul fondo: forse è una Vanitas. Forse…
Passo ora d’un opera giovanile il Sacrificio di Isacco.
La figura dell’angelo, al femminile, abiti mossi,
sontuosi, con i piedi, uno calzato, l’altro nudo, storto, ben in vista, avvolge il testone di Isacco,
che allarga la mano sinistra in controluce, come i rami, e fa brillare il coltello
impugnato con la destra.
Mi sposto ora alla Ultima Cena -400 x 311 cm- (lo stesso soggetto si ripete in una piccola tavoletta con meno spinte deformanti) -. L’uomo sporto in alto guarda stupito l’angioletto volante col turibolo, e al tavolo, intorno a Gesù, tra i ceffi da galera troneggia, di mezza schiena, il deretano di Giuda, contorto, ai cui piedi il diavolo si appresta con le catene. Un cane, sul bordo della scena, addenta un osso e guarda timoroso.
Rimango con un formato grande, alto e stretto -328 x 220 cm
-, il Riposo durante la fuga in Egitto.
Cercherò di riassumere la complessità della scena. La
Madonna, riparata dal mantello dell’angelo, guarda melanconica il bambino ,
come il secondo angelo dietro,
prevedendone il sacrificio. L’angioletto di sinistra arriva con i
datteri in grembo, quello di destra, guardandoci, estraneo al gruppo
famigliare, rifocilla il grande asino, l’enorme forma scura di lato, una quinta
teatrale. Un grappolo di angioletti volteggia in alto; altri fanno capolino più
in alto, tra le rovine di una antica costruzione, il mondo pagano crollato.
Lontano, in secondo piano, in una furiosa lotta tra cavalieri, madri e
carnefici, gli infanti precipitano dall’alto arco. Ancora più lontano gli
angiolini volanti impugnano le corone dei martiri. Si racconta che il pittore
prese per soggetti i famigliari, moglie e figli. Ma il riferimento è piuttosto
l’azione teatrale. La grande quinta del primo piano e lo sfondo lontano,
sfumato; la nuvola soffice, spumeggiante rispetto alla durezza delle colonne e
archi sbrecciati ben segnati del secondo piano e le figure in primo piano.
L’angiolino seduto, per conto suo, che ci guarda e il grosso mulo scuro di
destra, insieme al gruppo di sinistra, il mantello di Giuseppe, l’ala
dell’angelo, i nudini dei putti volanti, i resti della costruzione romana segnano
con forza il primo piano, rimandando la tragedia in fondo, lontano. Anche se le
varianti sono più di due, il prevalente doppio registro, serenità e tragedia,
compostezza e mostruosità sembra accompagnare con un’ironia sottile il lavoro del
nostro artista.
Tralascio altre grandi opere, come la Moltiplicazione dei pani e di pesci, per terminare con questo piccolo Cupido dormiente, appoggiato ad un
teschio nelle cui fauci occhieggia un rospo: anche questa una Vanitas?Amore, fiori e morte? Seduto su di un grande libro, il
sonno come preludio della fine oppure, con la freccia in mano, le pagine della
sapienza e i fiori di lato come un sogno, una speranza, un incubo, un destino?
La sottile ambiguità del grande Genovesino ci accompagna anche in
***
KUNIYOSHI LE ONDE LEGGERE DEL MONDO FLUTTUANTE
Per la
seconda volta, dopo il trio Hokusai, Hiroshige, Utamaro, un’altra mano stende
allegre trasparenze a sciogliere per un breve intervallo le pesantezze, gli
angoli duri, sfacciati, rumorosi delle nostre strade e muri inospitali. La
curva, la sfumatura, il sussurro, il sorriso, a rendere più sopportabile la nostra
gran cassa quotidiana. L’antico Giappone ci viene in aiuto.
Sto parlando
della mostra alla Permanente di Milano curata da Rosella Menegazzo (la stessa
della mostra precedente):165 silografie policrome di Utagawa Kuniyoshi
(1797-1861), 5 sezioni, Beltà, Paesaggi, Eroi e guerrieri, Animali, Gatti, ma
pure fantasmi e apparizioni, catalogo M. M.Skira. La cura degli animali, la
grandezza della balena per esempio, un ricamo, uccisa dal piccolo omuncolo, dimostra
l’ironia dell’artista, vivace anche nelle molte immagini del gatto-uomo, forse
a sostituire i giochi degli accoppiamenti sessuali colpiti dalla censura (una
censura che aveva condannato e imprigionato Utamaro nel 1804), un apparato
politico-religioso di ripresa neoconfuciana sospettoso di tutto ciò che si riferisse ai
quartieri del piacere.
Il filone
dell’ukiyoe (del ‘Mondo Fluttuante’)
corrispondeva “ai gusti della nuova classe cittadina dell’epoca, ai volti dei
personaggi celebri che questa ammirava, attori di teatro kabuki e beltà
femminili, soprattutto cortigiane e geishe delle case da tè del quartiere di
piacere Yoshiwara nato nella periferia di Edo” (R. Menegazzo). Quella qui
riprodotta ha pinze per capelli esagerate e un pubblico lontano di immobili
statuette. Il consueto sorriso di Kuniyoshi
I quartieri
del piacere, in Giappone non solo a Edo, godevano di una popolazione mista. La
cortigiana riprende in parte l’antico significato, donna di corte: elegante,
colta, capace nella musica - suona uno strumento -, nella poesia, nella
calligrafia, nella danza, nella cerimonia del tè e, anche, nei rapporti sessuali.
La sua arte è quella della accoglienza e dell’intrattenimento. I suoi sono perciò i luoghi frequentati anche
da artisti, disegnatori, scrittori, poeti, musici, attori, la festa fluttuante,
amata e insieme temuta dalla gente per bene, abituata, nella quotidianità, a gesti ripetuti, consolidati, riconoscibili.
La festa mobile ha invece un carattere
imprevisto, esalta la vista, il gusto, il sesso, il sogno, la fantasia, il
cambiamento, la sorpresa. Proprio ciò
che diverte Kuniyoshi. L’esagerazione è uno dei suoi strumenti.
E ancora,
nella grande misura, onde, spruzzi e un pubblico di tifosi per acchiappare due agili
coccodrilli; in fondo il classico
Fujiyama. Di nuovo un gioco.
Più triste
la lotta del guerriero: spossato, ferito, infilzato da un volar di frecce
brandisce ancora la sua spada insanguinata. Un altro tipo di sorriso
dell’artista sulla immagine ormai superata dell’eroe, di cui declina numerose
figure.
La principessa strega risveglia
uno scheletro mostruoso
Appena un
accenno ora, una riflessione sulla mobilità della festa, sulla sua attrazione e
timore, una eccezione desiderata. La città della festa fluttuante è vicina alla
città, ma non è la città, dove invece vigono regole stringenti, scambi, macchine,
interessi. E’ una vicinanza-lontananza, una tentazione e un sospetto. Il gatto
e la donna di Kuniyoshi sono l’attrazione, la espressione della festa, della
immaginazione libera, sì esaltante, ma per un breve tempo, una parentesi.
L’ancoraggio ai modi antichi, alle figure della tradizione, proprio di queste
incisioni, è un elemento di tranquillità,
di radici comuni che prepara il salto alla sorpresa, all’imprevisto. Ma il lavoro,
anche quello della non facile produzione delle immagini colorate, stampate a
migliaia di copie, della loro distribuzione non è la festa, anche se la
descrive; è la sua ammirevole traccia, il dopo-festa. Direi che c’è una festa,
un dopo-festa e una contro-festa (quelli che la temono per principio).
Kuniyoshi , nella metà dell’ottocento del suo Paese, sa che la festa è
declinante, e allora esagera, sia nei riferimenti al glorioso passato sia nel
sorriso che lo mette in discussione: il sacro monte del Fujiyama, il ricamo
delle onde e il gioco dei coccodrilli. E’ quello, mi pare, che noi, la nostra
storia recente non sa fare: conservare certi aspetti del passato e transitarli
nel nostro presente-futuro. Così termino con la variante della prima immagine:
la gheisa elegante gioca col gatto che le risponde affettuoso, ma sino ad un
certo punto. Ciascuno ha una parte diversa. L’artista farà giocare il gatto anche in un
altro modo, quando lo camufferà da uomo, a parti invertite. Il gatto che gioca
a fare l’uomo (o la donna).
I molti esempi da vedersi in mostra.
ottobre 2017
***
A VENEZIA BIENNALE E OLTRE:
IL TEATRO TRAGICO E GROTTESCO
DI GRISHA BRUSKIN
Grisha Bruskin (nato a Mosca nel 1945) espone nel padiglione russo della 57a Biennale
di Venezia. L’avevo conosciuto già due anni fa, sempre a Venezia, con due
presenze, una alla Fondazione Querini
Stampalia con Alefbet, grandi arazzi, 160
riquadri, una trama con figure simboliche, una specie di vocabolario, un Alphabet, sul libero uso della
tradizione ebraica del Talmud e della Kabbalah. Per esempio l’uomo a sinistra
ha due grandi occhi, l’uno fissa il tempo l’altro l’eternità. Accanto, la
figura legata, è il Golem, le passioni che possono schiacciare l’uomo ecc. Ogni
personaggio è dotato di un accessorio che lo caratterizza. Sul fondo la varietà
dei segni ricorda la difficoltà della comunicazione scritta.
Ma la scena più suggestiva si presenta negli spazi della ex
Chiesa di Santa Caterina.
La chiesa è sconsacrata come le figure, bamboccianti rotti ,
mezzi seppelliti nelle fosse, residui grotteschi della retorica sovietica: una
specie di cimitero dove sono sotterrate, immobili nei loro gesti
stereotipati, le varie forme di una dis-umanità
falsa e ferita. Siamo noi gli eredi? o gli affossatori? o gli innocui
succedanei? Nel buio del passato i colpi di luce fanno ritornare questi fantasmi alla nostra vista presente. Il pubblico cammina su
di una grata di metallo. Il carattere del luogo è ambiguo: la sacralità di una
chiesa che non può rinunciare alla propria storia e, al fondo, su di un grande
schermo cinematografico, le immagini proiettate delle stesse figure sparse nelle buche, ma ripulite, in
piedi, a rivendicare la propria incompleta, sotterranea permanenza. La scena
riprende una operazione che Bruskin aveva realizzato nel 1991: statue in bronzo,
stereotipi del potere sovietico, frantumate e interrate in Toscana, accanto ad
una necropoli etrusca (Roma e Mosca come terza Roma) e dopo tre anni riportati
alla luce, riscoperti, ripuliti ed esposti.
Ancora incrostati di fango, rotti, scheletri . Così il passato che rimane. Che deve rimanere.
Conclusa
l’epoca post-sovietica, terminata l’ubriacatura della incontrollata libertà,
ora il mondo vive una nuova era di terrorismo. Una folla indistinta di
‘microbici’ accetta felice, tutti insieme, il controllo che garantisce una sicurezza
contro il nuovo pericolo del terrorismo (da una intervista rilasciata da
Bruskin in occasione della recente Biennale).
L’aquila a
due teste: potere, folla, terrorismo
Vedere, sentire, controllare
Terrorista: un profilo vuoto, una
cintura di bombe
Anche un bambino, una macchina a quattro gambe, bombe alla cintura, pure lui terrorista
Anche un bambino, una macchina a quattro gambe, bombe alla cintura, pure lui terrorista
Tutti,
grandi, piccoli, volanti, tutti
indossano cinture esplosive,
tutti sorridono alla distruzione che verrà. Niente paura. Il teatrino dei
terroristi si presenta sul palco, attende gli applausi. Una recita, una
invenzione, un incubo, una fantasia.
Interrati, nei campi, nelle chiese di una volta, ricamati
sugli arazzi, sui palchi delle periferie tecnologiche, le figure spezzate di
una dittatura implacabile, il mondo di Bruskin mescola passato, presente e
futuro, il simbolo e la maschera, la minaccia e il gioco, la preghiera e il
timore. No, non c’è uno sviluppo unitario. Scava e troverai tante strade,
miserie e coraggio.
Mi pare che non sia poco.
luglio 2017
***
Denti per Leonardo
“Il
Cenacolo” oppure “L’Ultima Cena” di Leonardo è uno stereotipo rientrato in
tutte le forme possibili di riproduzioni. Nella cornice della Pop Art se n’era impadronito Andy Warhol
dedicando a questa “Cena” oltre cento opere. L’ultima, la più clamorosa, si
riferisce ad un lavoro di ben m.10 x 3, la “Sixty Last Supper”, 60 ripetizioni
xilografiche della ‘Cena’ insieme unite: anni ’80 del ‘900, esposta a Milano
nell’87. Seguito gigante della piccola“Campbell’Soup”, l’annullamento,
l’appiattimento di ogni qualità, di ogni singolarità.
Così quando
Giuseppe Denti negli anni ‘2000 si dedica al
Cenacolo leonardesco conosce bene questi antecedenti, ma
l’atteggiamento, che pur parte di lì, è diverso. Si tratta sempre di un
materiale ovvio, supernoto, ma giocato in una divertita trasformazione: guarda cosa ti combino con il tuo
intoccabile Leonardo! Forse non c’è nulla di intoccabile, forse. Denti si
diverte a mordicchiare e sorridere su Leonardo, per Leonardo.
L’acquerello
Il cristallo
Si tratta di
variazioni sul tema, un divertimento, una strizzatina d’occhio, un sorriso,
sino alla progressiva liquefazione.
Qui invece
un groviglio filiforme, vermiforme, un ingorgo su di un fondo nero minaccioso dove
a malapena si riconoscono le figure di partenza.
E, per
finire, l’originale è scomparso sotto una moltiplicazione di effetti luminosi,
similtubolari luci al neon. Non per accigliata polemica o intento
scolasticamente dissacratorio. Un consolidato monumento, oggetto di secolare
ammirazione sino alla diffusione nella
consunta cartolina-ricordo, è diventato un enigma sulle
possibilità trasformative, sulle metamorfosi che, come in un gioco di carte, un
gioco di prestigio arriva alla sua sorridente sparizione.
maggio 2017
***
WORLD PRESS PHOTO ‘17
‘Fotografia
e giornalismo’ alla Galleria Sozzani di Milano la 60a edizione del ‘World Press Photo ‘17’, dal 7 maggio
all’11 giugno. Si tratta di una importante selezione di fotografi provenienti
da 125 Stati. No, non intendo fare una descrizione della ricca mostra, ma di
indicarne solo alcuni elementi. Il primo, la prevalenza di immagini
distruttive, sconvolgenti, scene di massacri e torture, di profughi e disperati.
Naturalmente il pubblico gira tranquillo – io tra gli altri -, si ferma su
alcune immagini, magari prende appunti, scambia osservazioni con amici… La
trasformazione del vissuto in stampa fotografica muta la insopportabile
tragedia in accettabile racconto, triste, anche tristissimo, ma pur sempre
imparagonabile alla esperienza diretta. Non c’è volume, non c’è suono, non c’è
odore, non c’è respiro, non c’è movimento. Anche il primo premio, ‘Un assassinio in Turchia’, ‘foto dell’anno’, ben nota scena dell’omicidio
dell’ambasciatore russo ad Ankara, trasmette l’eleganza di una perfetta scena teatrale, con i profili netti
dei vestiti scuri sul fondo chiaro (è l’ambiente di una galleria d’arte!) e la
minaccia evidente sembra un grido rivolto ad un presunto pubblico.
Ed allora,
forse, è un rapporto meno coinvolgente spostarsi sul titolo ‘Natura’ che allontana gli aspetti
drammatici, di sopraffazione, propri dei comportamenti umani, anche se già
ammansiti dal filtro fotografico. In particolare vorrei fermarmi sulle foto che
si riferiscono alla condizione dei panda
e della cura che l’uomo-panda mette in atto.
L’uomo si è
trasformato in panda gigante per non spaventare il piccolo cucciolo che tiene
in braccio. Non è l’animale che deve umanizzarsi, diventare dipendente, come
avviene con gli animali detti ‘domestici’ ma, al contrario, è l’uomo ad
animalizzarsi, a svestirsi della sua solita veste di ‘padronanza’. Anche quando
devono monitorare a distanza, con i sensori, la condizione dei panda messi in
libertà, gli uomini della ‘riserva’
devono vestirsi da panda.
Mi sembra
una ammirevole trasformazione. Noi siamo soliti considerare ‘bestiale’ un
comportamento disgustoso, violento, irragionevole, contrapponendolo a ‘umano’, l’essere
pacifico e razionale per eccellenza. Anche dalle numerose fotografie esposte
nella presente mostra questa presunta ragionevole pacificazione non risulta
tanto frequente. Si è spesso confuso evoluzione con progresso, avanzamento. Non
vorrei affrontare problemi complicati e sarebbe ingenuo non riconoscere le
eccellenze della specie ‘homo sapiens’.
Forse però una maggiore attenzione alle specie viventi non umane potrebbe
essere una buona lezione anche per le nostre eccessive, pericolose presunzioni.
Insomma, qualche volta, vestirsi da panda.
maggio 2017
***
Jan van Eyck fu qui
Sulla parete di fondo del quadro l'autore scrive ‘Johannes de Eyck fuit hic – 1434’
‘Fu qui’: fece?
Si trovò? Si autorappresentò? La scena si riferisce a quell’anno firmato, 1434?
Anche lo specchio convesso sulla parete introduce degli interrogativi. Pure il
soggetto, “I coniugi Arnolfini” non è sicuro. Forse sarebbe meglio scivere “Hernoul-le
Fin con la moglie”, inventario 1516. Ricavo queste precisazioni dall’indagine
di Jean-Philippe Postel, “Il mistero Arnolfini”, ed. SKIRA.
L’autore è medico e scrittore, cioè non è, professionalmente, uno storico
dell’arte, il che, in un certo modo, lo libera dalle indagini sullo stile, i
colori, le parentele ecc. indirizzandolo piuttosto verso un’ampia indagine sui
significati possibili, presentando ben 12 interpretazioni già formulate sulla
coppia. Per cominciare i nomi dei due coniugi non sono certi. Il più accertato
Giovanni avrebbe spostato Costanza Trenta (della famiglia de’ Medici) morta nel
1433, un anno prima della data dipinta. Postel, l’autore, ora si rivolge allo
specchio che, per tradizione, è l’occhio di dio, è depositario della verità,
anche quando la nostra vista è fallace.
Lo specchio
racconta una scena diversa rispetto a quella ripresa frontalmente. Sono
visibili due personaggi che stanno entrando, un uomo e una donna – e questo è
possibile, sono fuori, al di qua della scena principale -, manca il cagnolino e
la coppia, vista di schiena, non si dà la mano. La ‘sposa’è
completamente girata, non lascia intravedere il profilo. Una forma nera, una
nube (?), si sviluppa davanti all’uomo e si riduce verso la finestra. Cosa
significa questa diversità? Qui l’autore introduce una spiegazione che non
riferisco perché toglierei la curiosità della lettura. In generale la
condizione della coppia è asimmetrica: la figura femminile non si trova nelle
condizioni di quella maschile. Una serie di indizi, scovati con divertimento da
racconto ‘giallo’, rinforzano questa interpretazione delle ‘diversità’. Ne
riprendo alcuni: i medaglioni dello specchio che raccontano la vita di Cristo,
il cane=fedeltà, i braccioli del divano (un diavolo e il leone), i vetri della
finestra, l’arancia sul davanzale (= la famosa mela del peccato), la corona del
rosario, la posizione a V delle pantofole rosse, la mancanza di sguardi
reciproci dei due, la mano di lui, alzata come in un giuramento, lo scopino
attaccato allo schienale, una candela del lampadario accesa nella luce del
giorno e un’altra, più piccola, senza stoppino… Infine si presenta un’altra
possibilità: “è lui, Jan van Eyck, a mostrarsi così, dissimulato, vestito di
nero, con in testa un cappellone di paglia?” (p. 110).
Il quadro
con uno specchio incorporato figura sempre come un doppio specchio. Altro
esempio illustre è l’opera di Velázquez, “Las Meninas” di un secolo dopo. Anche qui lo specchio di fondo
mostra ciò che nella scena è invisibile, il re Filippo IV e la moglie Marianna,
il vero centro del ‘potere’. La luce
della porta vicina non entra nello spazio della scena. E’ l’esterno, forse il
segno che la seduta sta per terminare. Lo spettacolo è rappresentato per chi è fuori dalla scena, la più pallida
delle immagini a cui nessuno presta attenzione perché tutti gli astanti
guardano verso un punto esterno al quadro, a partire dal quale però è possibile
la rappresentazione, dal quale, in senso lato - la regalità appunto -,
appartiene ogni possibile altra rappresentazione.
E’ forse
noto il commento di Michel Foucault al quadro di Velázquez.
Entrambi le opere sono una riflessione sulla immagine e sul potere dello
specchio. “L’occhio di dio”, lo specchio di Van Eyck, pone degli interrogativi
agli astanti del primo piano, dove gli sguardi sono sfuggenti, non s’incontrano
né ci incontrano. Il potere che li guida è l’interrogativo a cui lo specchio
dovrebbe rispondere. Mi pare perciò che Il
dipinto con specchio goda di uno statuto particolare, una specie di
indovinello, sia cioè un gioco di
rimandi a tre livelli: la scena principale in primo piano, la scena riflessa
nello specchio, e infine i soggetti assenti, ma costitutivi di quella scena,
che quel riflesso dovrebbe suggerire. Ora
riprendo il finale di Postel che ha così cercato di ricostruire il significato
della scena, quella della coppia in primo piano, quando la prima moglie era già
morta: nel giugno 1434 ci fu il battesimo del primogenito di Jan e Margarethe
(seconda moglie di van Eyck). Un racconto autobiografico. Come la prima moglie
fosse comparsa nel maggio o giugno di quello stesso anno, cioè poco prima della
nascita del figlio, lo lascio alla curiosità del lettore. Lo specchio aveva già
descritto la separazione dei due coniugi. In un modo o nell’altro, il quadro dipinto in
modo impeccabile, con raffinatezza sublime, rimane un affascinante mistero.
maggio 2017
***
PARADE
Primavera di
guerra 1917: Diaghilev è a Roma con Picasso e Cocteau, stranieri o ‘esenti’ da
obblighi militari. Oltre alla precedente organizzazione di ‘Fuochi d’atificio’ di Giacomo Balla, (di cui ho fatto il precedente
‘pezzino’), viene impostato anche un
nuovo balletto, ‘Parade’, con musiche
di Erik Satie e coreografia di Léonide Massine. Di Picasso rimane il ‘grandissimo’
sipario (base m. 17 x 10 di altezza), ora in esposizione sino al 10 luglio a
Napoli, al Museo di Capodimonte,
insieme a documenti, bozzetti del pittore che da Roma era sceso anche a Napoli e
Pompei.
Un
gruppo di saltimbanchi intorno a un tavolo si volta verso le mosse di una
ragazzina che, sulla groppa di un cavalla alata che lecca il suo puledrino, forse
si accinge a scendere da una scala che una scimmia le offre. Dietro il
tendaggio s’intravede un paesaggio di rovine. Il balletto non ha una vera trama:
un gruppo di attori circensi vorrebbero attrarre il pubblico alla loro
imminente rappresentazione. Si distinguono due Manager, uno europeo e uno
americano. Il tutto dura circa quindici minuti. Debutterà al Théâtre du Châtelet di Parigi nel maggio
dello stesso 1917.
Picasso,
che aveva guidato a Roma l’esecuzione del grande sipario con una impostazione volutamente
tradizionale – tra gli aiuti anche pittori futuristi italiani -, si
sbizzarrisce con gli attori (due per le quattro zampe del cavallo) in una
divertente variazione post-cubista.
Il
Manager
Il prestigiatore cinese
Se
ne ricava una semplice osservazione: la multiforme attività di Picasso, la
mescolanza di stili diversi, lontani, in una contraddizione che sorprende tra il
sipario/introduzione (una scena inventata ma con unità di racconto) e l’azione,
la figura irriconoscibile dei personaggi, a loro volta non tutti trasformati con
la stessa volontà spiazzante: da un essere umano ancora intravisto ad una
macchina di pura invenzione. Lo spazio teatrale lo permette meglio che non la singola tela dipinta, da connettersi
però sempre con l’insieme. Ne risulta la
scanzonata libertà dell’artista, dei suoi stili diversi e imprevedibili,
la capacità di rinventare la tragedia e l’allegria, lo sberleffo e la
tenerezza, che, per fare un singolo esempio, si può contrappone alla ‘maniaca’,
solitaria, meravigliosa ripetizione di un Morandi. Parade, una straordinaria parata della
diversità.
Maggio
2017
***
VENTI FUTURISTI NELLE MARCHE
1922. Il
giovane pittore – ha 21 anni – Ivo Pannaggi organizza a Macerata la prima
mostra marchigiana dedicata al Futurismo.
Scrive nel catalogo: “La persona di un imperatore o il bel vaso di porcellana
di una moderna latrina sono dal punto di vista pittorico ugualmente
interessanti. Ciò che ci colpisce è la costruzione del soggetto, il ritmico
accordo delle linee e dei piani che lo costituiscono”. Non si può non pensare
alla ‘Fontana’ di Duchamp del 1917.
La citazione è riportata nel catalogo della mostra ‘Venti Futuristi’, Silvana
Editoriale, a cura di Stefano Papetti, 13 aprile – 2 luglio, Senigallia.
Il ratto d'Europa
Rispetto al Manifesto di Marinetti del 1909, c’è una
guerra di mezzo e la morte di Boccioni, Sant’Elia e Carlo Erba. Ma il Futurismo,specialmente con l’autorità di
Giacomo Balla, che già nel ’15 aveva scritto con Depero il manifesto “Ricostruzione Futurista dell’Universo”
(vedi la mia precedente nota su Depero) continua il suo tragitto creativo e
negli anni ’20 s’incontra con l’Areopittura,
che conquista, tra gli altri, Bruno Tano
con questa madonnina dell’ala 1931:
Né può
mancare la velocità della curva, di Tullio Crali, 1930:
Scrivere
della “ditta” Balla, Giacomo con le due figlie, Luce ed Elica, l’indispensabile aiuto della moglie Elisa e
l’ombra protettrice della madre, non è scopo di questa breve nota. Considerato e
rispettato come maestro dai più giovani futuristi, la frenetica attività di Giacomo Balla si
allarga ai più numerosi campi d’intervento: oltre alla pittura, in tutti i
formati e tecniche possibili, la fotografia, la litografia, la moda, il cibo,
l’arredamento, l’oggettistica, la scultura, la pubblicità, la scrittura (i manifesti),
il teatro, la scenografia.… il suo ritirarsi nel ‘37 in una pittura realistica
e in una dimensione più raccolta, privata, lo allontanano dal pubblico e dall'interesse generale. Muore nel 1958. L’antifascismo postbellico lo ignora, salvo una
ripresa in grande stile dagli anni ’60 in poi. No, non è che si vogliano
ignorare i rapporti con il regime fascista che per lungo tempo ha condizionato
necessariamente anche le attività culturali. In buona parte uno stato di necessità, opere
pubbliche, esposizioni, premi ecc., e l’amichevole vicinanza allo stesso
Marinetti. Rimane un’opera straordinaria, dove la quantità delle opere non ne
ha mai svilito la qualità. La sua casa romana
in via Oslavia, una officina ricca di pitture, decorazione, oggetti, documenti
dell’artista, dopo la morte delle due figlie, nel 2004 è stata vincolata dallo
Stato italiano, offerta agli studiosi, ai collezionisti e al pubblico in genere.
Oggi non visitabile (?)
G. Balla, Fuochi
d’artificio, 1915, arazzo
Torno
alle Marche degli anni ’70-‘80. Pesaro si arricchisce di Gallerie d’arte,
favorite anche dal ‘Rossini Opera
Festival’ e da ‘Il Teatro degli Artisti’
col quale viene rimesso in piedi ‘Fuochi d’artificio’ di Balla; così riprendo
la storia della ‘prima’romana dello spettacolo. Siamo in tempi di guerra. Balla
ha l’incarico da Diaghilev di creare uno scenario plastico per ‘Feu d’artifice’ di Strawinsky. Il
balletto senza ballerini, di cui l’artista ha elaborato numerose prove e
bozzetti, va in scena il 12 aprile 1917 al Teatro Costanzi di Roma. Lo spazio è costituito da solidi
geometrici ricoperti di tela leggera virtualmente danzanti per il gioco di luci
ed ombre generato dall'accensione e spegnimento di 49 luci policrome. “Mostruosità geometriche, mezzo sferiche e mezzo cilindriche - scrive
Margherita Sarfatti - come le creature
antiche della favola, metà umani e metà bestiali… il singolare spettacolo dura non
più di cinque minuti ed è composto esclusivamente dalle vibrazioni
dell’etere, onde acustiche…”. Il pubblico di
allora rumoreggia, non gradisce. Dovranno passare parecchie decine d’anni prima
che si riscoprissero, una sorpresa, queste invenzioni.
G. Balla, Tazza de tè,
progetto 1925
Anche i più
semplici progetti acquistano una eleganza di favola, o di balletto o…..
Non solo
venti futuristi ma pure zefferi leggeri.
aprile 2017
***
DEPERO IL MAGO
“Noi futuristi, Balla e Depero,
vogliamo realizzare questa fusione totale per ricostruire l’universo
rallegrandolo, cioè ricreandolo totalmente. Daremo scheletro e carne
all’invisibile, all’impalpabile, all’imponderabile, all’impercettibile.
Troveremo degli equivalenti astratti di tutte le forme e di tutti
gli elementi dell’universo, poi li combineremo insieme, secondo
i capricci della nostra ispirazione, per formare dei complessi plastici
che metteremo in moto…
Complesso plastico 1. Astratto, 2.
Dinamico, 3. Trasparentissimo, 4. Coloratissimo e Luminosissimo, 5.
Autonomo, 6. Trasformabile, 7. Drammatico, 8. Volatile, 9. Odoroso, 10.
Rumoreggiante, 11. Scoppiante…” (Roma-Milano 11 marzo 1915).
Così
citavo dal manifesto “Ricostruzione futurista dell’universo” in un
‘pezzino’ che qualche ‘paziente’ lettore può ritrovare in ODISSEA/QUARTIRE
LATINO del 2013. Balla ha 44 anni, Depero 23 (nato in Val di Non, poi Rovereto,
allora Impero austriaco). Boccioni muore l’anno dopo. La guerra per i due
pittori, maestro e allievo, è lontana, pensano già alla ‘ricostruzione’
allegra.
Ora la
inesausta curiosità del ‘Mago’ Depero è ripresa dalla Fondazione Magnani-Rocca (Villa Mamiano di Traversetolo) dal
18 marzo al 2 luglio 2017.
Oltre cento opere tra dipinti, tarsie in
panno, collage, disegni, abiti, mobili, progetti pubblicitari, per celebrare il
geniale sperimentatore,
artefice di un’estetica che
mette in comunicazione le discipline dell’arte, dalla pittura alla scultura,
dall’architettura al design, al teatro. La mostra, curata da Nicoletta Boschiero, è frutto della
collaborazione fra la Fondazione e il Mart, Museo di arte moderna e
contemporanea di Trento e Rovereto,
la città dove l’italianissimo Depero lavorerà lungamente e felicemente sino
alla morte nel 1960.
Una parentesi importante
si apre a Roma nel periodo della guerra, quando nel 1917 si ritrova con
transfughi come Djagilev, Picasso, Cocteau, Strawinskij. Si tratta di balletti,
teatro e burattini.Vi si unisce anche un ricco svizzero, Gilbert Clavel,
entusiasta del progetto di Depero, da realizzarsi nella sua villa di Capri. In
realtà il progetto si potrà mettere in pratica solo dopo la guerra, a Roma, al
Teatro dei Piccoli, i ‘Balli Plastici’:
Meccanica di ballerini 1917
Nello stesso anno, 1919, a Rovereto, Depero, insieme alla
moglie Rosetta Amadori, apre una casa d’arte futurista,
specializzata nel settore della grafica pubblicitaria, “l’arte dell’avvenire” e
dell’arredo; in particolare, in quello degli arazzi. Partecipa alla Exposition
Internationale des Artes Décoratifs, Parigi 1925, e prima a Monza, le
Biennali e Quadriennali, il viaggio a New York (’28-30), il libro imbullonato,
l’editoria…
Depero, bozzetto di copertina
per Vanity Fair
New York 1930
Materie dure, contorni netti, ritagliati, personaggi-caricature,
metallici, una meccanica gioiosa e fantastica; semplificazione e rigore grafico
che ingegnosamente si combinano; scambi positivo-negativo di forme nette e
colori piatti; geometrie impossibili onnipresenti; divertimento, facilità di
far uscire dal cappello del mago personaggi sempre uguali e sempre diversi, un
sorriso, una favola senza fine che unisce l’innocenza della fanciullezza alla
tradizione dell’intagliatore trentino allo scatto libero, scanzonato dell’avanguardia.
aprile
2017
***
I VOLTI E IL CUORE Museo del paesaggio Pallanza
Sulla costa dl Lago Maggiore si apre il silenzioso edificio
del Museo del Paesaggio, una antica costruzione, il palazzo Viani Dugnani, di cui ho già scritto per la mostra di Paolo
Troubetzkoy, le cui sculture occupano tuttora il pianoterra. ‘I
volti e il cuore’ è il bel titolo di una mostra dedicata alla figura
femminile, pur vista e ritratta da maschietti. Comincio con Daniele Ranzoni. Leggero,
trasparente. 1879-80 “Pitturà col fiàa”, riferisce Margherita Sarfatti:
E continuo con lo sfaldamento acquoso, tra foglie mosse e
impossibili abbracci, la teatrale divisione-unione tra le sbarre, di A.
Alciati, “Il convegno” del 1918, 38
anni più tardi rispetto a Ranzoni, la distanza di una generazione; al soffio
silenzioso l’esagerazione:
Stessi anni invece della “Principessa Pignatelli”, ma il suo contrario. Segni duri, masse
compatte, nessun abbandono. Quasi una caricatura, questa di Adriana Bisi Fabbri, una delle due donne presenti nella mostra.
Non la figura-ambiente, non languore di sentimenti, ma l’ambiente scuro, la notte, che fa da cornice alla chiarezza della
carnagione, così come l’oscurità intorno agli occhi fa risaltare la fissità
minacciosa dello sguardo:
Ma vorrei giungere al nucleo più consistente della raccolta,
le sculture di Arturo Martini dagli anni ‘20 ai ’40. Comincio con ‘Busto di fanciulla’ del 1921:
Nel ’26 usciva ‘Il
gusto dei primitivi’ di Lionello Venturi, dove si contrapponeva il ‘400 al
‘500, e da qui in poi la rivalutazione delle opere pre-rinascimentali, e via
via sino, magari, alla mano dei pittori
di carretti siciliani che interessarono Guttuso. Martini fa parte di questo gusto
antiaccademico, genericamente ‘primitivo’, un po’ rigido all’inizio, che si
scioglie nel tempo. Ecco ‘Il nudino’ 1935,
una sottile ingenuità di espressione e di fattura, i seni sghembi, gli occhi,
due buchi, ci interpellano stupiti:
E più avanti, 1946-47, ‘Incontro’,
simile al precedente gesso ‘Ratto delle sabine’.
Segni veloci, un coinvolgente movimento di abbracci, di capelli e di vesti:
Dopo un lavoro intenso e di grande successo, Martini sente
che qualcosa sta finendo. La crisi del ’43, la guerra totale, è anche la sua
crisi e inizia a scrivere ‘Scultura lingua morta’, regno dei
fantasmi. “Dopo
l’ottocento poteva benissimo venire la fine del mondo. Infatti, noi, per conto
nostro, abbiamo ricominciato come se fosse avvenuta. Ecco il nostro
primitivismo … Ogni cosa è andata a fondo”. La sorpresa dello sguardo si è
spenta.
I ‘volti’ della mostra continuano con le opere d Mario Tozzi
e del giovane Mario Sironi, disegni custoditi dalla sorella Cristina.
Il pubblico si allontana dalle belle sale del palazzo
Dugnani, dai soffitti vivacemente decorati e dai frammenti volanti di un
affresco religioso staccato e ricomposto, in attesa del prossimo appuntamento.
marzo 2017
***
I MUSEI, NON SOLO CONSERVAZIONE.
LA LEZIONE DI
FRANCO RUSSOLI 1923-1977
e I DEPOSITI MUSEALI della GAM-MILANO
Per la conoscenza di una importante collezione e museo come
quello di Brera a Milano, rimane centrale la figura di Franco Russoli, suo direttore alla morte di Fernanda Wittgens,
della quale era stato aiutante dal 1950, ai tempi della ricostruzione del
palazzo bombardato dalla guerra, del suo riordino e ingrandimento con
l’acquisizione di palazzo Citterio, ora (!) finalmente in restauro. Le sue
riflessioni sul Museo, non solo archivio per gli addetti ai lavori, ma stimolo
al cittadino per una attenta coscienza del presente, della connessione sempre
viva tra passato e presente, rimangono un esempio illuminante anche per il
nuovo direttore James Bradburne
. Una antologia dei suoi scritti, ora riordinati da Erica Benardi, esce ora da
SKIRA. Un’utile lettura.
Che i musei abbiano anche il compito conservativo è ovvio.
Come ciò avvenga, spazio, temperatura, pulizia, restauro ecc. ne fornisce un
buon esempio la Galleria d’Arte Moderna
di Milano (GAM) con ‘100 anni
Scultura a Milano 1815-1915’.
Q. Corbellini, Primo
bagno al lido, 1873
Dovrei aggiungere che opere di questo tipo, aggraziate, bianche
di gesso o di marmo, nonostante la fortuna che godettero al loro tempo, non
sono il massimo del mio interesse; il che non diminuisce l’importanza della
conservazione (di un gusto, di una moda, di una consuetudine, di un costo) e l’offerta
allo studioso e al pubblico.
marzo 2017
***
KANDISKIJ IL VIAGGIO INTERIORE
Il cavaliere S. Giorgio e il drago 1914-15
Una mostra su di un artista come Kandinskij è sempre un fatto importante. Ne avevo già scritto per la
mostra di Palazzo Reale 2013-14 con opere provenienti dal Centre Pompidou e
così iniziavo con una generale descrizione dell’ambiente culturale europeo
quando Kandinskij si sposta dalla natale
Mosca a Monaco: “Una
prospettiva meccanico-materialistica, che aveva accompagnato lo sviluppo
industrale del secoloXIX, era entrata in crisi alla fine di quello stesso
secolo. La psicologia e le scienze fisiche ridefiniscono il mondo e i
poteri della mente umana: atomismo, elettricità, magnetismo, ipnotismo
spalancano nuovi universi. Mentre a Parigi Charcot cerca di controllare
l’isteria, e Marie Curie se ne interessa, Bergson fa una distinzione tra “Matière
et Memoire”; a Vienna Klimt fonda la nuova ‘Secessione’ e due medici , Freud e Schnitzler
pubblicano, l’uno “L’interpretazione
dei sogni”, l’altro, a proprie spese, “Girotondo” , che subito incappa nella censura”.
L’Art Nouveau o Jugendstil sono la moda diffusa da Vienna a Parigi a Londra:
stoffe, tappezzerie, grafica, mobili, vetri. Trionfa ‘le coup de fouet’, la
linea serpentina. La decorazione, le arti applicate godono della stessa stima
dell’Arte con l’A maiuscola.
L’attuale mostra
, inaugurata il 15 marzo 2017 al MUDEC (Museo Delle Culture) Milano,
rimarrà aperta sino al 9 luglio. Si tratta di 49 opere (incisioni,
disegni, pitture) e di 85 tra icone, stampe popolari ed esempi di arte
decorativa, tutte provenienti da musei e collezioni russe. Il numero delle
stampe (v. Caduta del falso re) e
oggetti vari rispetto alle opere dell’artista risulta forse eccessivo.
Riprendo alcuni
momenti ben noti della vita di Kandinskij, 1866-1944: nel 1889 a 23
anni, studente in legge all’università di Mosca, partecipa, come membro della
Società imperiale di scienze naturali, antropologia ed etnografia, ad una
spedizione di studio nelle campagne ugro-finniche del Vologda. "Non dimenticherò mai le grandi case di
legno ricoperte di incisioni. In queste case meravigliose ho vissuto
un'esperienza che non si è più ripetuta da allora. Esse m'insegnarono a
muovermi nel quadro, a vivere in esso." (V.K., Sguardo al passato (1901-1913),
1913, in Tutti gli scritti, vol.II, Milano1974 p.161). Nel 1896, laureato e sposato, decide di
dedicarsi alla pittura e di trasferirsi a Monaco, una capitale della cultura
moderna seconda solo a Parigi. Conosce abbastanza il tedesco dalla prima
infanzia, quando la nonna, di origine baltica, gli raccontava le favole in quella
lingua. Frequenta corsi privati di pittura e, per liberarsi dall’accademismo,
si indirizza verso un ripensamento dell’arte popolare con la tecnica della
xilografia:
Il tema del cavallo
e del cavaliere come segno dell’energia e della sfida compare già nel 1901 e in
un dipinto ad olio del 1903, Il cavaliere
azzurro (l’azzurro del cielo, della trasparenza, dello spirito):
La grafia Jugend, l’esplosione coloristica ‘fauve’ e lo slancio arcuato de ‘Il
muro rosso’ 1909, guida anche
alla direzione obliqua delle pennellate, prelude agli sviluppi futuri:
Kandinskij lavora
ad alcune forme di scrittura con immagini che definisce come Klänge, Sonorità,
interpretando colori e figure come espressioni
musicali. E’ il suono piuttosto che la rappresentazione del mondo esteriore
ad animare quella forza interiore che si trova alla base della creazione artistica.
Tra viaggi, in compagnia della pittrice Gabriele Müster, mostre e appunti, dopo un lungo
lavoro completa e pubblica, tra il 1910 e il 1911 ‘Lo spirituale nell’arte’.
Cita la Teosofia di Rudolf Steiner, la
signora Blavatzky, gli Indù e il Lombroso delle sedute spiritiche. Sente
l’urgenza di un cambiamento totale, la necessità di curare una malattia di cui
soffre una società che ha perduto la ricchezza della propria interiorità.
L’artista ha un compito salvifico. Con la collaborazione musicale di Schönberg e Skrjabin e insieme ad alcuni amici, quali Franz Marc e August
Macke, guida il gruppo del ‘Cavaliere Azzurro’. Oltre alla
esposizione il progetto prevede la stampa di una specie di manifesto, una
pubblicazione periodica, ‘l’Almanacco’, Der Blaue
Reiter Almanach, che non
andrà al di là del primo numero per lo scoppio della guerra. L’espressione
artistica oscillerà tra la ‘pura astrazione’ e il ‘puro realismo’ di Henri
Rousseau (l’ingenuità premiata). La copertina è di Kandinskij:
La creazione dell’Almanacco
“può essere visto come un atto apotropaico, un atto insieme di esorcismo e di
cura magica… per restaurare una società malata
di una molteplicità di aspetti materialisti. Dal San Giorgio della
copertina alle illustrazioni, gli autori intendevano che la pubblicazione
avesse chiaramente un effetto curativo” (Peg Weiss, Kandinsky in Munich, New York 1982), da un ex voto bavarese su
vetro ‘S. Martino e il mendicante’, a
una pittura su vetro dello stesso Kandinskij ‘La festa di Ongissanti’ , al ritratto del dottor Gachet di Van Gogh, a una maschera del Gabon (‘colui che vince la morte’), a una
miniatura persiana ecc. E nella mostra
del gruppo sono esposte sculture Tolteche, il mantello di un capo tribù dell’Alaska,
maschere di Ceylon (‘Il demone della malattia’),
delle isole Machesi, Pasqua e Nuova Caledonia. La consistente presenza
etnografico-religiosa richiama l’ispirazione antirealistica, antimaterialistica
del gruppo, la volontà ‘curativa’. Il cavaliere diventa una freccia, una
energia che scardina l’ovvio, il luogo comune nella direzione di una nuova
libertà. La luminosità del bianco diventa nel successivo dipinto del 1913 il
bordo di un’onda. Il cavaliere, a sinistra in basso, scaglia la sua lancia
chiara contro l’oscurità del mostro. Profili di monti inquadrano la scena.
Natura e supernatura.
Vorrei terminare con un’opera più tarda, del ’16, ‘Gli ingenui’, un accenno di figure intrappolate in una specie di corte, per aggiungere alcune considerazioni.
Kandinkij, pur
indicando i suoi lavori con termini psicologico-operativi, Impressione, Improvvisazione, Composizione, vi include un certo
divertimento narrativo, una ricca vibrazione sentimentale, quasi religiosa: una
via verso l’altrove. Il suo mondo è vario di memorie, di figure sacre, estranee alla preparazione accademica; la sua
tavolozza è squillante, i suoi tracciati sicuri, i passaggi graduati nelle sfumature,
i profili mobili, inquieti. Questo mondo finisce con lo scoppio della guerra e
con la necessità di abbandonare Monaco . Altri tempi lo attendono:
organizzativi nella Mosca rivoluzionaria, didattici al Bauhaus, una biologia fantastica a Parigi. A Monaco Kandinshij ha scoperto
la sua vocazione, ha svelato una via ‘astratta’ libera dalla ripetizione accademica,
uno sguardo nella propria interiorità che diventi esempio per tutti. Siamo
stati abituati a pensare la pittura non figurativa come una fredda geometria.
Ecco, Kandinskij ha dimostrato la possibilità tumultuosa, avvincente, di
un’altra strada.
marzo 2017
***
MANET l'enigma
Émile Zola 1868
Il Musée
d’Orsay estende spesso la sua presenza con importanti prestiti ad altri Paesi,
e spesso l’Italia ne ha beneficiato: Milano con Cézanne nel 2011 e Torino con Degas
2012, Renoir 2013, Monet 2015. Ora torna al Palazzo Reale di
Milano con Manet (e la Parigi moderna),
accompagnata da un bel catalogo SKIRA a cura di Guy Cogeval,Caroline Mathieu,
Isolde Pludermacher, indispensabile complemento della mostra che pur manca di
alcuni capolavori come Le déjeuner sur
l’herbe, Olympia, Le bal des le Folies-Bergère . Difetto
che si è accompagnato a tutte le mostre che il Musée d’Orsay ha offerto in
Italia. In ogni caso il termine Impressionisme (al quale Manet non ha
mai aderito) e i nomi degli artisti che ne fanno parte sono talmente popolari
che il successo è assicurato. E provo ora, nonostante la importante
bibliografia di cui gode, a fermarmi su
alcuni aspetti del personaggio, oggi al centro della esposizione milanese,
Edouard Manet, figura forse non così allegra, elegante e semplice come si è
soliti considerare: la sua cocciuta volontà di esporre nei tradizionali Salons dai quali è costantemente
rifiutato, i suoi ammiratori che lo
respingono (scrive Zola, suo primo sostenitore, nel 1879: “Manet appare
esaurito dalla produzione affrettata; egli non studia la natura con la passione
dei veri creatori”), nel ’52 ha forse un figlio naturale, Léon (si dubita che fosse
invece figlio del padre), dalla sua maestra di
piano l’olandese Suzanne, convivente e poi moglie undici anni dopo, affetti incerti (con Berthe Morisot?, della
quale dipinge dodici ritratti, andata poi sposa al fratello ), nel ’79 i primi
sintomi di una malattia, l’atassia di origine sifilitica, che lo porterà alla morte quattro anni più
tardi, nell’83 a cinquant’uno anni,
gli ultimi quadri a pastello per la sua impossibilità a dipingere in piedi, sino
alla amputazione della gamba sinistra. Dunque, nonostante alcuni tardivi
riconoscimenti (1881 ‘Cavaliere della Legion d’onore’ proposta dall’amico
Antonin Proust, divenuto ministro delle Arti), una carriera artistica faticosa,
ma una fedeltà assoluta alla sua dedizione artistica. Moderno? Dove comincia (o finisce) il moderno? Con la disfatta di
Sedan e la Comune di Parigi 1970-71 (Manet è a Parigi)? Oppure nello studio del
fotografo Felix Nadar? Oppure…. E la modernità di Parigi comincia con gli
sfondamenti del barone Hausman? In un certo senso sì, ma altri aspetti, secondo
i diversi punti di vista, segnano importanti cambiamenti, gli sviluppi delle
scienze, della medicina, dei trasporti ecc. Nella prima
fotografia parigina d’epoca con cui si apre il catalogo una torre gotica si
innalza sopra la strada dove una carrozza a due piani è trainata sulle rotaie da due cavalli.
Una
complessità, una cornice appropriata alla ricerca di Manet, con il suo guardare
agli artisti del passato Tiziano, Hals,Velasquez, Goya, i giapponesi, e insieme
la sua tecnica veloce, spavalda, un’abile sprezzatura, e poi il taglio
inconsueto, l’incrocio degli sguardi. Provo a prendere alcuni esempi:
‘La
cameriera del café-chantant’ (1878-79) - soggetto ripetuto anche in altri formati - voltandosi guarda fuori dal quadro, sposta gli occhi su di me, sul guardante.
Vedere senza essere visto (Foucault), I clienti, abbozzati di spalle, guardano
verso il palco dove della cantante s’indovina solo il braccio e il profilo del
vestito. Un giro di sguardi, il principale dei quali porta fuori dalla scena,
trattata con pennellate veloci, frustate, in diverse direzioni: “finito del
non-finito”. Si distinguono la pipa chiara e il cilindro scuro, la birra nel
vetro dei bicchieri appena visibili sul lato destro e nell’angolo a sinistra.
Ricordo giapponese di sfondo. Le piccole luci volano in alto.
‘Il balcone’ 1832-33. Il quadro misura cm 170 x 125. I
personaggi, amici dell’artista, hanno posato a lungo cinque volte: Berthe Morisot a sinistra col
ventaglio, Fanny Claus, violinista, coi guanti e l’ombrello (simmetrico, in
obliquo al ventaglio), dietro Antoine Guillement, pittore e, nella penombra,
col vassoio, forse Léo Koella, nipote dell’artista. Una specie di semicerchio dalla
luce al buio. Nessun dialogo, ciascuno guarda in una direzione diversa, sguardi
perduti nel vuoto, con una gradazione più sfumata dal primo piano della Morisot
agli altri due, il ragazzino confondendosi nella oscurità. Come nella
‘cameriera’ non c’è un dialogo interno - seppure la stanza lo potesse prevedere
- ma neppure un contatto con l’esterno. Piuttosto una infinita, triste
solitudine, dove anche la bianchezza fantasmatica dei vestiti introduce alla
oscurità dell’interno, dove anche gli oggetti, angolo dello sgabello,
ventaglio, ombrello, cravatta, il fumo del sigaro, piccoli cenni dei vetri
sono il pendant vibratile di quella luce muta a cui si dirigono, solitari, gli
occhi. Altro che Joie de vivre!
‘Berthe
Morisot con un mazzo di violette’ 1872. Ancora occhi.
Da quella oscurità dei panni, da quella fasciatura che l’avvolge, gli occhi ingranditi ci interpellano, ci
attirano nell’inganno della immagine. La scena del dipinto non ritrae solo il
soggetto ma anche la risposta del guardante: un fuori spazio, una assenza. Il
mazzo dei fiori è solo una variazione del nero e segna lo sbocciare del corpo e
del viso.
Ritorno ora
sul ritratto di Zola, misure ragguardevoli, cm 146 x 114, un ringraziamento
allo scrittore e una dichiarazione di preferenze, una specie di manifesto. Arretro al ’63, quando Manet espone Le déjeuner sur l’herbe al Salon
des Refusés e in seguito alla sua mostra personale in occasione della Esposizione Universale del ’66: scrive
Zola che «il posto di Manet al Louvre è segnato,
come quello di Courbet». Il Louvre, il museo dei capolavori! L’articolo viene
ripubblicato in forma di opuscolo con la copertina azzurra come compare, nel
ritratto, sul tavolo. Nelle riproduzioni sovrapposte incorniciate a parete, la
prima è la Olympia, la seconda è una
stampa di un lottatore giapponese di Utagawa Kuniaki II, la terza, semicoperta,
la ‘Festa di Bacco’di Velasquez. Il
Giappone ricompare nel paravento di sinistra. Il libro tenuto in mano da Zola è
‘L’Histoire des peintres’ di C.
Blanc. Non c’è più motivo di uscire con lo sguardo dal quadro. Tutti gli
elementi che interessano al pittore sono dentro il quadro.
Ho scritto ben poche note
rispetto ad una ricca e inquieta produzione pittorica, agli straordinari tagli,
inquadrature spiazzanti di opere come ‘Le
Bal Masqué’ oppure ‘Le Déjeuner à l’atelier’oppure
‘Un bar aux Folies-Bergère’…(nessuna esposta inquesta occasione). Rimarranno nel tempo, il contrario, per fortuna, di un felice, facile trionfo
sociale.
marzo 2017
BOSCH e VENEZIA
Venezia, isola,
porto, incontro di stranieri, navigatori, commercianti, avventurieri,
traduttori, lontananze… E lontano dai trionfalismi cinquecenteschi,
l’abbassamento di tono nelle raffigurazioni religiose era già stata opera della
tradizione fiamminga quattrocentesca. Ma con Bosch ('s-Hertogenbosch, 1453 – 1516) l’abbasamento
diventa una scavazione, un fuori luogo,
fuori da ogni luogo. Ora la mostra Jheronimus
Bosch e Venezia, Palazzo Ducale, 18
febbraio 4 giugno, ripropone, tramite la collezione Grimani, la
eccezionalità della sua opera, di cui è appena trascorso il centenario della
morte. E’ di aiuto il bel catalogo a cura di Bernard Aikema. Il punto di
partenza sono le tre opere dalla
raccolta del cardinale Domenico Grimani. Il documento più antico che ne
riporta la presenza è quanto ne scrive nel 1521 il critico d’arte veneziano
Marcantonio Michiel in visita alla collezione del cardinale, suo concittadino:
«La tela delinferno cun la gran diuersità de monstri fo de mano de Hieronimo
Bosch. La tela delli sogni fo de man delinstesso. La tela della Fortuna cun el
ceto che ingiotte Giona fo de man de linstesso». Anche se non è chiaro la
collocazione, se mai ci sia stata, della ‘tela della Fortuna’, Michiel scrive
pure di “molti altri quadretti..e tavolette” provenienti dalle Fiandre. Due
anni dopo, nel 1523 muore il cardinale Grimani lasciando le sculture e i
dipinti della sua collezione alla Serenissima Repubblica per pubblica fruizione.Le
sue volontà furono rispettate solo per le sculture, esposte in Palazzo Ducale,
non per i dipinti, che furono trasportati (tutti?) nei sotterranei dello stesso
Palazzo, da cui vengono recuperati solo nel 1615 e documentati per iscritto
solo nel 1733, più di 200 anni più
tardi!
Non ho
intenzione o la pretesa di intraprendere un discorso su Bosch che dal 1600 in
avanti conosce una popolarità unica tra gli artisti,
grandi artisti fiamminghi, di quel periodo. Soltanto qualche cenno. E’ un
benestante, viene da una famiglia di artisti-artigiani, il suo non comune nome
Jheronimus probabilmente proviene dal san Girolamo patrono di un ordine
monastico, i “Fratelli della Vita Comune”,
e Bosch, Bosco, dal nome della sua città. Non sembra abbia sofferto delle
tragiche guerre di religione che si stavano svolgendo nel suo
paese, se non, indirettamente, nel mondo sconvolto da lui dipinto. Anzi, i
maggiori suoi clienti furono figure di spicco dell’aristocrazia, connessi con
la monarchia asburgica e spagnola, Filippo il Bello, Margherita d’Austria,
Enrico III di Nassau, tanto che la principale collezione dei suoi lavori, ora
al Prado, fu accumulata dal
cattolicissimo Filippo II di Spagna, acerrimo nemico delle Chiese cristiane
riformate. Certo le sue “chimere e stregozzi” non sembrano soltanto curiosità
da ‘Wunderkammer’, ma incubi di un mondo condannato al martirio collettivo, dia-bolico (colui che divide), dove le parti sono capovolte, i corpi spezzati.
Non una simbologia, ma il contrario del
simbolo che unisce e armonizza le varietà. Perciò una disperazione
irreparabile, senza speranza. Certo, spostare queste immagini nel sogno o nella metafora o nello scherzo è
un modo per minimizzarle: il sogno
diventa un incubo, uno sprofondamento.
Anche la sua prospettiva ‘psicologica’ spiazza l’uniformità del racconto, non
obbedisce alle regole ottiche prestabilite, punto di fuga, Brunelleschi, Dürer
ecc. La sua tecnica tardo gotica isola, separa; i suoi scatti di misura sono il
contrario di uno spazio ottico unitario, pur rispettato in una stesura morbida
e volumetrica. Così lo scontro, la
contraddizione tra un visibile accurato e un significato perduto risulta più sorprendente.
Ora vengo
alle opere del cardinale Grimani.
Crocefissione
di Santa Octommernis, figlia di un re pagano, promessa a un Principe che lei,
cristiana, vuole evitare, alla quale Dio, per proteggerla, aveva fatto crescere
la barba (ancora se ne intravede un’ ombra nel quadro). Ma il padre la condanna
alla crocefissione. Immobilità serena della santa, mescolanza straordinaria
della folla, presa da diversi punti di vista. Alti dignitari a destra (il
primo, forse, il padre), poveracci usciti dal tronco bucato a sinistra, dietro
alla caduta del giovane, forse il promesso sposo pagano rifiutato, la buca
scavata, forse per un morto che non ci sarà. Tre ‘forse’, l’ambiguità del
soggetto.
Fontana della vita in alto, tra i cespugli un leone che ne divora un altro, anime salvate dagli angeli (a sinistra) e in ascesa al Paradiso, succhiate in un imbuto luminoso (a destra).
San Girolamo tra le rovine di un edificio pagano circondato
da figure malefiche. La consueta descrizione meticolosa sia di personaggi
normali che di presenze e nature sconvolte: il solito capovolgimento, anormali
diventano le prime e normali le seconde.
La diffusione di
questo mondo avviene anche con la grande diffusione di disegni e incisioni, che
si ripete nel tempo. Vi rientra anche la figura di Pieter Bruegel il Vecchio, ma
nato70, 80 anni dopo, citato pure dal Vasari e autore de ‘La torre di Babele’
(non in mostra), soggetto ricorrente negli inventari dei quadri Grimani. La
doppia prospettiva, dall’alto e dal basso, aumenta l’imponenza della torre. A sinistra il re Nembrot,
simbolo di superbia, è seguito da un gruppo di cortigiani
e soldati mentre l'architetto gli mostra la sua opera e gli scalpellini sono inginocchiati in segno ossequio.
A tutti i
numerosi esempi boschiani della mostra riprendo solo la ‘Bocca dell’inferno con
nave di Caronte’, scena dell’olandese Jacob Van Swanenburg nato a Leida nel
1571, con soggiorni anche a Venezia, Roma e Napoli, dove ebbe problemi con
l’Inquisizione.
Come erano
giunti i quadri di Bosch nella collezione Grimani? Il cardinale era personaggio
di grande cultura ed interessi, sia verso una repubblica di tipo erasmiano che
per una riforma sul modello indicato dal papa olandese Adriano VI. Le collezioni
del cardinale erano ricche e varie: monete, cammei e agate, statuaria antica e
arazzi, quadri e fogli miniati (il cinquecentesco breviario ‘Grimani’). Le sue letture spaziavano dalle speculazioni
neoplatoniche alla cabala ebraica, opere passate pure tra le mani del grande
stampatore Aldo Manuzio. Ma un’altra figura sarebbe stata tramite alle tavole
di Bosch, il fiammingo Daniel van Bomberghen, noto per la sua dimestichezza con
i fatti artistici nelle Fiandre e la sua fitta rete di attività commerciali europee;
avrebbe acquistato le opere rimaste nella bottega dopo la morte del pittore nel
1516 “per poi girarle al suo magnifico cliente veneziano” (Bernard Aikema p.
24). Uniche, di questo artista, rimaste poi in Italia.
Ma tale vivace e pacifica collaborazione internazionale tra eruditi, dotti religiosi, filosofi, traduttori, collezionisti s’interrompe con la
nomina del pontefice Paolo III, fautore di un Concilio mirato al’affermazione
di una sola rigida ortodossia, il
Concilio di Trento, 1545.
marzo 2017
***
MERET HOPPENHEIM TRA IO E NON-IO
Autoritratto 1980
Una ricca mostra al Museo d’arte
della Svizzera italiana (MASI Lugano) di Meret
Oppenheim, dal 12 febbraio al 28 maggio 2017, presenta una figura tanto
nota quanto sfuggente. La esposizione,
curata da Guido Comis in collaborazione con Maria Giuseppina Di Monte, la pone
‘in dialogo’ con amici e colleghi come Man Ray, Marcel Duchamp, Max Ernst,
Alberto Giacometti, René Magritte. Pur essendo una giramondo, il luogo di
Lugano – leggo dalla presentazione – si trova “a pochi passi da Carona, borgo
caro all’artista che lì, nella casa di villeggiatura di famiglia, trovò un
rifugio sereno anche nei momenti più inquieti della sua esistenza”.
L’autoritratto con tatuaggio del
1980, a 67 anni, si può mettere a confronto con la foto “Erotique”, nuda dietro
al torchio, scattata da Man Ray nel
1933, a 20 anni.
Sempre lei, soggetto e oggetto
dell’occhio fotografico.
Provo a indicare alcuni dati
biografici. Nasce a Berlino
(Charlottenburg) nel 1913 e muore a Basilea nel 1985. Ama la psicologia, la letteratura
e, in particolare, la pittura. Si reca a Parigi dove conosce Alberto Giacometti
e Hans Arp che la invitano a esporre nel 1933 al Salon des Surindependentes entrando a far parte del gruppo
Surrealista. Si fa fotografare da Man Ray nel 1934, nuda davanti al torchio
(vedi sopra). E’ del 1936
Colazione in pelliccia, comperata dal Museum of Modern Art di New
York, che diventa quasi la sigla del Surrealismo.
A partire da qui si potrebbero individuare almeno due caratteristiche dei
suoi interventi. Considerare se stessa,
il proprio corpo, la propria soggettività un elemento indisgiungibile
dall’oggetto/opera e considerare l’oggetto/opera l’assunzione di una animalità,
di una vibrazione, di una posizione che contraddice ogni plausibile utilità;
mai servire a….
Le due scarpe si baciano o si impediscono reciprocamente? Come non si
può bere dalla tazzina in pelliccia, non si può camminare con gli stivaletti
saldati in punta. In ogni caso si tratta di una
umanizzazione degli oggetti e, in se stessa, l’autrice, di una
oggettivazione dell’umano. Qualche volta l’oggetto è una animalizzazione, o
nella mano impellicciata 1936
o nel tavolo con le zampe d’uccello 1939 (1982)
Un esempio vicino, “in dialogo”,
con queste mescolanze “Il modello rosso”
di René Magritte 1947
Finisco con un diverso autoritratto ‘radiografico’ dell’artista, 1964
Ci può essere ironia o senso di morte, ma la presenza dell’artista in
quanto tale e in quanto manipolatrice è una costante. Gli oggetti sono
soggetivizzati e il soggetto-autrice oggettivato.
L’io,
il soggetto, l’artista non può dissociasi dall’opera, è la propria opera,
corpo, viso, cranio, anche se, per mestiere, deve trasformarsi in un oggetto di esposizione. E gli altri
oggetti? L’include nella propria soggettività privandoli in vari modi di ogni
possibile uso, guanti, scarpe, tavoli, tazze, restituendo loro la forza di una gioiosa, libera, divertita animalità. Non c’è
una realtà da rappresentare, un non io,
ma un’attività che agisce nelle sue capacità
di trasformazione sia sul
proprio io che sugli oggetti esterni, rendendo gli uni e gli altri
mutevoli e sfuggenti, contrari perciò all’autorità separata dell’artista e alla ovvietà
dell’oggetto. Calarsi nella propria corporalità, anche nei suoi angoli incerti,
e assorbire, ricostruire, capovolgere, ridefinire i corpi esterni, interiorizzarli. Una capacità che il
Surrealismo degli anni trenta non si era lasciato sfuggire.
febbraio 2017
***
GIUDITTA EROISMO E SEDUZIONE
La mostra Attorno a Klimt. Giuditta, eroismo e
seduzione, aperta al Centro Candiani di Mestre il 14
dicembre 2016 e visitabile sino al 5 marzo del 2017, presenta due novità: il
coinvolgimento della Municipalità di Mestre, solitamente esclusa dalle grandi
mostre, e il carattere di una lunga
vicenda iconografica, la figura biblica di Giuditta, nel nostro caso a partire
da una incisione tedesca del 1493 per giungere alla seconda versione di Gustav Klimt, acquistata per la Galleria
di Cà Pesaro in occasione della IX Biennale di Venezia del 1910, dove il
pittore, nella sala delle Secessione austriaca, espone 22 opere. La mostra è
accompagnata da un utile catalogo curato da Gabriella Belli con la
collaborazione di Elisabetta Barisoni, Matteo Piccolo, Flavio Caroli e Gian Piero Brunetta per il cinema.
La vicenda
della bella vedova Giuditta che incontra il condottiero assiro babilonese
Oloferne, il quale si accinge alla conquista della città ebraica di Betulia,
diventa particolarmente popolare dal medioevo in poi. Nella loro intimità
notturna la lama della donna cala su di un uomo annebbiato dal vino e
dall’eccitamento amoroso. Giuditta ritorna trionfante con l’ancella e la testa
mozzata nella cesta. Nomi illustri rappresentano la scena, Donatello, Mantegna,
Botticelli, Michelangelo, Giorgione, Tiziano… Ma io vorrei arrivare al dipinto di Caravaggio
1598-99 (non esposto in mostra) e a quello che ne segue.
E’ un’opera
giovanile di Caravaggio ma la crudeltà esibita anche da quel correre di
espressioni e di età, la vecchia di profilo preoccupata, l a giovane di tre
quarti, soda, concentrata, appena due rughe in fronte, con una mano stringe i
capelli di lui, con l’altra abbassa senza sforzo la spada, la vittima, viso
pieno, rovesciato nell’urlo, l’occhio spento, lo zampillo del sangue… Non c’è
giustificazione religiosa o difesa patriottica, ma teatralità compiaciuta, con
quel giro di panni tra oscurità e lampi di luce.
Ora c’è una brava seguace di Caravaggio,
Artemisia Gentileschi. Tra tanti artisti maschi lei è una donna che dipinge una
figura femminile. Caso molto raro. Lo schema è quello di Caravaggio ma con
particolari diversi. Le due donne hanno più o meno la stessa età e si aiutano a
vicenda. Giuditta è grassoccia, vestita con particolare eleganza, larga
scollatura, per nulla preoccupata. Il viso della vittima, quasi del tutto in
ombra, pare rassegnato oppure già spento nella morte. Ginocchio in vista,
nudità appena coperta. Il sangue si spande sulle lenzuola.
E poi, con
la fuga e la testa decollata nel cesto, le due donne, sempre molto eleganti in
due modi diversi, Giuditta con la spada in spalla, si voltano, attente che
nessuno le segua, con atteggiamento di complicità.
Artemisia,
com’è noto, aveva subito nel 1611 uno stupro da parte di Agostino Tassi, suo
maestro e collaboratore del padre Orazio, a cui era seguito un processo. I
commentatori successivi hanno sempre connesso la scena dipinta con l’affronto
subito. Perciò nella storia di Giuditta si sposta il significato da un gesto
religiosamente ispirato ad una vendetta di una brutale violenza sessuale: da
una funzione eroica ad una funzione erotica. Mi
sposto ora alla seconda metà dell’800 quando la figura femminile, sempre
descritta e dipinta da artisti maschi, è la femme
fàtale seduttricce/castatrice. La
spinta della passione erotica è insieme la distruzione dell’alterità,
dell’altro. Attrazione e timore. Anche la malattia punisce l’appagamento
erotico non regolato. Confini mutevoli invadono la passione maschile e la
subordinazione femminile, spesso uniti in un terreno mobile, dove il potere
femminile si concentra nella seduzione sessuale mentre quello maschile si arma
di scienza e di funzione pubblica. Medici, psichiatri, politici, giudici,
poliziotti sono maschi. La figura dell’artista assume una funzione incerta. Non
è più l’espressione di una casta aristocratica ma neppure il dipendente di un
onnivoro mercato: è una figura instabile che usa la propria pericolosa
ambiguità per esprimere scelte che il ‘buongusto’ maggioritario stenta
ad accettare. Le regole non sono più la applicazione di principi consolidati,
ma procedimenti innovativi, traguardi imprevisti, risultati sconvolgenti.
Naturalmente sono caratteri sociali che s’innestano in un mondo in veloce
trasformazione: la finis Austriae, il
pangermanesimo, il razzismo, le
organizzazioni operaie… L’eccentricità
dell’artista gli permette una certa libertà di movimento e di libertà culturale.
La novità di Gustav Klimt, che espone, come ricordavo, alla Biennale di Venezia del 1910, non è
abbastanza per Ardengo Soffici e Umberto Boccioni, né per il pubblico che ne
irride le deformazioni o i gazzettieri che scrivono di eccesso decorativo. Non
per il direttore della Biennale, Nino Barbantini che, con l’appoggio del Comune,
acquista la ‘Giuditta’ II, una
seconda versione dello stesso soggetto.
No, non il
ricordo di un’antica storia religiosa, ma piuttosto la fantasia di un Oriente
giapponese fantastico: la figura è tagliata sui lati, quasi spiata dalla
fessura di una porta, la capigliatura enorme, scura, un’onda larga sui lati che spinge fuori la carne
pallida, estenuata, svestita da una stoffa nera sulla quale s’intrecciano frecce,
si avvolgono riccioli, precipitano onde,
brillano punti elettrici, i tondini tra collo e spalla che richiamano i
capezzoli, le labbra, il neo sullo zigomo. Le palpebre abbassate sotto l’arco
nero del sopraciglio indicano un vedere assente, i suoi occhi stanchi sono
semichiusi, come le labbra( quelli di Oloferne, affondato nel sacco, chiusi dalla morte), le dita curve graffiano -per
comprimere la propria furia?, una mano, ricca di bracciali, tiene con le punte
i capelli del morto. Seduzione-castrazione, la donna che attrae e distrugge,
vendica la sua deflorazione: l’artista ha la libertà di esaltarla, il medico
Charcot di studiarla nel manicomio, l’antropologo nel primitivo, l’avvocato nel
postribolo. Certo la vicenda non è così schematica e la rappresentazione
artistica gode di una fortunata ambiguità, favorita anche, come nel caso di
Klimt, dalla sorprendente varietà espressiva: suggestioni orientali e
bizantine, compresenza di microbiologia ed anatomia, femminilità denudata e
ricchezza di ori (per es. Giuditta I
e Le tre età della donna); in
particolare luoghi di raffinato realismo e spazi di sconfinata invenzione
astratta. Altri artisti che seguiranno, pur con risultati interessanti, non saranno più in grado di tenere insieme
queste spinte divergenti che si arricchiscono nel contrasto. Due esempi
significativi nella loro diversità sono ben presenti in mostra, quello molto
corporale di Luigi Bonazza
Jovis Amores. Leda 1912
e quello di
Vittorio Zecchin, fiorito, fitto, tante murrine, fuochi
d’artificio, quasi un’astrazione
Corteo delle
Principesse 1914
Naturalmente
in questa rubrica il percorso è appena indicato. M anche quello della
ricca mostra di Mestre potrebbe
ampliarsi indefinitamente. L’immagine dipinta è un punto di arrivo e una
freccia di partenza. Non ci sono traguardi definitivi. E’ bene averla fatta
uscire da una parentela troppo stretta, quella del singolo autore, e averla
fatta correre non solo sul percorso temporale, la cosiddetta ‘storia’, ma su quello del soggetto significante, là
dove le differenze sono altrettanto importanti delle somiglianze.
gennaio 2017
***
Venerdì
27 gennaio, in occasione della GIORNATA
DELLA MEMORIA, Il Museo MADRE di Napoli, nel programma di visite didattiche
alla mostra di FABIO MAURI, presenta all’inizio
e al termine del percorso, la lettura di
due testi dell’Autore, ‘Ebrea’ 1971 e
‘La Resa’ 202, da cui traggo il
finale: “E’ la resa del giudizio… E la Storia, cui ho sempre dedicato attenzione…
in fine stritola la coscienza in un cappio di stupore e ribrezzo… Questa mia è
una resa formale. Una bandiera bianca. Una certa misura di resa può scoprire
forse alternative inedite di pace”.
FABIO MAURI TRA FINE E AFFINE
 |
| Fabio Mauri |
Fabio Mauri muore nel maggio 2009. Nel 2016 appena
trascorso si sono aperte sei mostre di sue opere, la retrospettiva al MADRE
Museo di Napoli “Luce solida” (aperta sino a marzo 2017), al P. Guggenheim e
alla Punta della Dogana a Venezia, alla GAMeC di Bergamo “Arte per legittima
difesa”, alla “Roma Pop City” MACRO di Roma, alla Kunsthalle di Dresda “Le
misure del non-uomo”. Pur aggiungendo che la sua presenza è curata allo Studio Fabio Mauri Associazione per l’Arte,
mi pare che risulti oggi quasi più vivace di quando l’artista fosse in vita.
Una vita tutt’altro che lineare. Provo a riprenderne alcuni dati. Figlio di
Umberto Mauri e Maria Luisa Bompiani, cresce in una famiglia attiva nel settore
editoriale. Ha vissuto a Bologna e a Milano fino al 1957, poi si trasferisce a
Roma. Nel 1942, a 16 anni, con l’amico Pasolini, fonda la rivista “Il
Setaccio”. Dal 1954 opera nell’ambito dell’avanguardia artistica. 1959, Con
Pasolini partecipa a ‘Officina’. Fa parte del ‘Gruppo 63’ e nel ’68, con Eco,
Sanguineti e Guglielmi fonda la rivista ‘Quindici’. Più avanti, nel ’76, è nel
gruppo del periodico ‘La Città di Riga’. Accanto all’impegno artistico, mostre,
installazioni, performance (per esempio con “Inverosimile” nel 2007 a
Milano-Bicocca in collettiva “Not Afraid of the Dark”), inviti alle Biennali di
Venezia nel 1954, 1974, 1978, 1993, 2003, lavora nella direzione della casa
editrice Bompiani e insegna Estetica all’Accademia di Belle Arti dell’Aquila.
Dunque una vita intensa, ramificata, tutt’altro che omogenea. La malattia è
sempre in agguato, una minaccia e un segno. Leggo in una bella pubblicazione di
Federica Boràgina su Fabio Mauri, Rubettino 2012: “…negli anni del Fascismo e
del Nazismo l’esperienza della guerra ha lasciato ferite sulla sua persona. Nel
dopoguerra l’artista è stato affetto da una malattia nervosa che lo ha
costretto a essere ricoverato ripetutamente in ospedale ed a un lungo periodo
di degenza in una clinica psichiatrica in Svizzera dove ha subito ben trentatré
elettroshock” (p. 65). Ai suoi frequenti lavori sulla persecuzione ebraica
dichiara: “Io non sono ebreo, né figlio di ebrei. Ho desiderato, anche, di
esserlo. Mi sento ebreo ogni volta che posso e patisco ingiusta
discriminazione. Fare un’operazione sul tema è complementare il lamento per un
utile noto all’attività poetica e, forse alla salute psicologica. Nessuno può
impedirmi di curarmi come credo”
 |
| Muro Occidentale o del Pianto (1993) |
Nelle crepe del Muro del Pianto a Gerusalemme, dove Dio è in ascolto,
gli israeliti infilano piccoli rotoli di carte con preghiere e richieste.
L’artista li simula inserendo nel suo muro un rotolo di tela bianca, una
preghiera dell’arte. “Vi cresce anche una pianta, segno di un proseguimento di
esistenza frammista che le pietre mute e squadrate o le valige vuote e inerti
nemmeno loro possono impedire” (testo che accompagna l’esposizione di Venezia).
A destra, nell’armadietto verticale aperto, si intravede il nudo femminile che
l’artista aveva presentato in Ebrea 1971, ricordo di ciò che gli ebrei
deportati avevano dovuto abbandonare all’ingresso dei Campi di sterminio. Uno
dei tanti ‘muri occidentali’.
 |
| Ebrea (1971) |
 |
| Ebrea (1971) |
La ragazza nuda ha soltanto la Stella di Davide segnata sul petto; si
accarezza la pelle del piede, forse in un anticipo di quella pelle dei cadaveri
ben diversamente usata. A sinistra la giovane, con il numero visibile sulla
spalla, si taglia i capelli per incollarli sullo specchio dell’Armadietto a
comporre, nuovamente, la Stella. Sul ripiano dello specchio sono appoggiati
scatole e contenitori di pelle, denti, ossa, forbici, capelli… una apparente
banale vita quotidiana, spaventosa quotidianità. Il voluto abbassamento di
tono, lo stravolgimento proprio dell’artista.
Due anni dopo, nel 1973 Mauri inscena la performance Ideologia e natura o, ugualmente, ma
con diversa preminenza Natura e cultura:
Una giovane vestita con la divisa di Piccola Italiana fascista si
spoglia e si riveste in continuazione. È illuminata da una forte luce che
proietta dietro di lei su di uno schermo la propria ombra. Infine rimane nuda,
abbandonando ogni residuo di copertura. L’abito (non) fa il monaco. Si tratta
di due coppie di significato: il primo, la ragazza con la divisa/ senza divisa,
nuda; il secondo, la ragazza, vestita o svestita/ la sua ombra. La conclusione:
il corpo vivo, senza segni vestimentali, appartiene solo a se stesso, non
indica subordinazioni o vicinanze. L’ombra, per quanto dai diversi contorni,
non cambia stato, non è peggiore né migliore, rimane nel regno dei segni. Una
riflessione sui titoli: ’ideologia’
–‘cultura’, sistema fisso di idee,
tendenzialmente totalitario e costrittivo. Al contrario l’artista usa ‘idee’
per smantellare i sistemi fissi e palesarne gli inganni. La ‘natura’ è un
indicatore limite, un ‘esserci’ senza.
Oscuramento è una
performance in tre parti, che si è svolta nell’aprile del 1975 al Museo romano
delle Cere. Per giungere alla seconda parte, la Storia, il pubblico attraversa le varie sale del museo, già
confondendo i nuovi convenuti con le statue di cera:
 |
Persone reali e attori si mescolano ai manichini. Maria Carta canta il
lamento Umbras . Così i visitatori si
accostano alla scena del Gran Consiglio Fascista nel quale Mussolini è
costretto alle dimissioni. Si chiude la
lunga esperienza dello stato fascista con una scena di personaggi falsi e di oggetti, bicchieri, tavoli, busti scolpiti
veri, come vere sono le persone in
carne ed ossa che vi si aggiungono. Verità e falsità, presente e ricordi.
Rappresentazione e vita si mescolano con le proiezioni
cinematografiche praticate dall’artista. La più nota è quella che si svolge con
Pasolini sulle scale esterne della
nuova Galleria d’Arte Moderna di Bologna nel 1975 dal titolo ‘Intellettuale ‘. Il poeta, sistemato su
di un alto sedile, diventa “schermo umano” del suo “Vangelo Secondo Matteo”. Una ‘luce solida’ (espressione di Mauri e
titolo della odierna retrospettiva di Bologna), colpisce il petto di Pasolini
in camicia bianca, mentre il sonoro viene trasmesso con un volume assordante.
Come sempre nelle opere di Mauri i significati di questa teatralità
sono molteplici. Profetici: “era
poco prima che P.P.P. dovese morire”. Soggettivi, per l’autore: “una scena in più della
nostra amicizia, e vita”. Soggettivi,
per il soggetto: “il torace (di Pasolini) assume così il valore di
specchio, di radiografia della propria soggettività intellettuale”. Oggettivi: “autore e opera formano una
scultura di carne e luce, una unità compatta”. E, infine il risultato estetico, un ”teatro per
restituire verosimiglianza a l’esistenza, che è inverosimile”. Le citazioni,
tutte del 1975, sono dell’autore, meno il ‘soggettivo per il soggetto’ di
Alberto Boatto (da ‘Fabio Mauri The End’ di F. Alfano Miglietti, SKIRA 2012).
Insomma l’opera dell’arte, attraverso la soggettività
personale, sofferta dell’artista colpisce, conserva, trasmette, restituisce
un momento della storia collettiva,
nella sue infamia e nel suo splendore.
Ecco allora che la biografia dell’autore Fabio Mauri, tra vestimento e
nudità, è chiave interpretativa della sua opera. La sua giovinezza è transitata
attraverso la dittatura fascista e l’invasione nazista, la sua maturità
attraverso la riflessione di ciò che è accaduto e di come le tracce permangono
di quella tragedia: “la mia vita è consistita nel modo in cui la seconda parte
ha giudicato la prima”. Non solo un tribunale, uno scavo nei disastri, ma la
speranza, attraverso la poesia, di una possibile accettazione del negativo. “The end” Mauri titola le ultime opere,
non soltanto la fine ma il fine della sopravvivenza, l’affinità delle
opposizioni, la via segreta delle parentele. Un percorso difficile, contrastato
nel quale la insopportabilità del negativo, la malattia ne è parte segreta e
palese.
La complessità, la ricchezza
della ricerca di Fabio Mauri ha faticato ad un riconoscimento appropriato, non
solo per la difficoltà degli intrecci, delle tecniche, delle sovrapposizioni,
ma anche per la peculiarità della sua esperienza plurima, la famiglia
benestante, il mondo dell’editoria, la sigla Bompiani, l’insegnamento
accademico, la varietà dei mezzi espressivi, la sofferenza nervosa… Forse oggi,
a otto anni dalla sua morte, è tempo di una accettazione più esplicita di una
particolarissima vivacità culturale che risulta una ricchezza per tutti. [gennaio 2017]
***
100 ANNI FA IL
FUTURISTA
ANTONIO SANT’ELIA…
… allo scoppio della guerra contro
l’Austria-Ungheria si arruola con Marinetti, Boccioni e Bucci nel ”Battaglione
lombardo volontari Ciclisti ed Automobilisti”.
Dopo una serie di scaramucce nella zona del Garda viene trasferito sul
fronte carsico. Il 10 ottobre del 1916 in uno scontro col nemico viene colpito
mortalmente alla testa nei pressi di Monfalcone. Aveva 28 anni. Boccioni era
morto il 17 agosto. Aveva 33 anni.
D’accordo, Marinetti aveva scritto: “Noi vogliamo
glorificare la guerra – sola igiene del mondo… le belle idee per cui si muore”.
Ma Boccioni aveva scritto dal fronte che la guerra, “quando si attende di
battersi, non è che questo: insetti + noia = eroismo oscuro…”.
Dunque 1916-2016. La Triennale di Milano dedica a
Sant’Elia, dal 24 novembre 2016 all’8 febbraio 2017, una mostra di 40 disegni,
la Città Nuova, a cui l’artista
inizia a lavorare dal 1914.
Antonio
Sant’Elia autoritratto
Riprendo alcuni aspetti della vicenda Sant’Elia. Fa parte di
un gruppo (con Chiattone, Funi, Dudeville) vicino al Futurismo, del quale
infine viene a far parte integrante nel giugno del 2014. Il mese seguente
scrive il Manifesto dell’architettura
futurista, pubblicato su “Lacerba”. Il tono rispecchia quello di Marinetti
e di Boccioni (che aveva appena scritto un testo, non pubblicato,
sull’architettura):
“Noi dobbiamo inventare e rifabbricare la città futurista,
simile a un immenso cantiere tumultuante, agile, mobile, dinamico in ogni sua
parte, e la casa futurista simile a una macchina gigantesca. Gli ascensori non
debbono rincattucciarsi come vermi
solitari nei vani delle scale, ma le scale, divenute inutili, devono essere
abolite e gli ascensori devono inerpicarsi lungo le facciate, come serpenti di
ferro e di vetro. La casa di cemento, di vetro, di ferro, senza pittura e senza
scultura, ricca soltanto della bellezza congenita alle sue linee e ai suoi rilievi,
straordinariamente brutta nella sua
meccanica semplicità, alta e larga quanto è più necessario… deve sorgere
sull’orlo di un abisso tumultuoso: la strada, che non si stenderà più come un
soppedaneo al livello delle portinerie, ma si sprofonderà nella terra per
parecchi piani, che accoglieranno il traffico metropolitano e saranno congiunti,
per i transiti necessari, da passerelle metalliche e da velocissimi tapis roilants”.
“… L’architettura futurista è l’architettura del calcolo,
dell’audacia temeraria e della semplicità; l’architettura del cemento armato,
del vetro, del ferro, del cartone, della fibra tessile e di tutti quei
surrogati del legno, della pietra e del mattone che permettono di ottenere il
massimo della elasticità e della leggerezza…”
“…
Per architettura si deve intendere lo sforzo di armonizzare, con libertà e con
grande audacia, l’ambiente con l’uomo, cioè rendere il mondo delle cose una
proiezione del mondo dello spirito…”.
L’omino e la sua ombra, la scalinata (la
salita in alto), i fari che sparano le loro luci su di un cielo rosato. Certo,
non sono disegni progettuali, piante, alzati, misure, particolari, impianti
ecc., ma diagrammi mentali di forze, spinte, tensioni: “una potenza emotiva”
della torre, dei piani inclinati, dei segni obliqui, saette elettriche. Non le
rotture e ricomposizioni di Boccioni, non la folla delle persone e dei gesti, ma
una pluralità di funzioni, di tensioni convergenti al risultato monumentale. Nuove
cattedrali viste dal basso all’alto, sfide al cielo. ‘La città del futuro’,
l’astrazione della città, un concentrato che ignora la bellezza dei
particolari, del singolo edificio, la strada, i negozi, la confusione delle
voci. Il segno della speranza deve essere imperativo, persuasivo, risolutivo. Niente
sarà come prima. Un segno che lascerà un segno.
Una corsa finita troppo presto.
dicembre 2016
****
ANISH KAPOOR NAVIGATORE DELLO SPAZIO
Il
17 dicembre apre al MACRO di Roma – sino
al 17 aprile 2017 - la mostra di uno degli artisti più caratteristici oggi
operanti, dentro e fuori da ogni perimetro prestabilito, dentro e fuori da ogni
chiusura e Galleria d’arte. Anish Kapoor nasce a Mumbay nel 1954 da padre
indiano e madre ebrea irachena. A diciannove anni si sposta a Londra
iscrivendosi ad una scuola d’arte: il suo interesse è guidato dalle macchine celibi di Marcel Duchamp: ingranaggi fantastici. Nel 1979 si reca nel suo paese d’origine,
ricco di spiritualità, e al suo ritorno in Inghilterra si rende conto di aver
maturato una coscienza plurale, dove oriente ed occidente si mescolano e
arricchiscono a vicenda. Usa vari materiali e complesse strutture, anche
inserite in ampi spazi. La carriera artistica è rapida e si svolge con successo
in diversi paesi del mondo. Ricorderò soltanto che viene premiato alla XLIV
Biennale di Venezia del1990 e l’anno successivo al Turner Price. Si tratta
sempre non di quadri appesi a parete, ma di complesse ‘macchine’ che richiedono
tecnici e operai specializzati sotto la sua direzione. Pittore, scultore,
architetto… Gli stessi colori non sono aggiunti col pennello, ma fanno parte intrinseca
delle varie materie, terre, cere, siliconi, marmi, legni, acciaio, PVC,
specchio... L’azzurro o blu, parente di Klein, è il colore del sublime, il
rosso della passione, il giallo della luce, il nero perdita, disorientamento.
La polarità
sempre presente: alto/basso, luce/buio, azzurro/nero, gioia/inquietudine.
Ritorno allo
specchio, alla luminosità con lo Sky Mirror dei Kensington Gardens di
Londra: il doppio capovolto, l’incertezza, dove siamo? Una inquietudine diversa
da quella del buio. Non una chiusura ma una apertura pluridirezionale, la
ricchezza dello spazio, il volo nell’aria, la forza della luce.
Quest’altro Sky Mirror (2009) del Rockefeller di New
York capovolge la strada sul cielo. Il volume
specchiante introduce la immaterialità dell’oggetto: “Ho fatto oggetti in cui
le cose non sono quello che in un primo momento sembrano essere. Una pietra può
perdere il suo peso o un oggetto in modo speculare può mimetizzarsi nei suoi
dintorni da apparire come un buco nello spazio”. Una gioiosa sorpresa.
Cloud Gate, la Porta-nuvola inaugurata al Millenium Park di Chicago il giorno 15
maggio del 2006, da allora chiamato il “Cloud Gate Day”, soprannominato
amabilmente ‘The Bean’, il Fagiolo, composto da 168 piastre di acciaio inox
saldate, lungo diciotto metri e alto nove, annulla il peso e trasforma i grattacieli specchiati
in segnali verso la curva celeste.
Il rapporto
di grandezza/piccolezza è l’altro elemento delle costruzioni espanse di Koons.
Non più leggerezza e capovolgimento, volo, ma piuttosto magnitudine, minaccia (in tela gonfiata) nel Leviathan al Grand Palais di Parigi 2011:
altezza 33 metri, larghezza 100, profondità 72, ingombro 72.000 metri cubi. La
misura annichilisce ogni presunzione, liberando fantasie ed emozioni. Se il
fuori è una sfida al ‘Grand’ vecchio palazzo e alla umana piccolezza, il vuoto
dell’interno, nel quale si entra, è, al contrario, un ventre rosso infuocato:
corrono
vene, si arrotondano mammelle, colano sudori. Esterno impositivo, freddo, un impedimento, interno assorbente, respirante, caldo. Mi pare che qui si colga,
insieme al coinvolgimento personale, alla reazione emotiva, la teatralità, la
voluta esagerazione linguistica, dove gli osservatori diventano attori:
freddo-caldo, interno-esterno, pieno-vuoto, grande-piccolo, le polarità che
accompagnano tutte le invenzioni dell’artista.
o quella
della Gibbs Farm tra i dolci colli
della Nuova Zelanda
o gli
interiori del Sectional Body preparing
for Monadic singularity 2015
o quella specie di Grand Canyon, titolato
‘Taratantara’
, costruito in tre mesi tra la
demolizione dell’edificio precedente e la costruzione del nuovo Baltic Centre
for Contemporary Arts di Gateshea.
L’ambiente, il dentro/fuori è doppio, lo
spazio rinchiuso dai muri di cemento e quello contenuto dentro le curve della tela
rossa. E si ripete il confronto: piccolezza dell’uomo, grandezza dello spazio.
Come lo specchio moltiplica lo spazio,
l’imbuto lo inghiotte, lo concentra, mescola suoni, voci, sentimenti, per
espellerli dall’altro lato, trasformati e dispersi nell’ambiente, liberi di
scegliere ogni altra via.
“Ho
sempre pensato al vuoto, scrive l’artista, come a uno spazio transitorio. E
tutto ciò ha molto a che fare con il tempo. Sono sempre stato interessato al
momento creativo in cui ogni cosa è possibile e niente è ancora accaduto. Il
vuoto è quel momento di tempo che precede la creazione, in cui tutto è
possibile” (cit. da Davide Dall’Ombra). Vuoto/pieno, interno/esterno, luce/buio, alto/basso, piccolo/grande ecc. sono le polarità in cui si
muove l’artista, e noi con lui. L’esperienza è sempre un vitale contrasto.
La complessità, la molteplicità degli
interventi di Anish Kapoor non può certo ridursi a queste brevi note. Spero che
possano almeno indicare le sorprendenti e diverse vie che sono state aperte
dall’artista, possibilità che non rientrano nei generi prestabiliti dalle
consuete attività artistiche. Seguendo la varietà e l’ampiezza dei suoi
percorsi spaziali, riconosceremo che il paesaggio abituale sul quale siamo
abituati ad esprimere i nostri giudizi forse è cambiato, sta cambiando, forse
si è arricchito.
dicembre 2016
***
INTORNO A BONURA
di Vincenzo Guarracino
 |
| Giuseppe Bonura |
Sarà poi vero che “la vera arte contraddice l’estetica” e che nell’arte “la bellezza esiste per nascondere il male sociale” con
l’implicita avvertenza che essa “serve per farci distogliere lo sguardo dalle
radici dell’ingiustizia”?
Chi fa siffatte affermazioni, sferzanti e sulfuree quanto si
addice al suo personaggio, è Giuseppe Bonura, un creativo dalla cifra
inconfondibile che non solo pratica i linguaggi più diversi, dalla scrittura (è
narratore di consolidata qualità e riconoscibilità e temuto critico letterario)
alla pittura, con esiti letterari e artistici mai banali e anzi di notevole
rilievo e sempre molto significativi e peculiari, ma sa perfino aforisticamente
riflettere sulle proprie scelte e direzioni, come fa in questa incantevole
silloge di Riflessioni sulla pittura (quaderno di “Odissea”, curato da
Angelo Gaccione, 2006), a corredo delle sue ultime mostre d’arte milanesi.
 |
| Il catalogo pubblicato dalle Edizioni Nuove Scritture |
Io ci ho riflettuto (anche perché chiamato in causa come
critico d’arte, come “esploratore” cioè arbitrario e mal tollerato di
“territori” per definizione “conosciuti solo dall’artista”) ed ho concluso che,
sì, è vero, a patto di intendere l’arte come esperienza di un linguaggio inteso
a dar voce a una visione della vita e delle cose fortemente compresa delle
responsabilità che competono a uno che, arrogandosi il ruolo di artista (ma chi
è veramente e in che consiste?), si ritrova di fronte a una realtà che oggi più
di sempre chiede ben altre performances che non siano quelle di neutrale
illustratore o decoratore, che, ancorché grande, con la sua arte si genufletta
al Mercato (c’è un aforisma illuminante al riguardo: “Cosa c’entra con l’arte il mercato dell’arte? Il capitalismo corrompe i valori”). In realtà,
l’artista – Bonura ha idee molto chiare in proposito – è tutt’altro che suddito
delle mode (di esse essendone schiavo soltanto il “vil mercante inteso alla moneta” di gozzaniana memoria): se mai ne
è con la sua opera creatore e padrone, presto però sbarazzandosene come un
Crono che i suoi figli stessi li divora per non essere da essi sopraffatto
(giusto perché “tutti i dipinti includono
il Tempo”).
Figlio del tempo, lui (“Il
pittore attraversa molte fasi che lo trasformano. L’ultimo Picasso non era neanche parente stretto del primo”) non
meno delle correnti artistiche (“impressionate
dalla Storia”), ma anche suo
nemico e killer implacabile, nel senso che di esso ne dà non l’immagine bensì
il fantasma, il pittore è fedele solo a se stesso, alla propria “ispirazione”,
al proprio istinto di guardare alla Natura e ai suoi processi creativi,
servendosi della tecnica (la migliore è quella che “l’artista inventa da sé e per sé”, fermo restando che “le forme migliori di un dipinto nascono dall’inconscio”) per esorcizzarne la
proterva drammaticità e al tempo stesso per gareggiare con essa nel ricreare la
vita, frammenti verosimili di vissuto, il disordine tragico del possibile, fino
a riconoscersi nel suo incomprensibile equilibrio.
 |
| Gaccione (a sin.) - Bonura (a des.) |
Col viatico di
siffatte dichiarazioni, apprestiamoci dunque a una visita virtuale di una sua
mostra, quella ad esempio tenuta allo Spazio Lattuada di Milano tra
marzo-aprile del 2006.
Un titolo mi viene in mente, anche se non esplicitamente in
questa richiamato: Natura Dolens, un titolo molto leopardiano (ricordo al
proposito un pensiero dello Zibaldone del 1826 in cui si parla in toni
drammatici e angosciati di un giardino
assalito e afflitto da ogni sorta di agenti patogeni, animali e vegetali), cosa
che per un marchigiano d’origine può ben suonare come più di una semplice
allusione. Apposto infatti a una mostra precedente (Gabriele Cappelletti, Arte
Moderna Contemporanea, Milano gennaio-febbraio 2003) ma tale da poter
abbracciare tutta la sua produzione, agendone da interpretante, da
dichiarazione per così dire di poetica, dice infatti di uno sguardo concentrato
su un oggetto assolutamente privilegiato, unico addirittura, il paesaggio
naturale, con un taglio teso a raccontarne ed evidenziarne la qualità di realtà
agita dall’uomo fino al limite dell’offesa, dell’asservimento più totale alle
leggi dell’incuria, prima, e del profitto più brutale, poi: una Natura
tragicamente offesa, insomma, agita e sconvolta dal caos, senza speranza di
redenzione o palingenesi, e ciononostante ancora in grado di esprimere una dose
inaspettata di laica sacralità, come attesta il latino memore di liturgiche
compostezze. Del resto, i progenitori Latini non esprimevano forse questo
concetto (di Natura Naturans, qui abbastanza esplicitamente evocato in “Mater Natura”, tecnica mista, 1996) consegnandolo
ad un fantasma sacrale, quello di Venus, tutt’altro che rassicurante come una
banalizzante vulgata ha voluto farci credere, parlandoci di una divinità della
bellezza e dell’amore (l’amore c’entra, sì, ma nell’accezione di sesso, di béance
sanguinante e castrante)?
 |
| Un'opera pittorica di Bonura |
Come però
sagacemente avverte un suo mentore, Maurizio Cecchetti, non ci si aspetti che
il “bisogno di raccontare” si traduca in un composto linguaggio di immagini
referenzialmente narrative e descrittive, ma piuttosto bisogna disporsi ad
accettarne l’apparizione come un monito, un avvertimento, un allarme, con la
consapevolezza di una loro presenza inquietante. In altre parole, se si parla
di caos, è proprio lui, il caos, che qui metonimicamente parla e la sua è una
voce di asprezze, lai, stridii, dissonanze, forme combuste e lacerate, graffi,
abrasioni, ustioni: una voce che si fa rappresentazione niente affatto passiva
e neutrale: bestemmia e denuncia, ecco, segnata com’è da una forte passione, da
quella che l’antico Giovenale considerava la matrice stessa di ogni esperienza
creativa (la “poesia” addirittura), ossia l’Indignatio, da una rinascita e
reviviscenza insomma della così tanto deplorata e deprecata Ideologia. In tempi
di trionfo del bello, dell’effimero e del Mercato, l’arte insomma si
riappropria il suo ruolo di dar corpo a fantasmi, a “qualcosa che non esiste”,
con la coscienza che in re, non in verbo est veritas.
 |
| Fano. La targa dedicata allo scrittore dettata da Angelo Gaccione |
Lacrimae rerum, insomma: forme ed ombre senza luce,
lemuri e cloni dell’inconscio (ma “le forme migliori di un dipinto”, va da sé, non son forse quelle che
“nascono dall’inconscio”?): simulacra luce carentum, che urlano la loro inclassificabilità, la
loro inappartenenza; tracce di una presenza o originaria o postuma, mai
flagrante e instante, escatologia che azzera ogni attesa, negando(si) ogni
speranza e persino il piacere dell’artista di sentirsene l’artefice. Una sorta
di “Paradiso perduto”, come paradigmaticamente recita il titolo di una tecnica
mista del ’95, dove ciò che appare è una sorta di catalogo a futura memoria:
evocazione e presagio con qualcosa di esorcistico e allarmato, di volta in
volta, in “Prima della casa” (tecnica
mista, 1998), in “Ricordo della notte”
(tecnica mista, 1998), in “Idea della
foresta” (1997), per citare solo alcuni titoli (ma il discorso potrebbe
valere ancor più là dove la passione dell’artista si scherma dietro nobili
referenti letterari presi in prestito (chessò Mann, Sartre, Calvino, Rigoni
Stern), secondo una ricorrente e caratteristica modalità operativa.
 |
| Da sin. Ugo Ronfani, Giuseppe Bonura, Morando Morandini a capotavola Angelo Gaccione, in primo piano sulla destra don Luigi Pozzoli e Francesco Piscitello |
È che “la mano dell’artista che ne ha disposto il
caos è sparita e pare che l’opera sia stata generata da sé”, come dice Angelo Gaccione, con un’intuizione che non solo
trova conferme in non poche dichiarazioni di Bonura, ma quel che più conta è
verificabile concretamente nelle opere, in quel “gioco” serio e tragico, al
tempo stesso, di forme che nascono e fioriscono nel colore, in una pennellata
sporca e impastata di apporti e concrezioni cromatiche e materiche. Magari
Bonura non resterà nella storia dell’arte – sia lecito dubitarlo e dirlo, senza
offesa – ma è sicuramente uno con le idee molto chiare e soprattutto non si
lascia sedurre dalle sirene delle Mode: ciò che rappresenta è un urlo, che
somiglia tanto all’ilare e beffarda disperazione del più “renitente” Leopardi
delle Operette Morali (penso, in
particolare, al Dialogo di Timandro e di Eleandro). Sa insomma che in arte ciò
che conta è fare; anzi, addirittura, come diceva il compianto Antonio Porta in
un suo verso memorabile, che “l’essere è
un fare” e per questo, lui, si ingegna e impegna a fare: e questo perché è
in gioco una cosa importantissima, l’esperienza di se stesso, a prescindere
dagli stessi risultati. Non so per gli altri, ma per me questa è la cosa più
importante: anzi, per dirla con lo stesso Bonura, è “tutto”, l’unica cosa che
paradossalmente si può e deve chiedere all’arte.
LA ELEGANZA DEL BIANCO/ NERO
di Giorgio Colombo
Milano. Abbandonando
la folla vociante che attraversa il primo grande cortile del Castello Sforzesco, nell’angolo in
fondo (un cartello a parete indica il nome del defunto espositore, Paolo Monti,
nato nel 1908, fotografie 1935-1982) si entra nelle silenziose sale dell’Antico
Ospedale Spagnolo. Sulle scure pareti si
moltiplicano ordinate scene fotografiche in un bianco e nero discreto,
bisbigliante, enigmatico, interrogativo. Discreto perché contrario ai colori
sfrontati delle pubblicità ingombranti, dei selfie
moltiplicatori delle nostre nullità, delle luci eccessive, dei sopratono
gutturali e motoristici. Sono, questi delle fotografie esposte, vecchi muri
scrostati, ombre lunghe, frammenti di sculture fuoriposto, un gatto.
Foto in bianco e nero, oggi in disuso, che esprimono una
impeccabile semplificazione. Ecco,
subito una differenza: il mondo è colorato. Queste fotografie non mancano di
nulla, le sfumature dal nero al bianco sono infinite, amano i passaggi
graduali, ma allontanano lo scontro colorato delle passioni, dei conflitti,
delle esagerazioni. C’è silenzio, introdotto dai piccoli formati, la prima
parete della mostra, quelli già ingialliti dal tempo. Il mondo c’è, ma concentrato,
come arricchito dal sogno. E’ una realtà, certo, quella via, quel canale c’era
davvero, forse c’è ancora, la fotografia ci assicura, pezzi di Venezia, ma il filtro del silenzio
acquieta vicoli, porte, finestre, persone. Penso all’oggi, alla discarica
umanoide che le grandi navi vomitano quotidianamente su di una irriconoscibile
Venezia – quando verrà distrutta la rifaranno in plastica -, zeppa di falsi
souvenirs cinesi, di false borse, sconciata di sudori e di falsi fotografi. Quanta
pace invece in questo “Rio dei Mendicanti” che Monti riprende insieme agli
amici de “La Gondola” nel 1949 attraverso gli occhi di una ragazzina e il
diaframma di una foglia!
Apro la parentesi sulla organizzazione della mostra di cui
sto parlando: si è inaugurata il 16 dicembre di quest’anno e rimarrà aperta
sino al 12 marzo 2017, curata da Pietrangelo Cavanna e Silvia Paoli,
utilizzando un archivio di Paolo Monti che conta circa 240.000 fotografie.
Aggiungerei che non intendo seguire l’attività eccezionale del fotografo, del
resto e per forza già ben selezionata in questa occasione, ma soltanto usarla come
stimolo per alcune riflessioni. Dunque il fotografo nel 1953 si sposta da Venezia a Milano, abbandona la
carriera di dirigente amministrativo per dedicarsi interamente alla fotografia,
è amico di pittori, lavora per la Triennale, collabora con la galleria “Il
Diaframma” e svolge importanti campagne di documentazione dei centri storici in
vari luoghi d’Italia senza abbandonare la più raffinata sperimentazione. Una
vicenda attiva ed inventiva.
Monti è ben consapevole che la fotografia è più di un documento da cui trae origine, è il
tentativo “di scoprire un aspetto nuovo ed essenziale, quasi un segreto”. Anche le tecniche si possono inventare, “ognuno
per sé” (1981). Scoprire è sollevare una coperta, mettere in luce il nascosto. La soggettività del fotografo è particolarmente accentuata.
Mi restringo a tre immagini che mostrano la varietà
dei riferimenti ma pure la forza dell’artificio. Non vita vissuta, ma vita inquadrata,
catturata, stampata di ‘oggetti’ a loro volta, nel caso dei nostri tre esempi,
stampati (un manifesto), costruiti (vecchi muri), scolpiti (una statua). Tralascio la lunga storia
dei numerosi processi e strumenti tecnici che di solito accompagnano i discorsi
sulla fotografia. Accennavo prima al ‘bianco/nero’ come semplificazione e
facilità di accoglienza. Meraviglia di questa fotografia: sembra tutto vero e
invece…. Certo, è un linguaggio, una scrittura, un arti-ficio, ma fatto di
presenze, di pre-essenze, quel viso che ti guarda e il filo spinato, gli alberi
spogli, e poi il sole del sud sugli archi e i muri imbiancati, e infine le
contorsioni del barocco che annullano il personaggio angelico, spuntano appena
le ali… Ecco, così accettiamo i colpi della realtà, la sua minacciosa
estraneità, la facciamo nostra, pure con un senso di piacere. Anche le immagine
più crude, di sangue e dolore, non puzzano, non minacciano, non ci inseguono
(se non nella nostra mente). Benemerita astrazione. Ma è meglio, come nel nostro
caso, quando sono filtrate con la
eleganza del bianco/nero, con il sussurro dell’aria e dei muri, con il gesto
immobile del lavoro, del tempo e dell’ingegno. Non una povertà di mezzi, ma una
scelta consapevole. Controllo dolce e severo. Uno spazio per la riflessione. Un
invito, un piacere.
manifesto periferia milanese 1953
case di pescatori, Procida 1972
Roma, Ponte Sant'Angelo, statua berniniana
dicembre 2016
***
Un amico
accogliente ma insieme schivo, uno sguardo pensoso - accetta il dialogo ma
difende la propria riservatezza - le rughe del tempo, Milano
festeggia i 90 anni di Arnaldo Pomodoro con una grande antologia contemporaneamente
allestita in più sedi, 4 dicembre 2016- 5 febbraio 2017. Al centro delle esposizioni la Sala delle
Cariatidi di Palazzo Reale, scoperchiata dai bombardamenti inglesi del 1943, e
restituita con le sue ferite per la mostra del ‘Guernica’ di Picasso nel ’53,
così come la vide Arnaldo Pomodoro nella sua prima visita alla città (oggi
ripulita con saggio restauro conservativo, come un antico frammento del
passato).
Difficile,
senza ripetersi, scrivere di un Autore di cui si è già detto molto, anche a
livello internazionale, sempre con rispetto e ammirazione. Ricorderò soltanto
alcuni punti fermi: la sua radice iniziale tra i colli del Montefeltro e il
mare di Pesaro, la sua lunga collaborazione con il fratello Giò(vanni) - che muore
nel 2002 dopo una importante attività di scultore -, la sua competenza
costruttiva e artigianale, la precisione
dell’orafo, mano e cervello, e infine l’incontro con Milano, una città tesa a
riprendesi dopo le distruzioni della guerra, con la presenza recente (era
rientrato nel ’47 dall’Argentina) di un Fontana ‘spazialista’, promotore nel ’61 della mostra ‘Continuità’ alla quale
partecipano i due fratelli Pomodoro. Arnaldo individua un linguaggio di piccoli
tratti, la cui ripetizione e disposizione può adattarsi ad una molteplicità di
significati: particolare e totale di Grande
tavola della memoria 1959-65, 225x325x60 cm.

 A ciò si aggiunga il gusto di una materia luminosa e
riflettente come il bronzo e le forme ordinate, geometriche, elementari, sfera,
cubo, cilindro, cono, piramide in diverse combinazioni: ecco questa è la grammatica
dell’artista, a cui si aggiunge un intervento fondamentale, la rottura della
superficie, l’interruzione della sicurezza, l’inquietudine dello squarcio, sia
sul disco stellare (di piazza Meda a Milano), anche il ricordo di un disegno leonardesco,
A ciò si aggiunga il gusto di una materia luminosa e
riflettente come il bronzo e le forme ordinate, geometriche, elementari, sfera,
cubo, cilindro, cono, piramide in diverse combinazioni: ecco questa è la grammatica
dell’artista, a cui si aggiunge un intervento fondamentale, la rottura della
superficie, l’interruzione della sicurezza, l’inquietudine dello squarcio, sia
sul disco stellare (di piazza Meda a Milano), anche il ricordo di un disegno leonardesco,
sia sulla
sfera (la prima è del 1963)
dove i
‘piccoli tratti’, quasi sconfitti dalla
luminosità del rispecchiamento, si rifugiano nella interiorità del solido:
minaccia o promessa? Anche la sfera fotografata da UgoMulas, dove il
rispecchiamento, qui sì, sconfigge l’interiorità dello squarcio, già regolarizzato dai due tagli centrali.
E ora arrivo
alla Sala delle Cariatidi, dove la scelta, la disposizione delle opere, la luce
è stata accuratamente disposta dallo stesso autore, e dove le superfici lisce
riflettenti e i tratti rigidi ripetuti in diverse dimensioni, interni alle
forme o esterni sulle pareti, accompagnati all’innalzarsi incerto della
costruzione sbrecciata del palazzo, innescano un particolare dialogo.
Le ferite
della guerra, conservate e ripulite, mantengono il senso della minaccia e la
smorfia della distruzione. Invece le interruzioni del bronzo pulito e
riflettente delle opere, gli squarci e
la messa a nudo delle interiorità, denti digrignanti o regolarità della
struttura interna, partecipano di una tranquillità raggiunta pur nella messa in
crisi della forma. E qui sta, a mio avviso, la riflessione critica e pacificata
di Pomodoro. La regolarità della superfice è messa in crisi dalla rottura, dalla
schiera interna dei denti, ma se a volte, nelle numerose sfere e colonne, questa
scopertura suggerisce una minaccia o una impossibilità di perfezione, altre
volte costruisce una felice nuova forma, come la stella nel disco di piazza
Meda. La scopertura è insomma sia un ‘ricordo’di ferita sia una esposizione
della interna struttura vitale, minacciosa ma vitale. E così tornano le
precedenti opere dei ‘piccoli tratti’ come ‘mappe’, come indagini di una
pacificata interiorità, piuttosto che una chirurgica, sanguinante scopertura di
ferita. Ma questi diversi elementi convivono. E a me sembra che questa
convivenza, così come lo sguardo pensoso e melanconico dell’artista, sia la
linfa pulsante della sua opera. L’oscurità e le luci della Sala delle
Cariatidi, i frammenti rotti, progressivamente persi nel buio delle pareti
diventano un opportuno commento delle forme scolpite, là dove, in basso, si
raccoglie la luce.
dicembre 2016
***
UN ANONIMO
RICERCATORE IN VIA SOLFERINO 56
Via
Solferino, una via diritta e trafficata di Milano, al 28 il ‘Corriere della
Sera’, nell’ultimo tratto verso i Bastioni quieta e in penombra, al 56 , viene interrotta dalla luce di una vetrina ‘SPAZIOTEMPORANEO’, temporaneo, che dura
poco, un soffio, oppure che appartiene al tempo di oggi, di tutti gli oggi, con-temporaneità.
Ancora soffi, ma ricorrenti. E’ una Galleria
d’arte. Lo spazio ampio, bianco, silenzioso, oggetti rotanti alle pareti,
‘oscuri universi’, in una vetrina
sculturine di anelli avvolgenti, di Fontalba, una scala in fondo, seggiole in
fila in attesa di una conferenza o pubblica lettura. Spazio appartato eppure
parlante, interrogativo. Ma sottovoce, a suggerire, a indovinare. Così le opere
di Paolo Bonaldi, che si dichiara ‘anonimo ricercatore’, gli ultimi giorni
della sua mostra (sino al 6 dicembre), isole, vortici, energie: plastica scura,
corrugata e raggi di spilli luminosi.
Tappe di una
ricerca lunga. Ritorno ai precedenti fiori e vapori del 2002. Fogli di plastica
colorata, fiori in scioglimento e fili inquieti.
I filamenti escono ad espandere lo sforzo (o lo scoppio).
Eppure le dichiarazioni dell’autore, in un denso librettino stampato in
occasione della mostra attuale, parlano del “vuoto”, che non è disperazione ma
un vuoto “verginale, pronto per essere vissuto”. Un “incorporeo nulla”, una eliminazione, un
isolamento che faccia spazio dentro se stessi: “si allontana da tutto e da
tutti, si stacca, perde il senso delle cose, di se stesso” (p.41). L’autore seguendo
la sua coscienza “lavora e scopre indipendentemente dal mondo”. Sembra una
frase del TAO, la Via: non vedere
nulla, non udire nulla, non nominare nulla. Wei wu
wei, fare ogni cosa nulla facendo. Gli opposti si richiamano, si producono
e si distruggono a vicenda, vita-morte,
possibilità-impossibilità, giusto-ingiusto. La vitalità equivale alla quiete
assoluta. La diversità con il Bonaldi artista, mi sembra, sta nella fiducia del
‘fare’, o meglio, nella presenza del fare. Il fare fatto “lo lascia
andare”, non lo interessa più. Ora ovviamente il ‘fare fatto’ sta da tempo sui
muri della Galleria. La dinamica rotatoria obbedisce alla produzione di un
oggetto che, almeno per noi guardanti, rimane nel tempo. Forse solo per noi. La
Galleria è lì per questo. Forse
l’artefice sta già facendo altro. Lo aspettiamo per la prossima volta.
dicembre 2016
****
Nobuyoshi
Araki
Negli spazi della Galleria
Sozzani di Milano, alle pareti la mostra del giapponese Nobuyoshi Araki, il
24 novembre scorso si è tenuta la presentazione della pubblicazione Seduction
of Photography del fotografoToni Thorimbert.
Leggo dalla presentazione: “Le foto sono state realizzate
con due macchine fotografiche collegate tra loro da un telecomando che le fa
scattare contemporaneamente: una utilizzata da Thorimbert, e l’altra posta su un cavalletto che inquadra la scena”, che
sarà poi lo sguardo del futuro spettatore.
L’immagine ripresa dal cavalletto si sviluppa sui due fogli
del libro. A destra s’intravede una camera da letto, a sinistra il fotografo e
la modella (?) che si specchia. “Io ti guardo o sei tu che mi guardi? Sono io,
fotografo, il seduttore, o sei tu, soggetto, che mi seduci con il tuo sguardo?”
Il soggetto si guarda nello specchio e sa di essere
guardato dall’obbiettivo del fotografo e da quello predisposto sul cavalletto.
Tre sguardi.
Nella quarta immagine lo specchio è scomparso e la figura
femminile, che prima era in sottana e reggipetto, si sta slacciando, davanti al
fotografo, una vestaglia bianca ad ampie maniche. Lo sfondo è ambiato: la
tappezzeria decorata è a sinistra e il bianco della porta a destra.
Quanto si sia aperta la vestaglia davanti al fotografo non sappiamo.
Le immagini
successive ripetono gli stessi soggetti, però non più stampate sulla
ondulazione doppia dei fogli, propria del libro, ma piatte, con taglio ortogonale, senza bordi.
Una maggiore intenzione di ‘realtà’ insomma, immagini sole, una specie di origine,
una presenza, capace di interpellare lo ‘spettatore’, non più soltanto
‘lettore’. E scelgo l’immagine doppia dello specchio, un raddoppiamento
originario.
A questo punto la fotografia non è più soltanto un rapporto
tra il fotografo e il suo oggetto (o soggetto), entrambi, a vario titolo,
co-produttori, ma tra il profilo specchiato, già doppio in sé, il guardante
interno, e il guardante esterno al plurale, gli spettatori. L’attività
seduttiva si moltiplica indefinitamente.
Mi sembrava opportuno unire queste riflessioni alla
precedente presentazione delle elaborazioni
fotografiche della Beecroft. Un ulteriore riscontro della ricchezza
semantica della fotografia, che pur trascinando in sé quel breve momento di
‘realtà’, il ‘c’è stato’, offre molteplici possibilità di elaborazioni tecniche e di risposte emotive.
novembre 2016
****
VANESSA BEECROFT: IL RITRATTO FEMMINILE
TRA NASCONDIMENTO E CONFESSIONE
Nell’ambito del Photo Vogue Festival a Milano e l’attivazione dello ‘sguardo femminile’ come soggetto che guarda e si guarda, e non
come ‘oggetto’ guardato maschile, quello più diffuso (oggetto femminile amato, contemplato, venerato, usato, manipolato,
disprezzato, distrutto), vorrei fermarmi alla mostra di Vanessa Beecroft, italiana che vive a Los Angeles, nei colorati appartamenti del Principe a Palazzo Reale: 36
ingrandimenti di rare polaroid 1993-2016 e alcune sculture. Una interessante
esposizione ma breve nel tempo, 24-29 novembre. Risale al lontano 2009 la sua
precedente performance milanese. Il lavoro dell’artista è più
complesso di quanto la grande e perfetta resa fotografica delle opere di questa
mostra potrebbe suggerire (perciò mi servo anche di lavori oggi non esposti).
Il corpo femminile è stato sempre il punto centrale d’interesse della Beecroft,
sia nella nuda presenza dei tableaux
vivants, dal manichino seriale al corpo dipinto o accompagnato dalla
propria forma statuale, anche in frammenti, che nella preminenza di un freddo marmo
similpelle, o là dove la testa si sforma o tras-forma in un appoggio al
piano-tavolo, oppure nella illusione fotografica - come nell’attuale
esposizione -, un viso ridipinto, quasi nascosto dietro una maschera mortuaria.
La durezza e
le irregolarità della pietra si trasforma nella mollezza e fragilità della
pelle, immobile nella sua pietrificazione, sino al viso fotografato ingrandito
e ridipinto, capelli inclusi. Lo shock del nudo femminile, sia che rimandi alla
pubblicità, all’erotismo, alla manipolazione fantastica, alla triste
rassegnazione, alla citazione classica, perde progressivamente il suo ‘odore’
esistenziale per raggiungere l’astrattezza del linguaggio, una lontananza
irraggiungibile, quei capelli dorati come le guance, oppure neri, lisci,
minacciosi, un colore che invade il viso senza perdere la tristezza degli occhi
spalancati, fermi, che ti fissano, e il segno pronunciato di una bocca immobile,
magari col filo rosa risucchiato nelle labbra, eppure conservando tuttavia quell’attimo
del c’è stato che è proprio della
presa fotografica.
Per ritornare ad una elegante trasparenza, sempre uno sguardo filtrato che riporta il nudo alla lontananza di un ricordo, magari alla nostalgia di un antico dipinto.
I grandi
visi colorati, a volte ritagliati sul contorno della figura,
allargati dalla
piccola polaroid di partenza, fuoriescono dal
momento dello scatto e sviluppo
immediato, da una certa casualità
della prova, per allontanarsi in un mondo di
irrimediabile tristezza,
così come i corpi velati, o svelati: non un incontro,
una carnalità,
una sessualità provocante, ma una ritrosia, una distanza, una
irraggiungibilità, una
promessa mancata. Il ri-tratto si trasforma nel
nascondimento, quasi una cancellazione,
che in questo spostarsi
rivela un’altra cosa, il senso di una perdita, di una
nostalgia; un
viso che l’obbiettivo
rende soggettivo, una comunicazione
incomunicabile. E proprio al termine di un processo che sembrava
scandaloso, un
occhio sfrontato, un labbro, un sesso denudato,
scaturisce non una promessa
proibita, ma una confessione, un
melanconico addio, una tenerezza perduta.
novembre 2016
****
PER KIRKEBY A MENDRISIO
Da una
piccola stradina di Mendrisio si entra nel lindo cortile porticato dell’antico
convento dei Serviti, oggi Museo, che dal 28 settembre sino al 29 gennaio 2017, ospita la mostra
dell’artista Per Kirkeby, con il bel catalogo dove il ‘per’ diventa in italiano
quasi ‘omaggio’ all’anziano artista, nato a Copenaghen nel 1938, ricco di un
invidiabile curriculum internazionale. Geologo, pittore, scultore, scenografo,
regista, grafico, poeta, storico dell’arte… La complessità, l’intrigo dei suoi
interessi e delle sue esperienze ne indicano la difficoltà di una esaustiva
presentazione. Intanto la sua preferenze per gli spazi difficili come la
Groenlandia, dove “Il paesaggio è troppo grande, il vento, il ghiaccio, troppo
potenti. In tutto questo l’uomo è perso,… allora il viaggio può iniziare” (cit.
nel cat. P. 15). Perdere l’uomo della norma e scoprire l’uomo dello stupore,
la capacità dell’emozione. La geologia invita a scoprire i vari
strati della realtà, così come la luce
i vari mutamenti delle superfici, il peso della profondità, la leggerezza del
soffio. L’acquerello serve a gettar giù la prima impressione. Poi occorre
scavare, entrare nella caverna.
2011
In mezzo
l’energia, la forza delle cascate, la trasparenza delle acque, e sotto la
penetrazione delle radici, il buio illuminato. S’impara a vedere, che non
dev’essere la presenza, l’immediatezza, l’ovvio, ma memoria selettiva, che
scarta, cancella, conserva, e diventa meditazione e premonizione. E anche per
noi, di fronte alle sue opere, occorre una fermata, una pausa, un isolamento,
per cogliere poco per volta i vari piani, inoltrarci nei percorsi multipli, sorprese
enigmatiche che l’artista ci propone e ci nasconde. Quasi un gioco a
rimpiattino. Insomma non una soddisfazione tranquilla.
1986
Negli anni
60-70 alla geologia artica si aggiunge la conoscenza e partecipazione alle
nuove avanguardie , Fluxus, minimalismo, Piero Manzoni e la libertà di
trasformare gli esempi illustri, la scultura di Rodin per esempio, rivoltarne
la retorica, sbriciolarne la superficie, polverizzare la figura, oppure la luce
di Turner, il riflesso, la duplicazione, ritmata dai tronchi/acqua (il Nilo?)
paralleli:
La storia
della pittura non obbedisce alla cronologia: il passato è presente e il
presenze e zeppo di passato. Ecco cosa diventa il cavallo di Hans BaldungGrien:
1534
2010
Sovrapposizioni,
mescolanze, rotture, frammentazioni. E il teatro, e il cinema di cui si occupa,
hanno anche loro questo aspetto, una finzione che è più vera della realtà. Il
geologo si è inoltrato nella caverna della immaginazione, e, ritornato nello
studio, ne ha segnato, ripensandoci, le
tracce, i ritorni, le memorie, le paure, lo stupore.
Sovrapposizioni,
mescolanze, rotture, frammentazioni. E il teatro, e il cinema di cui si occupa,
hanno anche loro questo aspetto, una finzione che è più vera della realtà. Il
geologo si è inoltrato nella caverna della immaginazione, e, ritornato nello
studio, ne ha segnato, ripensandoci, le
tracce, i ritorni, le memorie, le paure, lo stupore.
ottobre 2016
****
IN GIAPPONE
IL MONDO FLUTTUANTE
Nell’Europa
dell’800 le tecniche dell’incisione venivano usate come mezzi di riproduzione e
illustrazione libraria. Felix Bracquemond, amico degli impressionisti, è uno
dei principali autori e fautori dell’incisione creativa. Disegna anche per le
ceramiche di Sèvres e Haviland. Nel 1856, spachettando l’imballaggio di alcuni
oggetti provenienti dal Giappone si imbatte in alcuni fogli illustrati,
incisioni che lo sorprendono e che mostra ai suoi amici pittori, Manet, Degas,
Monet, Van Gogh, Cassatt, Toulouse Lautrec, Whistler.
A sinistra il ponte di Hiroshige a
destra la copia di Van Gogh
Edmond de Gouncourt scrive nel ‘91 “Outamaro: le peintre des maisons vertes”, le case di piacere. Il gallerista Samuel Bing,
interessato all’Art Nouveau, pubblica
la rivista Le Japon artistique. E’
una meraviglia sconvolgente: un modo, un gusto, una libertà, una eleganza
imprevista che diventa subito un modello per gli artisti innovatori, uno dei
caratteri fondamentali del Japonisme.
Perché
opere tanto raffinate erano diventate volgare materiale d’imballaggio? La
storia del Giappone è complessa. Ne riferirò solo, schematicamente, alcuni punti. Nel 1600 si instaura lo shogunato ereditario, il potere del clan Tokugawa che sposta la
capitale da Kyoto a Edo, l’odierna Tokyo, dando vita ad un periodo di pace e di
stabilità politica che durerà sino al 1868. Gilde di artigiani e mercanti
soddisfano le richieste di beni e servizi, la moneta è di uso corrente, nuovi
strumenti di credito facilitano il commercio. Pur nella rigidità della
organizzazione sociale il potere dei vecchi samurai
viene drasticamente ridotto imponendo loro di abitare periodicamente a Edo
mantenendo residenze lussuose; devono contribuire alla costosa vita religiosa e
chiedere il permesso per risiedere nei loro castelli. Si sviluppa una ricca
vita culturale e artistica con il teatro Kabuki o del Nō,
o le marionette del Bunraku , o
la musica del Koto, o il Sumo, la lotta giapponese. Ma l’aspetto
che qui ci interessa sono le immagini del “mondo
fluttuante”, ukiyo-e (yo, mondo, uki, fluttuante). L’espressione deriva dal Buddismo Zen, il
“mondo della sofferenza”, la transitorietà delle vicende umane, il nascere e il
corrompersi, che invece nella rinnovata società di Edo diventa, al
contrario, l’elemento positivo della
creatività, del piacere, del godimento, della bellezza, della
immagine-immaginazione, dello sguardo, vedere ed essere visti. Ukiyo, tutto
ciò che va di moda. Di qui lo sviluppo di una ricca produzione xilografica, un
grande successo popolare. E così arriviamo alla mostra aperta a Milano, Palazzo Reale, dal 22 settembre
2016 al 29 gennaio 2017. Una mostra che mi pare eccezionale, proveniente dall’Honolulo Museum of Art, con 200
incisioni policrome di tre maestri, Katsushika
Hokusai (1760-1849), Utagawa
Hiroshige (1797-1858) e Kitagawa
Utamaro (1753 – 1806), accompagnata da un prezioso e ricco catalogo Mondo Mostre SKIRA a cura di Rossella
Menegazzo.
I surimono, la “cosa stampata”, risponde a
numerose richieste, biglietti augurali, inviti a un concerto o a teatro, una
commemorazione, una pubblicità, una tiratura artistica. La produzione e l’uso
di xilografie in bianco e nero o a colori nel periodo Edo risponde ad una
richiesta di massa al cui centro si pone
la città, con i suoi sempre più numerosi e attivi abitanti, i suoi
divertimenti, i suoi quartieri. A capo del processo si trova l’editore che approva, supervisiona,
chiede l’assenso della censura, pubblica e distribuisce sul mercato il
prodotto, di cui ne conserva l’esclusiva. L’artista gli sottopone il disegno
preliminare che poi riporta su di una carta sottile, che passa all’intagliatore
il quale la incolla capovolgendola su di una matrice di legno di ciliegio e,
assumendone la traccia, scava i vuoti che non vanno inchiostrati. L’operazione
di scavo e stampa, entro il profilo del nero, si ripete per ogni colore.
Come mai
allora un prodotto così diffuso diventa carta straccia da usare per avvolgere
gli oggetti più costosi destinati alla esportazione? L’inizio del cambiamento è
così descritto in un libro del 1935 di Antonio Zischka, “Il Giappone nel
mondo”: “Un mattino brumoso del luglio 1853 i guardiacoste della Baia di Uraga
scorgono una flotta che avanza verso il cuore del Giappone. Non si tratta che
di due fregate a vapore, due navi da guerra con 600 uomini a bordo. Ma nella
bruma il loro aspetto incute terrore. I Giapponesi che li spiano credono di
vedere cento navi: quando la notizia giunge allo Shogun si parla di 100.000
uomini…”. Il commodoro U.S.A. Matthew C.
Perry consegna una lettera diretta al governo giapponese nella quale chiede
l’apertura dei porti, un trattato commerciale, la sicurezza dei loro uomini.
Tornerà l’anno seguente con sette navi e 2000 uomini per la risposta. Lo Shogun
cede, l’Imperatore firma “i trattati ineguali”. Agli americani
seguiranno l’Olanda, la Russia, l’Inghilterra, la Francia… Gli italiani
arriveranno nel ’66. Si chiameranno trattati di amicizia e commercio. Il
vecchio Giappone dello shogunato era finito. Iniziava nel 1869 il
periodo Meiji (“del regno
illuminato”). Mutsuhito, con la sua nomina,
proclama la restaurazione del potere imperiale, che promuove, insieme a
numerose riforme istituzionali, spesso modellate sulle istituzioni tedesche, la modernizzazione forzata con lo scopo
di raggiungere e superare le concorrenti potenze occidentali. Strumenti
principali le banche, le fabbriche, l’esercito, l’educazione. Le vecchie abitudini di intrattenimento e
di svago vengono abbandonate. Tra
queste anche le xilografie popolari del periodo Edo. Migliaia di studenti
sono inviati negli Stati Uniti e in Europa e più di tremila esperti
occidentali, i gaikokujin (impiegati
stranieri) vengono invitati per insegnare, insieme alle lingua, i più
aggiornati aggiornamenti scientifici e tecnologici. Il Giappone sta diventando
un potere mondiale rispettato e temuto. Questo breve riassunto vorrebbe rispondere
al deprezzamento delle mode precedenti e a quella preziosa carta stropicciata
arrivata a Parigi alla fine dell’800 e da allora alla sua giovanile rinascita
europea. In una situazione analoga si era trovato Enrico II di Borbone nel suo
viaggio in Giappone nel 1887-89, di cui ho già scritto in questa rubrica, e
della sua raccolta di vecchie fotografie, maschere, corazze, chimoni, oggi al ‘Museo Orientale Marco Polo’ di Venezia.
Così ritorno al centro dell’attenzione, l’attuale mostra delle xilografie - nell’ordine di nascita - di
Utamaro, Hokusai e Hiroshige, anche se
posso aggiungere poco a quel tanto che si è già scritto al riguardo. Riprendo
alcuni elementi che mi sembrano più evidenti: la ripresa degli stessi motivi,
sia dei concorrenti che dei predecessori. Il fatto cioè che non si vuole
sottolineare la singolarità, la sorpresa, la novità, ma la calma partecipazione
ad una estesa comune tradizione. Sì, c’è il tocco dell’autore, forse utile nella
competizione mercantile, ma anche un abbraccio pacificatore, l’autorevolezza di
un tempo lungo, un passato-presente, un qui e altrove di grande fascino. E’ il
caso delle Trentasei vedute del monte
Fuji di Hokusai (1830-32 circa) e di quelle dello stesso soggetto di
Hiroshige di vent’anni dopo! (1852-58), anche con la ripetizione della ben nota
‘onda’. Pure i soggetti sono organizzati secondo temi preordinati risalenti ai
secoli precedenti: così la pittura di paesaggio e dei luoghi celebri (oltre
alle trentasei vedute, le Cinquantatré stazioni di posta del Tōkaidō di
Hiroshige, le cascate e i ponti), lo “Specchio dei poeti giapponesi e cinesi”
di Hokusai, la pittura di fiori e uccelli, le grazie della beltà femminile di Utamaro, e infine
i quindici volumetti di “Schizzi sparsi per la Educazione dei principianti di Hokusai, detti Manga (immagini derisorie).
Comincio con Utamaro, un artista di sicuro successo e di rapido
tramonto. Incerta la nascita e l’infanzia. Trionfa con il suo soggetto
principale, la bellezza femminile e le case di piacere con la rappresentazione
dei più svariati accoppiamenti, gli shunga
(pitture della ‘primavera’). Scontratosi con la censura, viene processato e
imprigionato. Muore poco dopo la scarcerazione nel 1806 a 53 anni. Travolgente nella
modulazione elegante delle curve, esplode nel trionfo della capigliatura, un
nero vibrante, ondulato interrotto da pettini, fermagli, nastri, bastoncini. Un
viso diafano, oblungo che il segno sottile e sicuro contiene: due occhi
come due ferite convergenti unite alle piccole labbra dal filo allungato del naso. S’intravedono i
dentini come chicchi di riso.
E qui? “La ragazza precoce” dalla
serie “Varietà di fiori secondo il loro linguaggio”. Parlano i fiori del
silenzio interrogativo della ragazza. Ancora le curve nella loro sinuosa
mollezza e le piccole labbra che tengono un fazzoletto, una promessa?, e lo
sguardo pungente e più in alto la felicità della nera capigliatura che la banda
nera del manto preannuncia e sostiene.
Il discorso sullo spazio e la prospettiva è complesso. Mi limito a
indicare due immagini di Hokusai del monte Fuji. La prima con le zone piatte,
una davanti all’altra,
la seconda con il tondeggiare
delle nuvole, quasi mani protettive, vecchio sistema – dai tetti vola un
aquilone -, e il santuario a destra con la nuova, incompleta prospettiva (gli
omini ci lavorano, quasi scherzando, sul tetto).
Ma l’intervento sul paesaggio e ben più libero e fantasioso che non
l’applicazione di regole. E’ sufficiente uno sguardo alle cascate, la prima di
Hokusai e la seconda di Hiroshige, con le persone che si bagnano.
L’acqua è un elemento mobile per eccellenza, possiede la trasparenza, il
rispecchiamento, gli incubi dei sogni. E allora non si può non citare la
notissima onda di Hokusai che minaccia con la sua schiuma tentacolare di
inghiottire l’esile barca.
Un paese di isole, baie, torrenti deve poter spostarsi con strade e
ponti. Se l’onda è una fprza imprevedibile, il ponte è una sicurezza costruita
dall’uomo, è il segno delle sue capacità, dell’incontro, dello scambio. Così si
moltiplicano la immagini di questo passaggio. Due esempi splendidi di Hokusai, quasi
due favole: il ponte acrobatico e quello sospeso, “il ponte appeso alle nuvole
sul monte Gyōdō”:
Ecco, un assaggio di una
mostra importante, da vedersi e rivedersi con cura e pazienza, formati medio-piccoli
(una media ca. di 37 x 25 cm), per ritrovare un gusto raffinato, un realismo
fantastico raro, una capacità creativa inesauribile entro schemi ripetuti, il
senso di una tradizione continuamente ripresa, ravvivata, giunta sino a noi per
stupirci ancora, per concederci una pausa di serenità imprevista, salutare nel
povero sconquasso quotidiano. Un finale di Hokusai, con un cardellino su di un
ramo di fiori, ma l’albero è un ciliegio piangente e il cardellino è a testa in
giù.
settembre 2016
****
Il Neo di
SIGNAC
(La mostra a
LUGANO)
Notre-dame-de-la-garde-marseilles-(La
Bonne-Mere)
1905 300x231
1905 300x231
Signac – Riflessi sull’acqua, prima alla Fondation de l’Hermitage,
Lausanne e ora , sino all’8 gennaio del 2017, al Museo d’arte della Svizzera italiana (MASI) a Lugano, catalogo
SKIRA, presenta oltre centoquaranta lavori dell’artista provenienti da una
collezione privata. I miei amici lettori sanno che di solito non faccio la
descrizione puntuale della mostra, ma ne ricavo spunto per alcune
considerazioni. Paul Signac nasce dopo il gruppo dei cosiddetti
‘Impressionisti’, etichetta di grande successo che comprende però figure molto
diverse. Se mi riferisco alle date, Degas è del ’34, Monet del ’40, Gaugin del ‘48,
Van Gogh del ’53 ecc. Paul Signac, nato nel ’63, è più giovane, vicino invece a
Seurat (del ’59, muore a 31 anni), grande amico e in qualche modo suo modello.
Entrambi sono interessati al problema della luce, cioè come il colore
dell’oggetto viene acquisito dall’occhio e come l’occhio dell’artista lo
restituisce sulla tela. La soggettività e l’ottica vengono in soccorso al
pittore. Lo spettro solare è composto da tre colori fondamentali: giallo, rosso
e blu la cui unione produce la luce bianca: il cosiddetto cerchio cromatico di
Chevreul. Rosso + blu (viola) =
complementare del giallo, giallo + blu
(verde) = complementare del rosso, rosso + giallo (arancio) = complementare del
blu. Mescolare i colori sulla tavolozza significa spegnerne la forza. I singoli
colori vanno accostati e dipinti sul
piano (foglio, tela, parete) puri e divisi (divisionismo).
L’occhio del pittore e poi dello spettatore, guardando l’opera compiuta da una
certa distanza, li riunirà percependo della scena una particolare sensazione di
nitidezza e luminosità. Il passaggio da una zona colorata all’altra non è mai
netto. I punti colorati puri, corpuscolari, diminuiscono o s’infittiscono
gradatamente secondo andamenti calcolati in una comune vibrazione e consonanza.
1886, Seurat, Signac, Pissarro partecipano all’ottava mostra degli impressionisti; per loro il critico Félix Fénéon introduce il termine ‘neoimpressionista’. I temi del paesaggio e della vita moderna rimangono più o meno gli stessi. La novità del ‘neo’ è il rapporto tra pittore e soggetto. L’impressionista, almeno in prima battuta, dipinge di fronte al soggetto, in quel momento, con quelle ombre passeggere: i covoni di grano o le cattedrali di Monet. Il neoimpressionista, dopo aver disegnato alcuni schizzi, dipinge nel suo studio e ricostruisce pazientemente la scena secondo le nuove regole dell’ottica. Un processo del tutto concettuale. È il caso emblematico de la Grande Jatte di Seurat: sulla grande tela si sviluppa una sospensione interrogativa, una immobilità inquieta, la scimmia, il cagnetto fermato nel salto, il gioco degli ombrelli e dei cappelli, profili, luci e ombre ritmate. Uno sforzo tutto ‘di testa’, un balletto cristallizzato, sviluppando nel silenzio dello studio una grandiosità che vorrebbe essere ‘classica’.
1886, Seurat, Signac, Pissarro partecipano all’ottava mostra degli impressionisti; per loro il critico Félix Fénéon introduce il termine ‘neoimpressionista’. I temi del paesaggio e della vita moderna rimangono più o meno gli stessi. La novità del ‘neo’ è il rapporto tra pittore e soggetto. L’impressionista, almeno in prima battuta, dipinge di fronte al soggetto, in quel momento, con quelle ombre passeggere: i covoni di grano o le cattedrali di Monet. Il neoimpressionista, dopo aver disegnato alcuni schizzi, dipinge nel suo studio e ricostruisce pazientemente la scena secondo le nuove regole dell’ottica. Un processo del tutto concettuale. È il caso emblematico de la Grande Jatte di Seurat: sulla grande tela si sviluppa una sospensione interrogativa, una immobilità inquieta, la scimmia, il cagnetto fermato nel salto, il gioco degli ombrelli e dei cappelli, profili, luci e ombre ritmate. Uno sforzo tutto ‘di testa’, un balletto cristallizzato, sviluppando nel silenzio dello studio una grandiosità che vorrebbe essere ‘classica’.
G. Seurat, ASunday on La Grande
Jatte - 205,5 x 308 cm.
Signac
invece ama l’armonia, la festa pacata, una gioiosa vibrazione musicale che si
espande, accomunando terra, acqua e cielo. Rare le figure che pretenderebbero
una individualità, uno stacco, una durezza che il fremito diffuso ne sarebbe
scosso, interrotto. Anche quando a Saint-Tropez ricorda i tasselli di Cezanne,
la soddisfazione delle simmetrie, delle riprese, delle gioiose parentele dei blu, dei gialli, dei rosa, parlano di
accoglienza, di amicizia, di soddisfatta armonia. Ma il mondo stava cambiando. 1905,
da quelle parti passano Matisse, Marquet, Derain, i Fauves insomma, le belve, secondo la ben nota espressione del
critico Louis Vauxcelles, anche se alcune di quelle ‘belve’ abbasseranno i
ruggiti e riprenderanno i sospiri pacati di Signac. Ma, per ora, occorrono toni
forti, ribellioni pugnaci. Addio
delicatezze, luminosità diffuse, eleganze preziose. Quei tasselli che
costruiscono in sintonia acque e nuvole e barche, esprimono fiducia in una
cosmologia pacificata, nella quale il colore raggiunge la sua brillante
autonomia nella libertà dello sguardo e dell’invenzione, premessa al momento
gioioso dell’astrazione. Signac sente che quel tempo sta per finire, passa ad
altro, scopre negli alberi la curva elegante del giapponesismo, si sposta di
continuo, la grafia si fa veloce, lo schizzo un souvenir. Ancora navi, barche,
mari, nuvole, acquerello trasparente e pennino, quasi una cronaca turistica, ma
quella vibrazione sapiente, i sussurri
sommessi, quel fremito in espansione, avvolgente, attraverso i tocchi pazienti,
minuti del pennello, non tornerà più.
P. Signac Saint-Briac-Les-balises
1890
P. Signac Sainte-Anne (Saint-t
Tropez) 1905
No, non una fine, una
scomparsa definitiva, ma piuttosto una preziosa eredità trasmessa alle esperienze
meno barricardiere del ‘900.
****
Quand fondra la neige - Palazzo Fortuny
Già il luogo appartato in una Venezia assediata da un
turismo selvaggio, la vetusta magione gotica, l’ombra del suo immortale
proprietario spagnolo, la cui presenza aleggia nel piano nobile del palazzo, Marià Fortuny i de Madrazo, pittore,
collezionista, stilista, scenografo, sua la luce teatrale indiretta a cupola,
imprenditore, inventore dell’abbigliamento plisettato greco di Delphos …e poi quel titolo, oggi, “Quand fondra la neige, où ira le blanc”,
la neve lucente che si squaglia e quel non colore che vaga senza corpo, un
desiderio, un altrove, dove? … i puntini indicano un esserci che non c’è, non
un apparire ma una apparizione.
Le opere esposte, che vanno agli anni ’70
ai nostri giorni, sono di un collezionista bolognese, Enea Righi, il quale si chiede, e noi con lui: “Si vuole
collezionate per investimento? Per speculazione? Per acquisire uno status
sociale? Per arredare i muri di casa? O per una passione autentica per l’arte?
Solo in quest’ultimo caso, che è quello che mi interessa, occorre usare un
pizzico di razionalità unito a un pizzico di irrazionalità e con una buona dose
di follia”. (Studio in Triennale,
maggio 2013). Ecco, una buona dose di follia dove si spande più facilmente
quella polvere bianca di neve. Cominciamo con la pioggia di Philippe Parreno Speech Bubbles 2009, dal soffitto.
Bubbole, una pioggia di parole, lucide, gonfie, parole parole parole cantava
Mina.
Philippe Parreno
Due mi sembrano le caratteristiche di
questa collezione ‘personale’: la predominanza dell’autore straniero, non
italiano, una visione ampia, fuori dai tracciati più consueti, e la importanza
dell’aspetto ‘concettuale’ dell’opera che deve perciò esprimere un
‘significato’. Non solo edonismo formale insomma. Prendo due esempi, forti
anche nell’impatto sensoriale:
‘Break-through’,
‘Sfondare’ di T. Hirschhhorm, legni, pali spezzati, pannelli rotti appesi in
disordine, un senso d’angoscia, la guerra, il soffitto crollato, forse quel
soffitto che sta sopra all’opera.
In fondo al corridoio si legge: Poised Between Dissolution & Resolution
At the present time. Bella compagnia!
Secondo esempio, più leggero: Francesco
Vezzoli, ‘Self-Portrait as Emperor
Hadrian loving Antinous’ 2012
Due busti neoclassici di gesso, un occhio
a Paolini, si guardano con amore. Il giovane in alto, la sua lontananza, la sua
fine precoce. La vicenda antica con un switch ironico alla contemporaneità e
alla propria soggettività.
Markus Schinnwald, Ivy,
Ritratto ritoccato 2008
E al contrario del gioco erotico, lo
sberleffo, la reticella sullo stereotipo seduttivo del modo antico
incorniciato. Un salto con l’opera di Joan Jonas nel contrario ‘Crepuscolo’
tecnologico, un titolo sfottente della moderna femminilità imprigionata,
colpita dai raggi televisivi in Twilight 1975.
Il monitor non trasmette un’immagine, ma, al contrario sprigiona una luce
abbagliante che imprigiona la figura nel cerchio. Non fa vedere ma nega ogni
immagine, acceca e produce l’immensità
dell’ombra.
Joan Jonas Twilight
Fabio Mauri
Sulla parete
è incorniciata la fotografia della donna sfregiata di Robert Longo (1983-84)
come uno dei cattivi ricordi, così immagino, riposti nella valigia, una delle
tante trasportate a fatica, impilate, non diversamente da quelle che si
ammucchiano ne “Il muro del pianto” (1993)
di Fabio Mauri (non esposto in questa rassegna), perché anche in quelle diverse
valige si sono depositate le briciole del bianco che la neve ci ha lasciato:
viaggi, spostamenti, abbandoni, scoperte, attese, ricordi, perdite. E’ un modo di viaggiare pesante,
terrestre: carri e carrozze, animali,
sudori, rotaie, vagoni, anche piombati. La neve si è sciolta, il bianco abbandona la speranza e diventa
polvere.
Sulle
numerose opere, delle quali ho interrogato solo una minima parte, si spande più
il carattere della singolarità che quello della parentela, con un bel finale al
neon di Peter Friedl: “Io posso trovare
fantasie dove non c’è nessuno”. Affermazione dell’opera/fantasia e
negazione dello spettatore. Oppure, di Joseph Kosuth ‘Image’ , non la figura ma come si dice con le parole del
vocabolario:
Joseph Kosuth
Non facile
perciò tracciare un percorso tematico ritmato,
pur suggerito dagli organizzatori, diviso sui diversi piani
dell’edificio: solitudine/identità, amore/odio, eternità/fugacità,
realismo/utopia. No, non un andamento facile. Soltanto un suggerimento, quasi
una provocazione. Ogni visitatore potrà liberamente stabilire le vicinanze e
lontananze a suo piacimento: un bel gioco intellettuale.
Ci sarà il
tempo di provaci. La interessante mostra, a cura di Eric Mézil e Lorenzo Paini,
chiuderà il 10 ottobre prossimo.
***
ORGANISMI, DALL'ART NOUVEAU DI ÉMILE GALLÉ a….
A coups de fouet
si era perso per strada nell’Italia del dopoguerra. La storia dell’architettura
moderna di Bruno Zevi del 1950 aveva però introdotto, citando Wright,
l’espressione ‘architettura organica’, ciò
che appartiene, che si riferisce a un organismo, ne esprime la vitalità. Nello
stesso tempo lo stile Liberty (nome
del fondatore della omonima ditta londinese) veniva usato in Italia dagli
storici, sostituito più spesso con ‘Floreale’,
dal tono derisorio, ‘I fiori in cornice
(le buone cose di pessimo gusto!). La decorazione come un’aggiunta, un
mascheramento, una falsa graziosità. L’arte moderna insomma era un’altra cosa.
L’architettura di allora, che era in gran parte speculazione, rientrava poco
nelle infuocate polemiche di quei tempi. Nasce comunque, quasi come una
curiosità, il Neoliberty, non amato
da Zevi, ma con interessanti esempi a Torino e a Milano, dove s’innalza una
costruzione non più ignorabile, la Torre
Velasca,1956-58, firmata dal gruppo B.B.P.R.
(Banfi, Barbiano di Belgioioso, Peressutti, Rogers), una novità anche se
non proprio Liberty, un ricordo
medievale con cima allargata e strutture in vista. Non manca un importante
passo di lato: un quaderno di “Domus” del ’50 introdotto da Giuseppe Pagano
dedicato a L’elemento verde e l‘abitazione (vedi più avanti “Organismi
ecc.). La benedizione arriva parecchio dopo con la ‘Strada Novissima’ alla Biennale veneziana di architettura del 1980
diretta da Paolo Portoghesi. Alla novità della ‘strada’, firmata da nomi di
illustri architetti, veniva aggiunto il termine
‘Postmoderno’ e la sua giustificazione: la presenza del passato. Se mai
ci fosse ancora qualcuno che pensasse la storia come un percorso rettilineo di
superamenti più o meno inamovibili, dove l’oggi, la modernità, quella è (era) e
quella deve (doveva essere), trovava una ennesima smentita. Non si trattava
certo di una prima volta. Ma insomma, il Liberty
tornava a far sentire più forte il suo colpo di frusta, anche ripresentando
con autorità il proprio passato. Accanto alla mostra di Alfons Mucha, prima a
Palazzo Reale a Milano e poi a Palazzo Ducale a Genova,
…
……
ora “Organismi.
Dall’Art Nouveau di Émile Gallé alla Bioarchitettura” alla GAM di Torino
sino al 6 novembre, a cura di Carolyn
Christov-Bakargiev e Virginia Bertone, presenti anche con loro saggi nel bel
catalogo SKIRA. Il nome centrale è
quello di Émile Gallé, 1846-1904, grande innovatore nei settori del vetro,
della ceramica, della ebanisteria, inesausto animatore di una vera e propria École de Nancy. Ammiratore delle raffinatezze giapponesi, lettore di
Hoeckel (Kunstformer der Natur 1899),
amico degli orticultori, appassionato di botanica, cerca di
introdurre nella trasparenza e malleabilità del vetro la stessa eleganza e
flessibilità delle forme vegetali.
Gallé fotografa le piante che crescono tra gli edifici della sua fabbrica e nel suo giardino e le usa negli atti del Congresso Internazionale di Botanica all’Esposizione Universale del 1900. Le ricerche chimiche e gli esperimenti in laboratorio gli consentono di aumentare la varietà dei colori, dei rilievi, delle sovrapposizioni, nella creazione di un mondo liquido, di andature morbidi, di ondulazioni marine, dove insetti e molluschi danzano insieme a torsioni lente di gambi, foglie e petali: una congiunzione di vita vegetale e animale che scompagina le separazioni e le gerarchie nella indefinita levità del sogno. La boria autocratica dell’uomo, presunto signore dell’universo, si disfa nella avvolgente vitalità ambientale, là dove scopre di non essere irragiungibile padrone ma parte di un respiro ampio, attivo anche nella propria recondita interiorità, ricca, sorprendente e fragile.
L’attuale
esposizione ricorda pure l’appuntamento mancato tra Gallé e la ‘Esposizione Internazionale d’Arte Decorativa
Moderna’ apertasi a Torino nel 1902. Gallé e la sua scuola di Nancy si
prepara a prendervi parte, e l’architetto Émile André ne disegna il progetto
d’ingresso del proprio padiglione, ma i finanziamenti vengono a mancare. Gallé
deve rinunciare.
In mostra sono oggi presenti gli eleganti disegni di André e quelli
sorprendenti di Raimondo D’Aronco con una documentazione fotografica d’epoca.
Non poteva darsi maggiore risalto alla linea curva, la sua
soddisfatta mollezza e inclusività, in contrasto all’angolo retto del
razionalismo, nitido e assolutistico, a cui i grandi architetti del ‘900 , pur
con una parziale assunzione, avevano evitato nella loro particolare capacità
inventiva. Ma insomma le due spinte divergenti si erano prese di volta in volta
la scena, così che l’aumento della popolazione cittadina e la richiesta di
ridurre i costi avevano sviluppato la serialità e l’appannamento della più
individualizzante effusione naturalistica ed emotiva, risorgente poi sempre
come insopprimibile espressione vitale. Opportuno, anzi necessario ripercorrere
le tappe principali di questa periodica emersione, che trova il suo punto di
forza in quella Art Nouveau, oggi
ripensata e ripresa non solo con la
frequenza degli studi, ma pure con i recenti esempi operativi di artisti della
‘Bioarchitettura’
(quei puntini del nostro titolo) che la mostra torinese opportunamente
documenta.
agosto 2016
******
ESCHER UNA FORTUNA ANOMALA

Maurits Cornelis Escher (1898-1972) è uno dei più
famosi e popolari artisti grafici a
livello mondiale. A lui è dedicata la mostra a Palazzo Reale di Milano, aperta
dal 22 giugno 2016 al 22 gennaio 2017. Riprendo dalla presentazione: “Con
oltre 200 opere, l’itinerario del progetto espositivo sarà un viaggio
all’interno dello sviluppo creativo dell’artista, partendo dalla radice liberty
della sua cultura figurativa, soffermandosi sul
suo amore per l’Italia e individuando nel viaggio a L’Alhambra e a Cordova la
causa scatenante di un interesse per le forme geometriche già ampiamente
presente nella sua vena creativa”.
Nell’l’autoritratto in una spazio tondo, lo sguardo
verso lo spettatore, si rappresenta in una stanza stretta in compagnia delle
sue opere e di uno scaffale di libri. L’occhio è triste. In un’opera degli anni
’40 nella pupilla compare il teschio.
Cagionevole di salute, ha sempre condotto una vita
modesta da bravo artigiano usando in
prevalenza la tecnica antica dell’incisione su legno, la xilografia (importanza
del lavoro manuale, prevalenza del bianco-nero), e stampando un numero di copie
variabile, secondo la richiesta. Vicino a pochi amici, la sua fama è cresciuta
tardi, specialmente dopo la sua morte, diventando un beniamino sia degli
specialisti che del pubblico generico. Nasce nei Pasi Bassi. Non brillante
negli studi s’interessa alla decorazione Art Noveau e alla grafica. E’
importante la sua lunga permanenza in Italia e i suoi paesaggi dai tagli audaci
e volumi arrotondati, pesanti.
Castrovalva, Abruzzi 1930
La visita alla Alhambra moresca lo stimola alla libertà
decorativa, alla varietà della ripetizione. Lo scambio delle parti, la la
polarità bianco-nero, pieno-vuoto, creano piacevole sorpresa.
Ecco la mano,
l’origine. Il contorno ripete capovolta o stravolta, l’immagine. E quali
meraviglie le scale! Si lanciano nello spazio, si capovolgono, sopra sotto, s’intersecano, s’internano.
Ma anche le
forme, i visi si smembrano, muti, tagliati su nastri che si arrotolano in uno
spazio scuro, abitato da bolle leggere.
E’
un mondo di metamorfosi, di sorprese, di spazi multipli, di specchi che non confermano l’esistente ma lo spezzano, lo moltiplicano, lo disorientano.
Si
è parlato di una parentela inconsapevole con le matematiche più innovative, con
i paradossi scientifici più intricati. Non saprei entrare in queste difficili
disquisizioni. Metterlo, per nobilitarlo, tra i grandi nomi della scienza e
dell’arte, mi sembra inappropriato, non per ridurlo ma per restituirlo alla sua
originalità. Esher non polemizza in storici scontri, non partecipa a gruppi e
movimenti. La sua curiosità, solitaria, è ampia quanto la sua fantasia. Non è
un caso, mi pare, che applicazioni esheriane evidenti, prima che in
collezionisti d’arte, si trovano su copertine LP, complessi pop, fumetti,
francobolli, pubblicità, films fantascientifici. “L’effetto Droste”, la scatola di un famoso
cioccolato danese, è stato spesso citato per una delle tante trasposizioni,
rimpicciolimenti che Esher aveva sotto gli occhi e che si divertiva a
moltiplicare e stravolgere . E vi
aggiungerei un espressione dell’artista spesso citata: “lo stupore è il sale della terra”. Dunque l’anomalia che ha
rappresentato e rappresenta il caso Esher
potrebbe stare, a mio parere, nell’aver trasportato il mondo delle lanterne
magiche, degli specchi plurimi e deformanti, dei fumi, delle ombre, dei trucchi,
degli indovinelli, dei giochi di parole nella modernità. Stupore, divertimento,
spaesamento. C’è raffinatezza, ma pure nei suoi occhi melanconici col teschio
nella pupilla, l’abbandono dell’ovvio, c’è la forza dell’ironia, il trasportare
l’apparato esagerato, perfino carnevalesco dello spettacolo nei più
imprevedibili esercizi della fantasia.
****
LA BELLE ÉPOQUE DI PAOLO TROUBETZKOY
Museo del Paesaggio, strano nome per un Museo, ma in qualche modo connesso anche alle abitudini di un facoltoso principe russo, Pietro Troubetzkoy, che sulle rive del lago Maggiore si fa costruire nel 1867 una villa (la chiama Ada, come la moglie americana) ispirata agli chalet alpini e alle dacie russe, e nel suo grande giardino coltiva con passione piante rare ed esotiche. Nella nuova abitazione, frequentata da artisti, politici, principi e blasonati del bel mondo, crescono i tre figli, Pietro, Paolo e Luigi. Paolo, nato nel 1866, divenuto scultore, sarà ora il mio soggetto principale.
Occorre
attendere alcuni decenni perché Antonio Massara fondi a Pallanza nel 1909 il
Museo del Verbano trasformato nel 1914 in “Museo del Paesaggio”, ospitato nel
palazzo sei-settecentesco di Palazzo Viani-Dugnani, oggi completamente
restaurato, un restauro elegante e una accurata disposizione, ora il luogo
della mostra delle 150 sculture in gesso
di Paolo Troubetzkoy, quel figlio del principe russo, diventato fortunato artista
cosmopolita. Ufficio
Stampa Lucia Crespi. Catalogo ‘P. Troubetzkoy’ Il Quadrante Ediz. Verbania, Pallanza
1990.
Torno alla
seconda metà dell’800. Villa Ada è un cenacolo di artisti. Alla presenza fissa
di Daniele Ranzoni si aggiungono Tranquillo Cremona, Giovanni Segantini, Emilio
Longoni, Leonardo Bazzaro, Giuseppe Grandi e i compositori Alfredo Catalani e
Arrigo Boito. Paolo, poco dedito agli studi si trasferisce a Milano, si dedica
alla scultura e viene in contatto con i giovani della cosiddetta ‘Scapigliatura’, assumendone il tratto
svelto, sicuro, lontano dalla pignoleria dei particolari e dalla venerazione
dell’antico, una elegante sprezzatura che conserverà, anzi perfezionerà nella
sua molteplice produzione successiva, ma non l’atteggiamento critico, il
rifiuto, la “opposizione agli ordini stabiliti” propri della nuova borghesia a
cui contrapporre la libertà innovativa del “disordine” malato, a suo modo
creativo (come nel testo dell’Arrighi che seguiva “La Vie de Bohème” di Murger).
E qui mi sembra nasca la fortuna e insieme i limiti della sua produzione
successiva. Una indiscussa capacità rappresentativa, una esecuzione elegante e
disinvolta, ben dimostrata dagli innumerevoli ritratti di amici, parenti,
artisti, spesso già incontrati, giovanissimo, nella villa paterna, e figure note,
più o meno blasonate, proprie di una elegante aristocrazia internazionale.
Ma insieme la
sua estraneità a quella inquietudine, a quel disagio e senso di crisi, già
dichiarato dall’Arrighi sulle tracce di quella cultura internazionale che
andava da Baudelaire a Rimabaud, da Mallarmé a Moreau, Vrubel’, Klimt… e, trascurando i grandi nomi che tutti
conoscono, per stare tra gli italiani a Parigi, a Rosso e allo stesso modaiolo
Boldini, che Troubetzskoy ritrae e stima. Certo, la sua fedeltà ad un modalità
creativa raggiunta precocemente, la sua partecipazione ad un mondo benestante affettuosamente
coltivato lo hanno difeso dalle difficoltà che molti altri artisti suoi
contemporanei erano costretti ad affrontare, l’incomprensione, la ricerca di un
gallerista, di un cliente, l’appoggio di un critico. Eppure questa differenza
lo ha allontanato dalle vivaci e feroci polemiche che si andavano sviluppando
intorno a lui (ricordo che muore nel ’38) e lo ha reso estraneo ai cambiamenti
vorticosi dei vari movimenti che ben conosciamo, simbolismo, cubismo, futurismo
ecc. Riprendo questo controcanto per
individuare la particolarità della vicenda di Troubetzkoy che, pur partecipando
a concorsi pubblici e rispondendo a richieste di privati, spesso aristocratici, in prevalenza
per la ritrattistica, non vive lo scontro ma la condivisione, la simpatia, la
vicinanza sociale, e per lo stile, per le modalità di esecuzione, la continuità con le tecniche apprese nel suo
primo periodo giovanile e maturate senza scosse per la sua lunga attività.
La moglie, part. 1910-11
Nel
1898 incontra Lev Tolstoj nella tenuta di Jasnaja Poljana. Una illuminazione,
ne subisce l’influenza morale e ideologica; lo ritrae più volte in disegni e sculture.
Il 1905 poi è
un anno cruciale. In seguito ai primi moti rivoluzionari lascia la Russia, e
dopo una serie di spostamenti, anche a Milano e nello studio di Verbania, che
aveva visitato saltuariamente e non mancherà di farlo in seguito, si stabilisce
a Neuilly sur Seine, sobborgo di Parigi.
In occasione
di una sua mostra personale a Londra, nello studio di John Singer Sargent esegue
il primo busto, origine di molte successive varianti, di George Bernard Shaw, col quale condivide la dieta vegetariana e di
cui diventerà grande amico. Una fotografia li ritrae insieme a Pallanza, di
fronte all’innovativo monumento ai caduti: una giovane madre lascia cadere
alcuni petali sulla grande roccia-tomba .
Monumento ai caduti 1923
Le due
immagini successive si riferiscono ai vari ritratti di Bernard Shaw esposti nei
locali dell’attuale mostra al Museo del Paesaggio che conserva il lascito
Troubetzkoy, una gipsoteca costituita, secondo l’inventario del 1976, da ben 340 opere.
Al termine
di questi brevi cenni, vorrei tornare sulle ragioni di una certa ‘dimenticanza’
di cui mi pare soffra il nostro scultore. A mio parere si tratta del fatto che
l’arte ‘moderna’, pur diramata in tante tracce, ha percorso salti, rifiuti,
trasformazioni che l’hanno distanziata, contrapposta alle modalità
rappresentative proprie della prevalente tradizione ottocentesca e insieme, pur
con sbalzi e riserve, anche le istituzioni, il pubblico, i fruitori, sono
cambiati. Quella aristocrazia, quella eleganza che si suole far coincidere con la Belle époque è stata negata dalle Avanguardie e sotterrata
dalla guerra . Il monumento funebre scolpito da Troubetzkoy è quasi un
autoritratto. Ma niente si chiude del tutto. La fine delle mode artistiche, Land art, Arte povera, Minimal, Concettuale…non
significa la fine dei nuovi flussi, dei raggruppamenti, del mercato, ma la
tolleranza, la curiosità, le diverse ragioni anche di chi, come Troubetzkoy, è
stato fedele alla sua giovinezza, ai suoi affetti, al suo ambiente che le
vicende tumultuose del ‘900 stavano distruggendo. Così, a mio parere, va
ripresa la sua storia, la sua ansia dei grandi personaggi e il suo sogno del
paesino sul lago. E così ecco il suo, il nostro riavvicinamento.
Pallanza non
è ricca soltanto del paesaggio e della gipsoteca T. ma anche di un lascito di
53 sculture di Arturo Martini, e oltre al Palazzo di cui si è parlato, anche di
Villa Giulia, affacciata sul lago Maggiore, con la mostra ‘Immaginare il giardino’, immagini incise e proiettate dal 1600 a
oggi. Ma di questo scriverò un’altra volta. Ancora, nella cittadina lagunare vi
dimora la Fondazione Cefis, con più di 5000 ex-voto, documenti di arte popolare
che attende ancora una sua propria riflessione (Un nuovo centro si è aperto ora
anche a Milano). Insomma, una visita per molti motivi consigliata.
******
Un
anniversario, 1516-201
il primo Ghetto a Venezia
il primo Ghetto a Venezia
"Ghetto", forse da “geto”, gettare il metallo fuso, il nome indicava
il luogo delle fonderie, non più in uso, per la fabbricazione delle bombarde,
circondato da canali e facilmente controllabile. Qui il Senato veneziano, dopo
una lunga crisi bellica che gli aveva sottratto buona parte dei possedimenti di
terra ferma, stabiliva la reclusione della popolazione ebraica, secondo un
modello che con la bolla di papa Paolo IV
nel 1555, Cum nimis absurdum, veniva
esteso in tutta Europa.
La storia di questo luogo particolare,
tuttora attivo, è il soggetto della bella mostra “Venezia, gli ebrei e l’Europa 1516 – 2016”,
curata da Donatella Calabi, aperta dal 19 giugno sino al 13 novembre in Palazzo Ducale, là dove era stato
decretato cinquecento anni fa la nascita del ghetto. Riprendo dalla
presentazione stampa l’atto ufficiale di fondazione del ghetto: Il Senato
riunito decretò il 29 marzo del 1516... “che sarebbero state aperte due porte la mattina al suono della ”maragona” (la
campana di San Marco che dettava i ritmi dell’attività cittadina) e richiuse la
sera a mezzanotte da quattro custodi cristiani, pagati dai giudei e tenuti a
risiedere nel sito stesso, senza famiglia per potersi meglio dedicare
all’attività di controllo. Inoltre si sarebbero dovuti realizzare due muri alti
(che tuttavia non saranno mai eretti) a serrare l’aerea dalla parte dei rii che
la avrebbero circondata, murando tutte le rive che vi si aprivano. Due barche
del Consiglio dei Dieci con guardiani pagati dai nuovi “castellani”,
circoleranno di notte nel canale intorno all’isola per garantirne la sicurezza.
Il 1 aprile successivo, la stessa ‘grida’ venne proclamata a Rialto e in
corrispondenza dei ponti di tutte le contrade cittadine in cui risiedevano i
giudei…” Allo stesso tempo lo sguardo si allarga,
abbracciando le relazioni stabilite con il resto della città e con altri
quartieri ebraici
(e non solo) italiani ed europei, a sottolineare la ricchezza dei rapporti tra
gli ebrei e Venezia e tra gli ebrei la società civile, nei diversi periodi
della loro lunga permanenza in laguna, in area veneta e in area europea e
mediterranea. L’intento è infatti una maggiore consapevolezza delle diversità
culturali esistenti nella Venezia cosmopolita d’inizio Cinquecento e della
commistione di saperi, conoscenze, abitudini che ne costituiscono tuttora il
principale patrimonio. Non solo un lavoro d’indagine sull’area specifica dei
tre ghetti (Nuovo, Vecchio e Nuovissimo)
dunque, ma anche una riflessione sugli scambi culturali e linguistici, sulle
abilità artigianali e sui mestieri che la comunità ebraica ha condiviso con la
popolazione cristiana e le altre minoranze presenti in un centro mercantile di
straordinaria rilevanza. L’arco cronologico preso in considerazione va oltre la
caduta della Repubblica e l’apertura delle porte nel 1797 per volere di
Napoleone: apparirà in mostra anche il ruolo degli ebrei nell’età
dell’assimilazione e nel corso del Novecento.
La mostra
intende descrivere i processi che
sono alla base della nascita, della realizzazione e delle trasformazioni del
primo “recinto” al mondo destinato agli ebrei. Oltre agli italiani i due gruppi principali di ebrei che si mescolano nel
ghetto sono i Sefarditi o spagnoli,
detti anche ‘ponentini’ (Sefarad in
ebreo spagnolo indica ‘Spagna’) e gli Ashkenaziti
o tedeschi, detti anche ‘levantini’ (Ashkenaz in ebraico medievale nella
regione franco-tedesca significa ‘tedeschi’). Una mescolanza di lingue,
pratiche rituali e alimentari che certo
non facilitò all’inizio una inusuale convivenza, ma che caratterizzò per forza
una collaborazione e comprensione reciproca delle varie comunità ebraiche, che
costituì, nonostante i pesanti divieti e “il bel rogo” del Talmud (i commenti della Torah)
in piazza san Marco, secondo l’ordine di papa Giulio II, una ricchezza
anche per la città di Venezia. E ora un ricordo personale. All’inizio
degli anni ottanta, lavorando a New York all’Istituto Italiano di Cultura, avevo
assistito all’incontro tra Primo Levi - invitato per la edizione in inglese de
‘Il sistema periodico’ - e gli ebrei di Salonicco, trapiantati da tempo
negli USA, ‘Levantini’ di origine sefardita: si intendevano attraverso la
lingua spagnola!
Non riprendo una storia che è stata
raccontata tante volte, ma sulla quale forse è bene ritornare periodicamente
per il suo valore emblematico, una oppressione trasformata in vitalità, sofferta,
sì, ma, in qualche modo, trionfante.
Costretti in spazi e regole restrittive, spinti ad una conversione forzata al
cristianesimo (questo era il progetto della bolla papale), gli ebrei mantennero
invece la propria identità e la propria lingua, approfondirono gli studi sui
loro testi, indispensabili anche alle religioni che ad essi seguirono, si
fecero intermediari indispensabili tra Venezia, assediata dalle potenze europee
della Lega di Cambrai, e il mondo turco-mussulmano dove molti di loro, in fuga
dall’Europa, avevano preso dimora.
Doge
Leonardo Loredan (di V. Carpaccio) sotto la cui autorità viene firmato il
decreto istitutivo del ghetto
Predica
di Santo Stefano di Vettor Carpaccio: cristiani, turchi, un ebreo col copricapo
nero e una lunga barba
Rabbino,
Marc Chagall 1914-1922
Nobile
al banco di Giovanni Grevembroch sec. XVIII
Ebrezza di Noè, Giovanni Bellini. Rappresentazione caricaturale dell’ebreo
Contratto
matrimoniale ebraico 1723
Area
del ghetto, tra il canale dilli Hibrei e quello dilli Marani (=porci, come
erano chiamati gli ebrei spagnoli falsamente convertiti)
Tutte le immagini, salvo la prima, un olio
del Louvre, fanno parte di collezioni veneziane, ricche pure di edizioni
antiche stampate in ebraico. L’importanza di questa esposizione conferma che la
rinnovata riflessione su di una realtà così complessa e contraddittoria come la
secolare vicenda ebraica, non è mai solo un risultato archeologico, ma sempre anche
una scoperta e una responsabilità dell’oggi. Il caso insomma di una centenaria persecuzione e conflitto trasformata in abilità, conoscenza
e intelligente adattamento. Penso per esempio al ‘ banco di prestito’, la
padronanza del flusso di un simbolo astratto, il denaro, visto con fastidio sia
dalla Chiesa cattolica che dal Principe, che diventa lo strumento necessario
allo sviluppo della civiltà moderna. La mostra, presentando oggetti di culto,
immagini, documenti preziosi stimola il pubblico ad approfondire una conoscenza
data per scontata, ma solitamente approssimativa. La ragione perciò non è
soltanto l’ esibizione di un patrimonio eccezionale, concentrato in un luogo
storicamente unico, il ghetto appunto, da unirsi ad altri luoghi veneziani indimenticabili,
come il cimitero ebraico del Lido, ma la coraggiosa tenuta ‘culturale’ delle
ricche collezioni museali veneziane, il solo strumento, oggi, a contenere la
deriva onnivora e pericolosa dell’invasione turistica di basso livello,
scaricata da tutti i mezzi possibili, aerei, navi, auto, treni, che rischia di
obliterare quel prezioso tesoro di eccellenze artistiche e culturali che
Venezia ha sempre rappresentato.
giugno 2016
*****
CONFRONTI
La
Pinacoteca di Brera sta cambiando aspetto con la nuova direzione di James M.
Bradburne: ben leggibili didascalie, nuovi colori sulle pareti, diversa
illuminazione e distribuzione dei quadri, raggruppati per scuole e particolari
occasioni di confronto tra un dipinto molto noto della Pinacoteca e uno o più
altri provenienti da altre collezioni. Ora si tratta di un secondo
appuntamento, dopo quello di Raffello e Perugino sullo ‘Sposalizio della Vergine’ , fig. 1, sino al 27 giugno, e questo (da
giugno e settembre 2016) tra Andrea Mantegna, Annibale Carracci e Orazio
Borgianni sul ‘Cristo morto’ , fig.
2, 3, 4, 5. Di SKIRA la ricca presentazione stampa e la pubblicazione 'Attorno al Mantegna'.
.
Nel primo
caso si tratta di un sottile confronto tra un giovane ventunenne e un maestro
più che cinquantenne, entrambi quindi viventi e partecipi di un comune ambiente
culturale; nel secondo caso invece, tra Mantegna e gli altri due, corre un
salto di circa un secolo: luogo, clima, tempo completamente diversi. Certo, la
persistenza di un tema simile, un morto in ‘scurto’
disteso su di una lastra di pietra, la pietra dell’unzione, visto dai piedi
piagati, indica la lunga fortuna dell’opera mantegnesca, ma quale distanza!
Alla fredda compostezza e pietrificazione del primo si contrappone la
disarticolazione, le ferite sanguinanti, gli strumenti di tortura degli altri
due (Borgianni, trent’anni dopo, ripete simmetricamente, semplificando, la
posizione del modello carraccesco). La
nudità violata, la chiostra dei denti nella bocca sofferente, le membra rotte,
l’esibizione in primo piano degli strumenti di tortura, i chiodi, la tenaglia, la corona di spine… La
testa si perde nel buio, al contrario delle teste del Mantegna, dove le
emozioni dei presenti non alterano la serenità del Cristo, visi tutti
volutamente grandi, anche contro le regole prospettiche, che campeggiano nelle
loro diverse posizioni. Al contrario gli scoppi di luce e buio non lasciano
spazio di consolazione e pianto sul cadavere del Carracci, ma solitudine soltanto
e abbandono. Queste
poche note valgono solo per sottolineare la distanza che separa l’atteggiamento
del Mantegna da quello dei suoi colleghi seicenteschi, pur nella continuità del
soggetto. Opportuno il confronto, certo, su di un livello di alta qualità, ma
altrettanto importante sottolineare le fondamentali differenze di linguaggio,
così da abituare il pubblico a distinguere la diversità del significato di
un’opera anche di fronte ad una contiguità di argomento. Il cristallino quattrocentismo
del Mantegna mantovano rimane ben lontano dagli a(e)ffetti del Carracci, dalla
sua bolognese e poi romana drammatica teatralità.
giugno 2016
***
GUARDARE CON LE MANI

‘Guardare con e mani, ascoltare con gli occhi’.
Data la particolarità dell’evento ai Musei Civici di Monza mi pare opportuno indicarlo ai miei pochi e preziosi lettori. E' possibile? Come sarebbe possibile? In che modo i diversi sensi, con l'aiuto della parola, si sostituiscono e si aiutano a vicenda? Cosa si perde e cosa si mantiene? Dato che un primo appuntamento è già trascorso, consiglierei di rivolgersi al personale del Museo, anche perché le prossime date, rivolte a persone non vedenti, sono piuttosto lontane: domenica 18 settembre 2016 alle ore 15.30 e sabato 10 dicembre 2016 alle ore 15.30.
Il percorso espositivo verrà illustrato ai partecipanti da una guida specializzata e sarà possibile effettuare un’esperienza tattile su alcune opere esposte. Una occasione rara per incontrare la sorprendente capacità dei nostri orizzonti sensoriali esercitata sulle nostre più radicali disabilità.
Il percorso espositivo verrà illustrato ai partecipanti da una guida specializzata e sarà possibile effettuare un’esperienza tattile su alcune opere esposte. Una occasione rara per incontrare la sorprendente capacità dei nostri orizzonti sensoriali esercitata sulle nostre più radicali disabilità.
WORD PRESS PHOTO 2016. CRUDELTÀ PER IMMAGINI
Alla Galleria Sozzani di corso Como 10 a
Milano la 59° edizione del
Fotogiornalismo mondiale, 1 maggio – 5 giugno, una delle più importanti
rassegne fotografiche, con 83mila candidature selezionate da una giuria
indipendente di esperti. Nonostante otto categorie di concorso (spot news,
attualità, vita quotidiana, natura ecc.) sciagure, disastri, crudeltà sono i
soggetti più frequenti. Mi chiedevo se ci sono particolari ragioni di questa
preferenza, non solo nella riproduzione fotografica.
Serbia, in attesa di passare
Riandando al
passato delle immagini prodotte dagli artisti, mi pare che il ‘600 sia il secolo delle torture: la crocefissione, il martirio,
il delitto, le pene infernali.
Artemisia Gentileschi, Giuditta decapita Oloferne
Malattie,
guerre, fame non mancano. Ma non mancavano neppure prima. La consolazione
religiosa e l’eleganza delle Signorie, la signorilità, ne avevano ridotte
l’esibizione. La crocefissione per antonomasia, quella di Gesù, uscendo dalla
rigidità dell’icona, era pur circondata da un sacrale rispetto. Le guerre di
religione, l’aumento e la moltiplicazione dei poteri centrali, il movimento
delle popolazioni, l’estendersi delle epidemie, il progresso delle tecniche
riduce gli schemi metafisici, allontana i cieli promessi, aumenta la visibilità
dei disastri e delle malvagità. E’ più vicino l’inferno che il paradiso. La
crudeltà, la violenza, la spinta alla sopraffazione esiste, non solo
nell’ambiente esterno, ma anche dentro di me, così che io stesso devo imparare
a controllarla. La rappresentazione
artistica però non è soltanto la descrizione di un assedio, di una costante
minaccia, ma piuttosto una difesa; svolge una funzione apotropaica, un depotenziamento
nell’astrazione dell’immagine. Sì,
so che la minaccia c’è, ma in quella forma
non è un pericolo, anzi posso apprezzarne l’abilità della esecuzione, la
‘qualità artistica’. Il passaggio dalla pittura alla fotografia documentaria, che mi assicura della autenticità -o
almeno la prendo come tale -, indica un passo in più: quello che vedo su quella superficie, piccola o grande, colorata o
in bianco e nero, c’è veramente stato. Cosa significhi quell'esser stato è un problema ulteriore.
Bambini feriti, bambini in fuga
Così attraversano i mari
L’arrivo a Lesbo
Un chirurgo curdo medica un ferito dell’IS
Esplosione di un deposito nel porto cinese di Tianjin
Eppure anche
la fotografia-documento, non parla da sé. La ripresa dall’alto della Esplosione per esempio, potrebbe essere
un quadro astratto appeso alla parete. Però, mentre un dipinto come ‘Giuditta decapita Oloferne’ è
chiaramente un abile manufatto, che pure colpisce per il suo realismo, le
immagini fotografiche sono emotivamente forti perché percepite come impronta di
uno stato di fatto: io stesso potevo
essere in mezzo a quelle persone, io stesso avrei potuto toccare quelle ferite.
Ma veramente la scena fotografica parla da sé, è sempre un chiaro reperto di
realtà, senza bisogno di altri attestati? E’ nota la fotografia del ‘Soldato spagnolo colpito a morte’ di
Robert Capa; non si è mai saputo con certezza se il titolo corrispondesse ad
una vera morte fermata dallo scatto della sua Leika. Il che dimostra che la titolazione è complemento indispensabile alla comprensione dell'immagine.L’astrattezza della carta
stampata non può mai sostituire
l’impatto con il fatto che accade. Il processo riproduttivo, la luce, l’obiettivo,
l’emulsione ecc., è certamente diverso dalla manualità del pittore, ma non lo
potrà mai sostituire. E per fortuna. Si tratta di un immenso patrimonio che può
circolare pacificamente e contribuire alla conoscenza di tutti.
La
difficoltà di risposta dello spettatore aumenta se si passa alla scena cinematografica, che può essere
anche qui documentaria o
esplicitamente recitata da figure
che l’industria cinematografica ha reso note nella loro separata individualità.
L’autoinganno dello spettatore è parte del gioco. Trovarmi seduto su di una
comoda poltrona guardando un film di guerra, di morti, di feriti, tutti bravi
attori, non mi sottrae dalla emozione di partecipare ad una scena ‘vera’, che
sta accadendo davanti ai miei occhi. Dunque la mimesi cine-fotografica mantiene
di per sé la sua ambiguità. E’ una trasposizione che mi allontana dal sudore,
dagli odori, dai pericoli della scena accaduta, sia essa ricavata, rubata dalla
vita drammaticamente vissuta, sia ricostruita, recitata da attori. Il
livello di corrispondenza realistica è naturalmente maggiore di qualsiasi
dipinto, moderno o antico, ma la partecipazione
e insieme la distanza obbedisce ad un simile meccanismo, una emozione
pacificata dalla differenza del mezzo. La crudeltà, il fatto distruttivo mi
colpisce sino alle lacrime, ma so di stare seduto su di una comoda poltrona o
di passeggiare in una elegante galleria d’arte. Le immagini della cattiveria e della sofferenza stimolano la mia
paura e la mia pietà, ma la loro astrazione
rappresentativa allontana una mia partecipazione diretta. Potrei dire che
possono avere una funzione educativa, anche al di là di una certificazione di
autenticità. Così alla mostra fotografica delle mondiali disgrazie del World Press Photo ‘16 riconosciamo pure
il marchio non secondario del ‘così c’è stato’, ma la caratteristica del mezzo,
la distanza dai fatti cruenti, il luogo tranquillo e piacevole della
esposizione offre al visitatore una buona occasione per nutrire la sua
curiosità e aumentare la sua comprensione.
Maggio 2016
******
la/qui/la, i
fili della vita/lità di Max Bottino
Nelle bianche alte pareti della
Galleria Spaziotemporaneo, Milano
via Solferino 56, si dispongono su diverse file fogli uniti in regolari
scansioni dai titoli allusivi: due tempi e
tre atti/orizzonti di comparazione, tre atti/da Niente a Niente, volume/Migranti. La bella presentazione
di Eleonora Fiorani affronta subito
la voluta ambiguità delle opere: “L’immagine non rappresenta ma presenta: ci fa
vedere l’invisibile delle cose, il lato nascosto e anche quello oscuro, così che nel fare dell’arte le cose non sono
mai quelle che sembrano, eccedono sempre al di là del visibile”. Questi
spostamenti, sovrapposizioni e confronti
sono il carattere ricorrente dei fogli di Bottino, dove ‘l’immagine’ non è quella rappresentativa, che ri-presenta un oggetto compiuto, una
figura umana, un paesaggio, ma qualsiasi segno e gruppi di segni con una
significazione multipla, prevalentemente estetica, propria della tradizione
cosiddetta ‘concettuale’.
Un movimento che dalla macchia,
al segno, alla traccia, al ricamo giunge alla scrittura, solitamente stampata su vecchi fogli, e dalla scrittura
ritorna al ricamo, alla traccia, al segno, alla macchia, la quale, a sua volta,
nella sua casuale risultanza è pur sempre ciò che resta e ciò che potrebbe
essere, un ricordo e una potenzialità in-definita. Anche nelle comparazioni
i caratteri stampati di una fascia
di fogli, con tratti manuali si trasformano in smagliature e le forme informi
sottostanti si raggruppano come in animaleschi tentacoli che si staccano, si ingrigiscono
nel desiderio di fermarsi in scrittura.
UCCELLI MIGRANTI: l’intestazione
si legge sui fogli ingialliti, sopra un muoversi rapido di ondulazioni. Queste
matasse nuvolose diventano tracce di penna che avvolgano frasi stampate, enigmatiche, oracolari, con difficoltà districabili
dalle ondate dei segni. Anche qui una scrittura che s’inabissa nel segreto.
Ne riporto alcune:
Ciò che sei non vedi, ciò che
vedi è l'ombra tua.
I miei desideri sono folli, essi
gridano attraverso i tuoi canti, Maestro mio. Oh! Che io ascolti solamente. Non posso eleggere il meglio. Il meglio elegge me. Proiettano la loro ombra dinnanzi a sé, coloro che si portano la lanterna a tergo.
La difficoltà della lettura è aumentata quando le due pagine vengono ruotate sulla destra in posizione verticale. Un battito d’ali degli Uccelli migranti, l’incertezza della visione, la profondità della terra.
Dunque una scrittura codificata,
un codice fisso - pur nel significato ambiguo - obnubilata però da tracce mosse
in un ordine stratificato, geologico, oppure, come nella prima immagine, nel
reticolo di un ricamo. Dalla scrittura il-leggibile alla forma. Passaggi. Max Bottino ci spinge a
sdrucciolare sui diversi gradi della interpretazione.
3 maggio 2016
***
GUFRAM ON THE
ROCKS
“Gufram nasce a Torino nel 1966
rivoluzionando il paesaggio domestico e dando vita, assieme ad altre realtà di
quel periodo, a quello che oggi è conosciuto come Italian Radical Design… Le sue icone sono diventate dei punti
fermi nell’immaginario collettivo, come scogli intorno a cui passano le
correnti” (Charley Vezza). Io sono
abbastanza in là con gli anni da ricordarmi il felice effetto di una natura in
plastica, quasi uno scherzo, i sassi molli, “pavè piuma” di Piero Gilardi:
trattare, dipingere il poliuretano con pittura idrorepellente che lo
‘pellifica’ eliminando le fodere. Un processo che Gilardi definisce Guflac.
....
Questo è il
contenuto della bella mostra di ‘scultura morbida’ alla Galleria Carla Sozzani (sino a domenica 1 maggio), con un
luminoso parterre di frammenti, blocchi, bandiere, piante, sedili, pietre, pezzi vari, dagli
spigoli rigidi o arrotondati, coloratissimi, allegri, una mescolanza, un
disordine piacevole, lungi dal senso del cataclisma, ma al contrario nel divertimento del gioco e del sorriso.
Tanto è più duro l’aspetto, altrettanto più morbida la sua consistenza, in
voluto e scanzonato contrasto con le freddezze, assolutezze e seriosità delle
tecnologie. “Un pensiero indisciplinato” scrive sempre Vezza, che si prolunga,
con fortunato successo, dagli anni sessanta delle origini sino ai nostri
giorni.
Un gioco abitabile, una trasformazione irreale, una
artificialità scherzosa, una modernità del materiale e delle forme che vuole
contraddire se stessa. Tra l’assedio delle tragedie un intervallo del sorriso.
***
Toulouse-Lautrec tra festa e melanconia: l’opera grafica
Al Museo dell’Ara Pacis di Roma è aperta una mostra molto
interessante sull’opera grafica di Henri
de Toulouse-Lautrec (chiude l’8 maggio), 170 litografie dal Museo di Belle Arti di Budapest, che con
lungimiranza ne iniziò l’acquisto dal 1901, lo stesso anno della morte
dell’artista. Il catalogo SKIRA, un
importante complemento, contiene saggi utili alla conoscenza delle tecniche sui
diversi modi di lavoro e alla descrizione delle figure di editori e di amici
dell’artista che ne appoggiarono e seguirono il frenico lavoro sino alla sua
morte a 37 anni di età.
E’ difficile scrivere qualcosa che non sia già stato detto
su di un artista popolare, amato anche per la sua particolarità, “un nano di
Velàzquez, con il genio di Callot” (cit. p. 133) e la sua pungente,
disincantata descrizione che ci ha
lasciato dei mondi marginali propri di quell’industria del divertimento che caratterizza la Parigi fine
Ottocento.
Fotomontaggio di
M.Guibert 1890 ca.
Ripercorro tappe già raccontate varie volte, a cominciare
dalla malattia. Nato ad Albi nel
1864 da una ricca famiglia aristocratica, patisce di una malattia genetica
ossea - i genitori erano cugini primi – aggravata da due incidenti all’età di
14 anni, la frattura della gamba sinistra e del femore destro, che interrompe
la crescita degli arti inferiori. La statura si ferma a un metro e mezzo e la
camminata sarà sempre faticosa. La madre lo cura, lo segue a Parigi e il figlio
continuerà a scriverle, anche nei periodi di separazione. La breve vita di
Henri viene stroncata dalla sifilide e dall’alcolismo. La madre gli sarà vicino
anche sul letto di morte, nella casa di famiglia a Malromé, in quel 9 settembre del 1901.
La teatralità, il
palco, l’operetta, le canzoni, il ballo, il Café-chantant, il cabaret, la mescolanza tra pubblico e attori, una
artificialità mescolata alla vita corrente, una permissione programmata nella
esibizioni delle nudità offerte, nei gesti, nelle maschere che mascherano e
lasciano intra-vedere. Il pittore nuovo, Manet, Degas, capisce che si tratta di
una trasposizione del prorpio stesso dipingere, anzi, qualcosa di più: il corso
vitale inquadrato, esposto. Toulouse-Lautrec ne rimane affascinato, la sua
prima prova per il Moulin Rouge nel
1891, una stampa di grandi dimensioni (cm.191x 115) è un capolavoro:
Il teatro delle ombre, il taglio, l’essenzialità delle
xilografie giapponesi, la scrittura, firma e annuncio, che non disturbano la
scena, due personaggi, lui, Valentin le
Désossé, in controluce con la mano nell’apertura delle gambe di lei, La Goulue, in piena luce nella spaccata
che il pubblico attende.
La Litografia,
segno su pietra. Lautrec si è spostato a Montmartre, il luogo degli artisti.
Frequenta assiduamente i locali notturni e insieme i laboratori per la stampa
litografica a colori e gli editori raffinati come André Marty,direttore del
“Journal des Artistes” o i fratelli Natanson, noti per il loro salotto
intellettuale, che trasformano”La Revue
blanche” nel più importante organo di stampa dell’avanguardia artistica
parigina, dove si ritrova il gruppo dei Nabis, Bonnard, Vallotton, Vuillard, e
naturalmente Lautrec, immancabile ospite delle loro feste. I giovani artisti
avevano superato l’affezione per l’opera unica, abbracciando la possibilità di
una più ampia diffusione attraverso l’editoria e le stampe numerate, sempre più
richieste dai collezionisti. Lautrec ne
rappresenta un caso di punta, unendo nelle sue esposizioni presso le gallerie
d’arte sia dipinti che litografie, sia introducendo tecniche nuove nella stampa
litografica, come ‘lo spruzzato’ (crachis).
Non disdegna illustrazioni per i giornali, copertine di spartiti musicali e
locandine per il teatro, ma non dimentica l’eleganze raffinate della forma e
dei gesti, come nelle diverse stampe della ballerina loïe Fuller e i suoi veli
volanti.
Il mondo femminile.
Lautrec non ama la solitudine ma le feste, lo sguardo femminile, frequenta il
cabaret e i bordelli. Il mondo dei locali notturni e dei luoghi malfamati
risponde ad un sentimento di comunanza, dove si può dimenticare la propria fisica
malformazione. C’è pure il senso della festa, del travestimento, della
curiosità. Una popolazione in cerca di piacere, per chi lo richiede e chi lo
fornisce, due categorie differenti, e non c’è dubbio che Lautrec parteggia per
la seconda, in modo contenuto, lontano da ogni volgare insistenza. La sua
matita segna con sicurezza i contorni, le luci artificiali spingono il bianco
dei volti: compostezza, vicinanza. “Tra il 1892 e il 1895 trascorse intere
settimana nelle maisons closes…Con le sue buone maniere si guadagnò
l’affetto delle prostitute, tanto da diventare il loro confidente” (p. 133). Sì,
c’è anche, frequente tra le prostitute, l’amore saffico (v. ‘Il palco’). Il
medico lo ha definito una malattia solo maschile, l’artista lo rappresenta come
qualsiasi altro momento dell’affetto, della confidenza quotidiana. Il teatro, la caricatura, il travestimento, l’ebrezza alcolica sono la
volontà di uscire dalla quotidianità malata, quella quotidianità degli affari e
della politica (anche dell’ l’affaire
Dreyfus) che non lo interessano. Accompagnato da alcuni amici fedeli e
dallo sguardo lontano della madre, è accettato dal demi-monde
dell’intrattenimento notturno, spesso ballerine e saltimbanchi provenienti da
un povero mondo popolare, nel quale spesso, spente le luci della ribalta, vi
ritornano.
Au Salon de rue des Moulins, pastello 1894
Tolouse-Lautrec è una maschera ambigua di quella industria
del divertimento che è diventata il marchio di fabbrica della Belle Époque. Maschera ambigua perché nella
ricerca della esaltazione, della festa, della femminilità (pare che abbia avuto
un solo legame prolungato e finito male con la pittrice Suzanne Valadon),
serpeggia la melanconia di una povera umanità sofferente, compresa, abbracciata
con un segno (sulla carta) e uno sguardo di amorevole pietà. Attenzione, non è
solo un dare. Il perché sta nella sua personale insoddisfazione. Perché non è
contento di sé deve perdersi e riconoscersi altrove. Strada impervia. La sua
bussola è la sicurezza della sua grafia, lo scavo nei ‘personaggi’ che, ammirati
o temuti,vengono, nella trasposizione pittografica, neutralizzati, assimilati,
fatti propri, pur conservando la loro necessaria distanza. La sua attività di interprete, la sua capacità di rappresentare il
carattere è stato l’altro aspetto della comprensione e della sua sopravvivenza.
Su di ciò non ha mai nutrito dubbi. La sua forza.
Jane Avril 1893
24 aprile 2016
***
LA XXI ESPOSIZIONE DELLA TRIENNALE DI MILANO SI APRE DOPO VENT’ANNI
La
Triennale di Milano, fondata a Monza nel 1923 in occasione della I Biennale delle arti decorative dell’ISIA ad opera di Guido
Marangoni, è stata trasferita a Milano nel 1933, anno della
costruzione del Palazzo dell'Arte di Giovanni
Muzio. Ora, dopo l’interruzione del 1996, riapre con una
estensione ‘colossal’: mostre, eventi, festival, convegni, di cui indico le 19
principali sedi:
1.Triennale di Milano Viale Alemagna, 6 mar – dom 10.30 –
20.30 2.
Accademia di Belle Arti di Brera Via Brera, 28 lun – sab 09.00 – 19.00 3. BASE
Milano Via Bergognone, 34 mar – dom 10.30 – 20.30 4. Fabbrica del Vapore Via
Procaccini, 4 mar – dom 10.30 – 20.30 5. Pirelli Headquarters Viale Piero e Alberto Pirelli,
25 6.
Grattacielo Pirelli Via Fabio Filzi, 22 7. IULM Via Carlo Bo, 1 lun– ven 8.30 – 20.00 8. MUDEC
Via Tortona, 54 / Via Bergognone, 34 lun 14.30 – 19.30 mar, mer, ven e dom 9.30
– 19.30 giov e sab 9.30 – 22.30 9. Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia “Leonardo da Vinci” Via Olona, 6 mar – dom 10.30 – 20.30 10.
Museo Diocesano Corso di Porta Ticinese, 95 mar – dom 10.30 – 20.30 11.
Palazzo della Permanente Via Filippo Turati, 34 mar – dom 10.30 – 20.30 12.
Pirelli HangarBicocca Via Privata Chiese, 2 gio – dom 10.00 – 22.00 13.
Politecnico di Milano Campus Milano Leonardo Piazza Leonardo da Vinci, 26 lun –
ven 10.00 – 19.00 14. Politecnico di Milano Campus Milano Bovisa Via
Durando, 107 / Via La Masa, 34 15. Triennale ExpoGate Via Luca Beltrami, 1 mar –
dom 10.30 – 20.30 16. Università degli studi di Milano Via Festa del
Perdono, 7 17.
Area Expo Rho Fiera Milano mar – dom 10.30 – 20.30 18. Villa Reale di Monza Viale
Brianza, 1 – Monza mar – dom 10.00 – 19.00 ven 10.00 – 22.00 19.
Museo di Fotografia Contemporanea Villa Ghirlanda, via Frova 10 Cinisello
Balsamo.
Tra le
aperture straordinarie di edifici storici, suggerisco il Palazzo Turati in via Meravigli 7. Una
eccezionale sorpresa.
In
questa splendida dimora, mai prima aperta al pubblico, vanno in scena i lavori di 125 designer olandesi in un
sorprendente dialogo tra antichi spazi e vivaci mazzi di tulipani, eleganti
manufatti, opere d’arte fiamminga. Un appuntamento da non perdere.
***
SPLENDORI DEL RINASCIMENTO VENEZIANO
Nozze tra Cupido e Psiche 1550
Venezia, Museo Correr fino al 10 aprile, ultimi giorni per visitare la mostra di Andrea Medola detto Schiavone tra Tiziano, Tintoretto e Parmigianino, l'occasione per scoprire il ruolo centrale che questo maestro di origine dalmata svolse nel secolo d'oro della Serenissima.
***
BOCCIONI, LA FIDA DEL RISCHIO
Boccioni, ancora Boccioni! Ma sì.
L’occasione è la Mostra per il centenario della morte, 1916, Milano, Palazzo
Reale, UMBERTO BOCCIONI. GENIO E
MEMORIA, 23 marzo-10 luglio 2016, circa 280 opere tra disegni, dipinti, sculture,
incisioni, fotografie, libri, riviste. Per lungo tempo abbinato
all’etichetta del FUTURISMO, sembrava
incollato alla fortunata campagna pubblicitaria di Marinetti: “Noi vogliamo
cantare l’amor del pericolo, l’abitudine all’energia e alla temerità” 1909.
Boccioni aveva 27 anni e nel pieno delle sue capacità, già ampiamente
sviluppate. Il rifiuto del passato, il
“passatismo”, al di là della polemica contro le ripetizioni e la retorica
dell’Accademia (magnifico l’Antigrazioso),
non vale per Boccioni (nonostante le sue stesse affermazioni). Per lui il
rischio del nuovo, il salto nel vuoto, il timore della perdita o del nulla, non
elimina le spinte, gli indizi, i segnali del passato, pure nella forma dei
ricordi. Anche perché la negazione del passato non è, non può essere una scelta
‘razionale’. Il passato che abbiamo acquisito dentro di noi galleggia
indistinto e si traveste anche di presente. Boccioni lo tiene, lo incastra, lo
trasforma, per contrastare i rischi di una novità muta, vicina allo zero. Accetta
il rischio del nuovo, indispensabile a qualsiasi cambiamento, e perciò lo
affronta con atteggiamento insieme spavaldo e timoroso. Non ama i mezzi
termini, le nebbie, il compromesso. Ha fatto mille mestieri, vignettista e
illustratore, raccoglitore di preferenze, anche dall’antico (i diari,
l’Atlante), la scuola di Balla e i meravigliosi paesaggi pointillistes, i disegni, gli ‘Stati d’animo’, i ritratti…
una continua insoddisfazione e il coraggio di ricominciare. Sa che ogni
cambiamento è una perdita, ma sa pure che ogni perdita è necessaria allo
svolgimento vitale. Una ferita necessaria. Non la gioia di una conquista, ma la
tristezza e però la volontà di un salto necessario. Tutt’altra la posizione di
un suo più giovane collega, Giorgio Morandi, che non accetta la perdita, la
dissoluzione possibile e lavora accanitamente, in solitudine, nella riduzione
del rischio: ambiente, anche familiare, silenzioso e controllato, luci e ombre
segnate nei loro cambiamenti, posizioni precise dei soggetti, le sue brocche-personaggi.
Due posizioni: riduzione o sfida del rischio. Ma questo è un discorso da
svilupparsi altrove (di entrambi ne aveva scritto Roberto Longhi).
Ritorno al Boccioni del 1910,
quando dipinge‘La città che monta” (o che ‘sale’). Qui il bozzetto e il
grande quadro cm 199 x 301 (non in
mostra). Seguendo una tecnica appresa da Previati, il pittore raggruppa le
pennellate nervose in gruppi filiformi secondo le diverse inclinazioni e spinte
delle forze. I contorni si disfano. Il cavallo è la forza, la vitalità che
unisce i movimenti degli uomini a quello delle macchine, ‘cavalli-vapore’. L’umanizzazione della
macchina si unisce alla forza meccanica della vita. Ma è sempre la vitalità
creativa che vince sulla ripetizione meccanica. Un cavallo-turbine succhia gli
operai. Sul fondo edifici in costruzione come prue sparate verso il cielo.
Elasticità
1912
I filamenti si sono compattati
in forme ad incastri ondulati tra cavallo, cavaliere e ambiente. Una danza,
insieme pericolosa e avvolgente. Nella stessa figura del cavallo si inserisce
la parabola di Boccioni: forza, energia, velocità, elasticità è il destino della sua fine: dopo una lunga
licenza, richiamato al fronte a Chievo, frazione di Verona, il 16 agosto del
1916, disarcionato da una cavalla imbizzarritasi alla vista di un autocarro,
cade, batte la testa e muore il giorno dopo senza aver ripreso conoscenza.
Aveva 34 anni. Nel ’15, l’anno prima, con entusiasmo era entrato volontario in
guerra nel ‘Battaglione lombardo ciclisti e automobilisti’ insieme a Marinetti,
Sironi, Sant’Elia, Russolo, ma scriverà nel suo diario nell’inverno dello
stesso anno : “Viene la notte. Mi metto a dormire in una tinozza d’acqua, senza
esagerazioni, tremo di freddo. Umidità. All’una di notte ci svegliano. Si
parte, si torna. Me ne duole. Preferivo una coperta e rancio e rimanere.
Terribile e stupido”. Addio entusiasmo. Uno sconforto quasi presagio della
fine.
Dicevo prima del coraggio di Boccioni nell’affrontare il
rischio del cambiamento. Coraggio non privo di timore. E qui (Tre
donne), a questo timore si dispone a
riparo la figura materna, assidua, presente sempre, massiccia, solida e
sorridente. I fili della luce si uniscono alle pieghe leggere dei vestiti. In
seguito, nello sviluppo della sua ‘ricostruzione’ pittorica, la scomposizione
della figura/ambiente (v. ‘Valori orizzontali’), non
cancellerà questa intimità, ma anzi di Romanzo di una cuitrice, 1908
venterà più insistita sulla sicurezza di quelle grosse mani
incrociate che coinvolgono nel soggetto tutto l’ambiente circostante.
Tre donne
(la madre, la sorella Amelia e Ines un’amica) cm 180x132, 1909-10
La madre
Cecilia era cucitrice, lavorava in casa per una clientela privata e per aiutare
il figlio. L’abbandono del marito, considerato un tradimento irreparabile, ne
affrettò l’invecchiamento e ne aumentò la vicinanza col figlio, affettuoso e
geniale.
Veneriamo la madre, bozzetto 1909
Volumi orizzontali, 1912
Studio 1912
La madre, Cecilia, non è soltanto l'origine, il corpo protettivo, il primo sguardo, la risposta, la Grande Madre, il flusso cosmico, vitale continuità, forza complessiva sì, ma pure musica, ritmo, abbraccio. Umberto Boccioni, in spostamenti continui e frenetici, viaggi, mostre, incontri, le scrive, s'informa, la cerca, la va a trovare. Alla fine, a Milano, vivranno insieme. Quando Cecilia seppe della morte del figlio fu colta da un ictus che le impedì l'uso della parola per il resto della sua vita. Morì nel 1927, undici anni dopo, in una casa di cura vicino a Verona. Immobile, a letto - da sempre soffriva di reumatismi - le amiche le riconoscevano dai soli sguardi una intelligenza presente sino alla fine (V. Baradel, 'Boccioni prefuturista', Skira 2007). Amelia, la
figlia, nel ‘santino’ commemorativo della morte della madre, pubblica ‘la Pietà’ di Giovanni Bellini, una
immagine molto amata dal fratello, una coppia dalla quale manca la figura di
Giovanni alla destra di Gesù. Nello stampato una citazione biblica: “…Ponete
mente e vedete se v’è dolore simile al mio dolore!’.
Di Boccioni si
è scritto molto, ed è giusto: era una figura ‘teatrale’ nella vita e nelle
opere, molte, rimaste, alcune distrutte e ricostruite (il caso delle sculture).
Una figura bruciata in un soffio, ma ricca di scatti, scintille, di luci che
hanno illuminato il futuro della sua giovane morte. Io mi sono limitato a
sottolineare soltanto la ricca dinamica tra rischio del cambiamento e
protezione della continuità attraverso l’immagine materna: binomio necessario
ad una frenetica spinta creativa.
JAPONISME - GIAPPONE SEGRETO Nella Fotografia 1890-1910
La
ricerca di mondi ‘diversi’ , sia attraverso i racconti mitologici e religiosi,
sia attraverso le favolose terre dell’Oriente, per gli europei, è sempre stata
una prerogativa dell’immaginario. Nel
Sei-Settecento, sia per le continue insopportabili guerre di religione (in negativo),
sia per lo sviluppo della navigazione e dei commerci (in positivo), si sviluppò
un interesse per il leggendario impero cinese e di conseguenza una moda, la Chinoiserie, che riempì i salotti
aristocratici di dorature, porcellane, laccature, rilievi, profili mai visti
prima. Per i riformatori venne in aiuto il buon cittadino confuciano. Il secolo
dopo, l’Ottocento, fu la volta del Giappone, per lungo tempo chiuso ad ogni
intervento occidentale. Qui, con il rinnovamento Meiji nel 1868, l’occasione
non è solo l’apertura del paese agli scambi commerciali, indispensabili alla
trasformazione industriale, ma l’incoraggiamento, in Europa, ad un cambiamento
culturale in corso, dove la crisi del positivismo si poteva appoggiare ad un
recente ‘altrove’, un nuovo modo di
‘vedere’ e considerare la creazione artistica. S’introduce un nuovo gusto: le japonisme. Manet, Monet, Gaugin, Van
Gogh, guardano alla figure stampate su carta ukyjo-e (“immagine del mondo fluttuante”) da artisti come Hokusai,
Hiroshighe, Utamaro. Il realismo accademico scompare anche attraverso l’esempio
dei giapponesi.
 |
| Hiroshighe- Monet "Ponti" |
Van Gogh, ‘Père
Tanguy’
La situazione è curiosamente asimmetrica. I
pittori europei e americani ammirano e collezionano le opere giapponesi
stampate su carta da matrici intagliate in legno, vecchia maniera; i giapponesi imparano la fotografia con
stampe all’albumina/collodio, usando moderne macchine tedesche e americane e
vendono ai turisti, i globtrotters ,
queste foto insieme ai resti, oggetti, indumenti, del loro glorioso passato. Il
porto di Yokoama è il luogo di questi scambi, e la scuola fotografica di
Yokoama, sotto la guida di Felice Beato, è il nome, la garanzia con la quale si
vendono agli stranieri le fotografie giapponesi. Pittori e fotografi si
scambiano le modelle, ma saranno i pittori a diventare aiutanti dei fotografi
per i quali dipingeranno con grande cura i colori sulle monocrome
fotografie. Fatte
queste premesse, vengo alla mostra di 140 fotografie 1860-1910, GIAPPONE SEGRETO, 5 marzo – 5 giugno, Parma, Palazzo del Governatore.
L’autore è Enrico II di Borbone,
conte di Bardi, fratello dell’ultimo duca di Parma, Carlo III, che insieme alla
terza moglie Adelgonda di Braganza e al conte (contabile) Zileri dal Verme
parte da Trieste con una nave a vapore il 16 settembre del 1887 per un viaggio
di ‘esplorazione’ in Asia durato due anni, con il tempo più lungo in Giappone,
sette mesi tra febbraio e settembre 1889. Marito e moglie, sbarcati a Yokoama,
acquistano fotografie e diapositive per lanterna magica, anche da proiettarsi a
due, a tre alla volta in ambienti scuri; si valgono personalmente di fotografi
locali, il fiorentino Adolfo Farsari e il giapponese Kusakabe Kimbei, per
riprendere, a volte ricostruendoli, visi, scene, costumi, ambienti ritenuti
particolarmente significativi.
K. Kimbei, ‘La contessa Adelgonda di Braganza in
vesti giapponesi’
Naturalmente
acquistano anche armi, corazze, maschere, chimoni, oggetti di uso comune, tutti
segni di un passato feudale che il nuovo Giappone, proiettato su di un
frenetico sviluppo tecnico-industriale, intende dimenticare e perciò svende
volentieri. Molte botteghe, modeste all’ingresso, conservano all’interno gran
quantità di merce proveniente dai vecchi proprietari terrieri. Nel complesso però i costi per Enrico II e
Adelgonda sono ingenti: si tratta, come risultato di tutto il viaggio, di circa
30.000 pezzi. Le fotografie le ho
già introdotte con la nostra autorevole nobile coppia in veste giapponese.
Seguono alcuni esempi di figure che, sia per gli scenari, che per i lunghi
tempi di posa, che per le leggere alterazioni delle carte e delle sfumature
colorate, mescolano il documento, il ‘c’è stato,’ al ricordo,
allafantasticheria, al sogno. Mi sembra che questi sentimenti
erano anche quello che i nostri viaggiatori cercavano. Non la storia, non i
fatti, non l’enciclopedia, non la scienza. Perciò mi sembra inappropriato
accusare Enrico II di non aver seguito principi, guide chiare e sicure
nell’acquisto, nella raccolta dei materiali ‘esotici’. Si è scritto di
‘meraviglia’ seicentesca. E forse è la via giusta. Una meraviglia e un
rimpianto: qualcosa che non può tornare. Un passato che non appartiene alla mia
storia, una stranezza inconsueta che mi arriva attraverso filtri incerti,
colori sfumati, posizioni impreviste. Eppure, al contrario, si tratta di
qualcosa che appartiene in qualche modo alla mia animale umanità. Un
lontano-vicino, imprendibile, pensabile,
desiderabile.
Kusakabe Kimbei,
‘Armatura’
Kusakabe Kimbei
‘Donna che si lava’
Tamamura Kozaburo,
‘Tre geiko in figura di danza’
Ritornato
a Venezia Enrico II di Borbone affida ai suoi antiquari di fiducia, i Carrer
padre e figlio, la disposizione dei suoi oggetti nell’ultimo piano del suo
palazzo Vendramin Calergi sul Canal Grande, aprendolo al pubblico. Le difficoltà di sorveglianza e
accesso persuadono il proprietario a chiudere queste visite, così che la
raccolta rimane disponibile solo a specialisti, amici e parenti. Alla sua morte
nel 1905, dopo alterne vicende, la collezione passa nelle mani di un antiquario
viennese che ne iniziò la vendita, interrotta dallo scoppio del conflitto
mondiale, al termine del quale quello che rimane passa all’Itala in conto di
riparazione danni di guerra. E’ così che l’eredità antiquaria Borbone-Bardi,
salvo poche cose a Padova e Firenze,
viene infine riordinata nel 1928 al terzo piano di Ca’ Pesaro a Venezia
come ‘Museo Orientale Marco Polo’.
K. Kimbei,
‘Portantina’
K. Kimbei, ‘Incontro
di Kendō’
Utagagawa
Kunisada, xilografia ‘Il racconto di Komachi che si lava’
[Marzo 2016 ]
***
amoR Roma
Modello
sorelle Fonfana, Musei Capitolini Roma1952
Alla Galleria Carla
Sozzani di Milano, il 18 febbraio scorso è stato presentato, alla presenza
dell’Autore Stefano Malatesta, il suo libro
‘Quando Roma era un Paradiso’, edizioni SKIRA, il racconto
ironico della Roma anni ’50, la Roma della sua adolescenza, la Roma mitica
della Dolce Vita, degli Amerikani famosi, Orson Welles, Truman Capote, Gary
Grant e Audrey Hepburn, delle osterie generose di buon vino (tutto finisce in
trattoria), degli artisti difficili Schifano, de Dominicis, Tano Festa,
Kounellis, dei registi che inventano un nuovo cinema, Rossellini e Fellini, dei
cinematografari tuttofare,degli attori, degli scrittori, Moravia, Flaiano,
Pasolini, dei truffatori, dei falsari… Insomma flash rapidi e divertiti sulle
maschere degli italiani, maestri del
’sembrare’ piuttosto che dell‘essere’,
“parte della loro smodata voglia di piacere”; ricordi di una Roma, un
teatro a cielo aperto, “come una foresta
architetturale, che seguiva l’andamento ondeggiante del barocco e ancora non
era nascosta dal traffico”, “il posto ideale per curare le anime inquiete e
maltrattate”, una Roma-paradiso, quasi un sogno che scorre rinforzato da una
nostalgia d’infanzia. La descrizione gioca sulle contrapposizioni: coperte militari-eleganti cappotti, tutti fascisti-tutti comunisti,
gentilezza-insicurezza, poesia-gastronomia, principe del palcoscenico-baracca
dove “si respira un’aria mista di risciacquatura di piatti”, sadico che dice no-al masochista che si vorrebbe frustato. E
la contrapposizione diventa una presa in giro: “Quando il grande Federico Zeri
aveva qualche dubbio su un dipinto, telefonava a Pico (noto falsario) dicendo:
“Perché non vieni qua a vedere con quegli occhiacci tuoi?”. Gioco, battuta,
scherzo. Una lettura piacevole, che mescola personaggi noti e ignoti, grandi,
piccoli, piccolissimi, storie famose, ma con grotteschi risvolti (‘Roma città
aperta’) e storielle da bar Sport, simpatiche cattiverie e sottili rimpianti.
***
VENEZIA A PALAZZO FORTUNY: HENRIETTE
Henriette Fortuny, Ida Barbarigo pittrice, Romaine Brooks pittrice e diseVEgnatrice , Sara Moon fotografa, sono quattro straordinarie personalità
femminili connesse con PALAZZO FORTUNY di Venezia e che il MUSEO-PALAZZO
presenta come suo programma invernale.
Prima di fermarmi sulla prima figura, la padrona di casa del Palazzo Pesaro degli Orfei, divenuto Palazzo Fortuny con lei, Henriette, e
il marito Mariano, mi sembra opportuno sottolineare l’importanza di questo
programma sia per la rilevanza delle figure
femminili, solitamente eclissate dietro a quelle maschili, sia per il
livello artistico e culturale avviato dalla coppia nel secolo scorso, in un
ambiente internazionale di scambi, invenzioni raffinate, decorazioni, stoffe,
scritture. Va aggiunto il contributo
decisivo dei musei comunali veneziani, non solo Fortuny, a mantenere
elevata l’offerta culturale in una città fragile come Venezia, assalita,
deformata, ferita da una scomposta massa di turisti ignari e vocianti,
scaricati con ogni mezzo di trasporto, treni, auto, aerei, grandi navi, così
che dal tessuto urbano sono spariti negozianti e artigiani per lasciar posto soltanto
a caffè, ristoranti e alberghi di ogni tipo, grandezza e categoria. Con
un sospiro di sollievo e nostalgia, in un angolo ancora quieto e austero della
città, si può tornare alla prima di
queste illustri ospiti di Palazzo Fortuny, Adèle
Henriette Nigrin. Nata a Fontainebleu nell’ottobre del 1877, si trasferisce
con la famiglia a Parigi, dove, agli inizi del ‘900 incontra il trentenne Mariano Fortuny, di origine spagnola, famiglia
di pittori, che da anni viveva nella
capitale francese con la madre Cecilia de Madrazo, diventando un riconosciuto
esperto della macchina teatrale e, in particolare, della sua illuminazione con
la “Cupola Fortuny”. Mariano è un ingegno multiforme: pittura, incisione,
scenografia, scenotecnica, illuminotecnica… L’incontro si trasforma in un amore
duraturo e in una determinante collaborazione progettuale e lavorativa al cui
successo le capacità di Henriette contribuiscono in misura decisiva.
Mariano Fortuny, ‘Henriette nello studio di Palzzo Pesaro’,
Lastra di vetro alla gelatina, 1910 ca.
Lastra di vetro alla gelatina, 1910 ca.
La
coppia (che si sposerà ufficialmente solo nel 1924) si sposta a Venezia in
Palazzo Pesaro degli Orfei che diventa il luogo dei loro esperimenti, incontri
e realizzazioni. Siamo agli inizi del ‘900 e la moda sta tentando nuove strade per
una borghesia in ascesa, non estranea ad ascendenze aristocratiche, alla
ricerca di una collocazione particolare, desiderosa delle novità più spinte,
della singolarità, dell’eccezione, estranea alle consolidate regole di
comportamento: il Liberty o Art Nouveau o Deco o Floreale
che dir si voglia, il nuovo stile
insomma, che considera la decorazione, i materiali pregiati, l’erotismo e
l’esotismo, componenti indispensabili di una vita da spendersi coraggiosamente.
La figura di Gabriele D’Annunzio, che pure ha preso casa a Venezia, amico dei
Fortuny, è una specie di emblema. Romaine
Brooks, una delle artiste previste nel programma espositivo, lo rappresenta come ‘Il poeta in esilio’ 1912,
inappuntabile davanti a un paesaggio tempestoso.
“Liberty”
non è solo ‘Libertà’ ma indica anche un noto emporio di Londra che fin dal 1875
era diventato un punto di riferimento per i maggiori modisti e modiste del
tempo. La coppia Henriette-Mariano partecipa di quel mondo, ma da un impegno
mai messo in discussione: la loro totale collaborazione e reciproca fiducia.
Sia il teatro per lui che la raffinata invenzione di stoffe e indumenti
femminili per entrambi saranno i risultati più significativi, recuperando le suggestioni dell’antico abbigliamento greco, così come i suggerimenti delle stampe di Morris e dei motivi catalani: cappe,
mantelli, giacche, sciarpe, Knossos,
lo scialle di seta, Delphos, la tunica in seta plissettata, nel 1909 diventata un
brevetto, eleganti schemi decorativi applicati anche ad oggetti di
ambientazione, tendaggi, tappezzerie, copriletti, lampadari in seta.
Componenti naturali sono all’origine di nuovi colori, filature speciali per nuove stoffe.
Segreti gli ingredienti, i pigmenti, le colle, i fissanti. L’inizio è la
incisione di una matrice in legno, colorata a mano col pennello, che può
stampare direttamente sulla stoffa. Matrici più leggere e flessibili saranno
introdotte in seguito. I risultati sono rapidamente apprezzati a livello
mondiale, tanto che un settore viene aperto a New York con l’amica Elsie
McNeill. Il successo è clamoroso. Dive illustri e chiacchierate comprano e
prenotano scialli e tuniche Fortuny. Gli spazi di Palazzo Pesaro non sono
sufficienti. Uno stabilimento per i cotoni stampati viene aperto nella veneziana Giudecca in
collaborazione con Giancarlo Stucky (titolare del grande ‘Molino’), con nuovi
macchinari per produzioni in serie, i cui risultati finali però, tra lunghe
asciugature e ritocchi, risultano sempre pezzi
unici.
matrice in legno e prova di stampa
matrice di stampa dopo 1910
Plissettatura abito Delphos e sopravveste in garza di seta
stampata
Mariano
Fortuny, ritratto di Henriette 1915
I
viaggi, gli incontri, le feste, le stoffe, gli abiti squisiti, tutto
s’interrompe con la seconda guerra mondiale. La difficile ripresa dell’attività
nel 1945 dura poco. Mariano muore nel 1949. Henriette, priva di eredi, cede la
Società Anonima Fortuny all’amica Elsie McNeill, che continuerà l’attività
nella fabbrica della Giudecca, tuttora in funzione. S’impegna poi ad
inventariare i numerosi beni del palazzo, il tracciato di una, o meglio, di due
vite. Dopo il rifiuto dello stato spagnolo, decide di lasciare il palazzo e il
suo ricco contenuto alla città di Venezia, vincolandolo al nome suo e di suo marito. Il
grande Palazzo, oggi completamente restaurato, anche nei suoi ampi spazi
espositivi, con importanti interventi conservativi sulle opere, gli oggetti, i
tessuti, i mobili, gli strumenti, le attrezzature teatrali, gli originali
fotografici e filmici, è diventato un imprescindibile punto di riferimento per
la storia culturale non solo veneziana.
gennaio 2016
***
ADOLFO WILDT LA LIBERTA’ DI UN GRANDE SCULTORE RITROVATO
Se torno agli anni ’50, ’60 e
penso allo stile Liberty o, come si diceva, Floreale, mi tornano in mente i
noti versi di Guido Gozzano “Loreto impagliato e il busto d’Alfieri, di
Napoleone/ i fiori in cornice (le buone
cose di pessimo gusto!)”... L’arte moderna a cui si guardava era, sembrava
essere il contrario: la semplicità delle figure geometriche, la luce delle
grandi finestre -‘occhi senza ciglia’ scrive Savinio-, la pennellata libera,
Picasso in tutte le salse ecc. ecc. Ci son voluti anni, insieme all’invasione
speculativa del cemento, per risentire come una novità curiosa il “Neoliberty”
e il riuso di termini prima esecrati, ‘la decorazione’, ‘l’eleganza’ lo ‘stile’
nella mostra della Biennale veneziana di architettura ‘La presenza del passato’
1980 a cura di Paolo Portoghesi. E ancora il nome di Adolf Wildt era ignorato per colpe ‘fasciste’ dalle
quale certo non erano esenti molti campioni scopertisi rigorosi anti nel
dopoguerra. Si deve agli studi di Paola Mola (alla quale compete anche la
dichiarazione di autenticità delle opere), a partire dalleprima importante pubblicazione per le edizioni F.M.R. "WILDT" 1988 e la collaborazione con l’editore e studioso Vanni Scheiwiller, il cui padre
Giovanni aveva sposato la figlia di Wildt Artemia, la ripresa e definizione di
una figura eccezionale come quella di Adolf
Wildt, nato a Milano nel 1868 e ivi morto nel 1931. Alla mostra a Forlì
nel 2012, Musei San Domenico, curata da Paola Mola e Fernando Mazzocca (la
prima esposizione importante del dopoguerra era stata quella di Ca’ Pesaro a
Venezia del 1989-90 a cura di P. Mola e V. Scheiwiller), si aggiunge ora questa
più modesta, ma sempre di grande interesse, già presentata al Musée d’Orsay di
Parigi, dal 27 novembre al 14 febbraio 2016 alla Galleria d'Arte Moderna di
Milano.
Per quanto qui molto riassunta, la biografia di Adolf
Wild non può essere trascurata. Nato da una famiglia povera, a undici anni
entra nella bottega dello scultore Grandi dal quale passa nello studio del
Villa: ”Con lui imparai a lavorare il marmo con tanta efficacia che quando
volli affrontare da solo, con la mia cassettina e i miei diciotto anni, la vita
e l’avvenire, diventai rapidamente il primo ‘rifinitore’ di Milano”
(AdolfoWildt parla della sua vita e della sua arte, ’Secolo XX’ Milano marzo
1928). La scultura di un busto della moglie, appena sposata, intitolata La
Vedova, esposta alla milanese Società di Belle Arti, colpisce un ricco
latifondista prussiano, Franz Rose, il quale gli offre un contratto che prevede
la consegna di ogni primo esemplare di scultura con uno stipendio annuo di
quattromila lire. Wild ha 24 anni. Il collezionista “cercò con ogni mezzo di
impedire che le mie opere risentissero dell’ambiente artistico in cui vivevo e
mi tenne lontano da tutti con una gelosia strana, che se per me fu un bene, fu
in un certo qual modo un grande male” (Siviero, In memoria di Adolfo Wildt. Una
lettera autobiografica dello scultore ‘Il Messaggero’ Roma 17 marzo 1931). Pur
vivendo e lavorando a Milano, l’ambiente che frequenta è quello secessionista
germanico. Il suo isolamento, una delle cause di quel “grande male”, è anche
all’origine di una grave crisi che attraversa tra il 1906 1 il 1909. “Soffrivo
fino a rasentare la follia. Non volevo uscire dallo studio. Lavoravo come un
folle; e non ero mai contento del mio lavoro. Seguirono settimane e mesi
terribili. Intorno a me si era fatto il vuoto. Nel mio studio, ovunque io
mettessi le mani, nasceva la rovina. M’ero smarrito; non riuscivo a trovarmi.
Passavo intere settimane chiuso nel mio studio, dormendo per terra, crocefisso
al mio tormento” (‘Secolo XX’). La fine di questo tormento è firmata da un
autoritratto, “La maschera del dolore”, anno 1909 e tre croci.
Oltre ai suoi autoritratti, una parola non può mancare
sui ritratti successivi di Rose, di Toscanini, di Vittorio Emanuele III (tre
meravigliosi baffi!), della Sarfatti, di Fulcieri Paulucci de’ Calboli, di
Mussolini… Wildt non li esegue dal ‘vero’, ma da foto e riproduzioni, una
vecchia abitudine di quando copiava le statue antiche attraverso le piccole
riproduzioni di libretti economici, con una particolarità, il suo atteggiamento
anti-verista, la negazione dell’impatto diretto con il soggetto, la libera
torsione espressiva di allontanamento.
 |
| Ritratto di Franz Rose |
Nel 1912, alla morte di Franz Rose, Wildt si trova a
ricostruire daccapo i contatti a Milano. Non bastano le amicizie con V. Grubicy,
Previati, e specialmente con
Giovanni Scheiwiller. Deve riprendere il lavoro di ‘finitore’ del marmo. Le sue
difficoltà finiscono con il 1919, con il successo alla Galleria Pesaro,
l’appoggio della Sarfatti, l’interessamento dell’industriale Chierichetti, i
numerosi Premi, le varie nomine in Giurie e Comitati, Accademico d’Italia ecc.
ecc. Però dopo la esposizione de ‘Il puro folle’, un effeminato Parsifal alto 6
metri, modello in gesso, alla Quadriennale romana del 1931 (distrutto coi
bombardamenti del ’43), le simpatie del fascismo si allontanano. Ma è l’anno
della morte, dell’amatissima moglie Dina in gennaio, e poi di lui in marzo. La
sua figura risultava scomoda per il regime e scomoda anche per il dopo-regime.
Perché?
Vorrei cominciare con un gesso del 1905-1909 dal titolo ‘I Parlanti’. Mi pare un particolare
riferimento alla statuaria antica, anzi a un frammento da lui stesso costruito,
più volte modificato (una prima prova porta ancora la gamba sinistra e la mano destra staccata), tagliato, ridotto e conservato con una sua supposta
finitezza. Il riferimento all’antico è ambiguo: recepito come ‘frammento’ di
passato è consegnato nella sua definitiva incompletezza: uno stravolgimento
della finitezza accademica. Non solo. Il
viso dimezzato si rivolge a qualcuno, il proprio interlocutore, che però non compare
che nel titolo: I Parlanti. Una
parola, non una immagine. L’interlocutore, ciò che sfugge invisibile è invitato
a costituire il significato di quell’unico frammento d’immagine. L’immagine
come parte di un tutto dove l’interlocutore è invisibile diventa anche il gioco
dell’orecchio, nella versione in bronzo, il citofono funzionante di via
Serbelloni 20 a Milano.
La incompletezza dell’immagine rientra in un ambiente
simbolista/religioso nel quale l’apparire è sempre il segno di un ineffabile e
sfuggente significanza, come indica una testa del 1916 “L’Anima e la sua veste” o
quella dell’anno successivo, “Un rosario”,
dove il sottile intreccio dorato interrompe la lucida e smagrita corporeità,
non solo per avvilirla nella sua annunciata mortalità, ma per indicarne un
diverso percorso (in altri visi l’oro all’interno della scultura, appena
intravisto dal vuoto delle orbite, ha questo stesso significato): gli occhi
sono chiusi o vuoti, la bocca semiaperta non
per mascherare, nascondere una diversa vita dell’attore, ma per dare
inizio ad un viaggio nell’altrove. I sensi, diretti all’esterno, si chiudono
per dirigersi all’interno (e, ancora, esterno e interno, metafore inadeguate).
Il nero, il buio non è solo il grembo dell’apparizione ma anche l’insieme delle
possibili fughe.
Né “La Concezione”
del 1921 possiede alcunché di trionfalistico o piacevole. Il feto dorato è
parente di altri impauriti quasi-nati precedenti: sospeso, non vuole vedere
quello che sta succedendo, chiude gli occhi con i suoi pugnetti e chiusi sono
anche gli occhi dei genitori. Le due mani allungate, diafane di lei, ogiva o
vagina, sono altrettanto inquietanti delle contorsioni serpentine della barba
di lui, unite a quella strana fascia che gli scende dall’elmetto del cranio.
Cosa borbotta con quella bocca aperta? Non è certo un canto di gioia per la
nascita ventura.
E la famiglia de “I
Puri”, inchiostro e oro su pergamena 1913, in bilico su quella contorsione
vegetale, parente della barba serpentina del genitore in ‘La Concezione’, non sembra godere di una maggiore tranquillità.
Ecco allora le provvisorie risposte a quel precedente ‘perché’. Le inquietudini
sottili, pervasive, sfuggenti di Widt, la sua apparente ‘carineria’, quando
c’è, la sua ben evidente, esibita capacità tecnica, compiacimento e velo a un
tremore sotterraneo che la eccessiva politezza del marmo, i suoi buchi e
trasparenze non potevano o volevano nascondere, tutto ciò non poteva accordarsi
alle semplificazioni, non poteva accostumarsi né alle retoriche ottimistiche
del regime fascista né ai repentini voltafaccia e molteplici scontri
politico-culturali del dopoguerra. Ben ritrovato Adolfo Wildt.
***