La biblioteca fantastica di Adamo Calabrese
 |
| Illustrazione di Adamo Calabrese |
Sulle umbracule, amorose e irridenti
di Claudio Zanini
 |
| Mariano Bargellini |
L’enigma dei
pettirossi che, simili a migliaia di fiammelle arancioni sui teloni azzurri dei
TIR nella luce dell’alba, migrano clandestini sul traghetto da Olbia a Livorno,
appare come uno dei tanti rebus, arcani, indovinelli, nonsense, in cui ci si imbatte (da cui si è irretiti) nel romanzo La setta degli Uccelli. Non solo si
tratta d’un testo che spicca per la ricchezza lessicale, i diversi registri di
scrittura e il ritmo del linguaggio - qualità rarissime e inconsuete nel
panorama letterario contemporaneo in Italia -; oltre a queste qualità, già
peraltro note nella scrittura di Mariano Bargellini, il “romanzo” è ricco di
invenzioni sorprendenti.
Ho trovato, per fare un esempio, assai ironica e
divertente (direi addirittura comica, di una comicità surreale e, in certi casi
disperata: Buster Keaton, Totò, Vladimiro ed Estragone beckettiani...) la messa
in scena di vari personaggi e situazioni. Sembrano tutti incalzati, primo fra
tutti lo Scriba della Torre, da una realtà che sfugge, che si sdoppia, si
moltiplica nelle fisionomie degli innumerevoli sosia e nelle apparizioni degli
uccelli, (umbracule: uccelli con cui
siamo virtualmente “maritati”, nostre anime aeree e segrete); gli uccelli,
dunque, gente piccola e canora
(echeggiando Pascoli, così li chiama lo Scriba), abitatrice anch'essa di mondi
paralleli, insieme remoti e assai prossimi, da cui allestiscono e inviano
segni, enigmi ornitologici, rebus la cui soluzione è spesso sibillina e,
soprattutto, mai univoca.
Cito due
episodi che mi sembrano paradigmatici. Il primo: sogno in cui lo Scriba vede l’amata
Albertine – donna Anima - seduta
sopra un masso; sembra che lui possa avvicinarsi, ma lei è stranamente lontana e,
per quanti sforzi faccia, Albertine è irraggiungibile. Poi, all’improvviso,
egli, con una sorta di balzo, la sorpassa, sfiorandola. Sequenza struggente, da
film comico e da ossessione onirica.
Nel secondo, si descrive la luna che, appena fuori da
quel teatro che è la Torre avvolta nei grandi fogli di plastica, si affaccia da
una cornice di nuvole facendosi pericolosamente avanti, tanto avanti che i
nembi in cui è avvolta sembrano assestarsi dietro di lei. Scena da teatro
barocco o da film (di Méliès?).
Non a caso ho parlato di cinema. Osservava Carmelo Bene,
parlando di Joyce in un’interessante intervista, quanto il suo linguaggio sia
incredibilmente visivo, (fisico, empirico) non tanto letterario quanto filmico,
fatto di costanti folgorazioni visive di “cose”.
Anche qui, a me pare accada lo stesso. La narrazione è
satura di “cose” (parole) che incalzano, urgono, lampeggiano, interrogano e si
sovrappongono. Il testo si snoda procedendo impervio e accidentato, affollato
da luminosi incagli, osservazioni, “materiali verbali”, ecc., tali da suscitare
nel lettore (o nell’ascoltatore della narrazione orale) un continuo susseguirsi
d’immagini e concrete illuminazioni, impaginate in lunghi piani sequenza.
Oltremodo
intriganti, a mio avviso, i capitoli dedicati alle due fanciulle/uccello – entrambe
ambigue condomine della Torre -, per via di una tensione erotica che,
naturalmente, viene condotta fino all’insostenibile apice, sfociando in esiti
sorprendenti, ma tutto sommato inconsciamente cercati dall’augure della Torre,
dal devolaturo o come dir di voglia. Anch’egli forse anelerebbe a una
metamorfosi uccellesca? Non sarà certo un caso se la sua dimora esagonale è
infoderata nella plastica con le sei immagini smisurate di un gufo e una
civetta (umiliati ad apparire quali testimonial
d’un famoso marchio).
La squamosa Roberta, dalle natiche d’alluminio – creatura
mitica e cyber, nello stesso tempo - e la punk Duda, abbordate consenzienti per
via dell’incontenibile ninfolessia dello Scriba, non lo conducono fino alle
soglie dell’anelata trasformazione, all’ambìto commercio con gli uccelli? e lì,
frustrato, lo lasciano, irridendolo (beh, gli uccelli ci canzonano, ci beffano,
ci fischiano, lo dice lo Scriba medesimo, citando Leopardi)? Metamorfosi di cui
lui vorrebbe essere costantemente protagonista; tra l’altro, lui, l’uomo
pneumatico, per suo conto, ha già “un uccello in testa” (er hat einen Vogel, come recita un detto tedesco).
Vorrebbe, ma non può; come non può raggiungere Albertine.
Nel caso di Roberta (merla rubacuori!) si deve accontentare d’un simulacro di
ceramica vetrosa; in quello della Duda, vede svolazzare via tra la nebbia,
l’oggetto del desiderio, nelle fattezze d’una cincia dal ciuffo biondo. Di
Albertine rimane una raccolta di foto; delle foto costituite, però, della
materia dei sogni e ambientate nei paesaggi di un altrove inesistente.
 |
| Claudia Azzola e Mariano Bargellini |
Le inserzioni
di neologismi, citazioni colte, termini desueti e ricercati, arricchite da
quelle dialettali, volgari e plebee – vedi quella, magistrale, del controllore
della metro, che interpreta, a suo modo, equivocandolo, il colloquio dello Scriba
con la Duda – conferiscono al narrato un ritmo con modalità e sonorità
polifoniche.
A proposito dei fraintendimenti, dei misunderstanding, di cui è fitto il testo, a un certo punto accade
che un passero -“da fiabe e da enigmi”- impari e ripeta il gorgheggiare
meccanico di un cellulare. Ma, si da anche l’opposto; quando, di Albertine,
affiorano enigmatici segnali. Pare, allo Scriba, di poter colloquiare con la
voce della sua perduta donna Anima, scambiando
il frinire dell’accensione elettrica del gas (verso quasi da gazza), il tinnire
d’un vaso di cristallo, un refolo improvviso, per una sorta di linguaggio
oracolare.
Poi c’è l’equivoca
incertezza, sempre ricorrente, riguardo la vera natura degli animali; quando
quest’ultima si sdoppia rivelando un inquietante aspetto artificiale. Forse, il
fringuello che zampetta tra i libri sulla scrivania del mistagogo della Setta degli Uccelli, (la sua umbracula) non è anche un automa a carillon,
creatura hoffmanniana? E gli stessi scarafaggi nella cripta della Torre, parenti
di quelli che escono dalle pieghe dell’abito del coinquilino domatore, non si
muovono come robottini obbedienti, meccanismi con spiccate capacità di scelte
autonome? Il topo, sul tavolo dello scrittore è forse il mouse, o viceversa? Più avanti, sorprendentemente, è il topo
virtuale (il mouse) a ribellarsi, in
combutta con il topolino/icona, a non rispondere ai comandi (l’altro, quello
vero, di fogna, scompare per fatti suoi o per ricomparire in altra spoglia?).
Per non parlare della merla rubacuori e della cincia dal ciuffo biondo (alias
Roberta e Duda) equivoche e artificiose simulatrici dell’umano (o è il
contrario?).
Ho già alluso
al fatto che lo Scriba, ascoltatore del melodioso linguaggio della gente piccola e canora, ovvero gli
uccelli, intendesse ripetere e mimare il loro cinguettio e vorrebbe acquisire
sembiante hornithikòs (uccellesco). Tuttavia, se qui fallisce, egli subisce suo
malgrado altri, infausti e diversi sdoppiamenti, prima in difformi sue immagini
allo specchio, quindi in quelle d’innumerevoli sosia. Anzi, giunge,
addirittura, a scoprire nei volti che incontra - da provetto enigmista della
fisiognomica qual è - dei tratti, delle sfumature, dei minimi particolari,
insignificanti all’apparenza, (financo in capi d’abbigliamento, anche d’altre
età ed epoche) che svelano elementi della sua (quale?) identità in altri
soggetti, dei cosiddetti cripto-sosia che dissimulano malignamente un
perturbante principio di somiglianza. Per finire in gloria, con gli
innumerevoli sosia, un autobus affollato di sosia che, con il suo stesso volto,
irridenti, gli sghignazzano in faccia. Sembra quasi che il mondo diventi un
rispecchiamento dello Scriba ed egli possa identificarsi con tale mondo, ma
l’identificazione è sarcastica, una presa in giro. Infatti, subito si dissolve,
come in un teatro di miraggi e nebbie, e l’augure della Torre con lui.
Si parlava,
dianzi, di teatro. Qui mi sembra ci si muova sulla ribalta d’un teatro delle
marionette, quello di cui scriveva Kleist. Automi e marionette disarticolate, mosse
da una volontà estranea, aleatoria, arcana e dispettosa. Un’atroce messa in
scena, dove natura e artificio si confondono, e preparano il campo al prossimo
(nelle successive narrazioni di Bargellini) imporsi della realtà virtuale ma
totalizzante di un videogioco governato da una caotica tempesta d’impulsi
elettronici. Ma forse c’è salvezza nelle “anime aeree” (umbracule) libere e leggere (che, nelle gabbie dei videogiochi, non
immagino dove andranno, irridenti, a dissimularsi).
Innumeri e complesse sono le situazioni che hanno sollecitato
queste considerazioni; altre ancora mi affollano la mente. Per ora mi fermo
qui. Comunque, ribadisco e mi ripeto, un testo affascinante, pieno di poetiche suggestioni
e tremendi trabocchetti.
*Notizie biografiche
Mariano Bargellini, prosatore narratore. Ha
pubblicato: Mus utopicus, I.M.
Gallino ed., Premio Bagutta-Opera prima 2000, ex aequo con Giovanni Chiara; Del simulacro perso nei sogni, Edizioni
Marietti, 2004; La setta degli uccelli,
Corbo ed. 2010.
*Claudio Zanini
ha vinto il Premio Guido Morselli 2012 con Il
polittico della città di T (Nuova Magenta Editrice) e il Premio Fogazzaro
2013. Ha pubblicato con Bietti Editrice di Milano, “Il posto cieco” (2009), “Nero
di seppia” (2010) e “La scimmia
matematica” (2013). Inoltre, la raccolta di poesie inedite “Ansiose geometrie”.

IL
SENTIMENTO DEL TEMPO
I versi di Finzi
riflettono sulla condizione della vecchiaia
di Angelo
Gaccione
 |
| La copertina del libro di Gilberto Finzi |
Confesso che mi
sono vergognato a lungo come un ladro. Credevo di averlo irrimediabilmente perso
il libro di Gilberto Finzi, rincasando una sera del 16 agosto, dopo un incontro
conviviale tenuto in casa di Anita Sanesi, che come sempre ci aveva
affabilmente accolti. “Non mancare” mi aveva detto al telefono, “ci sarà anche
Gilberto Finzi assieme ad altri amici”. Non ero mancato, e Gilberto aveva
firmato per noi copie del suo ultimo prezioso libro. Ma i giorni seguenti non
ne trovai traccia in casa fra carte, volumi, giornali e riviste accatastati.
Potete immaginare la delusione e il senso di vergogna. Come osare telefonargli?
Poi
questa mattina, 28 settembre, il miracolo! Il libro è ricomparso a distanza di
un mese e 12 giorni, come posso verificare dalla dedica con data che Gilberto
vi ha apposto (16/8 per l’appunto), e ha indicato simpaticamente, accanto a
Milano, la dicitura: “da Anita”.
Questo
hanno di buono le nostre povere case sommerse di carte e di libri, a volte
nascondono, ma poi quando meno te l’aspetti restituiscono. Come in questo caso.
 |
| Gilberto Finzi |
“Diario del giorno prima” (Nomos Edizioni
pagg. 84, € 14) raccoglie in totale 61 testi poetici scritti, come l’autore
stesso ci informa nella nota di apertura, tra l’agosto del 2011 e il gennaio
2012. In un arco di tempo, dunque, relativamente contratto. Tutte le poesie
portano la data di stesura come a voler rimarcare nelle sue scansioni temporali
e nel suo procedere, l’idea del diario. A volte capita che più di un testo
prende vita nella stessa giornata, e quasi tutti si susseguono a distanza
ravvicinata di un giorno o due, segno che la materia era stata così
metabolizzata dal poeta che gli è bastata una scintilla per illuminare tutto il
firmamento di pensieri, riflessioni, memorie, sensazioni, visioni,
risentimenti, rabbia, che si portava dentro. Il tema di fondo è l’inesorabilità
del tempo che passa, la vecchiaia, il divenire vecchi con tutto ciò che questo
comporta. Dunque nessuna stoica accettazione, nessuna saggezza da trasmettere,
nessuna lectio vitae da consegnare ai
posteri. Dimenticatevi Seneca, Cicerone, Epicuro e lo stesso Bobbio. In questo
excursus oggettivo, analitico, condotto da un poeta ultra ottuagenario in
maniera impietosa sul proprio status di vecchio, si rivela a tutti noi quella
condizione umana precaria, marginale, fragile, separata, a cui saremo chi più
chi meno condannati.
“…Ora dimenticami, o mia sorte,
nessuno
riconosca l’invecchiato “io”,
lo scadimento
dei muscoli, degli arti,
le orbite
profonde degli occhi
luciferini, le
petecchie
nella pelle
infisse come chiodi,
la passiva
resistenza
a qualunque
umana vicenda,
il niente il
nulla l’assoluto zero.
Nessuna
illusione e nessuna mistificante filosofia della vecchiaia, magari edulcorata
dall’abilità funambolica del facitore di versi, dalla sua seduttiva sapienza
lessicale. Qui non si fa sconto a nessuno e tanto meno a se stessi. L’età monstre, la “vecchiaia puttana” come la
chiama Consolo in un racconto, è lì a ghermire inesorabile, spesso carica del
suo sadico risvolto.
“…In bagno no, prego, sono tanti i modi,
i luoghi, i
destini, non questo
mi tocchi e mi
sorprenda,
in bagno, solo,
no!”
Nessuna
accettazione, nessuna riconciliazione con la fine. L’impalcatura della fede a
sorreggere non c’è, qui non è contemplata. L’uomo contemporaneo non può contare
sull’esaltazione epica della “bella morte” della civiltà degli antichi; sulla
coralità del lutto; sui Campi Elisi. Se Socrate poteva morire sereno circondato
dall’affetto dei suoi estimatori; se Epicuro poteva andarsene confortato dalla
sua visione, certo che la sua scuola e il suo giardino filosofico avrebbero
continuato a prosperare, all’uomo contemporaneo e privo di fede tutto questo
non è dato. La sua precaria condizione esistenziale è figlia del vuoto, cammina
lungo il sentiero “dell’inutile e
sconsolato vivere” tracciato da Leopardi. Può imprecare, è quello che gli
resta.
Finzi, attraverso
questo libro, conduce un severo bilancio non solo sul suo nuovo status: fisico,
sociale, esistenziale (quello segnato dalla vecchiaia), ma dell’intero arco della
sua vita negli aspetti salienti. Tornano allora i ricordi e gli scorci della
sua Mantova; i visi colti in filigrana di alcuni momenti della giovinezza, gli
amici che se ne sono andati, la città divenuta distratta, indifferente, ostile,
il degrado morale che corrode la vita civile, il costume, gli ambienti
culturali a cui pure è, da protagonista, appartenuto. I due testi che qui
ripropongo, vi faranno assaporare tutto il retrogusto amaro che questo il libro
contiene.
Vecchio
mostro vedilo,
monstre dell’età
(è
una specie di ingiuria dell’ipocrisia)
brutto
e grosso sei
invisibile
alle nuove
scalcinate
generazioni,
tristi
senza saperlo,
scure
in volto ragazze seminude –
jeans
bastardi e brevi top –
ragazzi
incolti maleodoranti nei loro
brevi
calzoni, nelle calotte craniche dove
dritti
o annodati i capelli abbondano,
tutti
in sospetto delle parole
che
non arrivano,
non
contano più: sono i segni
a
valicare i nomi, i segni
delle
inventate emozioni che vengono e vanno
come
bisbocce fuori tempo
fatte
per vivere da bruti
semplici
nel sogno, violenti nella realtà.
Vecchio
invisibile, monstre dell’età
riconosci
te stesso, verde e magro,
le
prove del vivere, accanto e dopo,
il
cielo è azzurro, le piogge lievi,
dietro
l’arcobaleno c’è
il
breve, il niente, lo spazio perso.
[2-10-2011]
***
L’oro
che ti serviva
lo
hai perso,
non sei stato pronto
a
vederti integrato, sei stato
fermo
in fondo alla fila
ad
attendere
nonhaimaisaputocosache
hai
lasciato che colpa o merito
fossero
di altri, tu preferivi
enigmatico,
persino
ambiguo
mostrarti, pur senza fingere,
con
poca sostanza, ma con la voglia di sempre
di
dire “no” – senza freno,
senza
limiti –
a
tutto deciso pur di non decidere,
fermo
nel non dire, non fare.
Si
muovevano intanto gli altri,
i
tuoi nemici godevano, qualche
avversario
cedeva per stanca emozione,
tutto
avveniva: letteratura, politica,
eventi
personali e pubblico nullismo,
tutto
si teneva, e tu soffrendo
continuavi
continuavi
a
vivere per te, con te, da te.
Così
ti bollarono, i tuoi simili –
se
il non fare non è delitto ma etica virtù –
come
“probo”
[3-10-2011]
Per gli aspetti
anche “speculativi” del libro, i testi andrebbero riprodotti nella loro totalità.
Il lettore abituato alle ardue e a volte “petrose” sperimentazioni poetiche di
Finzi, si troverà davanti ad un libro spiazzante. Per me, al contrario, è stata
una felice sorpresa. Intanto perché lo ritengo un libro necessario: una materia
così insidiosa doveva essere maneggiata con cura per non scivolare nel già
letto e sentito, e abbisognava di un poeta attrezzato. Finzi ha lavorato la sua
materia magistralmente, e, pur tenendosi al di qua del lirismo, riesce ad
emozionarci perché la parola ed il verso si fanno “caldi”, “umani”, e spesso
distesi come una narrazione. Al lettore giovane questo libro potrà procurare disturbo e i versi sentirli emotivamente distanti; a chi giovane non lo è più apparirà come uno
specchio inesorabile, da cui non è possibile distogliere lo sguardo.
ALCUNI LIBRI DI FINZI

GILBERTO ISELLA
Salvatico è colui che si salva
(Fantasie leonardesche)
con immaginificazioni di Fiorenza Casanova
dedicato a Fiorenza Casanova
Le distruzioni dell’acqua
(Feltr. p.79)
.jpg) |
| Opera di Fiorenza Casanova |
Salvarsi dall’impeto delle acque è impresa temeraria
alquanto. Dico quell’acque strepitanti e d’opulentissima portata che l’alte
cime dei monti consumano e gran sassi disbalzano e persino i mari da essi
stessi scacciano, tanta copia d’alieni detriti vi posson riversare, consolidate
geologie capovolgendo. Quell’acque, da disegno divino imperscrutabile sul mondo riverse, che pur in cangianti guise promosse, aspre o dolci, malinconiche o gaie al variar
degli umori dell’Altissimo, il più delle volte in enormi incontenibili masse si
rapprendono. E allora, quasi un’anima propria ostentando e facendosi liquide
fiere, rovinano le alte rive, disvellono le più tenaci piante, seco trainando uomini, bestie, ville e
possessioni.
Il più gigantesco, calamitoso sovrabbondare d’acque,
di cui si tramanda, fu chiamato diluvio. Condensazione formidabile di nubi, squarciatura
del cielo intero, percussione d’onde marine contro obliqui monti. Fortemente
gemette la terra, in congiuntura simile tratta e impotente all’urto, e conobbe indicibile
morìa di vite, ma Noé patriarca, secondo le Scritture, ogni sua forza
investendo in salvifica impresa, poté un capientissimo guscio costruire e ivi
raccogliere ogni specie animale, dal vermicello all’elephas, dall’icneumone
alla spillancola, per indi sospenderlo sovra i flutti, onde sottrarre i viventi
alla follia dell’immenso flagello. Strumento istesso di Dio, Noè ardiva con Dio
competere– non sfugga la istranezza - nel
risolvere i compiti dell’idraulica prima, battendo e storcendo le onde, e non
senza reiterati calcoli l’impeto di esso diluvio genialmente temperando, sì da
portentosa vetta infine approdare, e ai congegni della macchina mondana
concedere nuovo moto.
Ardimento non minore dimostrò, nell’era nostra, Noemi,
dilettissima figlia di uno stimato sorvegliante di dighe, trovatasi un dì a
fronteggiare l’onda vertiginosa e perversa di un quesito che, studentessa in
quegli anni, si era vista rovesciare sull’asciutto foglio di un esame. Trattavasi
in verità di un curioso passatempo all’acqua scherzevolmente dedicato, ludo
d’infanzia i cui attori erano l’acqua,
una vasca, un rubinetto, un metallico
tappo e un baldanzoso corteo di numeri. Non s’erano ancora gli occhi di Noemi appuntati
alla scena, e la scena stessa del tutto
apparecchiata all’osservare, che da una piega del foglio si levò la magistrale
voce: “In quanto tempo, dati per cogniti portata del fluido e volume del
recipiente, e debitamente messe in conto sospensioni del getto e occlusioni repentine
dello scarico, da ascriversi esse a nobili modulazioni volte a tener vivo il
sollazzo, la vasca sarà colmata?” Infilatasi la giovinetta con corporale e
spirituale ardore in tale tormentoso passatempo, un torrentello
contesto di interrogativi punti parve il
medesimo traversare, e seguendo alvei
solo a lui famigliari, farsi grosso e minaccevole, e quale abnorme liquido
ordigno principiò a battere allo scrigno della mente di Noemi. La quale mente
venne espugnata infine, e a immateriale vasca, per insolita conversione, resa
identica. E a quel punto la giovine scopertamente si figurò il diluvio che
sulla vasca umana dell’intendere e giudicare da sempre incombe. Incombe esso,
rappreso in densissimo nembo di numeri,
lettere e altri segni per occulta fattura in varie posture messi, fino a che,
consumati gli spasmi suoi, che a quelli di partorienti dee si potrebbero
assembrare, con strepito inaudito si scatena. Verticale, breve, inesorabile. E
allora, fortemente temendo le precipitevoli acque e tra i lacci del quesito
senza posa dibattendosi, in Noemi surse una domanda. Se di tanta numeral furia
la mente umana è oggetto, da venirne, più che riempita, istordita al colmo e
quasi annichilita, potrà ancora essa,
fantasticando su improbabili vuoti fatti salvi, inclinarsi al quesito di colmare una vasca? Una insignificante vasca
nel vortice matematico del Tutto, tanto maraviglioso da potersi credere per
simulazion concepito?
L’asino e il ghiaccio
(p.122 Feltr.)
.jpg) |
| Opera di Fiorenza Casanova |
“La sapienza è figliola della sperienza”, così sentenzia
la maggior parte. Ma tale virtuosa generazione sta nell’universale, non nel
particulare. Proporzional sapere, dal
sommo al pressoché nullo, ogni esperienza induce, a seconda dei subietti. Si
consideri, al riguardo di taluni, il girare a vuoto per piazze e taverne, e
ricalcare ogni dì e quasi ricamando le conosciute orme, talora con iterati
cenni del capo ai circostanti dando convenzional saluto, fiaccandosi l’anima
nella consunzion del tempo, sempre la medesima aria fiutando e al vuoto
d’intorno con soffi cadenzati restituendola poi. Quale sapienza ne spillano gli
atti, forse una maggior cognizione del tempo e dello spazio? Alcuni gettano
carte e dadi, su banchi alla bisogna istituiti, e perseverando assai
nell’istudiar loro combinazioni mai non vincono, e ne ignorano causa. Si narra che un dì un tizio, noto per
il quotidiano esercizio del mal dire, sporta appena la bocca sua fuor dall’uscio,
ricevette per mano di un anonimo, a mo’ di dono, un involucro in cui v’era
lingua di bue fresca, un picciol coltello e spezie forti. Famelico egli e poco
avveduto, tornato al suo ricetto, con quella lingua pasteggiò. Ma la sera
istessa, rincasata la sua fante, ella scorse sul tavolo un rivolo di sangue e
in bella vista lingua umana posata nel mezzo. E udì lamenti forti da oltre una
parete. Ignorava, il poveretto, che certuni accadimenti che paiono schietti
all’apparire, come è di un innocente dono, tengono riposte e quasi allegoriche
significazioni. In specie attinenti a minacce o avvisaglie malvage di
contrappassi a preterite colpe destinati.
Se difetto di cerebro v’è, o per destinale
insufficienza dell’istesso membro o per via di torbide nebbie in esso cumulate,
esperienza a che giova? Questo in quanto agli umani. Ma compartecipando l’uomo
dell’anima animale, sì da potervisi con agio commisurare, è da un’esperienza
asinina che vorrei trar fabula. Visse in
tempi non lontani un asino mite e paziente, e alquanto laborioso, che
essendo d’abitudine strattonato e redarguito dall’insensibile padrone, un dì
non tennero muscoli e ligamenti suoi alla prova. Forse ciò anche a motivo della forte calura
che, prorompente da arie sature di raggi solari, le sue fatiche aggravava e al sonno
induceva. Deposta la soma sull’erba, scorse il nostro animale un profondo lago coperto
da ghiaccio ristoratore, e subito lo scelse per giaciglio. Addormentandosi egli
sovra il suddetto ghiaccio, e fiduciando in un subito conforto, il suo calore
lo dissolvé, e l’asino sotto acqua, a mal suo danno, si destò, e subito annegò.
Neppure
l’uomo, che più dell’asino è supposto ponderare gli accadimenti, è al riparo
da’ ghiacci. Narrasi di una possente nave, concepita da smisurato orgoglio, che
di festaiola brigata oltremodo colma e d’insolenti luminarie, stoltamente
procedendo nel boreale pelago, in enorme cattedrale di ghiaccio impattata e una
sol ragna di crepe divenuta, inclinatasi di molto affondò. Così nei pregressi
tempi. Ma vedrassi ancora a lungo sulla terra gelare acque e ghiacci
dissolversi, secondo cicli che natura non muta. E molte anime umane e asinine,
gemendo o ragliando secondo costume, da lor corpi malinconiosamente separarsi.
Come salvarsi dall’orso
(Bur, p.98)
.jpg) |
| Opera di Fiorenza Casanova |
Della nocività dell’orso assai si conversa nelle nostre
convalli. Non v’è baita o malga o casale
o il più spesso taverna ove iracundi pastori, talora soggiacendo al flusso di
bionde birre o aspri vini, lor nocche forte battendo su antichi e pazientissimi
legni, non discettino di come vendicarsi degli orsi predatori. C’è chi enumera
capre dai medesimi sbranate, o pecore o galline, o innocenti stambecchi su per le rocciose
guglie coi loro imponenti corni estirpati, e taluno pigliando gusto
all’iperbole si spinge persino ad evocare intere mandrie dilacerate e a bocconi
fatte, con tibie o bucrani lasciati ancor madidi di umori, nei solchi del terreno o nei
greti di impetuosi torrenti. E voci
persino si levano a denunciare aggressioni contro le istesse umane creature:
mai corpi mutili e tronchi in tanta copia si son visti d’attorno, a memoria
d’uomo, nella contrada. Se l’orso è colpevole di siffatte sciagure, alle quali
assommare è doveroso l’alterazione del valligiano moto dei venti, esemplar pena
andrà ad esso somministrata.
In ogni villaggio son di buon’ora convocati i consigli
degli anziani. Modi difensivi di vario tenore si discutono assai. Ove si pone
mente a barricamenti d’ogni guisa, argini, muraglie all’antica esperienza del
Catai ispirate, e incontro venendo ai buoni auspici dell’armata, che tutte le
istudia al solo fine d’isfogarsi in qualsivoglia forma, si discetta altresì di
mangani, baliste, arieti e catapulte, e addirittura sonvi evocate quelle
moderne bocche di ferro che scarlatte fiamme eruttano. “Ma l’orso”, obiettò un
vecchio paesano in un de’ convegni pervenuto con suo forcone, “è il più tenace:
l’orso è mostro immenso, e solo virtù di maghi e fattucchiere dalle sue
calamità posson metter riparo. Evvi
tuttavia un rimedio a portata nostra”. Leonardo
Vincent, tale il nome del paesano, così seguitò a concionare: “Essendo io di
api cultore e di miele espertissimo fatto, posso questo asseverare. Quando
l’orso va alle case delle api per torre loro il miele, esse api lo cominciano a
pungere, onde lui lascia il miele e corre alla vendetta, e volendosi con tutte
quelle che lo mordono vendicare, esperisce vana la fatica sua, in modo che la
sua rabbia cresce, e gittatosi in terra, con mani e piedi innaspando, indarno
da loro si difende. E il suo corpo, in tutte parti da incalcolabili morsure
d’api martoriato e dal velen di esse imbevute le membra, immobile in
fine sul nudo suolo istà”. Come miele giunser le parole di detto Leonardo agli
ascoltanti, sicché tutti, lasciate lor consuete faccende, deposti aratri e
vanghe, apicultori divennero e felicemente per l’uomo si compose infine la
guerra con i famelici orsi.
Comportamenti d’uccelli (Feltr.,
p.88 e sgg.)
Quando l’uccello ha gran grandezza d’ali e scarsa coda,
e che esso si voglia levare, allora alzerà forte l’ali, e girando riceverà il
vento sotto l’ali, godendo di sue spinte. Uccello e vento, su vie d’aria ad
essi pressoché compartite, entro rettilineo, obliquoso o circolare moto, quasi
da antichissimo e sacral vincolo congiunti, nel grande scenario del cielo si
conducono. Or in modo lento e quasi non avvenente, or in velocissimi guizzi e
tornate, a seconda dell’umor del volatile e della potenza del vento. Così
vediamo gru e cicogne formare lunghissimi cortei, e in ieratiche posture solennemente
procedere, il celeste scenario che le accoglie rigando e bipartendo. O al
contario, schiere di rondini sfrecciare in alto fino a disparire dall’umana
vista, tratte al largo in talune congiunture dall’appello di altri lidi. Ci sono pure generazioni d’uccelli, quali il
nibbio, che battendo poco l’ali, s’affidano passivi al volere del vento, in
esso gettandosi e a seconda delle ubicazioni di quello, per diverso condensarsi
d’aria, ascendere o calare.
Si dilettano, certo, gli uccelli, a mescersi con gli
aerei elementi, essendo per complessione loro affini, facendosene manto o scudo e, una volta tali forme di mascheramento conseguite,
apprestarsi a porre in esecuzione imprese necessarie a soddisfar lor
fame. Si narra che, negli antiquissimi tempi, accortisi un dì gli uccelli
dell’universal subbuglio generato dal diluvio, al principio della loro apparizione
entro la mirabile scena, presero forma
d’insensibile nuvola. In siffatta guisa l’occhio li discerneva, prima che
l’insolito viluppo si dissolvesse e nette apparissero sagome di torme
declinanti in basso, pronte a posarsi sui morti corpi portati dall’onde e indi
a cibarsene. E moltissime altre maniere
di volatili osservate, in relazione sia al muoversi che al tenersi fermi, o
mollemente sull’acque galleggiare, come usano anitre e cigni, portare a
conoscenza parrebbe opportuno.
Tanti e difformi sono gli atti che natura d’uccello
manifesta, eppur sì consoni al comune intendere, da poter apparentare quella
per sembianti a natura umana. Volatile anch’essa, per notoria inconstanza e
labilità d’umori ch’ogni dì sopporta, come dal quotidiano corso del vivere si
evince, e nondimeno atta al volo. Lo si constata con frequenza nell’incontenibile,
mobilissimo e quasi in aeree guise studiato spostarsi d’individui nei lochi dei
traffici e del mercatare, ove l’istessa merce, qui prelevata e là posta, qui
repleta di sguardi e là obliata, in potenzia o in atto a becchi parendo sospesa,
dei capricciosi e obliqui voli
dell’umana creatura partecipa. Ma nei casi superni, che mozioni d’animo per
così dire sgravate di pratico fine unicamente riguardano, qualunque sprizzo
ingegnoso e istantaneo da cerebro mosso vien detto ‘volo della mente’. Memoria
d’uccelli che batta l’ali forse in anima umana è scolpita? Molti casi confermerebbero
il suddetto supporre. In proposito si ponga mente a una moltitudine di
atteggiamenti che in egual modo si confanno a uccello e uomo. Così sonvi uomini-gufo,
che amando posar lor zampe sui rami più esposti degli alberi, sogliono stare
immobili a osservare i passanti. Il loro fisso sguardare indispettisce l’altra
gente, che sentendosi giudicata, e quasi defraudata della propria virtude, a
schivare tanta oculare insolenza ratta si dispone. Sonvi i vanesii
uomini-paone, gli imperiosi uomini-aquila, e tra i rapaci eccellono, vogliosi
di altrui spoglie che a crude lacerazioni sommettono, gli uomini-avvoltoi, ai
quattro lati dell’orbe più che uno immagini diffusi.
Eppure l’arte del volo di gran lunga è il vanto
dell’alata famiglia. Morso da invidia e parimenti conscio di partecipare della
specie dei volanti animali, e intuendo che l’uccello è strumento operante per
legge matematica, l’uomo a mezzo di dure
materie e formidabili legacci di metallo e con protratte calcolazioni
costruisce uno strumento a imitazion del loro volo, e con esso nell’aere
piacevolmente s’intrude, alquanto oscillando e pur in bilico il più sovente
standosi. E di ammirare lo spettacolo del mondo disideroso, vede monti sotto i
suoi piè, e deserti e mari e lunghi
mantigli di nuvole. Ma non v’è dì che, vuoi
per subitaneo turbamento d’aere vuoi per impazzimento dei congegni, le surriferite
macchine precipitose cadute verso il suolo non ischivino. Talché l’uomo-uccello s’inabissa. Vedrassi
allora cemeteri di carcame torridi emergere da dune di sabbia, oppure ghiacciati
torreggiare tra gli integumenti di artiche biancure. E nondimeno non
s’iscoraggia il pensante abitator della terra, che ha potestà di sostenersi
infra l’aria con battimento d’ali.
Un modo come un altro per passare il tempo.
Carissimi, purtroppo la sorte e l'insipienza altrui si
accaniscono contro di me.
La presenza di tre linfonodi, peraltro asportati, ma
infiltrati da cellule tumorali, mi avrebbero consigliato una chemioterapia che
fortunatamente ho rifiutato, perché avrebbe avuto conseguenze letali, dato lo
stato di sfinimento in cui mi trovo.
Ora le ragioni di questa spossatezza mi sono chiare: un
gravissimo scompenso cardiaco, dovuto con tutta probabilità agli effetti dell'
anestesia, o a complicazioni postoperatorie di cui non si sono valutate appieno
le conseguenze.
Sto cercando, per quanto possibile, di curarmi ma,
credetemi, mi riesce difficile anche il minimo movimento.
Per questo sono costretto piuttosto bruscamente a salutarvi,
ma, in attesa di recuperare le forze, vi prego di accettare quanto il vostro
amico vi acclude in calce.
Giulio
***
di Giulio Stocchi
a Deborah
Guerra
intestina
E’ curioso
per uno che ha sempre
predicato
la ribellione
vedere il proprio corpo
ribellarsi
e le cellule moltiplicarsi
impazzite al varco
dove si affollano
per pugnalarti a morte
E’ l’antico dissidio
fra la teoria
e la prassi
al quale assisto
con una certa
trepidazione
*
Se
lo conosci lo vinci
Buongiorno
Signor Cancro
Permetta
che mi presenti:
Mi chiamo
Giulio Stocchi
di professione
poeta
come attestano la mia magrezza
e la carta di identità
Giulio Pietro per l’esattezza
in verità
E’ per me un piacere mi creda e un onore
fare la Sua conoscenza
Ma quello
senza degnarmi di un’occhiata
tira diritto
per la sua strada
roteando la canna
di malacca
tronfio lardone
di malagrazia
con quella sua buffa bombetta
d’antan
il panciotto la catena
il cipollone
e la sempiterna tracotanza
del padrone
*
Ben
scavato vecchia talpa!
Mi sorprendo a biascicare
tra me e me
le parole dello scienziato
della rivoluzione
osservando nello specchio
il corpo emaciato
che il tumore
va divorando
Quello ingrassa
ed io dimagro
Buon appetito
compare!
dovrei piuttosto dire
per creanza
se ancora mi restasse
un filo di voce
per farlo
*
Luoghi
comuni
Variazioni
sul tema precedente
Quello ingrassa
ed io dimagro
Buon appetito
compare!
dovrei dunque dire
per creanza
Certo non è
un pranzo di gala
la rivoluzione
ma che divori i suoi figli
questo comincio davvero
a sospettarlo
*
Parodie
Una rosa
è una rosa
è una rosa
Un tumore
è un tumore
è un tumore
Il dolore
è il dolore
è il dolore
è il dolore
LE PULCI
di Laura
Margherita Volante
"Gli stolti spendono la loro curiosità per sapere
gli affari altrui.
Gli intelligenti la spendono nel campo della conoscenza e
dei saperi."
"Lo sciocco ti chiede l'età, l'intelligente ti
chiede come stai"
"Spesso si tende a scambiare la bontà per ingenuità,
ma la bontà vede il benne
perché ne è portatrice sana..."
"Chi comprende i difetti e gli errori altrui non li
giustifica ma ne capisce l'origine"
"Peccati di gola. Più il tempo passa e più la gola
reclama generi di conforto..."
"W il passato. Le memorie servono per non perdersi
in un ginepraio di sciocchezze e futilità"
"L'amore è quando il compagno/a perde una gamba e lo
guarda come fosse la Venere di Milo"
"Meglio enfatici che fanatici"
"Uno può anche essere un genio, ma se non tocca
l'inferno non conosce ciò di cui parla"
"Chi non ha conoscenza alcuna deve stare
zitto!"
"Femminicidi: oggi l'uomo è l'illusione delle disperate...ci
cascano e poi muoiono
uccise per mano
della loro illusione"
"Ogni donna merita un piano elevato se no per
compiacere si abbassa alla volgarità dei costumi"
"Se ogni uomo pensasse che in ogni donna c'è un po'
della mamma della figlia della sorella,
la guarderebbe come si guarda un'opera d'arte..."
LA LETTURA
Blu elettrico
di
Annalisa Bellerio
“Quindi sei qui per chiedermi il divorzio,
giusto? E la cosa un po’ ti imbarazza. Quando pensate di sposarvi? Flavia è già
incinta?”
Gemma
guarda il suo quasi ex marito dritto negli occhi, lui ha uno sguardo sorpreso e
spaventato, che subito abbassa sul cellulare che continua a toccare, ruotare,
prendere e riappoggiare sul tavolo del ristorante.
“Ma
no, cioè non so, non è ancora sicuro. Ma lei ci tiene, lo sai, ormai sono tre
anni e lei vuole…”
“Lei
vuole regolarizzare, certo. Vuole un bel matrimonio con tutto il paese in
festa, vuole un figlio, vuole una nuova casa, e soprattutto vuole qualcuno che
le assicuri tutto questo. Non ho dubbi su quello che vuole lei. E tu, Damiano,
tu che cosa vuoi?”
Ecco,
è diventata aggressiva, proprio come si era ripromessa di non essere. Ma era così
difficile controllarsi, evitare che il rancore straripasse e la travolgesse.
Tre anni. Erano tre anni che lui se ne era andato, o meglio che lei l’aveva
spinto a farlo, troppo sconvolta, esasperata, disgustata per sopportare ancora.
Poi
era venuto il dolore.
Si erano
messi insieme che erano ragazzi, cresciuti entrambi in quel paese di provincia che
avevano finalmente lasciato per una casa di una dignitosa periferia cittadina, dove
lei ancora vive con il loro bambino di nove anni e un futuro andato in pezzi. In
fondo non era male la vita che si erano costruiti, e che lei si aspettava
continuasse. Si amavano, amavano il loro bambino, amavano il loro lavoro.
Poteva andare avanti così. A lei piaceva insegnare in una scuola elementare e
lui aveva non poche soddisfazioni dalla piccola fabbrica di mobili di cui aveva
preso le redini dopo la morte del padre. Oppure no? Aveva invece bisogno di
qualcosa di diverso? Non sa più chi sia e cosa pensi veramente quell’uomo dal
viso di ragazzo e dal fisico robusto e ora, nota, anche un po’ ingrassato che
le sta seduto di fronte e che ancora è suo marito.
“Quando
nascerà il vostro bambino avrai ancora tempo per Mirco? Lei cercherà di farti
dimenticare che hai già un figlio.”
“Dai
Gemma, cosa vai a pensare. Ti sembra che possa dimenticarmi di Mirco? Che
Flavia possa impedirmi di vederlo? Non è un mostro, Flavia.”
Gemma
si morde le labbra per non dare voce ai suoi pensieri.
“Com’è?”
aveva chiesto a Damiano più di quattro anni prima, quando Flavia si era
presentata in ditta la prima volta. Aveva allora ventidue anni e aveva appena
faticosamente finito una scuola di ragioneria. Era figlia di conoscenti in
paese in difficoltà economiche, che avevano supplicato lei, Gemma, di chiedere
al marito di dare a quella ragazza l’opportunità di farsi un’esperienza di
lavoro. Sì, l’opportunità c’era. Serviva un temporaneo aiuto in amministrazione.
“Com’è?
Una ragazzotta vistosa”, aveva risposto Damiano. “Non mi sembra il tipo che
davvero vuole fare quel lavoro, ma non ci metterò molto a capire che cosa sa
fare. Basta che non mi faccia perdere tempo.”
In
effetti non c’era voluto molto a capire quello che Flavia sapeva fare. Lei
certo non aveva perso tempo e del tempo che aveva fatto perdere a Damiano lui non
si era lamentato. Evidentemente non aveva rimpianti.
Era
solo Gemma ad avere rimpianti.
Tra
poco lui sarebbe tornato al loro vecchio paese, nella sua casa con tavernetta e
un fazzoletto di giardino, nella sua nuova vita. E lei sarebbe tornata al suo
piccolo appartamento cittadino, alla sua vita spenta in cui solo il suo bambino
e i suoi piccoli alunni fanno luce.
Gemma
si guarda intorno nella trattoria dove una recente ristrutturazione ha
conservato studiati sprazzi della rustica tipologia originaria. Lui l’ha
portata in quel territorio neutrale per parlare di tutto quello di cui devono
parlare. Il Natale e le vacanze di Mirco, il computer che non funziona e le
spese di casa. Ma come lei si aspettava e temeva, lui aveva anche altri
argomenti da affrontare. Il divorzio. Il matrimonio. Il figlio forse già in
arrivo.
La
sala si sta svuotando. Anche i commensali dell’affollata tavolata d’angolo sono
già in piedi a scambiarsi rumorosamente le ultime battute della serata. Gemma e
Damiano rimangono soli, mentre i camerieri si muovono freneticamente intorno a
loro sparecchiando e preparando i tavoli per il giorno seguente.
“È
tardi, andiamo.”
In
pochi secondi Damiano chiede e paga il conto e insieme si avviano all’uscita.
La stanza del guardaroba è ormai vuota, lui si infila il giaccone di pelle e
Gemma cerca il suo, che aveva lasciato accanto. Il suo non c’è. L’unico rimasto
è un vaporoso pellicciotto sintetico blu elettrico, con un’alta cintura
elastica decorata di perline.
“Dov’è
il mio giaccone?”
“Qualcuno
l’avrà preso in sbaglio al posto del suo.”
“In
sbaglio? Ti pare possibile? Hai presente il mio, è un comunissimo piumino nero
lungo col cappuccio, come vuoi che si potesse scambiare con questo!”
Gemma
chiede ai camerieri, ma nessuno le presta molta attenzione, non sanno niente e
hanno fretta di chiudere.
“Ok
Gemma non è il tuo ma mettilo lo stesso, fuori fa un freddo cane.”
Gemma
infila a malincuore quell’eccentrico indumento che è esattamente della sua
taglia.
“Be’,
ti sta bene. Tutto sommato ci hai guadagnato.”
“Non
è il mio genere e comunque non è roba mia. Oddio, avevo qualcosa in tasca? Non
mi sembra. No, le chiavi le ho qui nella borsa.”
Fuori
dal ristorante ci sono ancora gruppetti di persone che si attardano a parlare
nonostante il freddo, la compagnia del tavolo d’angolo è ancora quasi al
completo e Gemma si avvicina quanto basta per osservare quello che ognuno ha
addosso. Ci sono parecchi piumini neri. Ma non il suo.
“Signora,
ha perso qualcosa?” Mentre si guarda intorno disorientata un uomo con un sigaro
in mano le è andato incontro.
“Sì.
Il mio cappotto.”
Il
tipo la osserva in silenzio con aria perplessa, continuando a fumare.
“Senti
Gemma”, dice Damiano raggiungendola, “torna qui domani all’ora di pranzo e vedi
se qualcuno ha riportato il tuo cappotto. Ora è tardi, andiamo.”
Il venerdì
Gemma esce presto da scuola. Alle due è al ristorante portando con sé il
pellicciotto colorato dentro una grande borsa di plastica. Ma nessuno ha
riportato il suo.
“No
signora ci dispiace non possiamo tenere qui questa pelliccia, ci lasci un recapito
e nel caso la chiamiamo.”
Gemma
scrive il suo nome e il numero del cellulare sull’agenda che le è stata aperta
davanti, e aggiunge “piumino nero” tra parentesi. Chissà se serve a qualcosa.
“Allora
ha ritrovato il suo cappotto?”
Gemma
si gira e riconosce il fumatore che la sera prima era davanti al ristorante. È
seduto a un piccolo tavolo da solo.
“Oh,
buongiorno. Anche lei è ancora qui.”
“Sì.”
L’osservazione sembra metterlo in imbarazzo. “Anch’io ieri sera ho perso
qualcosa. Una scatola di sigari. Niente di prezioso, ma ci tenevo. Sono passato
a cercarla, e visto che ero qui mi sono fermato a mangiare.”
“L’ha
trovata?”
“Cosa?”
“La
scatola di sigari.”
“Ah,
sì, nel parcheggio. E lei il suo cappotto? Ha rintracciato la proprietaria di
quella pelliccia blu?”
“No.
Non so niente né dell’uno né dell’altra. È proprio una cosa che non riesco a
spiegarmi. Sono cose così diverse, è impossibile confonderle.”
“Be’,
la tenga lei la pelliccia blu, le stava bene. Non le piace? Non piace a suo
marito?”
“Non
è più mio marito.” Chissà perché si è sentita di doverlo precisare.
“Oh,
allora c’è un’altra cosa che abbiamo perso entrambi. Ma magari per lei non è
stata una grave perdita.”
Gemma
rimane in silenzio.
“Scusi,
sono stato inopportuno. Capisco bene cosa prova, invece. Ha tempo per un caffè?
Si sieda, dieci minuti. Io mi chiamo Fausto.”
Gemma
si siede di fronte a quell’uomo dal fisico atletico e lo sguardo indagatore, che
potrebbe essere un istruttore di palestra e infatti lo è come attività
collaterale, perché di lavoro fa il tecnico informatico. Porta i segni di una
delusione recente subita con rabbiosa frustrazione. Ne accenna soltanto, e poi
con quel modo un po’ brusco eppure accattivante invita Gemma a raccontare di
sé. Sembra interessato per davvero. O in ogni caso è uno che sa ascoltare.
Gemma
se ne va con il numero di telefono di quell’uomo, con la sua promessa di dare
un’occhiata al computer appena possibile, e con un vago senso di leggerezza, di
commozione.
Fausto
è un uomo di parola. Dopo qualche giorno telefona e dice che gli è saltato un
appuntamento e potrebbe passare. In casa c’è anche Mirco immerso in un
videogioco. Il problema al computer sembra essere cosa da poco, in mezz’ora è
già sistemato, e Gemma prepara un caffè. Lui ha la cortesia di non fumare e di chiedere
a Mirco di insegnargli il gioco, così si siede accanto al bambino e per
un’altra mezz’ora sta lì a giocare con lui.
È la
prima visita e ne seguiranno molte altre. Fausto passa spesso, aggiusta il rubinetto
che perde, la porta che cigola, qualche volta porta Mirco con sé in palestra, quando
può va a prendere Gemma a scuola, mangia con lei, l’accompagna a fare quello
che lei prima faceva da sola. Passano i mesi e Gemma permette a quell’uomo di
entrare nella sua casa, nel suo letto, nella sua vita, pur cercando di negare a
se stessa quanto le sia davvero di conforto e di appoggio quella presenza
gratificante. Cerca di non fare progetti, di continuare a non farsi illusioni, cerca
di sottrarsi allo sguardo indagatore di Mirco, quel suo bambino sensibile che
percepisce ogni suo stato d’animo e ha capito quali argomenti non toccare,
quali domande non fare.
“Di
cosa hai paura, Gemma? Di rimanere ancora ferita?” le chiede la sua amica
Fiorenza. “Lasciati andare, goditi questa storia che ti fa bene, si vede. Anche
a Mirco fa bene avere a che fare con un personaggio maschile, visto che suo
padre è completamente rincoglionito. A te lui piace, giusto? E di sicuro tu
piaci molto a lui.”
Sì, questa
volta è diverso. A parte il conforto e l’appoggio questa storia procura a Gemma
un brivido di eccitazione che non provava più da tanto tempo. Si sente viva, ancora
giovane e desiderabile, ne ha un’evidente conferma e ne trae una calda energia.
Non vuole rinunciarci. Ormai non può nascondersi che non riesce più a farne a
meno.
Fausto
non fa mistero dell’attrazione che sente per lei e che manifesta in un modo a
cui Gemma non è abituata. È geloso. Damiano è mai stato geloso? In realtà non
ne ha mai avuto davvero motivo. E poi erano così giovani e innamorati quando
hanno cominciato a stare insieme, non potevano che avere davanti un futuro senza
dubbi, senza ombre. Avevano dato per scontato il destino che li attendeva.
Erano stati troppo sicuri l’uno dell’altra. O almeno lei era stata troppo
sicura. E Damiano ora era geloso di Flavia? Forse era questo che voleva, una
donna di cui non sentirsi troppo sicuro. Non sembrava il tipo, Damiano, da provare
questo genere di eccitazione, ma è vero che a lei non era mai sembrato il tipo
da poter fare quello che poi aveva fatto.
Fausto
invece non la considera una cosa acquisita, è sospettoso, teme di perderla.
Dunque prova per lei qualcosa che Damiano forse non ha mai provato.
“Come
mai sei uscita così tardi? È più di mezz’ora che sono qui ad aspettare.”
“Non
sapevo che venissi. Mi sono fermata a sentire le prove del coro con il maestro
di musica.”
“È
per lui che ti sei vestita così?”
“Così
come?”
“Con
quel vestito. Provocante.”
“Provocante?
Ma cosa dici.”
“È
lui il maestro di musica?”
Fausto
accenna a un uomo giovane e magro che esce in quel momento dalla scuola e va
dritto verso la sua bicicletta, senza voltarsi verso di loro.
“Sì
è lui, Giuseppe. Insegna qui da tre anni.”
Gemma
guarda la faccia di Fausto e non aggiunge altro. Giuseppe è una persona
sensibile e timida a cui è molto affezionata. Quando è rimasta sola lui le ha
fatto sentire la sua presenza discreta, le ha offerto la sua disponibilità nel
caso lei avesse avuto bisogno di qualunque cosa. Le ha sempre dimostrato una
gentile attenzione.
“Cosa
mi nascondi?”
L’espressione
di Fausto è dura, le prende un polso e le torce un braccio fino a farla gridare
dal male. Giuseppe si gira allarmato mentre già si sta allontanando in
bicicletta, ma Fausto la spinge con decisione e la fa salire in macchina.
“Scusa,
non sopporto gli uomini che hai intorno. Mi dispiace. Ti ho fatto male?”
Non
sopporta gli uomini che ha intorno. Anche Giuseppe è un potenziale rivale per
lui, come chiunque altro.
Quando
in estate la mamma di Massimo, un compagno di scuola di Mirco, li invita
entrambi per due settimane nella loro casa al mare, Fausto le telefona tutti i
giorni. Una domenica le compare davanti in spiaggia.
“Sono
venuto a trovarvi.”
E
forse a controllare, pensa Gemma. Ma quella visita improvvisa le fa piacere.
Lui aveva voglia di vederla.
Fausto
vorrebbe trasferirsi a casa di Gemma e Mirco, vivere con loro, ma lei non si
sente pronta a una convivenza. Non ancora. È troppo presto. Ma lui è così
possessivo, ci sono continue scene di gelosia quando non c’è Mirco. Le ha
lasciato dei lividi sulle braccia, a forza di scuoterla. Le ha tirato con
violenza i capelli.
È il
suo modo di esprimere il suo amore, Fausto non è uno di tante parole, è un uomo
d’azione. Ha paura di perderla, pensa Gemma, che sa di provare la stessa paura.
Ha paura che lui scompaia, ma a volte ha paura anche della sua presenza. La
paura le tiene spesso compagnia, ne sente accanto il respiro affannoso.
“Gemma,
qualcosa non va?”
Dopo
quell’episodio davanti a scuola, Giuseppe la osserva con più attenzione. Deve
controllarsi anche con lui, oltre che con Mirco.
“No,
va tutto bene. Perché?”
“Ogni
tanto hai l’aria di voler chiedere qualcosa, ma poi non lo fai.”
Cosa
potrebbe chiedere, e a chi? La sua vita è cambiata, lei stessa è cambiata, deve
rimettere ordine nei suoi pensieri, trovare un nuovo equilibrio, cosa c’è di
strano? Ha bisogno di tempo, un po’ di tempo ancora prima di decidersi a dare
ufficialità al suo rapporto con Fausto. Ma si vogliono bene, non ci sono dubbi.
È ormai quasi un anno che si sono conosciuti. Sono legati l’uno all’altra,
profondamente.
“Andiamo
via il prossimo week-end? Andiamo in montagna.”
“Non
posso, Damiano viene a prendere Mirco e abbiamo delle cose da discutere.”
“Ancora?
Ma l’hai appena visto, che cosa vuole?”
Sì,
Gemma l’aveva visto pochi giorni prima e le era sembrato confuso. Del divorzio
non aveva più parlato, neanche del figlio, ma lei non aveva fatto domande. Non
voleva essere coinvolta nei suoi dubbi, non voleva essere la sua confidente. E
alle domande che lui le faceva sulla sua vita privata lei dava risposte vaghe.
“Ha
detto che ha bisogno di parlarmi.”
“Si
è stancato della zoccola, vero? Vuole tornare con te.”
“Piantala
Fausto con questa storia.”
“Devo
piantarla, è così? Devo stare zitto e aspettare le tue decisioni!”
Lui la
prende per le spalle, sembra un abbraccio ma la spinge contro il muro e la
tiene ferma stringendole le dita intorno al collo. Gemma è atterrita e cerca di
difendersi, di prenderlo a calci, di divincolarsi. Appena lui diminuisce un
poco la presa gli grida “Lasciami, vai via, tra poco torna Mirco”.
“Mirco,
sempre Mirco.”
“Sì,
sempre Mirco. Vai via.” Gemma ha gli occhi pieni di lacrime ma cerca di reggere
quel suo sguardo furioso.
Non
se lo aspetta. Il pugno le arriva in faccia e lei perde l’equilibrio e cade,
sopraffatta dalla sorpresa e dal dolore, dall’orrore, dall’umiliazione.
Suona
il telefono. Gemma si riscuote e va a rispondere. È Mirco.
“Mamma,
Massimo mi ha chiesto se posso stare qui a cena e anche a dormire. Ti prego, mi
lasci? Domani andiamo insieme a scuola.”
“Va
bene, saluta Massimo e ringrazia la sua mamma.” Gemma cerca di controllare il
tremito della voce.
“
Grazie mamma. Che cos’hai? Hai una voce strana.”
“Sono
scivolata e ho picchiato la faccia contro il tavolo, ma non è niente di grave.”
Meglio dirgli subito qualcosa, prima che lui se ne accorga e faccia domande.
“Davvero?
Ti sei fatta tanto male?”
“Un
po’ ma non preoccuparti. Buona notte. Ti mando un bacio.”
“Anch’io,
ciao mamma buona notte.”
Gemma
rimane lì seduta per terra col telefono in mano. Grazie al cielo Mirco non la
vedrà in questo stato. Grazie al cielo.
Poi
fa il numero di Fiorenza. Quando l’amica risponde, dice qualche frase ma poi i
singhiozzi le impediscono di proseguire. Fiorenza spaventata le dice di
aspettarla, che arriva appena possibile.
Gemma
si alza e si guarda allo specchio. Oddio. Ha un grosso segno nero tra lo zigomo
e l’orecchio sinistro. Il livido diventerà ancora più grande, ma temeva peggio.
Non c’è lacerazione, non c’è niente di rotto.
Prende
del ghiaccio e se lo mette sopra la botta. Suona il telefono. È Fausto.
“Gemma
ti prego perdonami, sono stato una bestia. Come stai? Ti ho fatto molto male,
lo so. Non so cosa mi ha preso, non sopporto che tu esca con altri uomini,
neanche con tuo marito. Non riesco a controllarmi, lo so devo riuscire a farlo,
ti giuro che ci riuscirò, che non succederà mai più. Mi credi?”
“Fausto
non ho voglia di parlarti adesso.”
“C’è
lì Mirco?”
“No,
c’è Fiorenza. Devo andare.”
Fiorenza
in realtà non c’è ancora ma arriva poco dopo e la guarda sconvolta.
“Dimmi
cosa è successo.”
Gemma
racconta ma si accorge di tralasciare i dettagli, di cercare di minimizzare.
Fiorenza
vuole che comunque parli con un avvocato, lei lavora in uno studio legale e non
ha difficoltà a procurarle quello giusto. Anzi potrebbe farlo già stasera. Ha
una cena a cui non può più sottrarsi, ma insiste perché anche Gemma vada con
lei.
“Non
voglio lasciarti qui sola. Dai, ti aiuto a truccarti e usciamo insieme.”
Gemma
non ne ha voglia, ma non ha neanche voglia di stare lì sola in casa. Si lava,
si veste, si mette uno spesso strato di fondotinta e sistema i capelli in modo
da nascondere il livido.
Al
ristorante lui la chiama ancora. Potrebbe non rispondere, invece lo fa. In
fondo si aspetta qualcosa da lui, una spiegazione convincente, qualcosa che le
permetta di capire.
“Gemma
per favore posso venire? Devo vederti.”
“Sono
fuori a cena con Fiorenza e altre persone.”
“Siete
alla trattoria di Diego?”
“No,
in un posto che conosce lei, vicino a casa sua.”
“Come
torni a casa?”
“Qualcuno
mi accompagna.”
Lui
sta per chiedere chi, ma si trattiene. “Gemma ti amo lo sai, non farmi
soffrire.”
Ah,
era lui a soffrire. Probabilmente era vero, la amava e soffriva, in quel suo
modo incapace di controllo, di misura. Doveva forse avere pazienza, aiutarlo a
trovare la maniera di esprimere i suoi sentimenti.
Gemma
spegne il cellulare e Fiorenza la guarda. “Era meglio non dirgli niente. Lui
una volta mi ha accompagnato a casa dopo una cena a casa tua, sa dove abito e
qui intorno non ci sono molti ristoranti.”
Non
importa, pensa Gemma, ora lì si trova bene e vuole concedersi un piccolo
intervallo, una brevissima vacanza da se stessa e da tutto quello su cui deve
riflettere. E mentre si sforza di prendere parte alla conversazione ricacciando
indietro tutto il resto, qualcuno chiede: “Sta piovendo?” e l’uomo seduto di
fianco a lei si gira verso la finestra e scosta la tenda per guardare e Gemma
lo vede, lì fuori, vede Fausto in piedi accanto alla macchina di Fiorenza, lo
vede che aspetta fumando.
E
allora improvvisamente capisce. Capisce perché lui era fuori da quel ristorante
quella sera di un anno prima, quando l’ha visto per la prima volta, e capisce
la vera ragione per cui anche lui era tornato in quel posto, il giorno dopo.
Capisce
che lui non cambierà, che quanto è successo è destinato a ripetersi, che lei deve
svegliarsi dal suo lungo sonno e guardare quello che non ha voluto vedere.
Capisce che deve rimettersi faticosamente in piedi e andare incontro a una nuova
solitudine, che ancora sarà chiamata a dare prova di coraggio e di dignità. Chiederà
consiglio, chiederà aiuto, ma poi dovrà proseguire da sola per la sua strada.
Sa che deve farlo. Sa che può farlo. È ancora in tempo.
Prima
di dover fuggire da un ristorante nascosta dentro un anonimo piumino nero,
abbandonando nel guardaroba una pelliccia blu elettrico, troppo appariscente
per passare inosservata.

LA FRASE DEL GIORNO
“Cosa mi manca?
Mi mancano le persone che non mi vedono
e non mi mancano le persone che fanno finta
di non vedermi”
Laura Margherita
Volante

POETI
FILIPPO RAVIZZA
Dico
Un dirupo scavato nell’Atlantico
il nostro nome… generazione
del conforto forte battaglia, ansie
del rispetto… come quella sera
e quel mattino, dopo, poi… lì,
sì, lì, lì a Lisbona, pareva quasi
un precipizio il dirupo scavato
nell’Atlantico…
parevi tu parevo io noi tutti…
non dico poco non dico niente,
sai, dico io, la mia generazione
sì lei, lei dico, chinando il capo
al tempo che tutto dimentica
e tutto ama e distrugge perché
destina, dico…
capisci ora… capisci…
dico la mia apparizione…
dico Lisbona allora e adesso…
dico che ti voglio bene… dico
che abbiamo amato veramente
i ponti sentito sai sentito…
“quelle care sfavillanti luci
nella notte, da costa a costa…
il fuoco, l’uguaglianza,
la prossimità degli altri”
Un dirupo scavato nell’Atlantico
il nostro nome… generazione
del conforto forte battaglia, ansie
del rispetto… come quella sera
e quel mattino, dopo, poi… lì,
sì, lì, lì a Lisbona, pareva quasi
un precipizio il dirupo scavato
nell’Atlantico…
parevi tu parevo io noi tutti…
non dico poco non dico niente,
sai, dico io, la mia generazione
sì lei, lei dico, chinando il capo
al tempo che tutto dimentica
e tutto ama e distrugge perché
destina, dico…
capisci ora… capisci…
dico la mia apparizione…
dico Lisbona allora e adesso…
dico che ti voglio bene… dico
che abbiamo amato veramente
i ponti sentito sai sentito…
“quelle care sfavillanti luci
nella notte, da costa a costa…
il fuoco, l’uguaglianza,
la prossimità degli altri”

MOSAICO. Per Gregory Corso
di Gilberto Isella
La sovversione
è contenuta in una bomba. Quella “Bomba” poetica in forma di fungo che Gregory
Corso gettò in faccia al buonismo dei pacifisti russelliani, e che divenne
l’emblema dell’intera beat generation
(così come l’Urlo ginsbergiano o il vagabondaggio dharmico di Kerouac). “All man hates you… They’d rather die by anything but
you”, “L’uomo morirebbe di tutto piuttosto che te”. Elevando la poesia a deflagratore universale, Corso
contrappone con scaltra ironia la Morte cosmica alla piccolo-borghese, replicante,
privata (no-feeling, sadless) morte
naturale o incidentale. Ne fiuta l’irrevocabilità apocalittica, la complicità
con l’antica ekpiroris, ne contorna la
sublime sinopia mistico-religiosa, ma ci fa capire allo stesso tempo che nulla
trascende l’ordine simbolico.
Scriveva Burroughs nel 1989: “Il rozzo contestatore inglese che buttò
una scarpa contro Gregory mentre leggeva Bomba
non capirà mai la poesia e i poeti, poiché la realtà poetica non ha niente a
che fare con la realtà politica e sociale”. E difatti la poesia è un’esplosione
di ebbrezza anarchica insostenibile dalla società. Soltanto il suo dire,
rivoltandosi contro l’assetto “troppo umano” di un universo da cui Dio è
fuggito, può assurgere al ruolo di mito-bomba: reazione a catena di immagini e metafore dagli
effetti vertiginosi, proteiforme anti-Dio disseminato nel testuale, disposto a
scagliare strali infuocati o viceversa a dispensare dolcezze idilliache: “Pinkbombs will blossom”, “Bombe-garofano
sbocceranno”.
Disinnescata à tout jamais dalla
ragione storica, la bomba si trasforma in un’enorme cornucopia di parole e
suoni, riscopre e riillumina tesori letterari del passato, diventa una voliera
di uccelli variopinti, una polifonia di gorgheggi e striduli versi. L’atomica,
il maggior tabù dei nostri giorni, sarà
allora un “Giocattolo d’universo”, un oceano stellare di segni:
Le stelle uno sciame d’api nella tua borsa tinnante
Infila angeli sui tuoi piedi giubileo
ruote di pioggia-luce sul tuo
scanno
La tua ora è giunta vedi essa è giunta
e i cieli ti hanno assunta
osanna incalescente gloriosa unione
BOMBA O tumulto antifona spacco liquefatto BUM
Corso, come
sostiene Vito Amoruso, fa di “un simbolo di una condizione storica l’occasione
di una variazione stilistica, fonica e onomatopeica, cioè lo strumento di una
rappresentazione e di una presa di possesso solamente linguistiche della
realtà”[1] L’area
di deflagrazione dell’ordigno-mito non è insomma più vasta di un Mindfield, ossia il Campo mentale dove tutto brucia e si ricompone, all’insegna di una
partita che ha sentore di Eterno ritorno (“Evviva la squadra fuori casa del
Presente/ la squadra in casa del Passato) per poi archiviarsi come sogno nel sogno, meta-sogno.[2]
 |
| Ginsberg e Corso |
La metafora trionfa sopra il mondo. Compiendo n-volte il suo circuito virtuoso, essa produce senso al di là delle sterili opposizioni manichee. Feconda gli insiemi, i vasti alvei della memoria, trova convergenze deliranti (“coyote di vetta e luna”, “fu la vita a ficcargli un cucchiaio in bocca”), promuove l’everything included: rabbia ed euforia, prostrazione e autoesaltazione, veglia e sogno, il magico del quotidiano e il quotidiano del magico. Gregory rifiuta – nella vita e nell’arte – la contrapposizione degli estremi. Quali poi, e su quali assi ‘privilegiati’? Bello/brutto, alto/basso, stasi/movimento, bianco/nero? Che non sono a ben vedere cifre esistenziali, bensì poli di un’illusoria dialettica. Assai più redditizio – se si vuol cogliere l’Essere nella sua liquida, inesauribile polisemia – esercitare nei modi del jazz (vedi Requiem for “Bird” Parker o For Miles) l’arte del ‘tema con variazioni’, magari inghirlandate di anafore come negli antichi inni di lode. Giaculatorie alla Ginsberg, ma più distese e raffinatamente sofferte, anche se talvolta portate a una proliferazione immaginale estrema, ai limiti del fading. E così, in Gazoline (Benzina) del 1958, prorompe il Sole, significante e spugna potenziale del Tutto, archetipo di ogni antropomorfica bomba:
Il sole ha la forma di un dito curvo che accenna.
Il sole vortica cammina balla salta corre.
Il sole predilige palma agrumi polmoni tubercolosi.
Il sole ingoia il lago e le alpi Teliphicci ogni volta
che sorge.
Il sole non sa cosa vuol dire amare o odiare.
Il sole tutta la mia vita è sceso nel lago Teliphicci.
Oh foro costante dove ogni aldilà è pura Bisanzio.
Dove il “foro
costante” rimanda allo “spacco liquefatto” di Bomba: saturazione energetica, scoppio che apre varchi
e lascia che intorno si diffonda, col liquefarsi del senso, la pulviscolare,
impalpabile materia dell’altrove. Nella sua maestosità tragica, il Sole sembra
incedere fuggendo da se stesso, esporsi ingordo (“ingoia il lago… ogni volta
che sorge”) e sottrarsi (“è sceso nel lago”) come l’Essere heideggeriano, al
pari di ogni Macro-prodigio che seduca l’intelligenza umana. Per questo il Sole
è obliquità, “un dito curvo che accenna”, oracolarmente. Al fine di scongiurare la propria scomparsa,
ha bisogno di sentirsi nominato e rinominato, di farsi capoverso ad libitum, secondo il gioco subdolo
dell’anafora, regina dell’inno. Come pochi altri Corso ha cantato l’intrinseca
fragilità della Volontà di Potenza, che si nutre di ossimori tanto quanto
l’ottimismo imperiale americano. Nella semantica mitica del poeta newyorkese,
Bomba, Sole e Potere fanno un tutt’uno. Si legga qualche verso di Power (in The Happy Birthday of Death):
 |
| Ferlinghetti |
Il Potere è sottopotenziato
Il Potere è ciò che succede
Il Potere è senza corpo o spirito
Il Potere è tristemente fondamentale
Il Potere è raggiunto dalla Debolezza
La poesia, in
Corso, non si inchina alle schizomorfie del Logos, responsabili di ogni dogma
etico-gnoseologico. Preferisce ribellarsi agli infingimenti razioidi del sensus communis (la pacifica doxa occidentale nella variante USA), rifiuta decisamente di classificare i doni di Pandora
in base a criteri assiologici, moltiplica i suoi punti di fuga, adegua gli enunciati
a un’elastica ‘topologia’ del senso, godendo infine delle proprie
contraddizioni. Essa si spinge perfino, sul piano degli exempla, a sovvertire i valori comunemente attribuiti ai personaggi
mitologici, prendendo le difese di chi, tra loro, è decaduto o reietto,
foss’anche il più impopolare. A proposito del famigerato Polifemo, Gregory glosserà
in Mortal Infliction, Maledizione mortale:
Ulisse è morto
a quest’ora è morto
E quanto fu saggio
colui che accecò una creatura immortale?
In tal modo egli rivendica la massima libertà creativa, lasciando anche trapelare in varie occasioni
il personale attaccamento alle lezioni del romanticismo europeo più spigliato,
da Shelley a Rimbaud: “Whit a love a
madness for Shelley/ Chatterton
Rimbaud”, “con un amore un delirio per Shelley/ Chatterton Rimbaud”. In un
significativo testo della raccolta Herald
of the Autochtonic Spirit, Nunzio dello spirito autoctonio (1981), l’”autoctonia” che Corso
attribuisce a se stesso -vale a dire l’affermazione sincrona di indipendenza e istintualità
ctonia- comincia con un rito di svuotamento
dell’io dagli idoli metafisici ereditati dalla tradizione. Nel componimento, una
scherzosa pagina autobiografica intitolata The
Whole Mess… Almost, Tutta la baracca… o quasi, domina massicciamente il
verbo throwing out, buttar via.
Salii di corsa sei piani di scale
fino alla mia stanzetta ammobiliata
aprii la finestra
e cominciai a buttare via
le cose più importanti nella vita
Gli oggetti
della spoliazione intellettuale, debitamente personificati, sono la Verità, l’Amore,
le Virtù teologali, la Bellezza e, per finire, l’esistente-inesistente Morte. Non
si tratta di un puro esercizio di nichilismo,
perché il tentativo di autodafé ideologico è ostacolato almeno da una
delle grandi creazioni dello Spirito, la Bellezza. Assumendo il bello (anche se
dissonante) nelle proprie creazioni, il poeta non può ripudiarlo senza
smentirsi. E del resto l’aggressività
nei suoi confronti, intrisa com’è di freudiana Verneinung, appare piuttosto equivoca: “Non avendo l’intenzione di buttarla davvero/ feci di corsa le
scale/ arrivando appena in tempo per prenderla al volo”. Si salva infine, senza
però che l’autore lo confessi apertamente, l’Umorismo. Per quale motivo? Perché
gettarlo dalla finestra vorrebbe dire sbarazzarsi anche di questa e, per
sineddoche, dell’intera “baracca” della poesia: “Con l’Umorismo non potei far
altro che dire:/ Fuori dalla finestra con la finestra!”. Un gesto chiaramente assurdo, ma anche un
segnale a chi legge. L’Umorismo, infatti, va salvaguardato, in quanto ammortizzatore
delle pulsioni negative della mente e operatore indiscusso di catarsi. Difettando
di questo salutare jolly dello
spirito risulterebbe vano poetare. In
altra sede il poeta scriverà: “Vorrei che un umorismo mi salvasse dalla
filosofia dilettantesca”. E dall’umorismo al clownesco, come ben sapeva il
nostro Palazzeschi, il cammino è breve:
E perché ti dicono sii un uomo, non un pagliaccio?
E cosa vuol dire essere un uomo?
…..
Così facile congelare il proprio umorismo
- per far vento al sole.
(Clown, in The Happy Birthday of Death)
 |
| Corso e Ginsberg |
A cinque anni
vidi Dio in cielo
Stavo attraversando un ponte
per comprare del sale
e quando alzai gli occhi
vidi un uomo grosso
con capelli e barba bianchi
seduto a una scrivania di nuvole
con sopra due libri giganteschi
uno era nero
l’altro bianco
Provvederà un
confessore -depositario della Legge- a forzare l’ingenuo contrasto cromatico
nero/bianco dentro le austere caselle della moralizzazione: il libro bianco non
può che registrare il bene compiuto, e quello nero il male. Semplice, no? E
magari grazie a un simbolismo così rudimentale -fatto per tranquillizzare le
anime belle- l’agire di Dio acquista senso. Ma con quali conseguenze sulla
poesia?
La poesia, per il Corso smaliziato degli Unpublished Poems, è quell’anello magico che ci immunizza non tanto
dal Dio vagheggiato nei ‘paradisi infantili’ -ispiratore di fabulae e miti- quanto dal Dio della teologia dogmatica (“io non aderii ad arcane
trinità”) e dell’esegesi ecclesiale. Si
veda il componimento Fire Record- No
Alarm, Rapporto incendi- Nessun allarme:
sto solo
davanti all’universo
libero da Dio
padre dei miei figli
e sul mio dito
l’anello della poesia.
 |
| Corso |
Vidi
Lei ed esclamai: “Ah Signora Dio!”
Mi fece
segno di accomodarmi su un cuscino di velluto dorato
Mi
sedetti – e ai Suoi piedi di cigno stavano tre:
Ganesha,
Thoth, Ermes,
e su
una pipa della cenere scheletrica di Poe
soffiarono
un diamante infuocato di hash di Balbeck
“Oh
affascinante poeta-stallone che adoro
mio
Nunzio Corso Gregorio
(Columbia U Poesy Reading – 1975)
.jpg) |
| Keruac |
Nella raccolta in questione (The Happy Birthday of Death, Il buon
compleanno della morte, 1960) la morte
può perfino coincidere, grazie a un’astuta, beffarda sterzata metaforica, con
la caduta dei capelli (vedi Hair).
Quella calvizie che, fin dal mito di Sansone (Samson bear with me!”, “Sansone abbi indulgenza con me!”) simboleggia
la castrazione, nel senso della scomparsa di particolari attributi irrinunciabili
per il maschio (pensiamo ai ‘capelloni’ in voga nell’èra-beatniks):
Cosa serve che io cammini per Fifth Avenue
o vada a letto per l’intervallo
o sosti davanti a scuole femminili
quando non mi rimane niente da mostrare.
Ma è il cranio in sé, custode del Mindfield
(campo mentale) e dunque della
quintessenza umana, il cranio segnato per principio dal chiasmo morte/vita, a doversi
salvare e salire in Paradiso, come si evince da Transformation & Escape, Trasformazione ed evasione: “Il
cranio!/ “Il mio cranio!/ Il solo cranio in paradiso!”. E se la mente pensante fosse
innanzitutto la fucina dell’humour e
del clownesco, le virtù più idonee a rivitalizzare il mondo? A maggior ragione la creatura che le incarna
per eccellenza, il pagliaccio, meriterebbe la salvezza: “Se il pagliaccio
morisse/ il mese di agosto sarebbe appesantito/ di sacchi di frumento rancido”
(Clown). Il pagliaccio, icona del poeta
e frequentatore dei luoghi più rischiosi e segreti ha naturalmente a che fare
con la Morte (“È per la Morte che rendi nero profitto?”), ma proprio per questo
ne esce immunizzato. La scimmiesca
Morte, grottesca acrobata, non è del resto che l’immagine speculare del
clown-poeta, la sua irriverente controfigura:
La Morte, come la coda di una scimmia,
scende avvolta a spirale su un palo che sale,
che continua a salire.
La vera morte
inconsolabile, quella che neppure una risata clownesca consolerebbe, è per
Corso la morte dell’infanzia. Perché con
il venir meno di questa età, con il cristallizzarsi sul nostro volto
dell’adulta maschera razioide, sono gli
stessi germi del poetare-fantasticare-illudere a dissolversi. Ma se il bambino
è cosciente della propria supremazia mentre scruta la desolazione intellettuale
della vecchiaia, è capace all’istante di svelenirne la vista grazie alla pietas generata dalla profondità dei
suoi occhi. L’infanzia sa davvero sbugiardare diffusi truismi, ‘andare oltre’:
Il bambino
vede
la
stupidità della vecchiaia
in un
sapientone pigro –
la
profondità cosciente degli occhi del bambino
innocentemente
disprezza quella vista
 |
| Tomba di Gregory Corso |
Il
bambino tremò, cadde,
e si rialzò
barcollando,
io urlai il suo nome!
E una furia
di madri e padri
gli
affondarono i denti nel cervello.
Invocai
gli angeli della mia generazione
sui
tetti, nei vicoli,
sotto
l’immondizia e le pietre,
io urlai il nome! e
corsero da me in processione
e
rosicchiarono le ossa del bambino.
Io urlai il nome: Bellezza
Bellezza
Bellezza Bellezza
*
Gregory Corso (1930- 2001). Incarcerato nell’adolescenza a più riprese
per ricettazione e rapina. Redento in seguito, ma forse non del tutto, dalla
Musa poetica. Uomo di strada e pensatore sottile, ilare e malinconico, testimone
tra i più significativi della vita statunitense durante i ruggenti anni
sessanta-settanta, all’epoca della guerra in Vietnam e della contestazione
studentesca, delle morti per overdose e della lotta per l’emancipazione degli
afroamericani, immortalata dal jazz. Ma soprattutto poeta immaginifico e nel
contempo straordinario osservatore della realtà. Uno dei pilastri della beat generation. Così lo ricorda l’amico Allen Ginsberg:
“Corso è un Poeta dei poeti, il suo verso puro velluto, prossimo a John
Keats per il nostro tempo, squisitamente addentro ai modi della Musa. È stato e
sarà sempre un poeta caro a molti, risvegliatore di giovani, indovinello e
piacere per i più anziani e sofisticati bibliofili, “Immortale” quanto si può
essere immortali, Capitan Poesia che incarna la rivoluzione dello Spirito, la
sua “poesia come l’opposto dell’ipocrisia”, un solitario, ridicolmente ignorato
dai patri allori, divino Poeta Maledetto, poeta fuorilegge fratello di Villon e
Rimbaud la cui fama selvaggia si estende da decenni per tutto il globo dalla
Francia alla Cina, poeta del Mondo. (marzo 1989)
 |
| Ginsberg, Burrowsand, Corso |
Note
1.V. Amoruso,
La letteratura beat americana,
Laterza, Bari, 1969, p.191.
2.Minfield:
New and Selected Poems, così
s’intitola l’autoantologia pubblicata, grazie a finanziamenti pubblici, nel
1989. L’edizione italiana, da cui vengono citati i testi, è uscita a cura di
Massimo Bacigalupo per le Edizioni Newton (2007).
Roma città aperta di Roberto Rossellini, Italia, 1945
di Fiorenza Melani
La storia che vi voglio raccontare è quella
della nascita di un capolavoro inaspettato. Di un fiore che, contro ogni
aspettativa, germoglia nel deserto del dopoguerra. Questa storia inizia nel
1944, subito dopo la liberazione di Roma da parte delle truppe alleate. Sergio
Amidei, autore del soggetto e cosceneggiatore di “Roma città aperta”, propone a Roberto Rossellini di realizzare un
film che racconti l’occupazione tedesca di Roma con storie liberamente ispirate
a personaggi della resistenza. Storie che gli sono state raccontate
direttamente da partigiani con i quali era in contatto o che ha letto sulla
stampa clandestina. Roberto Rossellini accetta immediatamente, ed è grazie alla
sua presenza di autore già affermato che il progetto può cominciare a prendere
corpo.
Rossellini coinvolge Federico Fellini, che allora non era
ancora regista cinematografico ma aveva firmato diverse sceneggiature di film
popolari e aveva un negozio di caricaturista a Roma. Da Fellini ottiene la
collaborazione nella stesura della sceneggiatura, che viene quasi interamente
scritta nella sua casa romana, e l’intercessione presso l’amico Aldo Fabrizi,
che Rossellini vuole fortemente come protagonista del film. Non sappiamo però quanto
Rossellini sia stato fedele alla sceneggiatura originale, ormai perduta, perché
il regista crede nell’influenza del luogo sull’ispirazione, nell’importanza
dell’interazione tra gli attori all’interno della scena e usa quindi
abbondantemente l’improvvisazione a partire da un canovaccio.
Il film nasce tra le macerie della guerra, ma in un clima di
grande speranza e tensione verso il futuro. Nel ’44 dopo la liberazione di Roma
tutto era distrutto. L’industria cinematografica italiana era stata spazzata via
dalla guerra. Cinecittà, uno dei simboli del fascismo per gli americani, era
stata trasformata dalle truppe alleate in un campo profughi. È in questo clima,
e grazie all’enorme libertà che la mancanza di una produzione strutturata
comporta, che può nascere “Roma città
aperta”. Così scrive Rossellini nella sua autobiografia: “alla fine
della guerra ci ritrovammo come in un deserto. Abbiamo ricominciato da zero,
senza fare della poesia sul dolore che avevamo sofferto”.
La lavorazione del film inizia a gennaio e termina a giugno
del 1945. È una lavorazione travagliata, che procede a singhiozzo tra ostacoli
di ogni genere. Manca la pellicola e Rossellini è costretto ad utilizzare
pellicola di risulta, avanzi di magazzino oppure quel che resta agli americani
dopo aver girato le attualità di guerra. Non ha il positivo per vedere i
giornalieri e controllare così le riprese. Gira senza sonoro per ridurre le
spese (gli attori doppieranno se stessi a montaggio completo) e durante la
notte, in uno studio improvvisato in via degli Avignonesi n.30, perché di
giorno non c’è la corrente elettrica. I finanziamenti non sono sufficienti. La
presenza di Rossellini garantisce il supporto di alcuni mecenati, ma le cifre
sono modeste e i soldi finiscono in fretta. Rossellini vende l’arredamento di
casa per terminare il film, compreso il letto su cui dorme.
Con notevole spirito di avventura da parte degli attori e di
tutta la troupe “Roma città aperta” viene
terminato e a settembre del ’45 presentato a Roma in un piccolo festival. L’accoglienza
da parte della critica è tiepida, diventerà entusiasta soltanto a fronte dei riconoscimenti
internazionali. Nel 1946 il film riceve il Gran Premio della Giuria al Festival
di Cannes e nello stesso anno il Nastro d’Argento per la Miglior Regia e per la
Miglior Attrice Non Protagonista: Anna Magnani. Grazie a “Roma città aperta” viene riconosciuto il talento drammatico di Anna
Magnani, che diventa una vera e proprio icona della rappresentazione
cinematografica della resistenza e viene lanciata in ambito internazionale.
Al contrario della critica, il pubblico lo ama fin dal
principio: è il film italiano più visto nella stagione ’45-’46. Il suo valore è
affrontare senza reticenze e falsi pudori ciò che le persone comuni avevano
vissuto, mettendo in scena una realtà raccontata senza orpelli, a levare
come la scultura di Michelangelo.
Con “Roma città aperta”
Roberto Rossellini dà inizio alla sua trilogia della guerra (che proseguirà con
i film “Paisà” e “Germania Anno Zero”) ma soprattutto fonda il neorealismo, una
delle correnti più fulgide della cinematografia del nostro Paese. Tra il 1945 e
il 1946 molti autori italiani sentono l’urgenza di narrare storie in modo
nuovo, affondando le radici nella realtà, guardando al passato recente o
all’attualità del dopoguerra (tra i nomi più importanti: Cesare Zavattini,
Vittorio De Sica, Luigi Zampa). È improprio parlare di una scuola, perché ogni
autore interpretò il neorealismo in modo personale, ma fu indubbiamente una
corrente di pensiero che rappresentava una nuova etica ed estetica
cinematografica, nella quale utilizzare il cinema fuori dagli schemi
spettacolari tradizionali come testimone di un’epoca. Immagine e messa in scena
erano minimali, dovevano avvicinarsi alla realtà, liberarsi dalle sovrastrutture
per andare al cuore dell’umanità. Un’attenzione all’uomo e alle sfumature del
suo essere che può essere considerata un vero e proprio umanesimo
cinematografico.
Rossellini ha sempre rifiutato l’etichetta di neorealista
perché non accettava di essere vincolato da schemi contenutistici e formali
rigidi e ripetitivi. Per lui il neorealismo era soprattutto una posizione
morale: guardare alla realtà nel suo farsi, senza giudizio, partendo da una
posizione di estremo interesse e fiducia nei confronti dell’essere umano. Così
scrive nella sua autobiografia: “Il realismo è una maggiore curiosità per
gli individui, rendersi conto della realtà in modo spietatamente concreto. Una
sincera necessità di vedere con umiltà gli uomini quali sono, senza ricorrere
allo stratagemma di inventare lo straordinario. Oggetto vivo del film
realistico è il mondo, non la storia, non il racconto. È il film che pone e si
pone dei problemi”.
E se le storie narrate sono gesta eroiche insieme a piccoli
intrighi da feuilleton, da romanzo di
serie B, è perché così è l’esistenza stessa, perché “i grandi gesti o i
grandi fatti si producono nello stesso modo dei piccoli fatti normali della
vita”.
POETI
 |
| Lidia Sella |
Buon viaggio
nell'imbuto degli anni
sui tornanti della vita
lungo la galleria dei sogni.
Buon viaggio
attraverso i campi
dello spazio-tempo
dentro gli sguardi che incroceremo
fra le isole d’Amore
fino alle spiagge
dove l'oceano del pensiero
depone conchiglie di parole.
Buon viaggio a chi buca
le nubi della mediocrità
e alla musica antica
che veleggia
verso galassie lontane.
Buon viaggio
nelle profondità della morte
e sulle contrade future
che un giorno sorvoleremo
da semplici scaglie di energia.
Buon viaggio a coloro che esplorano
le infinite dimensioni dello spirito
e a tutti quelli che navigano
sulle onde della gioia
mentre ancora posseggono un corpo
e antenne per vibrare
di piacere e bellezza.
Lidia Sella
Muse
Mary-Lou
i do not take care of you
because you are old
and in need of care
Mary-Lou
i do not take care of you
because it is my duty
as your husband
Mary-Lou
i do not take care of you
because others would dump you
in an istant
in a nursing home
Mary-Lou
i take care of you
because
love is the greatest thing in the world
i take care of you
because
you always made my soul sing
i take care of you Mary-Lou
because you are the great poem
in my life.
Don Burness
Rindge, USA, 8 september 2012
Rindge, USA, 8 september 2012
Mary-Lou
mi prendo cura di te
non perché sei vecchia
e hai bisogno di cure
Mary-Lou
mi prendo cura di te
non perché è il mio dovere
di marito
Mary-Lou
mi prendo cura di te
non perché altri ti avrebbero scaricata
in un attimo
in una casa di cura
Mary-Lou
mi prendo cura di te
perché
l'amore è la cosa più bella del mondo
mi prendo cura di te
perché
hai sempre fatto cantare la mia anima
mi prendo cura di te Mary-Lou
perché tu sei il grande poema
nella mia vita.
Don Burness
Rindge, USA, 8 settembre 2012
Rindge, USA, 8 settembre 2012
Traduzione di Max Luciani
L’autobiografismo
metafisico di Clemente Rebora
di
Giovanni Bianchi
Il tormento dei versi
esiste
Tornare
ai poeti serve. Non so come, ma serve al pensiero e alla vita. Per
quell’ineliminabile istinto pasquale che la poesia porta inevitabilmente in sé:
più vertiginosamente profonda della filosofia, più realistica della politica e
delle sue astuzie machiavelliche. Potente perché gratuita. Incontenibile perché
timida e sommessa. Luogo della tragedia vera e di tutti i funambolismi
possibili: vivente di ossimori continui e ripetuti; scrive infatti per
frammenti un discorso infinito e interminabile. Vela senza la barca.
Per
questo sono tornato a quel Clemente Rebora che non ho mai dismesso. (Prima e
dopo la sua conversione.) Il più frequentato e scalpellato tra i poeti del mio
desco da ciabattino. In un andamento sinfonico al quale abbandonarmi, una volta
tanto senza note a piè di pagina, in un furto non dissimulato e continuo di
pensieri e citazioni altrui. Quasi che la lettura si arrabbi con la critica e
la dileggi e che un impulso poetico sgangherato (il mio) s'anneghi nel mare
vasto di un rigore vigile e non di rado autofustigatore.
Critica
dei tempi ed autocritica, controcorrente e in anticipo rispetto alle odierne
generazioni senza storia e senza memoria –barbare di una verginità lieve,
impalpabile e orrenda (il ballo di Salomè che decapita il Battista)– per le
quali l'autocritica pare declassata a critica delle auto… Nella stagione in cui
non è più la politica a farsi musica, ma la musica a farsi politica. Gustav
Klimt e il suo gruppo della Secessione
viennese potrebbero ben commentare: "Al tempo la sua arte, all'arte la sua
libertà".
Dunque
Rebora, da un luogo dove insiste esausto il pensare politica, là dove Cristo ha ragione e Machiavelli vince:
il verso che prediligo.
Vale
la pena ricordare, per scansar equivoci, il principio di Sant'Ambrogio che
Lazzati amava ripetere: "Cercare sempre cose nuove, conservando il meglio
di quelle antiche". E potrei anche provare
lo slogan: Viva la gioventù! Abbasso il giovanilismo. Tutto preso, lo ammetto nella civil asfissìa, architettando il
diavol suo scompiglio, preso all'artiglio dell’io.
 |
| Clemente Rebora |
L'artiglio dell’io uccide
Perché
l'artiglio dell'io uccide, il poeta cerca in tutto l'esistere un varco e una
sortita: quel "solco" che tiene insieme nella metafora un rimpianto
contadino che si sporge senza remore nella vertigine metropolitana di una
Milano in trasformazione. Luogo poetico ed epicentro di un sisma interiore la
minuscola mansarda di via Tadino, la
topière dove condivide con la pianista russa Lidya Natus un amore
smisurato, ma destinato a finire nell'abbandono.
In
campo aperto lo coglie la grande guerra, in prima linea sul fronte goriziano,
dove verso Natale l'esplosione ravvicinata di un proiettile d'artiglieria gli
provoca un grave trauma nervoso. E prima di venire "riformato", nel
nosocomio di Reggio Emilia, un medico psichiatra gli diagnosticherà una
"mania dell'eterno".
È
dunque la biografia il materiale non al tutto grezzo dal quale estrarre i versi
di una poesia consapevolissima e che si esercita anche nelle forme esteriori
più minute in una composizione di luogo che vede nell’abbaino di via Tadino gli
appunti stesi lungo i fili solitamente destinati all'appendimento degli abiti.
Sono le tessere che si tengono, e si possono tenere, in autobiografia e
metafisica. La definizione è di Contini ed è azzeccata dal momento che il poeta
è portatore di un "io largo", non narcisistico ma collettivo. Nel
caso di Rebora addirittura "metafisico". E vedremo perché.
Prendo
le mosse da un ricordo. Ero all'aeroporto di Zurigo in partenza per il Corno
d'Africa. E mi era capitata tra le mani una intervista a Carlo Bo sulla
"Stampa" di Torino dove, allora, Carlo Bo, sottoponendosi a una
specie di gioco della torre, affermava che nel terzo millennio in valigia
avrebbe forse dimenticato Thomas Mann, ma avrebbe senz'altro riposto Clemente
Rebora e l'ultimo Turoldo...
L’io
poetico infatti non è narcisistico perché inaugura uno spazio pubblico: quello
nel quale Antonio Prete fa campeggiare Giacomo Leopardi, ma anche Shelling e il
suo ab-solutus, l’agorà cui fa
riferimento Zigmunt Bauman in La
solitudine del cittadino globale: uno "spazio né privato né pubblico,
ma più esattamente privato e pubblico al tempo stesso". Dove alla forza mite
del Poeta corrisponde l'insignificanza del Politico. E dove l'unica
cittadinanza possibile è il consumo, che produce spazzatura. È per questo che ritornano le domande: perché autobiografismo? E in che senso metafisico?
Quanto
all'autobiografismo lettori, critici e analisti concordano nel ritenere Rebora
riservato e modernissimamente "petroso". Non è e non si atteggia a
Vate. Nessuno infatti è indotto leggendolo a pensare al Carducci, proprio per
questo magniloquente, sapendo di stare in cattedra rispetto a una Nazione
attenta. Non pensiamo neppure al Giacomo Leopardi dei Canti che in All’Italia
scrive:
Nessun pugna per te? non ti
difende
Nessun de’ tuoi? L’armi,
qua l’armi: io solo
Combatterò, procomberò sol
io.
Dammi, o ciel, che sia foco
Agl’italici petti il sangue
mio.
Non
penso neppure al Leopardi delle Operette
Morali o dello Zibaldone dei Pensieri.
Non penso all'Ezra Pound dei Pisan Cantos
e neppure all‘Allen Ginsberg di "Urlo".
Non penso neppure a Bob Dylan... Clemente Rebora non ha programmi da esibire.
Orizzonti da ostinatamente proporre. Per questo la vita, nella sua densità
anche di vita interiore, è testimonianza che si versa nella pagina:
autobiografia senza ostentazione. E alla timidezza dell'animo e alla
riservatezza della vita interiore corrisponde la dura scorza di una parola
lontana –starei per dire ostile– ad ogni petrarchismo:
Al tornar nelle genti io
son sconfitto;
Ripiglio i colpi, gemo
sotto il basto:
Cristo ha ragione e
Machiavelli vince.
Appunto.
Una denuncia dura eppure non estranea alla speranza:
Per aguzzar lontano,
Al nostro polmon sano
Anche poc’aria basta
Per respirar profondo,
Se turbini con Dio
La volontà nutrita
Di ricrear nel mondo
Questa angoscia gioita,
Quest'impeto fecondo,
Questo veggente oblio:
Questa vita che è vita.
In che senso metafisico?
Lontano
dai petrarchismi, ho detto. Non pregiudizialmente avverso agli
sperimentalismi... L'uomo interiore che, secondo l'ammonimento dell'apostolo
Paolo, giudica tutte le cose. (Prima e dopo la conversione). Aiutano a
comprendere e a introdursi nell'universo reboriano già da subito quei Frammenti Lirici pubblicati nelle
edizioni della "Voce" di
Prezzolini
–l'ultima
presenza pensosa di una destra italiana altrimenti introvabile– così come i
versi e le riflessioni successivi ai voti religiosi presi come rosminiano nella
maturità.
Morto
nel 1957 a Stresa dopo lunga malattia, per la quale Eugenio montale scrisse:
"È un conforto pensare che il calvario dei suoi ultimi anni –la sua
distruzione fisica– sia stato per lui, probabilmente, la parte più inebriante
del suo Curriculum Vitae". La
ragione del resto è dichiarata:
Quando morir mi parve unico
scampo,
Varco d’aria al respiro a
me fu il canto:
A verità condusse poesia.
La
poesia del viandante inquieto e del poeta errante. Perché preminente in Rebora
è l'urgenza di una strada che conduca lontano dall'andamento generale delle
cose e quindi dalla loro insopportabile quotidianità. Il non essere sedentario,
il rifiutare fin da ragazzo di salire sui marciapiedi, raduna insieme l’ansia
della ricerca, una istintiva indipendenza, la difficile definizione del
traguardo. E se i Frammenti Lirici
nascono nella casa paterna di viale Venezia 12, non è casuale che vengano
definitivamente composti nell’angusta mansarda di via Tadino, a stretto
contatto con i tetti.
Anche
qui un'ansia perfino nevrotica di scorgere il perché che sta all'origine dei
versi così come alla ricerca della meta cui i versi tendono. E come si addice a
un autentico divoratore d'assoluto, la costante della poesia è il contenuto,
una densità del pensiero oltre se stesso, i cui confini sono costituiti da una
vigile disperazione e da una sorprendente disciplina apocalittica. Il tutto
giocato ai limiti dell'autodistruzione, che quasi si compiace dei funghi
velenosi deliberatamente mangiati, e alla tendenza a sfidare la tempesta.
E
forse, misurato con il senno di poi, il suo non è istinto apocalittico, ma una
tensione spasmodica che progressivamente sostituisce all'impazienza la fede.
Testardo e perseverante. Una solitudine da progressivamente popolare, quasi che
dalla solitudine stessa nascesse un'istanza di agorà. Come se il paradosso e
l'ossimoro fossero la cifra esistenziale prima del vivere che della pagina:
La verità lontano in pigro
scorno;
E ritorno, uguale ritorno
Dell'indifferente vita,
Mentr’eccheggia la via
Consueti fragori e nelle
corti
S'amplian faccende in
conosciute voci,
E bello intorno il mondo,
par dileggio
All’inarrivabile gloria
Al piacer che non so,
E immemore di me epico arméggio
Verso conquiste ch'io non
griderò.
È
dunque lo "sgomento di vivere" l'inizio dell'approccio metafisico
all'esistenza e al versificare:
Mentre la terra gli chiede
il suo verbo
E appassionata nel volere
acerbo
Paga col sangue, sola, la
sua fede.
Né
serve mutare la location da Milano, a Stresa, a Rovereto. Perché il dramma
dell'io non è una tentazione individualistica. O almeno non è soltanto questo.
O almeno non lo è per Rebora:
Ai nervi delle strade,
Con àliti e gorghi
Con guizzi e clangori
Ebbra l’ora si stordiva;
Ebbra l’ora si smarriva
Nel senso delle voci
Di giovani a diporto,
Di giovani cercanti
Dal pensiero la vita.
Dove
la fatica di vivere non smarrisce il balzo giovanile, pur sapendone tutta la
fatica e il rischio che corre di disperdersi in labirinti successivi. Dove
importante è per la Giulietta e il Romeo reboriani non demordere.
 |
| Clemente Rebora |
Prete rosminiano
Ricorda
il fratello: "È fermo il treno che torna da Lourdes dove Clemente era
stato. Non parlo del treno spettrale e delle ombre che contiene. L'unico vivo
tra quelle apparenze è lui che scende a salutare alcune persone che sono venute
a incontrarlo".
Perché
Clemente ha aggiunto un altro capitolo alla sua storia: l'assistenza agli
esseri che si sentono casi del dolore e chiedono la cura degli altri. Un altro
pezzo dell'itinerario dove si svolge la vicenda tormentata dell'io. Dove il non detto è che
l'individualismo è l'assenza della gioia e perfino del dolore: il vivere
superficialmente fuori da se stessi in un io fittizio condanna al vuoto della
superficialità, e all'assenza conseguente di una vocazione umana. Nessun
dubbio: meglio il tormento del vuoto.
In
fondo è il prolungarsi della ricerca iniziata nell’abbaino di via Torino dove
Clemente sostava in cucina davanti un mucchio di libri e di carta stracciata.
Purtroppo quei documenti e quelle lettere andranno distrutti, anche se il poeta
avrà modo di pentirsene sul letto della malattia: "Non appartenevano a me
quelle cose... non avrei dovuto".
Ma
intanto si è consumato il passaggio dai Canti
Anonimi al Curriculum Vitae.
Il
fulcro dei Canti è indubbiamente
costituito da Al tempo che la vita era
inesplosa, probabilmente la più compiuta e riuscita fra le liriche del
poeta, che cede il passo per notorietà a Dall’immagine
tesa, certamente la più giustamente famosa.
Mentre
ancora ci sconvolge la tragica densità di Viatico:
O ferito laggiù nel valloncello,
Tanto invocasti
Se tre compagni interi
Cadder per te che quasi più
non eri,
Tra melma e sangue
Tronco senza gambe
E il tuo lamento ancora,
...................
Nella demenza che non sa
impazzire,
Mentre sosta il momento,
Il sonno sul cervello,
Lasciaci in silenzio –
Grazie, fratello.
In
proposito è stato osservato che questa lirica terribile è tale che "anche
il fante Ungaretti rischia di apparirci un letterato compiaciuto".
Né
mancano passaggi obbligati di lettura sui quali giustamente la critica invita a
soffermarsi. Di quanti exergo mi sono appropriato, a partire dal primo
frammento che per me ha costituito una chiave di interpretazione sul confine
che separa ed unisce la politica e la storia:
Perde, chi scruta,
L'irrevocabil presente.
Perché
devo ammettere che Clemente Rebora ha costituito uno dei punti nodali di
sintesi – ma anche di analisi – del mio ostinato frequentare il pensiero
cattolico-democratico, pensandolo non riducibile a semplice residuo paretiano.
Dal momento che anche gli aspetti più scopertamente elegiaci e rammemoranti
costituiscono in Rebora elemento di scavo analitico e materiali da costruzione
per un ulteriore del quale egli stesso legittimamente ignora la sostanza ed il
limite:
Al tempo che la vita era
inesplosa
E l'amor mi pareva umana
cosa,
Fanciullo a te venivo
O Carlo contadino.
La
sequenza è inusitatamente lunga all'interno dei Canti Anonimi (1922). Ma anche l'andamento idilliaco e il
concedersi al sentimento bucolico costituiscono materiali per la ricostruzione
di un mondo, quasi una ristrutturazione, capace di indicare i ritmi e le strade
di un altro mondo nuovo e possibile.
La
catastrofe e l'apocalisse si tengono infatti nel credente Rebora in ordine alla
riedificazione di un mondo non pacificato, ma capace di tendere all'oltre da sé.
Né è casuale che i Canti Anonimi si
chiudano con i versi celebratissimi che aprono l'ultima lirica:
Dall'immagine tesa
Vigilo l'istante
Con imminenza di attesa –
E non aspetto nessuno.
Così
il ritmo della campagna può pure tornare in città, ma il tempo agreste, pur
conservando la sua struggente tenerezza, non riesce ad apparirci con
l'innocenza che gli fu propria, perché tutto i tempi e le sincopi metropolitane
hanno travolto e stravolto e comunque riassunto nella propria dismisura.
Rebora
può militare cristianamente a Rovereto e svernare rosminianamente a Stresa, ma
lo stigma milanese è destinato a non abbandonarlo mai: la mansarda condivisa in
via Tadino con Lydia Natus e gli appunti appesi ai fili tirati sotto il basso
soffitto al posto dei panni lavati restano un eden indelebile che il fracasso
della metropoli non riesce a cancellare…
La
sua mistica è destinata a restare metropolitana: per questo incapace di
chiudersi nei facili devozionismi, che rappresentano il succedaneo freudiano di
certi pavidi devoti. Chi ha scritto alcuni decenni prima Viatico non può ritornare a un'infanzia della religione falsa
perché incontaminata.
L'infanzia
evangelica cui Clemente Rebora accede negli ultimi anni dell'esistenza da
religioso è conquista che viene dopo la nevrosi del vivere moderno e delle sue
inconciliabili aporie. La memoria, qualunque essa sia, non può essere infatti
archiviata. Scrive dunque il 24 dicembre 1955:
e mentre stai e senza sorte
certa,
umiliato, e come maledetto,
Dio in misericordia ti
conferma.
 |
| G. Raboni grande estimatore di Rebora |
 |
| Patrizia Valduga: Rebora è fra i suoi poeti preferiti |
Tornare
a Rebora non acquieta né rappacifica. La postmodernità ha provveduto nel frattempo
a sostituire New Age ai tradizionali
lenitivi della religione. Già, nel frattempo... Quante cose dopo Rebora e senza
Rebora, che –come scrisse di lui Giorgio Caproni sulla "Fiera Letteraria"
del 2 dicembre 1956– "la parola invece di idoleggiarla ha preferito
prenderla risolutamente per il collo". I suoi versi infatti –ha ragione
Giovanni Raboni– colpiscono "come una sassata, come un meteorite scagliato
dallo spazio".
Lo
stile aspro e pulito (sempre pensoso, mai mellifluo) di Rebora deve essere
ancora rifrequentato e studiato; e
all'impresa dovrebbe servire la lettura dei diari, ancora inediti e custoditi
nell'Archivio Rosminiano di Stresa.
Rebora
è una miniera nella quale ancora troppo pochi minatori amici della profondità
hanno avuto il coraggio di infilarsi. Anche perché agli orafi del bello stile
può fare spavento la citazione abusata che a
verità condusse poesia.
Uno
che ha avuto la capacità di chiamare a raccolta le sue antiche risorse
espressive riuscendo ad attualizzarle, "come Poliziano faceva con il
latino dei classici". Uno che ha saputo coniugare la rapidità del flash
con la ricerca più ardua del Verbo, pur così mischiato alle nostre storie
comuni. Uno che prima di un Papa durato pochissimo era riuscito a chiamare mamma anche Dio. Uno che nella civil asfissìa ha osato coniare
l'espressione angoscia gioita.
Una
"posizione assoluta" la sua. Probabilmente per questo senza seguaci
ed imitatori. Chi si pone più di fronte alla quotidianità come divoratore
d'assoluto?
Come
per Simone Weil si può nel suo caso parlare di "annientamento
deciso". Geni vertiginosi ed esistenze sul confine, dove probabilmente non
è casuale elemento comune l'attenzione all'altro, fino a risultare spasmodica.
Non interessati all'equilibrio dell'essere, quanto alla sua vertigine. Là dove
l'intelligenza è obbligata a farsi poesia, indipendentemente dalle convenzioni
vigenti.
LETTURE
Un giorno mia nipote Nelly, intenta a ripescare in una vecchia scatola, rimasta dall’alluvione, foto d’epoca di parenti e amici, rimase sorpresa. Disse a mamy:

LA
BAMBOLA CHE NON C’È PIÙ
di Lisa Albertini
Un giorno mia nipote Nelly, intenta a ripescare in una vecchia scatola, rimasta dall’alluvione, foto d’epoca di parenti e amici, rimase sorpresa. Disse a mamy:
“E questa chi è?”,
alludendo all’immagine di una foto sbiadita, con lo sfondo verdastro e un ponte
in lontananza. Sembrava un fiume in città.
Mamy la guardò di
sfuggita. La figura in primo piano era femminile: capelli scuri a caschetto,
gonna gonfia a balze chiare e sospese, scarpine cenerentola. Appariva piccola e
minuta.
“Cos’è, vorrai dire!”,
rise mamy. “Bambole come questa bellissime, di porcellana, si trovavano sui
banchi delle fiere nei paesi, il giorno della lotteria. Ed erano così belle che
qualcuno, ogni tanto, le fotografava”.
“Ma qui dietro c’è una
data ed anche un nome”, replicò Nelly, “non può essere una bambola”. E lesse
alcune lettere sbiadite e dei numeri.
“Ofelia
millenovecentoquarantacinque”.
Il mattino dopo, solo
in negozio, mi trovai a sbirciare tra le statuine esposte in porcellana, lo
sguardo rivolto fuori, alla strada dal traffico intenso, continuo. Le mie
vetrine erano poste ad angolo tra le due vie. Verso l’altra, lunga e stretta ma
tranquilla, avevo l’ingresso.
Tra i passanti, pochi
per la verità, vidi una signora, inquadrata dalla vetrina.
Caschetto di capelli
neri con frangia a taglio francese, camminava a rilento. Sembrava
pavoneggiarsi, con discrezione, nell’abito bianco. La gonna gonfia, al
ginocchio, pareva sollevata da due o tre sottogonne a balze, con cappe
disegnate in pizzo; il corpino, attillato, si disegnava sotto un golfino nero,
mignon; in fondo, brillavano due scarpine a cenerentola.
Mi chiesi chi fosse
mai. Sembrava fuori tempo e fuori età, giacché aveva senza dubbio superato i
sessanta, ma vestiva come una bambola d’epoca e si muoveva come una
quindicenne.
‘Quindici anni... una bambola’. L’interferenza attraversò i
miei pensieri: di quelle con cui giocava nonna e che mia madre raccontava di
criticare, quand’era quindicenne. Diceva: “Le bambole di porcellana! Ma come
facevano a giocarci? Nemmeno si muovevano, erano pesanti, lo sguardo fisso. .
.bellissime, certo, ma solo quello non basta.”
Guardai oltre il vetro
quella signora. Le bambole non si muovevano, per l’appunto, ma lei sì. Non si
capiva, dall’espressione serenamente onirica, se fosse felice o lo fosse stata.
Suggeriva l’idea di un tempo trascorso, dove nulla era lasciato al caso: segreteria
condotta alla perfezione o elegante casa signorile, o ancora laboratorio di
ricami da condurre in guanti bianchi. . .
Risi delle mie
fantasie. Sentii la porta, all’estrema sinistra oltre la vetrina, suonare.
La signora entrò
graziosa, sorridente, chiudendo in mano un ventaglio spagnolo, nero a fiori.
Chiese il prezzo di ‘Mimì’, la ballerina alta non più di dieci centimetri con
la gonna inamidata, di ceramica bianca. La prese in mano e si mostrò
soddisfatta.
“Grazie, è proprio
bella!”, disse.
“Le piacciono le
ballerine?”, chiesi sbirciando Mimì e il vestito della cliente, finché
incartavo la statuina.
“Non tanto le
ballerine, ma le bambole vestite da ballerina”, disse, mentre riponeva la
scatolina nella borsetta di paglia viennese, dal manico d’osso.
“Mi ricordano quelle di
casa, in soffitta.”
La guardavo interrogativo,
senza parlare. Cercavo di ricordare dove e quando l’avessi vista, forse a un
concerto in piazza, la scorsa estate, o a teatro d’inverno in balconata, o
forse somigliava al manichino di un negozio, con quella gonna gonfia a godet e
il corsetto attillato, che finiva diritto sopra al seno.
Anche finché parlava,
gestiva e si muoveva un po’ rigida, come se qualcuno le orientasse, a destra e
a sinistra, i fili da marionetta. Quando sorrideva si sporgeva in avanti quasi
iniziasse un inchino. Affascinante, in ogni modo.
“Sì, in soffitta”,
continuava lei. “Erano di una vecchia antenata, nobile, che ne faceva
collezione, pensi un po’! Al tempo in cui le normali bambine avevano per loro
bambole di pezza, al massimo con il solo viso di porcellana dipinta. Ma lei era
nobile, così le regalavano bambole di porcellana, vestite da ballerina. Con abitini
in pizzo bianco, orlato di passamanerie dorate e scarpine a punta modellate, ai
piedi. Le trovai una volta da piccina andando in soffitta con mia nonna, che
aprì un vecchio cassone cercando un piumino messo in naftalina anni prima e non
più usato. Rimase sorpresa anche lei. Non le ricordava. Erano nel sottofondo
del cassone, disposte in bell’ordine: cinque in fila, l’una accanto all’altra.
Le portai in casa con il permesso di mia nonna. Feci un gran lavoro di
ripulitura e poi iniziai a giocarvi. Nella diversità di visi e acconciature,
una sola cosa le accomunava. Si muovevano tutte in modo rigido, per via della
porcellana. Ciò nonostante mi piacevano immensamente. Anche senza la voce
registrata di oggi, quelle parlavano con gli occhi. Una, persino, aveva un
meccanismo che le faceva alzare e abbassare il capo, o muoverlo a destra e a
sinistra, forse per accompagnare la danza. Erano ballerine, capisce? Non le
solite bambole di casa. E ballerine classiche, adatte allo 'Schiaccianoci' o al
'Lago dei cigni'. Così la mia fantasia di bimba volava.”
Pensai meccanicamente
all’ora di chiusura che si avvicinava. Ma lei parlava ancora.
“Le ha a tutt’oggi?”,
chiesi.
“Oh, no! Purtroppo no.
La guerra, i bombardamenti… Ci giocavo in una sala della casa di mia nonna,
sotto a una terrazza. La terrazza andò distrutta, e così la sala. Noi in quei
giorni eravamo in montagna, sfollati. Ma le bambole non le avevo portate con me
poiché erano preziose, in quanto appartenevano alla casa di mia nonna. Così rimasi
senza.”
Quasi dispiaceva anche
a me, per cui non la interruppi, anche se l’ora di chiusura era passata.
“E poi… vi restai così
male quando lo seppi, al ritorno in città, che continuai a pensare alle
bambole. Anche se eravamo tutti felici, poiché
la guerra era finita. Non ne parlavo. Nessuno lo doveva sapere poiché, come le
ho detto, c’era una gioia, in giro, un’euforia indescrivibile, e nemmeno uno mi
avrebbe capita, tantomeno consolata.
Una sera, sola in casa
con le luci del salotto dei miei tutte accese, presi a osservare un quadro, una
riproduzione delle ‘Ballerine’ di Degas. Talmente belle da lasciarmi di stucco.
Senza nemmeno accorgermi provai a imitarne il movimento che era sulla tela,
immaginando che fossero bambole, e non creature in carne ed ossa.
Mi muovevo un po’ a
scatti, rigida, ma la cosa mi piaceva. Articolavo braccia e gambe come le
avessi di porcellana. E mi sentivo molto bella. Toccavo la pelle del braccio e
la lisciavo, percependola al tatto fresca e scivolosa.
Lo feci qualche altra
volta con un sottofondo musicale, mettendo in funzione il giradischi dei miei
senza farmi scorgere. Sino a preparare un balletto. Chiesi a casa di farmi il
vestito per la prossima stagione, quello nuovo di ogni anno, bianco a balze,
con la gonna rigonfia e un po’ corta. Al pranzo pasquale offersi, a sorpresa, il
mio balletto. Riscossi applausi e meraviglia. Al punto che il giorno seguente
vollero condurmi dal fotografo, che m'immortalò con uno sfondo a pannello che
teneva sempre nel suo studio, di verde campagna con un fiume e un ponte.
Dietro vi scrissero il
mio nome: Ofelia. Ora non soffrivo più, così tanto.
Ero divenuta anch’io
una bambola ballerina!
Quel gusto mi rimase, nell’animo".
Sospirò e chiuse gli occhi, rammentando. Li riaprì bruscamente e guardò
l’orologio.
“Oh, ma lo poteva dire!
S’è fatto tardi. Mi scusi, mi scusi tanto!”, esclamò. Corse via dal negozio
senza nemmeno lasciarmi il tempo di salutarla. Nel chiudere la porta a vetri,
dietro di sé, fece con la mano un cenno di saluto, sorridendo. Il caschetto di
capelli scuri piegato graziosamente a lato, un lungo orecchino che brillava
oscillando, la gonna gonfia in movimento sulle scarpette bianche, in punta di
piedi.

LIBRI
NELIDA MILANI KRULJAC. LO SCRITTORE E L’INGIUSTIZIA
 |
| Nella foto: Nelida Milani Kruljac |
LA BACCHETTA DEL DIRETTORE
Dal nuovo libro della scrittrice Nelida Milani Kruljac,
figure indimenticabili destinate a trovare un posto nel cuore del lettore
La prima
cosa che colpisce, stordisce per meglio dire, in questo triduo di lunghi
racconti, è la percezione della dissoluzione di un mondo, pianificata e portata
avanti con determinazione spietata dal regime di Tito, dopo la seconda guerra
mondiale. La distruzione di una cultura, quella dell’Istria, centenaria e fatta
di riti, usanze, filastrocche, giochi, linguaggio, cibi ed anche mare,
agricoltura, pesca, noia, povertà, che nel loro complesso davano un ritmo, un
significato, dei valori precisi e dei sentimenti per cui vivere e nei quali
morire.
Conduce irrimediabilmente,
questa scrittura, al ricordo della narrazione di un altro esule di un mondo
perduto, quel Joseph Roth che aveva assistito al dissolvimento dell’Impero
Austro-Ungarico. Nelida Milani Kruljac mi ricorda il grande scrittore austriaco per
quella simile e densa atmosfera di nostalgia vicina alla franca tristezza che
grava in ogni dove, per la capacità di tingere i contorni di personaggi e
luoghi nei dettagli delle memorie culturali. La scrittrice sa imprimere al
racconto il giusto ritmo, tra descrizioni, dialoghi e riflessioni.
Negli scritti della
Kruljac la viva sofferenza ci contagia, al pensiero di una così grande
ricchezza umana andata perduta per sempre, il condensato di secoli di
consuetudini, conoscenze contadine o artigianali, le piccolissime sfumature
quotidiane di un gesto o di un ornamento, frutto ancor più prezioso perché
risultato di una convivenza e miscuglio delle popolazioni italiana, slava ed
austriaca. Simile anche in questo caso al popolo di riferimento di Joseph Roth.
Il regime di Tito volle
azzerare, polverizzare la memoria italiana e gli italiani stessi: ed ecco, in
un batter d’occhio, cambiare il nome delle vie, gli insegnanti italiani sparire
ed essere sostituiti da persone che si esprimono in una lingua sconosciuta,
difficile da pronunciare e da farsi penetrare nel cuore. Le case, a volte,
vengono “nazionalizzate” e tolte alle famiglie italiane che le possedevano da
generazioni. Ne consegue un esodo, prolungato e doloroso, fatto contro voglia,
di uomini e di oggetti, tutto il trasportabile, lasciando case deserte, case
fantasma, riempite in fretta da altrettanti fantasmi stranieri giunti
dall’entroterra.
Fascismo, nazismo,
comunismo: totalitarismi che hanno spezzato non solo il mondo ma spesso anche
la vita del popolo di questa piccola terra, non tanto perché i giovani non
abbiano tentato di reagire e di continuare ad amare, a ridere e a costruirsi un
sogno, ma perché la violenza e l’abitudine alla violenza ed alla tragedia entra
poco a poco, come un veleno, nel cuore e nei gesti, e non è più possibile
liberarsene, anzi diventa un destino.
E la tragedia come
destino, sembra aspettare al varco quasi tutti i personaggi di questo intenso,
commovente libro, che si erge a monumento di un popolo, di un momento storico,
che non deve essere dimenticato mai.
Una madre che porta i cibi
preferiti sulla tomba del figlio, una giovane sorridente con dei preziosi
pettini a dividerle i capelli, un bambino che affronta i nazisti faccia a faccia,
un padre che non può perdonare: figure indimenticabili, destinate a trovare un
posto nel cuore del lettore.
Nelida Milani Kruljac è
riuscita a compiere quello che solo i veri scrittori possono: ha fatto parlare
la sofferenza, sua e di tanti altri, l’ha resa condivisibile e comprensibile
anche da chi non sapeva nulla del suo mondo, nulla delle piccole case e del
mare dell’Istria.
E la sofferenza espressa
diventa quasi un balsamo che lenisce, che rende accettabile l’inaccettabile
accaduto. Visi, gesti, persone che sono per sempre fissati nella storia
attraverso le sue parole; non verranno mai più dimenticati, non scivoleranno
nell’oblio.
E questa è la grande
rivincita dello scrittore sull’ingiustizia.
Beatrice Anton Rossetti
Nelida
Milani Kruljac
La bacchetta del
direttore
Oltre
Edizioni, 2013
Pagg.
184 € 18,00
LIBRI
DANTE MAFFIA E IL
SUO POEMA TOTALE
di Angelo Gaccione
 |
| Dante Maffìa con il presidente Ciampi |
In una email di risposta che ho salvato, ma
di cui non riesco più a ricostruire con precisione la data (un’altra perdita
operata del passaggio dalla scrittura cartacea a quella virtuale), così Dante
Maffìa definisce il suo ponderoso poema (oltre 700 pagine e qualche migliaia di
versi) “Io. Poema totale della dissolvenza” (Edilet. Edilazio Letteraria, 2013,
Pagg. 708 € 35,00):
“…Un mare immenso
in cui lo scibile umano è setacciato e ribaltato, con sperimentazioni
linguistiche, metriche, filosofiche e via dicendo. Gli apocrifi, ne troverai
parecchi oltre alla prefazione, non sono una trovata, ma l’affermazione che la
poesia ha ed è un perenne presente e che le “rivoluzioni” sono un fatto di sensibilità, di approdi
sottili e quasi impercettibili…”.
Bastano questi pochi segnali per dirvi che ci troviamo
davanti ad un’opera totale. Totale non solo nel senso degli stili poetici
ascrivibili all’intera tradizione letteraria da noi conosciuta (da quella
classica di derivazione greca e magnogreca, alla scuola siciliana; da quella
trecentesca toscana, a quella aulica di piglio risorgimentale; da quella
barocca dal sapore sensuale, alla ballata dal sapore furfantesco; dai registri
musicali e ritmici che accompagnano l’oralità della villanella (tutti di
impianto calabrese), alla sonorità della tarantella; dagli impasti
mistilinguistici ultrasperimentali, alla figuralità immaginativa e prepotente
della lingua terragna che si incarna nel dialetto di Roseto Capo Spulico (terra
del poeta) e dintorni. Se leggerete attentamente questi blocchi di versi che
compongono i singoli “canti”, troverete persino lacerti delle laudi e delle
litanie. Potrei continuare su questa scia per pagine e pagine, tanto è ricca e
variegata la fucina di Maffìa. Egli ha lavorato come quegli alchimisti che
avendo a disposizione una quantità considerevole di miscele, di pozioni, ne ha
dosati gli impasti con sapienza sperimentandone gli esiti, le possibili ed
impossibili trasformazioni. Qui davvero la materia è lavorata con l’esperienza
del “magister”, del vecchio abile artigiano (ricordiamoci che arte viene da
artigiano) a cui, come si esprime magnificamente il filosofo Giordano Bruno,
“gli dèi avevano donato l’intelletto e le mani”.
 |
| Dante Maffia con il presidente Napolitano |
In una
conversazione telefonica, avevo chiesto a Maffìa quanto tempo avesse impiegato
a comporre un’opera così densa e vasta. La risposta è stata: otto mesi. Non
sono del tutto convinto della verità di questa risposta. Qua e là il volume
contiene testi le cui date rimandano a periodi diversi e che lui ha
successivamente inserito perché coerenti con il discorso del poema che ha poi
via via preso piede. Tuttavia se accettiamo per vera l’affermazione del poeta,
otto mesi, dobbiamo riconoscere che la materia, e soprattutto il modo di
condurla (come ho già detto il registro stilistico muta di continuo), erano
stati così intimamente lavorati, così interiormente introiettati, amalgamati,
intellettualmente organizzati, che è bastato un tempo limitato di stesura tanto
la materia fluiva liquida a rapprendersi dentro lo stampo. È raro che un
delirio creativo, un’accensione immaginativa e visionaria duri un tempo così
lungo; per la vastità dei temi qui toccati direi veramente impossibile. Non è
stato usato a caso l’aggettivo totale,
per definire questo immenso lavoro. Qui dentro, come per il poema omerico e
dell’Alighieri c’è tutto; non solo i temi canonici (la nascita, la vita, la
morte, la guerra, il dolore, l’interrogazione metafisica, la colpa, la gioia,
l’eros e così via): c’è la radicalità politica che più radicale non si può; c’è
la rivolta contro il cielo e la terra; c’è la parodia e c’è l’invettiva; c’è la
corporalità e c’è la malattia; c’è la medicina e c’è la psicanalisi; c’è la
filosofia e c’è la scienza; c’è la tecnica e c’è il potere; c’è la letteratura
e ci sono i letterati; i contemporanei e gli scomparsi; il fascismo e il
consumismo; la democrazia e le sue degenerazioni; i miti del passato e la
ridicola mitologia metropolitana contemporanea; c’è il condominio e c’è il
mondo; c’è l’America e c’è Roseto; ci sono gli ulivi, il mare, gli antenati, la
fatica, gli animali, il sogno, la bellezza, la memoria, il sesso, i libri, il
virtuale, i supermarket, le merci, la miseria, gli odori, le lingue e i
personaggi di un universo minore che le ha incarnate o rese poetiche, c’è il
disfacimento di ciascuno di noi fatalmente votato alla “dissolvenza” come ogni
elemento della natura, c’è l’amarezza per tutto questo e c’è la speranza che ha
gli occhi curiosi, incantati e innocenti di Ludovico, Ginevra e Alice, i nipoti
del poeta, a cui egli stesso dà la parola nelle schede di appendice, accanto a
Leopardi, a Lorca, alla Dickinson, a Saffo, ad Eliot, come a voler stabilire un
legame di anime, un passaggio di testimone per le intelligenze, una fiaccola
che torni a rischiarare, a fare luce, a illuminare gli eterni mali e gioie del
mondo, la memoria di chi è destinato a sparire, ma che ha lasciato una traccia
fertile contro la barbarie. Mi è sembrato che proprio queste tre giovani voci
aprano il poema alla speranza, alla forza indistruttibile della parola
autentica e della poesia; così per lo meno è sembrato a me.
Opera totale, ho detto. Dotata di grande forza espressiva
e di potenza immaginativa, mi ha molto impressionato per l’ampiezza di vedute;
per la capacità analitica, per lo sguardo sapienziale come non accade più ai
nostri poeti occidentali, e che ne fanno forse il più importante poeta italiano
di questo nostro tempo.
 |
| Dante Maffìa con il poeta G. Raboni alla fine degli anni Settanta |
 |
| La copertina del volume |
Gallery: Una foto curiosa del poeta da giovane, una copertina e un dipinto dedicatogli
dal pittore Ennio Calabria. (Archivio "Odissea")
 |
| Dante Maffìa in un ritratto di Ennio Calabria |
LA LETTURA
Un racconto di Beatrice Anton Rossetti
GINEVRA
Mi alzo stanca, nervosa, con
le occhiaie. Mi vesto elegantemente: camicia con maniche a sbuffo e inserti
arricciati color malva, pantaloni maschili dello stesso colore, scarpe viola
con i tacchi; traccio una linea di eye-liner sugli occhi, stendo la crema
fondotinta e un po’ di cipria sulle guance. Trascino il trolley in
metropolitana, faccio il biglietto.
Quando, finalmente, mi siedo
ed il treno si mette in marcia, provo un poco di sollievo: fuori città il cielo
azzurro riempie tutto l’orizzonte sui campi, mossi dal vento. Mi metto le
cuffie per ascoltare la musica e mi perdo nel sogno vacuo che è dolce perché
riesce a non avere alcuna forma. Kilometro dopo kilometro mi sento sempre più
libera, tra persone che non sanno nulla di me, a cui non devo dare nessuna
spiegazione, in un non-luogo dove posso
essere chiunque .
Scendo eccitatissima alla
stazione di Brignole e mi affretto verso la casa che ho visto solo una volta,
tra i vicoli, qualche mese fa. Cammino per le strade strette e sporche del
centro città: Genova l’ho sempre amata, questa maledetta città azzurra, a volte
sudicia, con i suoi grandi palazzi di marmo e gli improvvisi scorci turchini.
Ginevra, detta Gin, la mia
migliore amica, quella con cui c’è sempre stata l’intesa emotiva più forte, si
è trasferita qui. La mia shiatsu-friend. La migliore.
Mi ero iscritta al corso per
diventare massaggiatore shiatsu perché ero disoccupata, non sapevo che fare
della mia vita e per giunta, per sopravvivere, dovevo fare l’accompagnatrice.
Eh, la vita è dura quando,
due o tre sere la settimana, ricevi una chiamata improvvisa dall’agenzia e devi
romperti il collo per prepararti in brevissimo tempo, tutta in tiro: capelli,
trucco, profumo, minigonne e top attillato, e guidare come in F1 per giungere
puntuale in un ristorante o in un hotel, per incontrare un tipo mai visto - di
solito vecchi dirigenti danarosi, a volte giovani tipo malavitosi- e “tenergli
compagnia” per due o tre ore (io non accetto di stare tutta la notte).
Poi, di solito, sono
noiosissimi, e ti fanno domande idiote come “Ti piace fare questo mestiere?”,
io li prendo in giro e inizio a inventarmi di essere orfana o di dover pagare
le cure costosissime del mio fidanzato in coma da anni o cose così, per vedere
la faccia che fanno. Mi faccio chiamare Mia e, ormai, anche quando sono sola mi
rivolgo a me stessa così: Mia è diventata la mia vera personalità.
Allora mi sono detta: “Forse
con questo corso per massaggi, potrò trovare un vero lavoro e smetterla con
questi incontri disgustosi che mi stanno facendo venire sempre più spesso crisi
di ansia e panico ed insonnia. Lo psichiatra da cui sono in cura mi dice di
provare a costruirmi una vita più tranquilla, con un vero lavoro e una
relazione affettiva stabile, ma ogni seduta costa un occhio, e come farei con
un lavoretto mal pagato a continuare ad andare da lui? Ma forse, se stessi
bene, da lui non dovrei più andare.
Purtroppo i massaggi io non
sono diventata molto brava a farli, perché o premo troppo forte i punti o mi
muovo troppo in fretta lungo gli arti; insomma mi hanno dato il diploma per
pietà ma non ho trovato lavoro come
massaggiatrice shiatsu e ho dovuto continuare con la vecchia vita; però ora
cerco di accettare solo un appuntamento a settimana, per stare più tranquilla.
Ginevra i massaggi invece li
fa benissimo e andavo sempre da lei per un trattamento in attimi di stress ed
esaurimento, quando ancora vivevamo nella stessa fottuta città. Ma ora non può
più aiutarmi.
Mi sento un po’ orfana senza
Gin, a volte sogno di percorrere la via di Milano per giungere a casa sua,
salire con l’ascensore e dal ballatoio, che lei teneva pieno di fiori,
affacciarmi dalla porta nell’ unica stanza che aveva, tutta libri e lampade di
vetro colorato e chiamarla . “Ehi Gin, sono arrivata!”. Ma, ormai, mi sono
abituata a questo strappo. D’altronde Gin non aveva scelta, quando ha preso la
decisione di tornare a Genova.
Girato l’angolo, dopo essermi
fumata una sigaretta che mi fa girare la testa e mi mozza il respiro, riconosco il piccolo portone d’ingresso e mi
attacco al citofono entusiasta.
“Ciao Gin, finalmente sono
arrivata!”
“Dai, stai calma, Mia, ora
sei qui! Staremo finalmente un po’insieme e mi racconterai tutto, mi sembri un
poco agitata.” Adoro la sua voce profonda che mi rilassa all’istante.
Mi viene incontro sulle
scale: “Ma che borsa c’hai?” sbotta, strigliandomi subito per bene con il suo
modo di fare fintamente aspro. Abbasso il manico del trolley e lo trascino su
per le scale strette dicendo ansimando: “Una signora non viaggia mai sprovvista
del necessario! Ma ce la faccio Gin, ce la faccio, non ti preoccupare!”
“Allora vieni, grande donna,
mettiti le ciabattine che ti preparo un tè.”
La casa di Gin è piccola, ma
perfetta: nel salotto tendine bianche di pizzo alle finestre, CD ben allineati
tra candele colorate e, di fronte allo scaffale, un gonfio divano rosso; una
piccola stanzetta profumata di incenso predisposta per effettuare massaggi
shiatsu, con al centro dispiegato un futon, alle sue pareti poster con la
visualizzazione dei canali energetici del corpo umano ed alcuni arazzi con la
raffigurazione di dei indiani. Il bagno è blu e bianco, disseminato di profumi
orientali, shampoo alle erbe, smalti colorati per le unghie, spugne di ogni
dimensione; sulla mensola una grande conchiglia piena di orecchini minuscoli,
piattini con anelli e bracciali.
In camera un grande letto a
due piazze coperto da una soffice trapunta bianca e nera ed un comò con
specchiera antica. Il vano cucina munito di due pensiline con gancetti
-difficilissime da aprire- che contengono: tè, caffè biologico, miele
proveniente dalla Sardegna, vitamina D e melassa; crostatine biologiche e
infuso di fiori di pesco. Nulla di possibilmente immaginabile manca in questa
casa.
“Ah” sospira Gin, “al centro
benessere mi sfruttano, tiranneggiano, e non faccio quasi mai massaggi, ma solo
la serva. E, allora, mi dico, perché sono andata avanti nello studio dello
shiatsu? A cosa è servito? Ma che vuoi
farci? Non c’è altro per ora all’orizzonte ed è da troppo tempo che sono fuori
da tutti i giri; poi, in questa città non conosco più nessuno, sono mancata per
troppi anni …”
Gin possiede un corpo esile e
aggraziato: ha lavorato prima come attrice, poi come attrice e commessa in un
negozio di articoli indiani, poi come attrice- commessa in un negozio di
articoli indiani e massaggiatrice shiatsu. Poi non era stato più possibile
aggiungere altro, almeno a Milano, e Gin aveva dovuto fare ritorno a Genova,
dove era cresciuta, e sistemarsi in un appartamento di proprietà della sua
famiglia e ripartire da zero, a più di quarant’anni. Con allegria mi enumera gli undici traslochi
della sua vita, concludendo che, a quanto pare, non è proprio destinata alla
stabilità.
“Coma va con Bruno?” cambio
argomento io.
«L’ho sentito una volta sola
in due mesi. Il problema è che io ho un’esigenza di amore e cura che lui mi ha
detto chiaramente di non poter corrispondere. Ogni volta che vado a casa sua a
Pisa, lui cerca di essere gentile ma io sento che manca il vero coinvolgimento
e allora non faccio che piangere; così ho capito che è meglio non vederlo più
ed anche sentirlo il meno possibile. Quando l’ho conosciuto, in Grecia,
l’estate scorsa, non mi sarei mai aspettata un ‘evoluzione del genere. Non
credevo che mi sarei tanto coinvolta nei suoi confronti. Quel giorno le onde
erano forti, ma io conosco quella spiaggia da anni e so perfettamente fino a
dove si può entrare. Ad un certo punto vedo lui che si avvicina: occhialini sul
viso, pinne ed una canna da pesca assurdamente lunga ed inadatta a quel
fondale.
Mi dice: “Attenta! Non rischi
così, oggi il mare è grosso, non vada più avanti!”
Mi dava anche del lei! Io l’ho guardato e sono scoppiata a
ridere. Anche lui ha riso improvvisamente, e a quel punto ci siamo seduti sui
miei teli e ci siamo messi a chiacchierare. Io ero molto turbata perché avevo
appena scoperto che Georgos, il proprietario dell’agriturismo dove alloggiavo,
e con il quale stavo andando a letto da due settimane, si era invaghito di una
ragazza appena arrivata, dopo che io mi ero allontanata solo per due giorni.
Sai come sono fatta io: mi piacciono gli uomini forti ed un po’ primitivi; e
lui, che viveva in mezzo ai cavalli, alle pecore, che faceva il miele con le
sue mani, era per me un’attrazione irresistibile. Ero così frustrata che, dal
momento che Bruno aveva iniziato a raccontarmi di essere innamorato di una
donna sposata e straniera che vedeva pochissimo, anch’io buttai fuori la mia
rabbia verso Georgos, raccontando tutta la storia.»
Gin riprende: “Gli ho raccontato tutto: di essermi assentata
due giorni per incontrare un’amica e di aver trovato, al ritorno, il mio posto
a letto occupato da un’altra.”
“Certo, parlare di queste cose non è un grande avvio per una
storia d’amore...” mi permetto di osservare. Mi guarda con i suoi occhi
castani, intelligenti e profondi, come se mi vedesse per la prima volta: “Ora
che mi ci fai pensare è vero, ma allora io non credevo che avrei avuto un
interesse così grande per lui, riuscivo solo ad immaginare una amicizia
passeggera e, forse, una scopata.”
“Gli uomini. Anche quando si mostrano apparentemente
disinibiti e comprensivi non bisogna lasciarsi andare, perché in realtà sono
cambiati poco dal Medioevo ad oggi e vogliono solo ed ancora immaginare che la
loro donna sia pura, e che si sia donata solo a loro. O forse Bruno rientra nel
gruppo che considera la relazione con una donna come un accessorio da
utilizzare solo nei week end o un peso che limita la libertà: e questo è il
quadro completo dell’uomo medio, compreso tra i venti ed i cinquant’anni della
nostra epoca.” sermoneggio annoiata.
“Comunque sia,” conclude Gin, “non può darmi quella
tenerezza di cui sono così bisognosa, e perciò si può dire che le cose sono
state da subito, o sono diventate, ormai
irreparabili. Sono andata due volte a trovarlo e due volte è venuto lui,
ma è il suo modo di porsi è restare ad una certa distanza. Non dice di amarmi,
né fa progetti con me. Facciamo solo del gran sesso, per ore di fila.
E’instancabile ed arriva all’orgasmo solo quando lo decide lui. Fantastico. Dal
lato affettivo, però, non vuole coinvolgimento e per me è straziante. Meglio
non pensarci più e tenermi alla larga.” Scuote la sua massa di capelli lisci e
folti, come un leone che volesse liberarsi di un insetto rimasto impigliato.
“Io non trovo un uomo decente neanche se mi ammazzo, per
cui, sono resto e, penso, resterò sola per tutta la vita. Mi sento uno schifo,
ma cosa posso fare? Ho una vita troppo disordinata per ambire ad una relazione
seria.” dico io.
Gin ride: “Ma sei tu che ti stai creando questo destino
negativo, perché sei vuota e piena di paura. Non credi in niente, non sai
sperare, devi avere il coraggio di cambiare vita e affidarti al destino.
Sto iniziando a pensare, per esempio, che sia l’oblio della
fede religiosa, che coinvolge tante persone oggi, a incidere grandemente sui rapporti tra uomo e donna. Nel passato,
anche se non sempre, lo ammetto, c’era un ideale di eros che comprendeva il
desiderio di eterno e di un’ armonia celestiale da raggiungere; amare era
allora una sorta di mediazione verso il divino: la donna angelo di Dante o
Petrarca, la passione romantica di Byron o Shelly, il sentimento disperato di
Baudelaire, Mann, Montale, Blixen, era anche una ricerca dell’infinito e
persino di Dio.
Si coltivava l’orizzonte di un sentimento profondo, più
forte della sola emozione volatile, si cercava anzi di spiritualizzare questo
sentimento, di renderlo fonte di ispirazione artistica, di pietà, di estasi, di
perdono, di ogni buona acqua che può sgorgare dal nostro cuore. C’era una
coscienza morale a cui rendere conto, che, a volte, frenava dallo sfruttare
l’altro e di usarlo solo per il proprio interesse.
C’era il paradiso e l’inferno con l’amore al centro, senza
via di scampo e senza via di mezzo.
Che fine farà l’amore tra due persone? Che cosa è oggi? Un
breve e burocratico scambio di organi.
Quando colui che era il mio compagno da dieci anni mi ha
imposto l’aborto, minacciandomi altrimenti di sparire, perché assolutamente non
si sentiva di svolgere il ruolo del padre, ho provato sensazioni simili alle
tue. Sono andata in ospedale, ho fatto quello che mi si richiedeva di fare, e
poi sono tornata a casa e ho riempito immediatamente le valigie e ho lasciato
quell’uomo; dopodiché ho pianto ininterrottamente per tre anni, l’ho odiato più
di quanto abbia mai odiato qualcuno in vita mia. E poi sono semplicemente
sopravvissuta.”
Improvvisamente scopriamo di avere entrambe il viso rigato di
lacrime. Ci alziamo dalle sedie disposte intorno al tavolo e ci stringiamo in
un abbraccio consolatorio. La stretta dura a lungo; poi sciogliamo l’abbraccio
e ci risediamo un poco imbarazzate, forse, ma felici della condivisione che
abbiamo avuto.
“Sì”, riprendo tristemente, “il patto di reciproco sostegno,
nella buona e nella cattiva sorte, in salute ed in malattia, in ricchezza ed in
povertà, non si applica quasi più alle coppie, sia sposate che non. Questa
parte è stata rimossa, per lasciare tutto lo spazio al piacere ed alla libertà
di togliersi elegantemente di torno alla prima sgradevolezza. Chi prende
appuntamento con me è quasi sempre sposato o fidanzato …
Come sarebbe bello sapere che chi ti ama resterà nei paraggi,
anche se litigherete, anche se lo rifiuterai o dovesse scoprire che una fa il
lavoro che faccio io. Qualche mese fa avevo conosciuto un ragazzo bellissimo.
Siamo usciti insieme per quasi un mese, ma io non sono riuscita a confessargli
il lavoro che faccio e poi quando stavo con un cliente, ero terrorizzata che
lui chiamasse e ho cominciato a bere troppo e prendere ansiolitici a manetta.
Allora ci ho litigato, gli ho fatto scene isteriche e di pianto e lui ha
tagliato di netto con me, comprensibilmente. Ora avverto uno squarcio nella mia
carne. Per non parlare poi del trattamento che i clienti mi riservano: ricorda
la freddezza che si usa negli allevamenti intensivi verso gli animali o che
usavano i nazisti nei campi di
sterminio: mi sento considerata cosa e non persona, ogni dignità negata, sono
solo un oggetto che serve ad uno scopo e che poi verrà distrutto, smembrato.
Negli allevamenti intensivi l’animale viene sgozzato con un
colpo secco, profondo e poi lasciato agonizzante a dissanguarsi. L’agonia è
lunga, credo sia molto dolorosa, anche. Molte volte mi sento come uno di quegli
indifesi animali; poi, inaspettatamente, ho attimi di breve euforia, di tenera
aspettativa, quasi, magari solo perché ha smesso di piovere ed il sole luccica
sull’asfalto bagnato.”
II
Gin ed io ci siamo spostate sul bel divano
rosso; è ormai sera, le tenebre stanno avvolgendo il mondo e la stanza, dove
non abbiamo acceso luce elettrica; mi sento illanguidita per l’affetto che
sento intorno a me ma anche molto, molto triste. Improvvisa, la mia suoneria
con canzone giapponese spezza l’atmosfera. Ginny si alza e accende la
luce. “Ah, ciao” dico con tutta la
dolcezza falsa che posso, “no, stasera non posso lavorare perché sono fuori
città da un’amica. Va bene … ci sentiamo magari domani sera … Ciao.”
“Ti sei agitata vero?” dice Gin, vedendo che la mia mano
trama un poco.
“Sì, non voglio più fare questo schifo di lavoro, non ne
posso più, mi sento una schiava senza la possibilità di costruirmi una vita
normale, di vivere un amore vero. Ma che cavolo di lavoro posso fare? Io non
sono capace di fare niente di specifico...”
“Senti: io sono stanca e domani mi devo alzare alle 6.30 per
lavorare. Andiamo a letto e rimandiamo tutti i pensieri a domani.” Gin mi
abbraccia forte e lascia la stanza.
“Prendo la mia fedele pillolina di sonnifero, fumo una
sigaretta e ti raggiungo” le grido dietro. Esco a fumare un’ultima sigaretta
sul balconcino: i fiori, le conchiglie appese, la luna: ed io, sotto di lei,
triste.
Nel cortile una siepe di rose rosse sbocciate emana il suo
profumo fino a me, o così mi pare e, vicino, un gatto nero e bianco a pelo
lungo si gode la frescura della notte.
Loro godono il momento
presente, senza paure o considerazioni alcune. Questa è la vera essenza della
vita” penso tra me
osservandolo mentre fa dondolare la coda.
Quando entro nella camera da letto, lo faccio con l’aiuto di
un accendino pila perché, con le vecchie ante serrate, il buio è completo. Non
mi piace dormire senza vedere penetrare almeno uno spiraglio di luce nella stanza, ma mi adeguo.
La camera d’altronde, è fresca, le lenzuola profumate. Gin, nell’altra metà del
letto è una presenza tranquillizzante.
Come sempre nel corso della notte, mi sveglio due o tre
volte: verso le due, poi ancora alle cinque, poi alle sette. Un incubo: una donna
grassa, fortissima, enorme mi aggredisce, non riesco a staccarmela di dosso
malgrado provi un senso di repellenza nervosa appena una sua mano riesce a
toccarmi. Sono con Gin, cerco di difendermi con tutte le mie forze ma mi sento
bloccata; allora Gin le spara, altrimenti quella furia mi avrebbe ucciso.
Mi sveglio tutta sudata e sento Gin trafficare per casa ed
uscire verso le sette e trenta per andare al lavoro. Mi calmo, trovandomi in un
ambiente ovattato e protetto e mettendomi di impegno, riesco a riaddormentarmi;
alla fine mi alzo alle 8.30, un orario che per me significa aver dormito a
lungo. Mi alzo con molta calma; faccio un’ ottima doccia; mi metto al tavolo
davanti ad un tè caldo con biscotti;
fumo una sigaretta sul balconcino. Sento la pace e la pienezza del momento.
Un momento brevissimo nell’arco del tempo della vita, però
esistente e non inutile, un attimo di grazia da assaporare completamente
proprio perché limitato.
Vorrei rimanere qui per sempre. Forse questa è la soluzione
per essere finalmente sereni e placati: organizzare la vita con degli amici, in
una specie di comunità di affetto e sostegno reciproco e di ideali comuni da
perseguire. Una vecchia cascina, per esempio, con tanti piccoli appartamenti, dove
ognuno mantenga la propria identità ed il suo lavoro da seguire, magari
esterno, ma poi al rientro serale, si ritrovi in un gruppo accogliente in cui
prevalga la visione comune, la condivisione del dolore sulla solitudine e
l’individualismo.”
Penso al romanzo “Sul filo del tempo” * con la
comunità di Mattapoissett di Luciente; lì si viveva in piccoli gruppi
condividendo gli amori, le capacità, le emozioni.
Mentre sto sognando, chiama di nuovo la mia agenzia. “Cosa?
Per stasera alle nove? E vuole che indossi un abito bianco … ma io non ho un
abito bianco … Vabbè dai, a dopo.”
Uffa, che palle, devo uscire a comprarmi un vestito bianco
trasparente.
Esco in fretta e, chiusa la porta alle mie spalle provo
subito a riaprirla con la chiave che mi ha consegnato Gin, per vedere se
funziona. La chiave non gira. Riprovo. Gira avanti ed indietro, ma non apre.
Sono rimasta chiusa fuori!
Solo un attimo di panico. Calma. Per fortuna Gin sarà di ritorno tra due
ore.
Mi rassegno, anche se mi maledico per aver obbedito
immediatamente al comando.
Stavo davvero bene e ho interrotto un momento magico.
Vado in edicola e sparlo un po’con l’edicolante dei politici
di turno e soprattutto del Capo del Governo; poi mi dirigo verso il centro, tra
case vecchie e fatiscenti e affascinanti, tra la vita che pulsa, bevo un caffè,
compro, a caro prezzo, lo stramaledetto vestito bianco. Poi, torno sui miei
passi, spensierata e, quando arrivo a casa, Gin è già arrivata, moderatamente
stanca. Mi guarda con compatimento, avverte la mia agitazione. Cerca di tirarmi
su con qualche pettegolezzo:
“Sai cosa mi ha raccontato oggi la mia capa? Lei ha avuto
una lunga relazione con un critico musicale: vivevano in campagna, in
un’atmosfera surreale dove lei non ce l’ha fatta, le dava un senso di
oppressione quel mondo silenzioso lontano dalla città, fatto di nebbia e cognac
bevuto la sera di fronte al camino. Però lo amava molto e lo ama ancora. Mentre
però era tornata qui in città per riflettere, lui aveva cominciato una
relazione con un’altra donna. E’ lei che,
alla fine, glielo ha rubato e che lui ha poi sposato. La settimana scorsa lui le telefona, le dice che
è a Genova per una Fiera, le chiede di incontrarlo. Arriva a casa sua per
portarla a cena, ma appena dopo i convenevoli, la abbraccia baciandola sul
collo e cadono sul letto. Hanno fatto l’amore tutta la notte.
La mattina dopo riparte, in fretta e furia mentre le aveva
detto che si sarebbe fermato ancora un giorno. Ora, le ha proibito di inviargli
mail per paura che sua moglie le possa leggere ed anche su face book appena lei
accede lui si scollega. Lei lo sogna ogni notte, è un incubo che è ricominciato
…”
Io e Gin siamo scandalizzate dal comportamento dell’uomo ed
io aggiungo storcendo la bocca:
“Face book: tanti volti, tante pose, feste, risate a due
dimensioni, come una zuppa insensata, spesso maschera i sentimenti. Quanti rapporti
sono distorti in rete! La verità viene raccontata in parte o per nulla; è
scelta, rimaneggiata.”
“La realtà in ogni caso nel nostro tempo è un orpello
ininfluente” interviene Gin “l’unica cosa che conta è la propria verità, la
propria immaginazione, ci si abitua alla solitudine che è la sola condizione
che ci dà sempre ragione, che non sconvolge mai le nostre illusioni e certezze.
La donna forse, in questo nuovo gioco è quella che rischia di più il collasso
emotivo perché ha bisogno di relazione intima vera, calda.”
“Tutto ciò che appare esteriormente deve necessariamente
rimandare ad una dimensione interiore dell’essere, ti ricordi Gin cosa ci
insegnavano al corso di shiatsu?” dico io “Ma quale? Mai come oggi, in un mondo
semi virtuale, è difficile capire cosa è detto e cosa è taciuto e chi si ha
davanti.
Gli esseri umani costruiscono mondi e universi, a volte
ingannevoli, a volte poi li distruggono e divengono incubi per chi ne è stato
coinvolto. Siamo, mi sembra, più che mai attori: non tutti abbiamo lo stesso
ruolo, ma tutti fingiamo, rimestando la verità con ciò che ci è più conveniente
dire e forse credere di noi stessi … Ah, mi sto perdendo …”
Ridiamo.
“Forse,” dice Gin “più di ogni altra cosa, oggi l’uomo vuole
un rapporto d’amore a distanza.
Una persona eterea, misteriosa, una beatrice, alla quale
rivolgersi piangere e pregare, ma che non veda tutti i giorni, anzi quasi mai,
assente, lontana, morta forse, che lasci tutto lo spazio intatto.
Se pensi che ancora nel 186...e qualcosa, la donna era
considerata proprietà del marito e solo nel 1975 in Italia è stata
sancita la parità tra i coniugi, capirai che l’uomo ancora non è pronto ad un
rapporto alla pari e forse neanche noi.
Il classico gioco: la donna deve sedurre e compiacere, il
maschio deve dominare e far soffrire.
Una volta la donna non era vissuta come un vero
interlocutore ma un subalterno o un oggetto sessuale, ancora peggio, per i
figli e la posizione sociale. Da qualche decennio, invece, è iniziata una nuova
era per i rapporti tra uomo e donna basati sulla teorica parità; ma per ora è
molto difficile capire se il risultato è stato positivo e come si evolverà.
Bruno è gentile, ma distratto, e distante. Ma, d’altronde, cosa pretendo da un
uomo di 50 anni che ha ormai delle sue abitudini da solitario alle quali
difficilmente rinuncerà? Io mi sono sistemata nella mia casetta, non ho bisogno
di nessuno. Eppure come ben sai il mio cuore spesso sanguina. Razionalmente so
che aspettarsi dagli altri quello che non possono dare logora i rapporti e
forse ci rende ingiusti, pretendendo che essi siano come li desideriamo, e non
accettandoli per quello che invece sono, noi diventiamo di conseguenza tiranni.
Spesso gli uomini pensano alla loro soddisfazione
momentanea, vivono nel presente molto di più di noi donne che subito corriamo
al futuro, alle conseguenze di un’azione; ma, Dio mio, non c’è un po’ di
misericordia e di dolcezza in quei cuori? Così bisogna accettarli: freddi, egoisti,
vigliacchi, sadici, sfruttatori, manipolatori?
Questa è la giustizia, la giusta libertà di cui hanno il diritto?”
“Bisognerebbe staccarsi completamente dal desiderio di
controllare gli altri e di avere consolazione da loro,” intervengo io “è l’unico
modo per conservare la propria forza. Ma
questo nell’amore non è possibile e così possiamo solo far fluire tutto
onestamente: la speranza, le aspettative sugli altri, le lacrime.”
“E se ci fosse una speranza di riscatto?” Gin mi guarda di
sottecchi.
“No, non ci credo più,” dico, “ora non più …”
“E’ inutile che fai così, Mia, sai anche tu che noi esseri
umani abbiamo bisogno di speranza e se non possiamo riporla negli esseri umani
che deludono, possiamo farlo solo in qualcuno che è oltre l’imperfezione e in
buona analisi la cattiveria umana e questi può essere solo Dio. E’ come la
storia di Filumena Marturano di Eduardo De Filippo, la conosci? Filumena, una
prostituta senza mezzi, rimane incinta e tutte le compagne di sventura le
consigliano di abortire. Lei non vorrebbe, ma ha paura di non essere in grado
di mantenere e crescere il bambino. Mentre sta vagando in preda ai suoi
pensieri, arriva di fronte ad una edicola della Madonna; allora per la
disperazione si rivolge a lei per sapere cosa fare. Proprio in quel momento ode
una voce che dice I figli sono figli
. la voce arriva da una casa vicina, ma l’aver udito proprio questa frase nel
momento in cui chiedeva una risposta le fa comprendere che è un messaggio
giunto per volontà della Madonna. Decide così di tenere il bambino .”
“E non fa più la prostituta?” chiedo io speranzosa.
“Beh per un po’ la fa ancora ma alla fine avrà un vero
lavoro e si sposerà.”
“Ma dai …” mi sento
di nuovo vuota e triste. Penso alla mia difficoltà, al peso che questo
lavoro mi dà e vorrei anch’io ricevere l’aiuto della Madonna come Filumena lo
ricevette.
Gin percepisce il mio cambio di umore e dice: “Che hai
ancora? Sei diventata smorta e preoccupata, ti si è formata la ruga verticale
tra le sopraciglia.”
Mi sento così inquieta ed insicura e, inoltre, sento
l’impulso di piangere.
“Senti scemetta”, mi dice Gin “oggi ho parlato delle tue
difficoltà finanziarie con la mia capa e forse nei prossimi giorni ti proporrà
un posticino come receptionist e tuttofare del centro benessere. Ti piacerebbe?”
“Ma, è vero?” strabuzzo gli occhi io.
“Sì, stupidina, però i soldi saranno pochini. Nei primi
tempi potresti stare qui da me, ma non a lungo, perché io ormai sono un vecchio
lupo solitario ed ho bisogno del mio spazio. Potresti trovare una stanza in un
appartamento in condivisione …”
Sento che sto per piangere. “Mi piacerebbe molto accettare
questa proposta.” Le dico con il labbro che mi trema.
“E allora dai, amica mia, speriamo che tu debba tornare a
Milano solo per poco tempo, per fare le valigie e trasferirti qui.”
L’abbraccio forte e, anche se non vorrei, inizio a
singhiozzare e questi singhiozzi e queste lacrime che scendono a fiotti dalle
guance, mi fanno finalmente sentire libera.
*Romanzo di Marge Piercy,
1976.
ILLUSIONE?
Un racconto di Lisa Albertini
Un racconto di Lisa Albertini
 |
| Giuseppe De Vincenti "Viandante che guarda il mare" Omaggio a Theo Angelopulos Pastello, 2014 |
Acqua blu cobalto, con isolotti sullo
sfondo d'infinito. Scogli piatti in fila, bianchi sul mare come pietre lunari
dai crepacci grigio e argento. Sul fianco d'uno, che un po' discosto dai più
emerge alto dall'acqua, una scritta incisa.
Dietro, inconsapevole, un uomo controluce, scuro nei riflessi
aranciati del tramonto. In piedi su uno scoglio, Fausto osserva tre nuotatori a
colloquio, vicino alla boa. Nel guardarli non si accorge, delle frasi segnate a
graffito sulla pietra. Infine, in equilibrio instabile si avvia alla battigia,
per fermarsi subito dopo. Una donna, ferma vicino all'incisione, si sta
asciugando i piedi. Gli appare di una bellezza ignota, senza inizio né fine.
Forse una sirena in corpo femminile giunta d'altri lidi. Guardandola
apertamente, vede infine la scritta vicina. La osserva incuriosito ma subito si
ritrae, senza leggerla. E' incisa con caratteri dell'alfabeto greco. Egli non
ne comprende la provenienza, né l'obiettivo: gli ricorda invece i suoi giochi
di ragazzo con lettere in codice su fogli segreti, in uso nelle bande tra i
compagni di allora. Di quelli rammenta i visi. Uno, in particolare, che
femminile e giovanissimo aveva riccioli biondi e occhi verdi a mandorla.
Fausto ritorna solo all’albergo, dov’è alcuni giorni in
vacanza. A sera, nel contemplare la luna piena dalla terrazza, immagina quel
volto nuovamente.
E' un viso di bimba, immersa nel gioco a nascondino di
allora, svolto nel campeggio adiacente al mare, tra cespugli di mirto e pitosforo.
Dietro al muretto a secco dell'oliveto, dove macchie fucsia di oleandri estivi
confondevano il profumo di schiacciata all'olio e sale calda il mattino. La
portava sempre un vecchio, sull'asino carico di ceste con formelle di pecorino,
da vendere al mercato.
E' il volto di Arìe, bimba che veniva dalla Palestina: a soli
dieci anni già seducente come una gazzella. Giunta qui così piccola per via di
suo padre medico trasferitosi in Italia, luogo dei suoi precedenti studi.
Ironia della sorte, dalla sua terra divenuta simbolo di grande dolore, per
avervi perso la giovane moglie e un bimbo in un parto infelice.
Fausto si rivede già innamorato, a quel tempo. Dodicenne, nel
gioco correva in ogni angolo per trovarla nascosta. Vi riusciva sempre, ma prima
di battere sul muretto la sua vittoria, la guardava un attimo negli occhi a
mandorla, cogliendone lo sguardo lontano di piccola straniera. Una volta,
avvicinatosi veloce, l'aveva vista fuggire con l'immediatezza di una gazzella. Nel
volgersi di scatto a guardarla era caduto, strusciando il viso contro un sasso
spigoloso. Era stato forse quello, il remoto principio dei suoi amori.
La luna rimane alta, nel cielo sempre più buio. Ora che il
silenzio notturno ha addormentato ogni cosa, lo sciabordio dell'acqua, lieve ma
presente, è percepibile sino a lì. Fausto ne segue andate e ritorni, sull'onda
dei quali rievoca le vecchie storie, dei suoi amori trascorsi.
Anita, sulla barca, quel giorno andando verso l'isola si lasciava
guardare con sensuale complicità. La sua figura, splendida nel kimono a rameggi
viola, lo induceva a sognare. Così rimase, nel loro rapporto esclusivo dove
lui, sultano, governava la schiava cortigiana. Tutto si consumò in pochi anni
come fiamma di candela sempre più esile, sino a spegnersi.
Greta, invece, giovane vedova in lutto stretto, l'aveva
conosciuta davanti al cimitero in un pomeriggio di pioggia torrenziale. Sola,
con un foulard nero grondante appiccicato al capo, la sua figura si disegnava scura,
contro il muro bianco dell'ingresso monumentale. L'aveva condotta in auto al
portone di casa. Greta ringraziava. L'amore era iniziato solo in seguito, per
terminare dopo una decina d'anni, con la malattia fulminante di lei. A Fausto
rimaneva il figlio di Greta, conosciuto e già grande al loro incontro.
Solo allora, aveva compreso il desiderio d'un figlio di Anna,
da poco segretaria nel suo ufficio. Ai propri ripetuti, e tuttavia vani
tentativi di renderla madre, lei aveva risposto con una partenza. Se n'era
andata alla ventura. Sosteneva che l'amore così, da soli, era vuoto.
Oggetto di seduzione, uomo compassionevole, padre
inesistente, egli si definisce ora, dopo quelle storie stranamente lontane,
sebbene vissute sino a due anni prima.
Il mattino seguente, assai presto, si propone di ripercorrere
gli scogli del giorno prima. Il mare a un'ora così precoce è liscio, profumato.
Le grandi pietre, ancora fresche, sembrano godere del recente riposo notturno.
Si siede vicino allo scoglio diritto e levigato. Guarda la
frase incisa per breve tempo, ma intensamente. Le sillabe, mute, sembrano
uscire vivaci dalla pietra.
'L'amore è come un fantasma, tutti ne parlano, ma nessuno
l'ha visto '.
Il significato delle parole scritte lo attrae, per il gioco
del controsenso. In fondo si tratta di attimi, ma esistono pure istanti in cui
l'amore è visibile, catalogabile, egli pensa.
Solo ora si accorge della particolare forma di scrittura,
dove ogni riga inizia con una maiuscola. Legge l'una di seguito all'altra le
lettere a capo riga. Ne esce una frase: ‘L'amore è illusione’ (in
greco).
Quest'ultimo accostamento, sibillino, lo lascia sconcertato.
“Ha bisogno di qualcosa?”, si sente chiedere. Gli è accaduto
altre volte di sentirsi chiamare. Non si accorge quando parla tra sé e sé ad
alta voce.
La domanda proviene dalla turista del giorno prima. E'
arrivata in silenzio e siede due scogli più in là. Lo guarda.
“No, no, grazie. Va tutto bene; a volte mi succede”, risponde
lui.
“Parlava di amore catalogabile”, ribatte lei scherzando. “Che
intendeva?”.
“Niente di strano. Mi riferivo, credo, a quando lo si può
misurare.”.
“Ah, allora è vera, l'iscrizione!”, riprende lei.
“Perché?”.
“Beh, l'amore sfugge, non si può misurare in alcun modo.
Nessuno lo fa. Sebbene il tempo a volte lo faccia passare per vero, datato. Ma
spesso è solo apparenza, in quei casi. Che cosa vi stia dietro, non lo
sappiamo.”.
Fausto la guarda perplesso. Ne coglie i tratti del volto, gli
occhi. Soprattutto gli occhi di un verde chiarissimo, brillante.
“Non a caso”, continua lei, “quando si fa un incontro
particolare si dice sempre che è casuale, assolutamente imprevisto. E se
qualcuno ha la fortuna di vivere un amore a lungo, di solito non lo sa
spiegare. C'è ma non si vede!”.
“Già”, risponde Fausto. Il suo pensiero è tuttavia lontano,
mentre aggiunge: “A volte ci si conosce da piccoli per poi ritrovarsi da adulti
dopo venti, trent'anni. Ci si ravvisa a fatica. Ma i sogni fatti da bambini,
cancellati dagli anni inclementi tornano a galla d’improvviso”.
Lei lo guarda curiosa. Solo ora si accorge della lunga
cicatrice bianca, che lui porta sulla guancia sinistra. Chiude gli occhi, ma li
riapre subito dopo.
“Faustino?”, chiede incredula.
“Arìe?”, risponde lui d'impeto.
Vanno nell'area attrezzata e il campeggio c'è ancora. ALBATROS, anziché VELA BIANCA.
E così il riparo nascosto dietro al grande ulivo.
Lei vi si nasconde a fatica. Fausto la vede, e picchia sul
muretto la sua vittoria.
MAGICI FILI
IL RACCONTO
Con questo primo racconto la scrittrice veronese Lisa Albertini
inizia la sua collaborazione con "Odissea"
 |
| Nella foto: Lisa Albertini |
PARTENZA
Un contorno di
gondole nere, sparse nell’acqua blu verdastra avanti alla riva, con i riflessi
brillanti del sole meridiano. Contro il cielo d’un azzurro pastoso denso di
luce, diritto in piedi un palo d’attracco delle gondole. Su di esso una
gabbianella bianca, pulita, dal becco ocra smussato in punta aperto verso
l’aria, in cerca di sogni. Alle sue spalle il Palazzo Ducale, dai bianchi
ricami d’un candore abbacinante traforati come pizzi ottocenteschi profumati
d’amido, e gli archi aperti di seguito, su colonne snelle, accoglienti nel loro
invito a chi passa, di entrare a fermarsi in sosta.
E in mezzo a loro, sulla Riva degli
Schiavoni stesa verso il prossimo ponte bianca di pietra, un brulichio
incessante d’uomini d’ogni colore. Fitto, in continuo movimento senz’ordine, ma
festoso e ridente. Soli o a gruppetti
felici, guardano verso punti qua e là d’intenso colore. Si avvolgono e si
svolgono, le digitali in mano, d’attorno a maschere di rito del Carnevale di
Venezia.
Un grande pappagallo verde a bolli
d’oro, dal becco giallo, signori e signore del settecento ricchi di perle e
drappeggi, coppie in verdi abiti lunghi coperti di frutta e fiori, due finte
gondole a passeggio, pochi egizi in luminosi paramenti trapunti di pietre
colorate…
e numerose altre invenzioni dal sapore magico, nella luce
intensa di fine inverno. Nel loro spazio ridotto, ma dilatato dallo sguardo di
ognuno si muovono piano, in silenzio. Sussurrano mezzi sorrisi, accolgono
compagni di foto con cortese condiscendenza. L’aura di mistero che li avvolge
si veste a tratti di giocosa allegria, subito tolta da altri, in diversa
pretesa. Volta a volta, con diplomatica noia si spostano in direzioni
impreviste e senz’ordine, appunto.
Davanti alla Basilica di S. Marco dal morbido, arcuato
disegno orientale, un clan di giocolieri si arrampica su alti trespoli. Da lì
fa ondeggiare sinuose strisce di carta
colorata, formando disegni aerei incrociati. Note dal colore intenso,
altrettanto modulate, si spandono per la piazza. Sono armonie classiche,
composte con passione e sentimento. Accompagnano i motti di spirito delle
antiche maschere sul palco in fondo, in preliminari per la prossima recita del
pomeriggio.
La gabbianella,
che curiosa ha visto tutto volando a lato, a bassa quota, ritorna sul palo
vicino alle gondole. Ripensa al ‘suo’ carnevale. E’ per lei quello di sempre,
che ogni anno colora le rive di umani, divertenti pupazzi. Con occhio attento
ne cerca ancora i colori, che da lì appaiono seminascosti nel brulichio fitto e
disordinato. Odora anche, grata, gli effluvi di acqua salmastra, ricca di alghe
floride d’un verde vivo, da primavera prossima. Scuote vezzosa le piume verso
il gabbiano grande del palo vicino, in un’illusione di futuro affetto, poiché
dovrà andarsene tra breve. La chiama il migrare dovuto a lei, giovane. Non
vorrebbe lasciare la riva vicino alla piazza; neppure il palo, le gondole nere,
l’aria umida e densa. E tuttavia, in uno sforzo naturale, aspro di senso, si
alza ad ali spiegate. Vola prima lenta, accosto alla riva. Poi, con sempre
maggior vigore in là, sul mare aperto, incontro al proprio destino, ignoto.
Nota Biografica
Sposata con tre figli,
laureata in Psicologia clinica a Padova, Lisa
(Marialisa) Albertini ha seguito
training e corsi di perfezionamento, specialmente in Psicologia relazionale
sistemico cibernetica a Milano e in Psicologia forense a Venezia. E’ stata
psicologa in Consultorio familiare, insegnante in materie psicologiche per l’ULSS
25 Regione Veneto, consulente tecnica per il Tribunale civile.
E’ psicologa clinica in
libera professione. Da una decina d’anni s’interessa di narrativa. Ha pubblicato:
‘La venditrice di bambole’ Maremmi 2004, ‘Di sola madre’ Quiedit 2008 (finalista
al premio ‘Vinceremo le malattie gravi’ 2013 , Milano Sesto S. Giovanni ), ‘Al
balcone di Giulietta e altri racconti’ Quiedit 2011, ‘Il tulipano nero’ Quiedit
2014 (tra i premiati al concorso letterario ‘Città di Castello’ 2013). I
racconti brevi, qui presentati, sono parte di una nuova raccolta inedita.
DOVE FINISCE LA CITTÀ
C’è un punto della città
dove l’asfalto incontra il nulla. Dove draghi tecnologici ritmano il loro
incedere sugli scatti calibrati dalla ferrea battuta delle ruote sui binari nei
giunti dilatatori. Musica di sempre per un uomo contemporaneo. Musica
fantastica per un bambino ed il treno delle vacanze.
C’è un punto della città
che apre un varco ed uno sguardo al di là delle cose, al di là del vero,
nell’universo immenso e favoloso della memoria, dell’incoscienza, della perdita
della cognizione del tempo e dello spazio. È un punto dove non esisti.
E improvvisamente il nulla
della gravità, proietta nei 4 punti cardinali, nello spazio, le tue membra, le
tue mani, le tue braccia, le tue gambe, il tuo capo, che si separano dal tuo
corpo e iniziano a fluttuare nel grigiore di un etere senza sole e antimateria.
Tiziano Rovelli
LA
LETTURA
DANTE MAFFIA
Del Poema di Dante Maffìa, "Odissea" si occuperà in modo più organico prossimamente, regaliamo intanto ai nostri lettori questo suo meraviglioso,
emozionante omaggio ad uno degli alberi più umani e sacri della tradizione
e della cultura.
L’ OLIVO
(con
stormire di fronde e cantilene di raccoglitrici)
a Giovanni
Pistoia
1
Ma
certo, trasgredire un suo consiglio sarebbe
un
grave danno e ne potrebbe venire fuori
un
lungo travaglio e liti e incomprensioni, meglio
obbedirle
per filo e per segno, in fondo
è
la Concetta di sempre, sempre prodiga
nelle
spiegazioni pronta a dire e ridire
che
una buona minestra si fa se l’olio è quello
che
viene dagli alberi antichi che svettano grigi
assolati
sui poggi e guardano il mare da un lato
e
i monti dall’altro a giusta distanza.
È
quasi ai novanta, borbotta cammina si ferma
al
balcone scruta si siede e sospira. I pensieri
vanno
veloci ma ancora conosce chi macina olive
sincere
e chi mette nei tomoli chiacchiere e frasche.
2
Alla
fine del banchetto la prova del nove
è
mettere olio sul pane di casa, assaggiare
lentamente,
schioccare la lingua, e aspettare.
3
Ero
appena un ragazzo quando al paese
venivano
a frotte le raccoglitrici, d’ogni età,
quasi
vecchie, donne robuste, bambine,
con
gli occhi aperti, le mani a geloni,
lo
scialle di lana annodato sul collo.
Un
pezzo di pane e due olive, un tarallo,
un
sorso d’acqua, due fichi. Cantavano
al
freddo le mani gelate, i piedi
nel
fango. “L’olio è sacro, lo sai?”.
“No”.
Mi pareva che fosse un liquore
che
sa dare anima al cibo. Solo questo,
ed
era un pensiero visto in chissà quale storia
appresa
la sera davanti al camino d’Antonia.
Il
frantoio era zeppo di gente,
la
macina andava veloce
tirata
dal mulo bendato.
Colava
dai fischi quell’oro
sfacciato
e solenne.
L’unto
era sempre nascosto appeso alla Croce.
4
ORA
È UNA CHIESA ABBANDONATA
Tutti
i corvi, scendendo da una nuvola pesante,
si
nascondevano sull’olivo davanti casa
che
subito volava verso l’orizzonte
con
la gioia di chi fa una marachella.
Lui
conosceva le opere dei grandi,
soprattutto
filosofi,
il
pensiero del vecchio Kant,
di
Socrate e Telesio.
I
corvi felici d’ascoltare
parole
incomprensibili. L’assenso
lo
davano mangiando molte olive.
Poi,
nella notte, a pericolo sparito,
l’olivo
ritornava a troneggiare
davanti
casa. La luna inargentava
la
sua chioma. Per quasi mille anni
produsse
olio grazie al suo pensare.
Le
idee erano linfa, ora è una chiesa
abbandonata,
il rifugio d’una scrofa.
5
IL
SUO VERDE ERA STANCO
Le
mattine di gelo aspro, la furia
della
tramontana che tagliava le mani,
e
l’infuriare della neve. Ma qualcuno
pensava
ad accendere un fuoco
di
rami secchi, un crepitare
di
ricordi proprio accanto a lui
forse
un po’ invidioso dei fratelli
che
digradando verso la pianura
gridavano
la gloria e l’abbondanza.
Il
suo verde era stanco, come chiuso
in
un cielo corroso.
Ma
ricordava il verde della terra
e
l’odore verde del suo nettare,
e
il canto della sua anima
che
bruciava traguardi e dava l’Unto
in
nome del Padre, del Figlio
e
dello Spirito Santo.
6
UN
LUOGO SACRO AI GIOCHI
L’antro
che nascondeva la capretta
nei
giorni di pioggia, quel mistero
che
aveva la faccia stupita. Era un’isola
di
beatitudine, un luogo sacro ai giochi
e
io ne inventavo dall’alba al tramonto
sempre
nuovi, accogliendo gli altri
al
ricovero. In dieci ci rifugiammo
durante
una tempesta
e
poi vedemmo l’orrore
negli
occhi delle madri: i lampi
vi
potevano colpire. Ridevamo felici
ancora
cullati dal calore del vecchio olivo.
Aveva
cuore grande e braccia lunghe,
un
gigante buono, una città di sogni.
7
QUANDO
DIO CREO’ L’OLIVO
Quando
Dio creò l’olivo e lo radicò
per
restare secoli e secoli all’addiaccio,
al
sole e alle tempeste, lo rese sacro
e
stabilì che fosse
l’albero
dell’amore.
Benedisse
le fronde
e
affidò al suo frutto
l’immagine
del Figlio.
Un
abisso di lumi lo scuote
ad
ogni autunno;
c’è
una dolce lussuria
nel
suo argento immacolato
e
s’io lo guardo nel tramonto impallidire
penso
a mia madre stanca:
lo
guardava paga e innamorata.
8
CHE
COSA SAREBBE IL MONDO SENZA L’OLIVO?
Passandoti
accanto,
ognuno
ti guardava compunto,
ti
bisbigliava una frase, ti diceva
una
parola dolce, ti sorrideva.
Dalla
finestra guardavo incapace
di
capire . La tua maestosità era una traccia
e
un invito, non cercavi né l’alba
né
la conoscenza, offrivi te stesso
nel
fiume dell’amore,
non
indicavi la strada
del
progresso, né quella che porta
alla
vita eterna, soltanto mormoravi,
appena
la brezza muoveva le sue braccia
o
balbettava qualche sussurro,
di
vivere in pace, e il contadino
pensava:
“Che cosa sarebbe il mondo
senza
l’olivo? Una povera cosa
in
attesa di nascere”. L’olivo ha un cuore
che
trasuda e spande intorno la gioia,
ha
le ali grandi, e le parole sante
per
gridare al mondo: pace, pace!
E
il grido s’apre in un vento caldo
che
copre l’universo. Onde si propagano
ripetendo:
pace, pace, pace.
9
L’ALBERO
CUSTODE
Niente
è eterno, eppure tu avevi
il
viso di Cristo radioso, e un’ombra
così
grande che temevo avvolgesse la mia vita
cancellandomi
i sogni turchesi intravisti
quando
a frotte ti piluccavano il cervello
torme
di passeri affamati.
Dove
sono quei sogni? Li hai nascosti
nel
tuo seno, oppure sono svaniti?
Da
qualche anno sei silenzioso
come
se ti specchiassi in me che ho perduto
la
freschezza del canto e l’armonia.
Ecco,
lo so, tu sei custode
del
dolore del mondo e del mio dolore
che
somiglia sempre più
ai
crisantemi calpestati il due novembre.
Niente
è eterno, e quando perirai
anche
l’ultimo mio fiato avrà perduto
consistenza
e i tuoi frutti saranno
un
canto metafisico, una nenia.
Va’,
allontanati da me, e sii sempre
le
mille braccia amorose, la vastità dell’amore,
sii
custode della mia anima fino a quando
potrai
sfidare i venti e ridere con gli arcobaleni.
Se
ti penso senza più radici
perdo
l’anima, mi marciscono gli occhi.
LA LETTURA - IL RACCONTO
Tutti d'un pezzo
di Annalisa Bellerio
La partita di
calcio finì e subito cominciò la pubblicità. Tommaso non si mosse dalla sua
postazione di fronte al televisore. Comparve un bambino che giocando si
rovesciava addosso ogni genere di schifezze, sotto lo sguardo soave della
madre, la cui serenità d’animo poggiava solidamente sull’esistenza di un certo
detersivo. Tommaso raccolse i pezzi sparsi del suo corpo di tredicenne e passò
in camera dei genitori per la buonanotte.
“Mamma, perché fai sempre tante scene quando torno
conciato dal calcio? Non potresti usare un detersivo di più concentrata forza
sbiancante?”
“Ma Tommy, cosa dici? Sai bene che la pubblicità ti
presenta un prodotto come se fosse miracoloso. Non vorrai crederci davvero!”
protestò la mamma, continuando a spalmarsi sul viso una costosissima crema
antirughe e “ridensificante” che, a quanto Tommaso ricordasse, nel corso dei
mesi non aveva visibilmente cambiato la situazione.
“Dai Tommaso, vai a letto che è tardi. Domani andrò a
parlare coi tuoi professori, quindi sarò qui a pranzo, e nel pomeriggio
verranno due mie colleghe per una riunione.”
La mattina
dopo, uscendo di casa, Tommaso incontrò il brillante avvocato del piano di
sotto, quello che telefonava per protestare ogni volta che lui suonava la
chitarra dopo cena coi suoi amici.
“Ciao Tommaso, vieni, ti accompagno con la mia nuova
macchina.”
“Grazie, ma la mia scuola è qui vicino…” cercò di
sottrarsi Tommaso, deciso a evitare quella poco gradita compagnia. Ma
l’avvocato lo prese praticamente per un braccio, spingendolo nella sua
direzione senza smettere di parlare.
“Oggi sono di ottimo umore. Domani parto per una vacanza
di dieci giorni ai Caraibi, in un’isola incontaminata, lontana dal traffico,
dall’inquinamento, dallo stress di questa orrenda città”, declamava l’avvocato
avviando il suo gigantesco fuoristrada, con cui ogni giorno percorreva pochi
isolati. “Non prendertela per l’altra sera, ma davvero io non posso sopportare
il rumore”, spiegò cambiando argomento, notando la scarsa propensione al
dialogo di Tommaso. In quel momento una bicicletta tentò di attraversare e lui
si attaccò furiosamente al clacson rompendo i timpani all’intero quartiere.
“Queste dannate biciclette! Sono un vero intralcio.”
Fu con grande sollievo che Tommaso arrivò a scuola.
Finite le
lezioni, si avviò verso casa senza fretta, perdendo tempo coi compagni. Si era
dimenticato che, contrariamente al solito, la mamma era a casa, dopo il
colloquio coi professori.
“Oh, eccoti finalmente, vieni a mangiare, Tommy”, lo
chiamò la mamma con voce che gli parve rassicurante. “Allora, la professoressa
di matematica dice che vai abbastanza bene, ma potresti fare di più.” Quando un
giorno Tommaso le aveva chiesto di fermarsi un poco per spiegargli meglio un
problema, lei aveva avanzato mille scuse. Per fortuna era intervenuta una
giovane supplente, molto più simpatica e disponibile. “Anche la prof. di lettere
è contenta, ma ti raccomanda di leggere molto.”
“Sì, Tommy, cerca di perdere meno tempo coi videogiochi e
prenditi dei libri”, intervenne Francesca, la sorella maggiore, disponendosi a
guardare la sua telenovela preferita.
Più tardi nel pomeriggio Tommaso prese la bicicletta per
andare in piscina, e lungo la strada si fermò in una libreria. Mentre rovistava
tra gli scaffali, arrivò una commessa. “Cerchi qualcosa di preciso? No? Bene,
per la tua età puoi scegliere romanzi classici, di avventura, dell’orrore, di
magia…”
“A me piacciono i racconti un po’ ironici.”
“Racconti ironici? Magari senza nessun intento didattico?
Ma no, per i ragazzi della tua età i racconti non sono previsti. Guarda qui,
c’è un’ampia scelta di romanzi, ti consiglio…”
“Ecco, questo un mio amico l’ha letto e mi ha detto che è
bello”, la interruppe Tommaso estraendo dallo scaffale un volumetto di racconti
di un autore sconosciuto.
“Non dovresti essere così influenzabile”, commentò con
tono acido la commessa, avviandosi alla cassa.
Dopo un’ora di
nuoto, Tommaso incontrò i suoi amici negli spogliatoi e cominciarono a parlare
tutti insieme.
“Insomma, ragazzi, che confusione che fate, e che
disordine che lasciate in giro! Non siete i soli qua dentro!” protestò un
signore appena uscito dalla doccia, dove era stato circa mezz’ora, ignorando la
coda di quelli che aspettavano il loro turno.
Fuori, cominciava a piovere. Tommaso inforcò la
bicicletta e corse a più non posso, sfrecciando nel traffico lento e zigzagando
abilmente tra i passanti.
“Ma dico! Credi di essere il padrone della strada?” lo
rimproverò un signore mentre raggiungeva con calma la sua automobile che,
lasciata in seconda fila a motore acceso, aveva creato un discreto ingorgo.
“Si credono unici al mondo, non hanno nessuna attenzione
né rispetto per gli altri”, concordò un’elegante signora, mentre il cane che
teneva al guinzaglio faceva i suoi bisogni in mezzo al marciapiedi.
Tommaso non riuscì a evitare di arrivare a casa
completamente bagnato.
La mamma, in compagnia di due colleghe, quando lo vide
rimase sconvolta.
“Tommy, ma sei fradicio! E poi con quei pantaloni, che ti
lasciano la pancia fuori! Non potevi metterti una giacca, o un impermeabile? Ti
verrà un accidente!”
“Per i giovani la moda è più importante della comodità”,
sentenziò la collega bionda, barcollando pericolosamente sui tacchi a spillo.
“E non hanno nessun riguardo per la propria salute”,
aggiunse l’altra collega, accendendosi l’ennesima sigaretta.
Dopo cena, suo
papà lo guardò con aria severa. “Tommy, mi avevi detto di aver fatto mettere a
posto i freni della bicicletta, invece ho visto che sono esattamente come
prima. È pericoloso, lo capisci? E poi non mi piace affatto che tu non dica la
verità.” Fu interrotto dal suono del suo cellulare. “Sì? Ah, buonasera
ragioniere. No, non sono in casa in questo momento e non posso controllare. No,
tornerò tardi… cercherò di vedere domani. Sì, ci risentiamo, buonasera.” Spense
e sbuffò. “Quel rompiscatole, non riesco a liberarmene. Mi raccomando”, disse
rivolgendosi a tutti i presenti, “se chiama qui il ragionier Fuselli, io
stasera non ci sono.”
“Ciao a tutti, io esco”, salutò Francesca infilandosi il
giaccone.
“Dove vai?” chiese la mamma.
“Vado al cinema con Stefano.”
“Ma come, non avevi detto che non volevi mai più sentirlo
nominare?”
“Ho cambiato idea”, tagliò corto Francesca chiudendo la
porta.
“Cosa vuoi”, commentò il papà rivolto alla mamma,
scuotendo la testa, “dai giovani non si può pretendere la coerenza.”
(12-7-2007)
Il corpo della modella
di Annalisa
Bellerio
L’aula di
figura era affollata e avrei già dovuto iniziare la lezione, ma la modella non
arrivava ancora. Il ritardo si dilatava e così la mia impazienza e il mio
nervosismo. Gli studenti e i frequentatori esterni del corso parlavano a voce
alta tra loro o al cellulare ingannando l’attesa, voltandosi ogni tanto verso
di me con aria interrogativa. Suonò il mio telefono. Era Simona, la modella che
usavo spesso ed era sempre puntuale. Mi spiegò che era al pronto soccorso, era
scivolata sui gradini della metropolitana umidi di pioggia e aveva una caviglia
gonfia e dolorante. Le dispiaceva molto ma non era riuscita ad avvisarmi prima
e neanche a rispondere alla mia chiamata. Le dissi di non preoccuparsi e le
feci gli auguri, cercando di controllare il disappunto. Non facevo più in tempo
a chiamare qualcun’altra a sostituirla, non mi restava che dirottare la lezione
su una scultura o un modello anatomico in gesso. Mentre mi muovevo verso il
deposito, mi si avvicinò una giovane donna che avevo visto più volte al mio
corso, di cui ricordavo qualche lavoro dal tratto incisivo e essenziale.
“Professore, mi scusi, ho capito che la modella ha avuto
un incidente e non può venire, se a lei va bene posso posare io al suo posto.”
La guardai sorpreso. Aveva un corpo esile e un viso
minuto, capelli scuri molto corti e due occhi che mi guardavano seri,
traboccando di riflessi verdi e di malinconia.
Non aveva certo l’aspetto consueto della modella dei
pittori, dalle forme piene e generose, se non addirittura abbondanti. Sembrava
piuttosto una ballerina classica, attardata in un fisico adolescente. Ero
incerto, ma anche tentato da quell’offerta imprevista.
“Ha mai posato?”
“No.
“Ci vuole molta pazienza e disponibilità a stare a lungo piuttosto
scomodi e in questi giorni anche al freddo.”
“Penso di poterci provare.”
“Va bene. Proviamo.”
Lei si ritirò dietro il paravento a spogliarsi e
ricomparve con addosso soltanto una lunga camicia e così salì sulla pedana e si
sedette sul piano d’appoggio coperto da un materasso e da un’ampia tela
drappeggiata. Si tolse la camicia e rimase nuda, con un piede a terra e l’altro
appoggiato sul materasso, tenendosi con una mano la caviglia della gamba
piegata e voltandosi verso di me con una rotazione del busto.
“Come mi devo mettere?”
Gli allievi del corso guardavano un po’ stupiti e un po’
divertiti la compagna che si improvvisava modella, ma nessuno trovò la cosa
troppo eccentrica. Non ci furono obiezioni né commenti inappropriati. Uno dei
più creativi le girò intorno considerandola da più angolazioni e alla fine
disse: “Secondo me potresti stare così”. Gli altri erano d’accordo con lui.
Preferisco far decidere alla classe le pose da adottare,
così salii sulla pedana a sistemare la stufetta in modo che fosse orientata il
meglio possibile verso quel corpo esposto alle gelide correnti dello stanzone
in cui ci trovavamo. Tutti cominciarono a disegnare, sui banchi o in piedi al
cavalletto, oppure seduti precariamente tenendo appoggiato verticale su un ginocchio
il foglio fissato a un supporto.
Guardavo la giovane donna che stava in posa con
naturalezza, ma assorbita e compresa nel suo ruolo. Aveva una struttura leggera
ed essenziale fatta di poca carne compatta attraverso la quale si indovinavano
le ossa, sottili ed eleganti. In realtà non sembrava un’adolescente. Non faceva
pensare a forme acerbe in divenire, e la sua non era affatto una magrezza
emaciata, ma come distillata, delicatamente liberata del superfluo, e percorsa
da una tensione consapevole e matura.
Girai per la classe a osservare il progredire dei lavori.
Tutti si accorgevano di come la nuova modella richiedesse una costruzione
anatomica rigorosa, perfettamente sorvegliata, che non poteva nascondersi
dietro volumi gonfiati e linee espanse, ma rimaneva ineludibile in trasparenza.
Era una prova difficile, una sfida stimolante. Avevo voglia di tirar fuori
anch’io un foglio e mettermi a disegnare, continuai invece a intervenire qua e
là come il solito, con correzioni, osservazioni e suggerimenti.
Ogni tanto qualcuno si alzava e cambiava il punto di
osservazione, iniziando un nuovo disegno con una prospettiva differente.
Dopo quasi un’ora in cui la modella non si era mai
lamentata e non aveva mai chiesto di potersi muovere, proposi un intervallo di
riposo prima di una nuova posa. Lei si coprì e si alzò per sgranchirsi, io mi
complimentai per l’atteggiamento professionale e le portai un caffè. Lei
intanto si mise a girare per la classe guardando come ipnotizzata i disegni che
la ritraevano. Tirò addirittura fuori il cellulare e ne fotografò alcuni. Poi
tornò sulla pedana pronta alla nuova posa, questa volta distesa su un fianco, e
così rimase, ferma ma non rigida, per più di mezz’ora.
Alla fine della lezione si rivestì in fretta e girò
ancora tra i banchi irresistibilmente attratta da quei disegni. Qualcuno degli
autori più produttivi gliene regalò uno, con sua timida ma evidente
gratitudine.
“Buongiorno professore, ciao Olga e grazie” salutò un
ragazzo uscendo dall’aula.
Aspettai che lei tornasse verso di me per darle il
compenso che le era dovuto, ma lei lo rifiutò.
“L’ho fatto per me” dichiarò. Chissà cosa voleva dire.
“Grazie, Olga” le dissi anch’io, usando per la prima
volta il suo nome.
Per la lezione successiva convocai un’altra modella del gruppo di quattro o cinque su cui potevo contare e che chiamavo a rotazione. Seduta tra gli altri allievi individuai Olga, che mi rivolse un breve sorriso. Durante l’intervallo mi avvicinai al suo banco curioso di vedere quello che aveva eseguito durante l’ora precedente e le chiesi se avesse da mostrarmi altri suoi lavori. Aprì la cartelletta e lasciò che esaminassi quei corpi accennati, non finiti, attraversati da un senso di irrequietezza, di sofferenza o di vuoto. Avevano qualcosa di commovente e insieme di inquietante.
Mentre riponeva i fogli che via via le restituivo notai
che si era tagliata un dito con la carta e che il sangue rischiava di macchiare
i disegni. Le presi la mano alzandola davanti al suo viso.
“Attenta, ti sei fatta male.” Ormai ci davamo del tu.
Appena si accorse della ferita si allontanò da me con
violenza e con un’espressione di terrore, e cominciò convulsamente a tamponare
il sangue che usciva, tenendosi il dito avvolto in due o tre fazzoletti. Finì
di mettere via i fogli, chiuse la cartelletta e se ne andò via senza neanche
guardarmi.
Che strana creatura, pensai. Da artista mi sentivo
anch’io un emotivo, ma una simile reazione era davvero sproporzionata.
Per due settimane non la vidi. Mi rendevo conto che
entrando nell’aula di figura la cercavo tra i presenti e che la sua assenza mi
lasciava deluso. Quando ricomparve provai un innegabile senso di sollievo. Si
scusò dicendo che aveva avuto problemi di lavoro, sembrava comunque piuttosto
tranquilla e così a fine lezione ne approfittai per farle la proposta a cui
avevo a lungo pensato in quei giorni. Stavo preparando una mostra di quadri
miei e mi sarebbe piaciuto che lei si prestasse ancora a fare da modella,
questa volta per me.
Arrivava
puntuale nel mio studio, si spogliava e si appoggiava ai cuscini, ritrovando
facilmente la posa stabilita. I suoi umori erano molto variabili. C’erano
giorni che se ne stava chiusa in se stessa e se ne andava senza dire quasi una
parola, e altre volte in cui si presentava con aria più rilassata e disponibile
e con un po’ di voglia di parlare. Mi raccontò che lavorava come grafica e le
era sempre piaciuto disegnare, ma il mio era il primo corso di figura che
seguiva dai tempi della scuola. Aveva ripreso da sola a studiare arte, e ne
discuteva con me volentieri.
Della sua vita
privata non parlava mai ma sembrava che tutto quanto faceva lo facesse da sola.
Scoraggiava ogni tipo di confidenza, controllava i gesti affettuosi, evitava il
contatto, se non quello con gli oggetti e quanto di inanimato la circondava.
Un giorno si fermò un po’ più a lungo nel mio studio a
guardare i miei vecchi lavori, schizzi e disegni accumulati negli anni. Tra
tanti ritratti femminili, uno la colpì particolarmente.
“Era solo una modella?”
“No. È una donna a cui sono stato legato.”
“Eri innamorato?”
“Direi di sì. O comunque ha lasciato un segno.”
“Che tipo di segno?”
“Un segno nella mia storia, nella mia immaginazione,
nella mia anima. Nessuno su di te ha mai lasciato un segno?”
Vidi ancora sul suo volto quell’espressione di muto
terrore.
“Sì, un segno. Nel mio sangue.”
Completai le
opere che volevo presentare in mostra, tra cui i nudi per cui lei aveva posato.
Rimase a lungo a guardarli tutti insieme, assorta come era stata davanti ai
disegni dei compagni per i quali aveva fatto da modella la prima volta.
“Come ti sembrano, ti riconosci? Pensi che sia riuscito a
cogliere qualcosa di te, oltre la superficie?”
“Mi piace come mi vedi. Nelle tue tele il mio corpo non
fa paura.”
“Paura? E perché mai dovrebbe fare paura? Il tuo corpo
può suscitare diverse emozioni, ma davvero non direi la paura.”
Mi sorprendeva spesso con quei commenti improvvisi e
incongrui, che lasciava cadere senza mai prestarsi a una spiegazione. Avevo
l’impressione che avesse bisogno di specchiarsi nell’immagine che gli altri
coglievano e tratteggiavano di lei, che non sapesse come affrontare se stessa e
cercasse altri punti di vista.
Il suo atteggiamento alla vernice della mia mostra sembrò
confermare questa idea. Rimase tutto il tempo un po’ in disparte, a osservare
le reazioni dei visitatori alle opere in cui l’avevo ritratta. Se ne andò come
sempre immersa nei suoi pensieri.
Anch’io mi immersi nei miei.
Un giorno
arrivò in galleria in un’ora in cui sapeva che oltre a me non c’era nessuno. Mi
si sedette accanto gustando a lungo il silenzio e la sola presenza delle opere
esposte.
Era però una delle rare occasioni in cui sembrava avere
voglia di parlare. Voleva ringraziarmi per averle dato quella opportunità.
“Vorrei poter vivere soltanto sulla carta, sulla tela, in
un’opera d’arte. Vorrei essere davvero quella che hai visto tu mentre posavo, e
i compagni del corso, e la gente che è venuta a visitare la mostra. Vorrei che
il mio corpo fosse davvero quello” disse accennando alla propria figura dipinta
in un quadro che le stava davanti.
Guardò la mia faccia perplessa e un po’ preoccupata e
questa volta proseguì, con tono quasi di sfida. “Non posso più continuare a
tacere. È successo nell’estate di due anni fa, durante un viaggio dall’altra
parte del mondo. Niente faceva pensare che potesse finire così. So che ora
anche tu non mi vorrai più vedere, non verrò più neanche al corso, ma ti devo
avvisare.”
“Che sei sieropositiva?”
Spalancò gli occhi per lo stupore. “Come lo sai?” mi
chiese.
“L’ho capito.”
Era spiazzata e cominciò a tremare.
“Il mio corpo è pericoloso, per me e per gli altri. Chi
lo sa ha smesso di frequentarmi e mi sta lontano.”
“Io non l’ho fatto.”
Mi guardò con gli occhi pieni di lacrime e fuggì via
quasi correndo. Io non mi mossi.
L’avrei cercata là dove si era perduta. L’avrei trovata.
E lei alla fine sarebbe tornata.
IL LIBRO
Il poeta è un
clandestino
di Angelo Gaccione
Confesso di
avere avuto più di una perplessità ad affrontare questo nuovo libro del poeta
cosentino Carlo Cipparrone: “Il poeta è
un clandestino” (De Felice Edizioni 2013, Pagg. 128 € 12,00), per più di
una ragione. Basta già il tono asseverativamente perentorio a scoraggiare
chiunque vi si voglia applicare. Siamo di fronte ad un libro ultimativo, in più
di un senso; stringente nel suo rigore dialettico, spietato nella sua verità;
scettico e tuttavia irriducibile. Il libro si presenta al lettore come una
lunga sincera confessione, senza bluffare
e senza voler nascondere il bilancio di un personale fallimento di poeta. Agli
addetti ai lavori (critici, sodali di penna e colleghi poeti) si presenta
invece come una parabola dispiegata su più piani per minarne ogni certezza,
ogni sicumera, consapevole, alla fine di una lunga carriera di poeta, che poco
o nulla resterà nell’affollata foresta della poesia, se non qualche robusta
pianta secolare: gli arbusti, gli alberelli, (a cui egli stesso si mescola)
faranno vita stentata all’ombra di quegli alberi giganti, per finire
inesorabilmente nell’oblio. Il tempo non perdona ed il peso dei poeti nella
società si è ridotto fino a divenire trascurabile, se non inesistente.
Antilirico per eccellenza, questo lungo discorso di un
poeta sulla poesia e i suoi dintorni, è strutturato in versi (perché questa è
la sua cifra), ma ha l’andamento prosastico e ragionante di un vero e proprio pamplet critico, a cui poco,
oggettivamente si può opporre. Chiunque è stato in questi ultimi trent’anni
dentro il territorio affollato e magmatico della poesia, non potrà che
riconoscere quante le sconsolate e disilluse proposizioni del poeta calabrese
siano vere. Dalla sua ha inoltre due privilegi: di aver raggiunto un’età che
non permette inganni (80 sono ora gli anni del poeta); di aver guardato
all’affannarsi e al brulicare dei gruppi, dei movimenti, delle tendenze e delle
scuole, da un osservatorio decentrato (la sua Cosenza) con un occhio lucido e
scevro da facili abbagli. Una Cosenza tuttavia ricca di personalità poetiche di
primo piano, e che conserva tuttora alcune delle voci più significative ed
interessanti del fare poesia nazionale. Basti citare per tutti “Capoverso” ed
il nutrito gruppo che vi ruota intorno.
La lunga premessa stessa dell’Autore (sono dieci
densissime e argomentative pagine in cui egli ragiona a tutto campo sul suo
lungo percorso di poeta, sul suo fare poesia, sulle sue “visioni” estetiche,
sulle sue pulsioni, e ce ne dà ragione senza fare sconto agli altri ed a se
stesso, con un misto di demitizzante autoironia, come poche volte mi è accaduto
di leggere in un poeta contemporaneo) è così conchiusamente circolare nella
analiticità della sua critica, così minuziosamente definita (dall’interno) dalle sue parole, che non
saprei come si possa dir meglio (diciamo così dall’esterno, da altri) dei suoi versi e del suo fare poesia. Anche
questo un altro dei motivi scoraggianti di cui dicevo all’inizio, e dunque
forse vale la pena vederne dei lacerti di questo “ragionar critico” di
Cipparrone.
“Quella contenuta in questo libro può definirsi,
pertanto, una scrittura dove le questioni metaletterarie si intrecciano ai temi
poetici dando vita a un discorso lucido e razionale; l’autore è, infatti,
prevalentemente impegnato ad indagare ed analizzare, ora con maggiore evidenza
ora in modo più sotteso, le ragioni della stessa poesia con amara e insieme
ironica obiettività, giudicando il proprio lavoro poetico e quello degli altri
autori con la stessa imparzialità (…)”. E a proposito della sua di poesia,
scrive: “(…) Sul piano stilistico questo ritorno all’umiltà e alla concretezza
coincide con una ripresa dialogale, discorsiva, pacata, che riconduce a una
poesia di tipo saggistico e accetta l’ironia come umanissima misura di
giudizio. Sobria, colloquiale, disincantata, essenziale nella concretezza delle
immagini, questa poesia rifiuta preziosismo ed estremismo, tendendo a
ricondurre indietro il discorso poetico, un po’ più indietro della meta ideale
(il bello), erogandola magari allo stato ancora grezzo di riproposta,
attraverso ragionamenti calmi e distaccati, esercitazioni ironiche ed
autoironiche, in cui pure è possibile scorgere la sopravvivenza di
un’immedicabile malinconia meridionale”. Per la pregnanza del dire e per come
Cipparrone illumina la sua poesia (e ci illumina), tutti i concetti più
salienti di queste pagine andrebbero qui riproposte. Uno dei testi poetici va
tuttavia riportato in questo contesto, se non altro a conferma del suo concreto
procedere in versi: “Non pretendiamo
troppo/ dai nostri versi, non chiediamogli/ nulla di più di ciò che sono:/
scorie di bosco, inariditi rami,/ foglie secche, tozzi di legno/ che ardendo si
consumano./ Servono a tener vivo il fuoco./ Altri verrà dopo di noi/ a dar
forza alla fiamma/ a sollevare più alte faville./ (Altri verrà).
Ho scritto in un saggio per un Convegno, diversi anni fa,
che “le teorie” poetiche (o se volete le motivazioni) sono tante quanti sono i
poeti; ed è giusto che sia così. Non sono invece molto sicuro di quella che
Cipparrone richiama anche nel titolo del suo saggio-poema: la clandestinità dei
poeti.
Anche il più decentrato, il più nascosto, il più
appartato di essi, finisce per venire alla luce attraverso pagine di libri e di
riviste, e di consegnarsi fatalmente ad uno spazio pubblico, ad un agorà.
Quanta questa esistenza possa rivelarsi precaria, Cipparrone ce lo mostra, ma i
buoni versi restano buoni versi, anche se spesso sommersi da un surplus
quantitativo divenuto soffocante. Del resto era stato Antonio Mignosi a
scrivere questo divertente aforisma: “Vermi e sorci, mosche pidocchi e poeti,
che tutte le armi della terra non riescono a sterminare”; dunque non avremo
scampo. In questi giorni in cui prendevo in mano il libro di Cipparrone,
curiosamente a parlarmi di “clandestinità” è stato il filosofo Fulvio Papi; e di
“poetica del fallimento” in una email
dalla Croazia, la scrittrice Nelida Kruliač. Sicuramente Cipparrone è stato un
poeta parco e avveduto, ed ha pubblicato le sue poche raccolte ad intervalli di
tempo molto lunghi, come dovrebbe fare un vero poeta (Le oscure radici nel 1963; L’ignoranza
e altri versi nel 1985; Strategie
nell’assedio nel 1999); tuttavia per la sua parabola poetica non si può
parlare né di clandestinità, né di fallimento: non solo per essere stato, e di
esserlo, animatore del dibattito poetico (riviste, quotidiane, antologie,
legami e contatti con personalità di primo piano di quel mondo), ma perché i
suoi versi hanno varcato anche i confini nazionali, come è attestato dalla
traduzione di due suoi libri in Polonia e in America.
LA LETTURA
Il fragile contorno delle
parole
di Annalisa Bellerio
Uno struggente e umanissimo
racconto di Annalisa Bellerio
Secondo piano. Mi
investe il solito odore di minestra e disinfettante. Sono più di sei mesi che vengo
in questo posto quasi tutti i giorni e ancora non riesco ad abituarmi, a questo
odore.
Quasi in fondo al corridoio, la stanza di mia madre è come
sempre nella penombra, le veneziane abbassate. Lei è lì, seduta accanto alla
finestra con un libro chiuso in grembo.
In che stato sarà oggi? Guarda un punto imprecisato con
un’aria persa che mi mette in allarme. Sdraiata sul letto di fianco la sua
compagna di stanza dorme, o comunque è del tutto assente. Come quasi sempre.
“Ciao mamma, sono Elisa, eccomi qua.” Mi presento ogni
volta, nell’inconfessato timore che anche il mio nome possa stingersi nella sua
mente, e svaporare. “Ho fatto tardi, lo sai, il sabato sono tutti a casa e c’è
sempre qualcosa che si mette di traverso. Come stai? Cosa stai leggendo?”
Domanda retorica. Lo so benissimo. Da due mesi ha in mano
quel romanzo di Isabel Allende e non riesce ad andare avanti. Non ricorda a che
punto è arrivata. Non ricorda i personaggi, che cosa è successo prima. Deve
tornare continuamente indietro. Si scoraggia. Pianta lì. La mamma non risponde,
ma mi guarda con un vago sorriso. Buon segno.
“Come diavolo fai a vederci? Come fai a leggere qui?” Faccio
entrare uno spiraglio un po’ più deciso di luce dalle veneziane, e subito la
compagna di stanza si agita emettendo sibili indecifrabili.
“Mamma, andiamo fuori di qua.” La prendo sottobraccio e
lentamente ci incamminiamo verso il corridoio, e giù nel giardino che nei fine
settimana si affolla di parenti di ogni fascia di età, compresi bambinetti
tenuti a freno perché qui tutto è fragile e va al rallentatore.
“Vuoi che ti legga io un po’ del libro?” La mamma annuisce
con espressione riconoscente.
Comincio a leggere. Lei era maestra, ha insegnato a leggere
a centinaia di bambini, e anche a me. Avevo cinque anni e la vedevo assorta nei
suoi libri, ne ero curiosa, ne ero gelosa, era un mondo misterioso in cui i miei
genitori e mio fratello si rinchiudevano e io restavo fuori. Con pazienza, la
mamma vi aveva fatto entrare anche me. Ma ora le parole le sfuggono, si perdono,
e lei cerca in tutti i modi di ritrovarle e trattenerle accanto a sé, nei tre
scaffali con i suoi libri più cari, il giornale, il blocco per gli appunti, la
radio, il dialogo faticoso con me, un poco ogni giorno.
Chiudo il libro e comincio a parlare, piccoli, minuscoli
aggiornamenti, marito, figli, parenti, conoscenti, la casa, il lavoro, i libri.
Le racconto anche i libri che leggo, come una volta lei faceva con me bambina,
quando mi recitava storie e poesie. Si alza un po’ di vento.
Torniamo lentamente nella stanza, dove è arrivata Paula che sta
sistemando la biancheria della vicina di letto, raccoglie cose da lavare, tira
fuori giornali illustrati e succhi di frutta.
“Buongiorno, Paula.” Un giorno lei ha visto il titolo di un
libro della mamma e mi ha detto che quello è il suo nome. È giovanissima,
peruviana, parla pochissimo l’italiano, parla pochissimo in generale. È
comparsa da un mese, viene due volte alla settimana per occuparsi della signora
Elena, il cui figlio lavora come rappresentante sempre in giro per l’Italia,
sempre affannato. L’ho visto quattro o cinque volte, mentre ascoltava stancamente
sua madre tirar fuori con fatica parole di rimprovero e lamentele. Paula è premurosa
e gentile, anche con Elena che la tratta ruvidamente e con lei non parla quasi
mai, perché dice che è inutile, non sa l’italiano. A me invece piacerebbe poter
parlare con questa ragazza dolce, mi ha detto che la sera studia, che qui ha la
mamma e una sorella, che abita lontano, deve prendere la metropolitana e un
pullman.
Mi siedo accanto alla mamma, cercando di parlare piano.
“Sai mamma, ci siamo finalmente, lunedì Silvia si laurea. In
medicina, ricordi? Avremo un medico in famiglia, sei contenta?”
La signora Elena emette un sibilo. Ci fermiamo. “I medici…”
Aspettiamo, educatamente. Vuole dirci qualcosa.
“I medici, son tutti…”
Nessuno osa fiatare.
“Delinquenti.”
Restiamo immobili, in silenzio. Paula mi guarda con i suoi grandi
occhi scuri spalancati, la mamma rimane impassibile. Almeno abbiamo scoperto
che la signora Elena ci sente bene. E che aveva un messaggio da lasciare al
mondo.
“Buongiorno Elena, buongiorno Valeria, come andiamo?
Buongiorno a tutti.”
Appena entra l’infermiera, Elena si gira dall’altra parte,
fa cenno a Paula di andarsene, la ragazza raccoglie le cose, ci saluta e se ne
va.
“Valeria, oggi la vedo proprio bene, ma quando c’è Elisa sta
sempre bene, vero? Anche noi parliamo però, sa? Ci raccontiamo. Durante la
settimana, quando non ci sono i parenti. Domani sarà anche peggio. Domani è il
mio onomastico, come ogni settimana, ricorda come mi chiamo? Do… Do…”
La mamma la guarda un po’ persa, mi viene l’ansia, ma che
modo è, mia mamma non ha tre anni, ma improvvisamente le si spiana il viso:
“Domenica”.
“Domenica, proprio così…”
Delle grida arrivano dal corridoio e compare un’inserviente.
“Domenica, presto, c’è Piera che…”
“Oh Maria Vergine, scusate, devo andare, ci siamo di nuovo.”
Piera sta gridando, c’è un trambusto in corridoio, Elena
lancia un sibilo, la mamma si stringe le mani spaventata.
Cerco di riprendere la conversazione. “Allora, ti dicevo di
Silvia, che si laurea in medicina. Sì, Silvia, Silvia…” Ripeto il nome, in
attesa.
“Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale… quando beltà
splendea negli occhi tuoi ridenti… e fuggitivi.” Fa un respiro profondo.
Proseguo in quello che ormai è un rituale a cui nessuna delle due sa
rinunciare.
“E sai, forse tra un paio di settimane verrà Federico dalla Germania.
Sono tre mesi che non vedo Federico. Federico.” Aspetto.
“Sta Federico imperatore in Como. Ed ecco… un messaggero entra in
Milano…”
Io la ascolto recitare a memoria e mi si allarga il cuore.
Ogni giorno, ogni
volta, le lancio l’esca e lei aspetta e la raccoglie. Non ricorda i nomi delle
cose, delle persone, si innervosisce e si avvilisce, ma ricorda alcune poesie e
questo la rasserena.
Ma martedì il rituale si inceppa.
Arrivo di corsa dopo il lavoro, le lascio il giornale sul
comodino, la vedo distante e spenta.
Non sorride neanche a Paula, che mi guarda preoccupata.
“Mamma sono Elisa, ecco qui, guarda cosa ti ho portato.”
Accendo l’IPad. Me l’ha regalato Federico e non lo padroneggio ancora, smanetto
impaziente in cerca delle foto. “Guarda, la laurea di Silvia. È stata brava,
sai? Eccola qui, quando esce. E questi sono i suoi amici. Purtroppo Federico
non è riuscito a venire a festeggiare sua sorella, non poteva prendere ferie.
Guardala come è felice, stasera fa una festa, domani ha detto che viene con me
a trovarti. Sei contenta? Vengo con Silvia. Silvia.” Aspetto. Aspetto.
“Silvia, rimembri… il tempo…” Mi guarda sperduta. Oddio.
“… della tua vita mortale”, le suggerisco piano, ma lei scuote la
testa, mi guarda con disperazione, indica qualcosa, fa fatica a parlare.
“Il libro, vuoi il libro?” Cerco Leopardi convulsamente negli
scaffali, non lo trovo, dov’è?
“Sotto il… il…” Indica sempre più in affanno, no, ti prego, stai
tranquilla. Tu e anche io.
“Sotto cosa? Il giornale? Il comodino?” Mi muovo frenetica, guardo
sotto il letto, sotto il cuscino. Mi trovo Paula di fianco, alza il plaid
posato sul letto e mi porge il libro che era lì sotto. Benedetta ragazza. Sto quasi
per piangere come una bambina, ma la bambina è lei, quanti anni hai, quindici,
sedici? E sei così attenta, solida, discreta.
“Grazie Paula.”
Il plaid. Il plaid.
La mamma prende il libro, le mani le tremano. “Gli…”
“Gli occhiali?” mi affretto a dire. “Sì, te li do subito, sono nel
cassetto?” Non ci sono. “Nell’armadio? In una borsa?”
“Là, sul…”
Su che cosa, per carità del Signore, devo stare calma. Sul tavolo?
Non ci sono.
Ho un’illuminazione: “Sul davanzale della finestra?” Eccoli.
Glieli do. Sono sfinita e mortificata quanto lei.
Metto a posto le cose che ho tirato fuori dal cassetto e dalla
borsa.
Mi trovo in mano il blocco. Con qualche appunto.
Mi attraversa un ricordo. Un pensiero.
Prendo un pennarello dalla mia borsa e torno a sedermi col blocco
in mano, lo sfoglio fino alla prima pagina bianca e scrivo in grande davanzale, poi su un altro foglio scrivo
plaid, e poi armadio, e poi comodino, cassetto, poltrona, finestra, quadro, specchio, lampada,
e così via, scrivo almeno venti parole ognuna su un foglio che poi stacco, la
mamma mi guarda, Paula mi guarda, io guardo loro. “Ora mi serve lo scotch.” Mi
alzo e mi avvio alla porta, chissà se Domenica ha lo scotch, o forse giù in
segreteria.
“Signora”, sento chiamare. È Paula, con un rotolo di scotch in
mano.
Questa ragazza è incredibile, come diavolo fa ad avere lo scotch,
comunque grazie, stacco i pezzetti e attacco i fogli, ognuno al suo posto.
Sembra un’aula scolastica, di prima elementare.
La mamma ha gli occhi che brillano, è così che mi ha insegnato a
leggere, col gioco dei foglietti che faceva coi suoi alunni. Ora che il tempo e
la malattia hanno invertito le parti, sono io ad allestire il gioco, non perché
lei scopra le parole, ma perché non le perda, perché non le senta scivolare via
dalle cose, lasciandole spoglie e mute.
Paula ha i grandi occhi incantati, persino Elena per un attimo perde
la sua espressione assente e ne assume una quasi stupita.
Vado via prima di Paula, sono esausta.
Il giorno dopo torno
a casa e lascio andare Silvia da sola dalla nonna, le porta un libro di
racconti brevi (“così non perde il filo della trama”) e una serie di post-it e
cartoncini di vari colori e dimensioni. Sono tre settimane che non si vedono, Silvia
poi mi racconta che all’inizio è stato imbarazzante, ma poi i fili si sono
riannodati, insieme hanno dato i nomi alle cose (“come Adamo, ha detto la
nonna”) sulla carta colorata, e ogni tanto qualcuno entrava a guardare.
Nei giorni seguenti la trovo tranquilla, di buon umore. Il gioco
la rassicura, le dà appigli. Non oso riproporre il rituale delle poesie, non
ancora, le parlo della nuova ragazza tedesca di Federico, si chiama Edelgard,
non credo che il nome le susciti echi letterari, non mi pare le susciti echi in
assoluto ma è un argomento nuovo che ho a disposizione.
Sabato arrivo nel pomeriggio, e insieme al solito insopportabile
odore sono assalita anche da Domenica, Piera ha avuto una crisi violenta, è
andata in giro per il reparto a gridare e fare danni, è caduta e si è rotta il
femore, l’hanno portata via da meno di un’ora.
“È entrata anche da sua mamma, prima che riuscissimo a fermarla, ha
strappato tutti i cartellini colorati, in un’altra stanza ha rotto un vaso di
fiori…”
Scappo via, non oso pensare cosa troverò, come la troverò, chissà
se è passato un medico, bisognerà darle qualcosa per calmarla, questa Piera
possibile che riesca ad andare in giro a fare tutto ’sto casino, devo cercare
di stare calma altrimenti la metto ancora più in agitazione.
Mi affaccio sulla porta con cautela, pronta al peggio.
Trovo una calma perfetta. Elena dorme. La mamma è seduta in
poltrona, Paula è seduta accanto a lei. Sta scrivendo parole su nuovi
cartoncini. Molti sono già stati riattaccati agli oggetti corrispondenti. La
mamma fa capire a Paula che ha scritto una parola sbagliata, tovaglia non
toalla, lei prende un altro cartoncino e riscrive, la mamma annuisce.
Mi avvicino, mi vedono e sorridono entrambe. Il gioco non si è
rotto, il gioco continua.
Le parole non andranno perdute. C’è Paula a raccoglierle.
Le restituisce alla mamma, e intanto le trattiene per sé.
LA LETTURA
Emblema
Racconto di Cesare Vergati
Il vegliardo sapeva per lui e sovrunamo sforzo quando a mano tremebonda
lentamente – quasi rosso fuscello il vento leggero che piega appena, oramai
magro esile – l’aspetto al passante che curioso lo osserva / il vecchiardo
intento a minimi lavori cosiddetto giardinaggio il primo mattino già fievole
luce incerta al giorno, lentamente l’uomo vecchio tremebonda la mano curva in
avanti il busto, la grandissima fatica quante volte giunge a morte, la grande
idea di raccogliere e chicco caffè da porre certamente accanto chicco grano
chicco frumento se la stravaganza visionario il vecchiardo esausto
all’esistenza; così il vecchio uomo il mostruoso tentativo suda il difficile atto
– quando il neofita ambisce alla vetta più alta, l’altra mano a tenere tanto
tremebonda e piccolo panno a croma unicamente scarlatto – lo splendore il
persiano abito di rosso tinto, per cui comunque riesce il sudore a tergere se
stupida traspirazione tale irritante incolore liquido l’organismo tuttavia in
marasma, la gioia intensa in sé dentro perché a mezzo cammino sicuramente il
lieve accenno e delicato il sorriso l’uomo vecchio in ultimo di vita – a
ricordo il presente signore e anziano, lo chiamano chissà senile, il lungo
questo invernale pomeriggio lo spento camino presso indubbiamente su sedia a
dondolo seduto / come a piena mente molte le ricordazioni quando fanciullo
quando uomo d’affari sapeva il nonno la casa colonica, la vasta cucina il
parente a piegare busto e corpo la ricerca i chicchi grano riso frumento caffè –
(fosse a modo di dire primo raccoglitore, a fare collezione d’oggetti rari
preziosi strani), perché a mezzo cammino sicuramente il lieve accenno e
delicato il sorriso l’uomo vecchio in ultimo la vita che pervicace caparbio, la
forza d’essere che si accanisce alla meta, semplicemente – lo sforzo sovrumano,
continua solenne e lento piegamento la tremebonda mano verso il grossolano
piantito a grezza materia impropria forma a scacchiera bizzarro tavoliere a
solo colore nero l’intenso di pece brutto alla vista – quando a ricordanza l’anziano
la sedia a dondolo stanchissimo, tuttora pensava tese vivaci mani da bimbo le
protendeva a ricevere la lanceolata foglia ruvida a giallognole striature ed
unica venatura violacea, quale possibilmente regalo il padre del padre a fama
di eccentrico collezionista i chicchi grano caffè frumento riso, il vecchiardo
allora perspicace intuisce il pronto sguardo a penetrare il tempo la sua fine –
per motivo forze minori infine minute / la candela che strugge a termine, in
ulteriore finale sforzo maggiormente curva schiena – dimentico estremo suo
decadimento e corpo il senile marasma, il piccolo panno ancora poggiato su
umida fronte e tremebonda mano e tremebonda mano il chicco il caffè, così
intensamente protesa finché sfinito in tutto e per tutto stramazza al suolo –
colui che cade a terra di colpo il colpo di mazza colpito da pastore fuori
senno in sospetto di furto a mancanza l’ultima pecora bianca. Quando
attualmente l’anziano signore su sedia a dondolo – a ricordo certamente il giocattolo
un cavallino di legno le sue assicelle ricurve ed infine l’oscillazione
gioiosa, gli occhi tutti a fisso sguardo il focolare - tale piano la pietra rossagna, se meritato
riposo la vecchiaia conosce a memoria, lui uomo di affari, il mestiere che il
figlio conosce bene – il figlio in uso il grido al padre tante volte a dire il
disprezzo / lo chiama odio / per gente che sta a dondola in vita, che fa così
un cattivo affare d’esitenza ed eternità, il figlio le tante faccende pel mondo
in voga – l’eccitazione suprema i maestosi compiti – così attualmente il
signore anziano i giorni ultimi sta per sé unicamente le tante ricordazioni
perché il figlio maschio l’infanzia durante, sapeva bene l’altalena il gioco il
giorno durante a toccare ripetutamente -
il farsi di un rito – il ligneo asse a toccare le funi sospese in alto
l’insieme dunque che oscilla interminabilmente – il fugace sentore l’animale
che libra ludico in aria senza orpelli – così attualmente il sognaore dondola
ancora impercettibilmente la sedia – già tutto compreso del suo quotidiano
vagare se evanescenti nuvole le ricordanze, a concetto lentamente ora – il
sempre maggiore dondolio – protendere il capo il busto se possibile sicuramente
le mani tremebonde il volto arrugato – la faccia solchi e grinze segnata il
villano il durissimo lavoro perché nei campi, interminabilmente – il fine certo
fermo proposito mettere mano a secchi rametti a legna secca – il lato l’antico
camino d’epoca il secolo passato, questo sognatore che finalmente la sua sedia
dondola sa pienmente il dolce movimento in qua ed in là – il giubilo l’altalena
a ricordazione il fanciullo che gioca interminabilmente - leggera sensuale oscillazione la pietra del
camino verso, il sudore la fronte le mani entrambe quanto stanche eppure il
simile colui che prende slancio, l’anziano signore – accenno sebbene effimero
sorriso le screpolate labbra a morsi oramai lividi e visibile sanguinamento,
puerile entusiasmo d’amateur – in aiuto brusco repentino movimento malato corpo
tutto degenere il vegliardo – l’esempio antica macchina da guerra che lancia
pietre – poiché a violenza di gesto impetuoso incontrollato, il vecchiardo
l’efficacia quindi la catapulta – fortemente vibrante il corpo malato degenere
tutto quando per l’appunto la bestia in agonia ferocemente piccata rudimentale
arnese il cavernicolo in bisogno di sopravvivenza – termina e breve crudele
viaggio in focolare il solo volto in cenere tutta imbrattato oramai viso spenta
grigiastra fredda polvere polveroso residuo già spento fuoco i tempi passati –
finché a morte ineluttabile ferito il naso – l’abbondante sangue ad impasto la
cenere abbondante, il signore anziano l’anziano signore – ancora l’abituale ricordanza,
remota malinconica ricordazione struggente – sì moribondo l’acuto dolore il
corpo straziato sa nondimeno la lontana figura il vecchissimo parente che a
vivida immagine curva e piega schiena e corpo strenuamente l’idea di raccogliere
minuto chicco caffè, il fervido desiderio allora semplicemente far collezione
gratuita e intima tanti granelli di vita.
Cesare Vergati
Nota Biografica
Cesare Vergati
vince una borsa di studio per un anno: USA (Diploma High
School). Si laurea a Roma in Psicologia e in Filosofia. A
Madrid e
Barcellona studia letteratura spagnola. Frequenta per un
anno la
facoltà di Filosofia a Berlino. Studia e lavora a Parigi
per più anni
e consegue il dottorato in Filosofia e psicanalisi. A San
Pietroburgo
e a Mosca studia letteratura russa. Dal 1988 è
Responsabile Cinema
Institut Français Milano.
Con ExCogita pubblica nel 2004 il primo volume della
Trilogia
dell'Eco, A sorpresa,
romanzo in poesia, nel 2006 il secondo volume
dal titolo Soldato
a veli, romanzo in teatro, dal quale viene tratta
una riduzione-pièce teatrale, rappresentata a Milano e a
San Pietroburgo,
e nel 2007 il terzo, Ragazzo
a pendolo, romanzo in musica.
I tre libri sono stati tradotti in russo. Nel 2009,
sempre con
ExCogita, pubblica la Prima Piega del Trittico d'ombra, Faust o l'inconverso,
nel 2011 la Seconda, Don
Giovanni o l'incomodo, tradotto
in francese, con testo a fronte, e in russo; entrambe le
opere sono
state rappresentate in teatro a Milano. La conclusione
della Terza
Piega, oggi, con questo Falstaff o l'inconsueto.
UNA
CERIMONIA PARTICOLARE
Era una
giornata di novembre particolarmente
uggiosa, faceva freddo e pioveva.
La
Chiesa era aperta per celebrare il funerale di una persona che il Parroco
conosceva appena,
e
non avrebbe potuto dire nulla di particolare se non le solite omelie funebri.
Aveva
chiesto a colui che aveva ordinato di celebrare la messa funebre notizie
intorno a quest’uomo così solitario che, pur abitando da qualche anno nel
paese, non aveva fatto amicizia con nessuno, anzi pareva che le persone lo guardassero
in modo strano e gli erano ostili, ma quella persona non aveva dato che vaghe
risposte, però gli aveva detto che era una bravissima persona.
Gli
aveva chiesto come era morto: “Era molto malato di cuore” gli aveva risposto.
Alla
ulteriore domanda se era credente in quanto non l’aveva mai visto nella sua
Chiesa, lui lo guardò direttamente in viso e gli rispose: “È mai stato a
trovarlo a casa sua?” alla risposta di diniego aggiunse: “Le sue opere le
dimostreranno quanto lo fosse, e per la Chiesa non si preoccupi lui amava andare in una piccola Cappelletta
del suo paese di origine vicino ai suoi cari, dove trovava quella pace e
serenità che gli erano necessari”
Si
erano lasciati così senza altre spiegazioni; quello che non riusciva a capire
era questo funerale voluto proprio nella Chiesa del paese dove non aveva mai
posto piede. Comunque non si pose altre domande.
 |
| Il buon samaritano |
Ricordava
solo di averlo visto qualche volta percorrere la piazza appoggiato ad un bastone,
vestito in modo non trasandato e con lo
sguardo fisso a terra, come a non voler essere salutato; ricordava che un
giorno gli aveva detto “buongiorno”
sperando di instaurare un rapporto, ma lui di rimando senza alzare lo sguardo
aveva ripetuto “buongiorno” ed aveva continuato a camminare.
Non
l’avendolo mai visto in Chiesa, non sapeva se si fosse mai confessato e
comunicato a meno che lo facesse nell’altro luogo al di fuori del paese.
Aveva
quindi deciso il giorno precedente di chiedere aiuto alle parrocchiane più
assidue (che molti chiamano in tono dispregiativo: le beghine) per cercare di
sapergli dire qualcosa in più in modo che potesse almeno dire due parole su di
lui. Queste si erano date da fare e
avevano sondato con i vicini di casa che tipo era; ma questi dissero di aver
ben poco da dire salvo qualche stranezza anche un po’ noiosa, intanto lui aveva
con sé due o tre cani anch’essi piuttosto malandati, i tipici cani abbandonati nei canili, certo non cani di
razza ma un incrocio dei più incredibili, comunque abbaiavano se qualcuno si
avvicinava alla cancellata. Quando chiesero se avesse una moglie, dei figli,
degli amici, risposero di malavoglia che aveva una domestica a ore che gli
rigovernava la casa durante la settimana, che veniva da fuori paese e non
faceva amicizia con nessuno, neppure con i bottegai, che comunque parecchie
persone andavano da lui: potevano essere giovani come vecchi. Ricordavano che un Natale erano arrivati
parecchi bambini accompagnati da giovani donne e per l’occasione lui aveva
addobbato anche un pino all’esterno con delle luci e avevano sentito che vi era
molta allegria quel giorno poiché arrivavano le voci dei bambini molto festose.
Ma a volte avevano visto anche qualche sbandato che lui riceveva, anzi qualcuno
era rimasto a dormire nella casa per qualche mese, anche qualche zingara che li
aveva messi in un certo allarme; ad ogni modo lui non cercava un rapporto
amichevole di buon vicinato e dopo qualche approccio e qualche domanda sulle
persone che riceveva, lui pareva infastidito ed era approdato ad uno svogliato
“buongiorno o buonasera”, dopo di che avevano desistito e lo avevano evitato; in pratica di lui si
sapeva ben poco e poi non era nativo di lì. Aveva comperato cinque anni fa quella
villa che confinava con la loro e che aveva anche un bel giardino intorno ed un
orto sul fondo; quello che riuscivano a vedere dalle loro finestre è che lui si prodigava molto per l’orto, anche se ultimamente
avevano capito che non stava bene
perché lo aveva trascurato. Non potevano parlare né bene né male, certamente
non era un solitario, ma aveva voluto essere estraneo alla comunità del paese e
questo indispettiva non poco le persone. Aggiunsero che vi era poi una persona
che regolarmente andava da lui ogni settimana, un uomo sui cinquant’anni che
arrivava con una automobile di un certo pregio e si fermava tutto il
pomeriggio, l’avevano pure visto che portava con sé delle valigie e delle
borse, altro non avrebbero potuto dire. Conoscevano il nome e cognome perché
era apposto vicino al campanello del cancello: Francesco Sordelli. Conclusero dicendo che il giorno prima al
mattino la domestica l’aveva trovato morto
nel suo letto, poi era arrivato il medico per constatare il decesso, e subito
dopo quella persona dell’automobile.
 |
| Il buon samaritano |
Il Parroco
dopo queste notizie era più desolato di prima, non sapeva che dire, avrebbe
fatto una cerimonia la più semplice possibile, anche se gli era stato detto di
farne una completa, e per questo era stato ben remunerato. Si premurò di
raccomandare alle parrocchiane di essere presenti in modo che non ci fosse solo
la bara e null’altro, e loro avevano risposto che sarebbero venute, e concordarono di leggere il passo di Isaia
50-51 “Ascoltate il servo del Signore”
mentre il Parroco scelse dei leggere la
parabola del Vangelo secondo Giovanni “ Gesù
è la vera vita”.
Vennero
gli addobbatori e misero i paramenti esterni con il nome del defunto.
Il
Parroco mise i suoi paramenti violetti e alle 15 del pomeriggio venne portata la bara a spalla da
quattro persone sconosciute, una bara semplice senza alcun fiore, e subito dopo
vide una processione di persone che portavano in mano ognuno un giglio bianco, e con
meraviglia delle parrocchiane e del Parroco entrarono in Chiesa e si sedettero
compostamente nei banchi. Il Parroco
sempre più stupito guardò quella moltitudine di persone, tra le più
stravaganti, vi erano tanti bambini, dei giovani, delle donne molto commosse, e
pure degli zingari, qualche barbone, alcune persone erano di una
età molto simile a quella del defunto che aveva 75 anni.
 |
| Il buon samaritano |
Ma
com’era possibile che una persona quasi sconosciuta ai più potesse avere tante
persone che gli tributavano un ultimo saluto? Si sentiva molto turbato per non
conoscere nulla di quest’uomo, per non essere andato mai a trovarlo, per non
aver cercato un colloquio, un inizio per instaurare un rapporto. Sentiva dentro
di sé come una colpa.
Iniziò
la Messa funebre, le parrocchiane lessero il passo di Isaia, ma prima di
leggere il Vangelo, qualcuno chiese di poter parlare di quest’uomo. Si alzò un
giovane uomo.
“Caro signor Francesco, oggi il Cielo sarà
ben felice di avere un nuovo Angelo, io ero un disperato, e lei un giorno mi
vide con gli occhi persi nel vuoto e capì subito qual era il mio dramma, mi
prese per mano e mi portò a casa sua, non mi chiese nulla, semplicemente si
mise ai fornelli e mi preparò una
cena fatta con tanto amore paterno e mi disse: -Ora riposa, c’è tempo per parlare, quando vorrai farlo io ti ascolterò e insieme troveremo la
via d’uscita, questa casa è il rifugio di coloro che soffrono, possa essere un
balsamo per te, io ci sono e ci sarò,
questa notte dormi tranquillo e che Dio ti protegga-. Queste parole le ho stampate nel mio cuore e nella mia anima, se ora
sono diverso, riabilitato con me stesso e la comunità, lo debbo a lei, mia
guida, mio protettore, mio padre. Dio è con lei, e per Suo tramite noi le
chiediamo di vegliare su questa comunità che lei ha così ardentemente voluto e
assistito”. Poi scendendo mise il suo giglio sulla bara.
Subito
dopo si alzò una donna: “Non dimenticherò
mai il giorno in cui ero al colmo della disperazione perché non avevo più un lavoro
e il mio bambino era ricoverato all’ospedale, per caso lui passò nei pressi
dove io piangevo, mi si avvicinò e con delicatezza mi chiese qual era il
motivo; gli dissi di essere una ragazza madre e che il mio bambino era molto
sofferente per una brutta polmonite, perché dove abitavo era un locale molto
umido e freddo e non avevo i soldi per riscaldarlo in quanto avevo perso il
lavoro. Mi disse che Dio era misericordioso e che non dovevo perdermi d’animo,
che lui sarebbe stato felice di potermi aiutare, mi disse che era solo anch’egli
con un grande dolore: sua moglie e suo figlio erano morti in un grave incidente,
e da quel momento non aveva altra ragione nella vita se non aiutare chi aveva
bisogno. E come mi aiutò? Mi comperò due locali, pagò le cure del mio bambino e
mi trovò un lavoro dignitoso, ora il mio bambino è qui, va a scuola, è bravo e
gentile. Sono qui per benedirla caro signor Francesco, non potrò mai più
dimenticarla, le voglio bene, tutti qui le vogliamo bene perché si è occupato
di tutti noi, grazie, grazie ancora e sempre per quanto ha fatto, per la sua
nobiltà d’animo, noi la riteniamo un sant’uomo”. Scese anch’essa con gli
occhi pieni di lacrime e posò il suo giglio sulla bara.
 |
| Il buon samaritano |
Ognuno
portò il suo giglio e la bara si rivestì come un giardino di maggio; ognuno l’accarezzò.
Il
Parroco era scioccato, era in presenza di un grande cristiano che aveva fatto
nell’ombra
una
carità non manifesta se non a chi stava nel
bisogno. Quelli che si ritenevano grandi cristiani e ostentavano ogni atto, non valevano un’unghia
di questo Francesco. Anche le parrocchiane erano allibite. Il Parroco decide di
cambiare la parabola, era più consona per questo signor Francesco quella dal
Vangelo secondo Giovanni “Il Comandamento
nuovo”.
“Io vi do un comandamento nuovo: amatevi gli
uni gli altri. Amatevi come io vi ho amato! Da questo tutti sapranno che siete
miei discepoli se vi amate gli uni gli altri”.
Alla
fine della cerimonia i bambini presenti iniziarono un canto lieve e gioioso,
proprio come avrebbe voluto il loro benefattore Francesco Sordelli; le
letterine che avevano scritto e che tenevano nelle loro piccole mani le
avrebbero poi poste nella tomba.
Wilma Minotti Cerini
Wilma
Minotti Cerini ha pubblicato i seguenti libri:
Poesia:
La Luce del Domani- La Ricerca di Shanti (1a-2a ediz. ampliata)
Prometheus Editore Milano; “La Strada del
ritorno” Guido Miano editore Milano;
Saggistica:
“ Caro Gozzano” Ed. Nuove Sscritture, Abbiategrasso;
“Rajana” racconto indiano. Ed. Nuove Ssritture,
Abbiategrasso;
Teatro:
“Una questione di dosaggio” Ed. Nuove
Scritture, Abbiategrasso;
Racconti collettivi:
“Se una notte d’inverno un narratore…”
Ed. Nuove Scritture;
“Ti parlerò di me” Ed. Nuove Scritture;
Romanzo-Filosofico:
“I figli dell’Illusione” Blu di
Prussia editore Piacenza;
Romanzo
“Ci vediamo al Jamaica” Albatros Ed. Il
Filo, Roma;
È
presente online sul sistema: www. Literary.it
È
presente in varie antologie: Storia della
Letteratura Italiana -La poesia
contemporanea-
Guido
Miano Editore Milano; “Cantano Le Muse
Florilegio del Concorso Letterario G.S.P.
Raiteri” e in riviste
letterarie con recensioni, racconti e poesie sparse.
L’ISOLA DELLE
ZIE
Il nuovo atteso romanzo di Lubrano
Intanto
comincerei con alcune contestualizzazioni necessarie, cominciando dal topos: siamo a Procida, isola del Golfo
di Napoli, meno di 4 kmq, isola famosa per i suoi marinai e perché ha posseduto
un penitenziario. Di marinai parla questo libro, ma lo vedremo in dettaglio. Se
Procida è il luogo dove la materia di questo romanzo si dipana, il contenitore;
il tempo, l’arco storico, abbraccia gli anni
Cinquanta e Sessanta del secolo scorso. Le due lettere che i giovani
fidanzati si scambiano (Carluccio e Flavia), portano infatti la data del
febbraio 1960; Carluccio scrive da Napoli dove si è trasferito per lavorare
come giornalista in un noto quotidiano; Flavia da Bordeaux, ora che è diventata
capitano di lungo corso e naviga, primo caso nella storia della marineria di
Procida, da sempre rigorosamente appannaggio degli uomini.
E ora veniamo
ai personaggi. Il personaggio principale è il capitano Matteo Cardale, morto
“misteriosamente” all’età di 53 anni (era nato nel luglio del 1879,
precisamente il 4, ed era morto sul Risorgimento II a Mogadiscio il 4 ottobre
del 1932. Notate che il 4 è un giorno fatale: nasce il 4 e muore il 4. Su
questa morte aleggia un fitto mistero e la famiglia mantiene un rigoroso
riserbo, che finirà per alimentare le più ardite congetture. Perché ho detto
che Matteo Cardale è il personaggio principale? In fondo non è che un morto. È
vero: è un morto, ma riempie di sé tutto il romanzo. La sua è una presenza
debordante, invasiva, che domina con la sua leggenda da Casanova (o
sciupafemmine), per la sua morte oscura, per il mito che gli è stato costruito
intorno. Nessun personaggio è così vivo quanto questo morto così ingombrante.
Oscura ogni altro personaggio ed è divenuto una ossessione, e “Ossessione
Matteo” si intitola il 1° capitolo che apre il libro. Ossessione che si
riscontra nella vedova Cecilia Cardale (Cilla, come viene chiamata in famiglia)
e che si è chiusa in una volontaria reclusione. Ossessione nel nipote sedicenne
Carluccio Mazzella (’o figlio d’a rossa)
come viene popolarmente identificato, che sedotto dalla personalità dello zio
(la pecora nera della famiglia, quella che Carluccio definisce “la Stirpe”),
dalla sua leggendaria morte, ha deciso di scriverci su un libro, di iniziare
un’indagine segreta a cui dà il titolo di “Mogadiscio. Ossessione, infine, nell’altrettanto
misteriosa e fascinosa “frastiera”; una francese che affronta un lungo viaggio
ogni primo venerdì del mese di ottobre, per portare sulla tomba di Matteo tre
rose rosse, come devozione e pegno del suo antico amore.
Se questi sono i personaggi principali,
molti altri ve ne sono che agiscono attivamente o rimangono sullo sfondo.
Descriverveli tutti sarebbe troppo lungo e forse anche noioso. Alcuni non
hanno, com’è giusto che sia, un grande spessore psicologico; altri sono solo
dei bozzetti o delle figure piuttosto evanescenti. Ma quelli che contano hanno
invece personalità e carattere, e ci restano in mente vividi e concreti. Di
alcuni, poche pennellate, come in un quadro impressionista, ne definiscono l’essenza.
Un esempio per tutti: la romagnola zia Tosca (a proposito, L’isola delle zie è affollato di donne, di zie. Queste vedove
bianche i cui mariti solcano mari e stanno lontano molti mesi all’anno)
magistralmente battezzata dal resto del parentado come “zia rondine”, per aver
risposto al telegramma del marito che la invitava a raggiungerla in uno degli
approdi italiani, con un altro telegramma di tre parole: “Volo. Tua rondine”.
Trovo questo dettaglio, narrativamente magistrale. Voi lettori siete
giustamente attratti dall’ordito, dalla trama e dalle vicende, ma l’occhio del
lettore-scrittore è molto interessato allo stile, ai singoli dettagli, al modo
del condurre il racconto. Trovo letterariamente efficacissimo l’attacco del
capitolo 6° intitolato “La straniera” che così esordisce: “E chesta chi è?”. Solo uno scrittore
disinvolto e smaliziato può iniziare un capitolo con un attacco così fulminante
e sintetico; solo un narratore nutrito della teatralità napoletana (della sua
oralità popolana) può immaginare un attacco del genere.
Vi dicevo delle donne. Una mezza dozzina sono le zie di
questo romanzo, alcune non hanno un grande peso ma altre sono presenze
femminili importanti all’interno della “Stirpe”, a cominciare dalla vedova
inconsolabile zia Cecilia, la reclusa, la stanca, la affaticata, “il
monumento”, quella che “non sta di genio”, che risponde alla figlia a tocchi di
bastone. È un personaggio riuscitissimo e che Lubrano ci descrive magnificamente.
C’è zia Filomena detta Memè; zia Immacolata detta Tetè (“la monaca di casa che
ha sposato Gesù”); zia Tosca, “la Rondine” già citata; zia Gabriella, la
seducente moglie di zio Riccardo: quest’ultimo si suiciderà in mare per il
dolore dei tradimenti della moglie e della richiesta di separazione. Infine, non posso non citare Costanza,
o meglio, donna Costanza detta Tina, la soave, la rossa, mamma di Carluccio.
Sono queste donne a difendere il clima di omertà sulla “scandalosa” morte di
quello che il prete del paese don Anselmo definisce “peccatore reo confesso”.
Ma in che
consiste l’oscurità della morte del capitano Cardale, il suo mistero? In realtà
non c’è alcun mistero, e l’ipotesi di un avvelenamento da parte di una donna
innamorata abbandonata che si vendica, è una pura leggenda. Carluccio lo
scoprirà con il suo fiuto, la sua ostinazione e la sua indagine, mettendo
assieme un tassello alla volta, i singoli pezzi. La strana visita della madama
francese Alisèe Larousse sulla tomba del morto; il singolare biglietto che vi
lascia e che poi si rivelerà una infantile filastrocca proustiana, un gioco
innocente fra i due amanti, le notizie fornitegli da marinaio in pensione
Pasquale Monaci che con Matteo Cardale aveva navigato, e soprattutto dalle rivelazioni
del barbiere Giovangiuseppe Jorio, confidente del capitano. Da Jorio Carluccio
venne a sapere che lo zio e la francese si erano amati, che quella donna gli
aveva “afferrato il cuore”. E sarà la francese stessa, madama Alisèe a
rivelarglielo, e a chiarirgli il significato della filastrocca proustiana, in
occasione di un secondo viaggio con relativa visita al cimitero.
Com’erano andate realmente le cose? Beh.
Questo lo scoprirete se leggerete il romanzo. Io posso dirvi soltanto che la
donna si suiciderà non molto tempo dopo quella seconda visita. Sarà Flavia a
darne notizia a Carluccio, in una lettera datata 10 febbraio 1960, riportando
un brano del “Corriere di Bordeaux” acquistato qualche giorno prima. La donna
si era tolta la vita all’età di 70 anni ingerendo una delle due pillole che
teneva in un porta-pillole. Erano due le pillole: quella dell’amore e quella
dell’oblio. Ah, dimenticavo: se vi metterete in ascolto sentirete tutti i
profumi e gli odori dell’isola; non è poca cosa.
 |
Presentazione del libro di Lubrano
(nella foto Lubrano e Gaccione)
|
Antonio Lubrano
L’isola delle zie
Ferrari Editore, 2013
Pagg. 144 € 15,00
MAURIZIO MESCHIA
Istantanee nel Metrò
Un maestro del racconto breve, anzi brevissimo, in tre brandelli metropolitani.
Scena 1
Milano, giugno, ore 18,30. A una fermata di snodo della
linea verde entrano nell’ultimo vagone, affollato e senza aria condizionata, in
ordine: un giovane alternativo con bicicletta e un cane malconcio a seguito,
una sudamericana con un passeggino biposto (vuoto), una coppia di musicisti rom
con chitarra e fisarmonica, una giovane studentessa d’arte, si presume, con un
lungo tubo e un quadro imballato di circa un metro per lato. Si riparte. Attacca
la musica. Relatività dello spazio…
Scena 2
Durante il tragitto, brandelli di conversazione al cellulare
involontariamente rapiti a causa del volume di voce da angiporto:
…No, ggiuro che lo mando aff……
...No, senti, basta, stavolta mi ha rotto il c….
...Sai che ti dico? Stasera vado al Caribbean e mi faccio il
primo che capita, ti ggiuro, c….!
E può andare a farsi f…… quel pezzo di m....
….Ok, ci becchiamo a casa. Ciao mamma.
La giovane ripone lo strumento in un’elegante borsetta
griffata, da cui spunta un quotidiano economico, in tono con un tailleur avana
di finissima foggia che avvolge due gambe tornite e abbronzate. Ai piedi calza
costose scarpe con vertiginoso tacco a spillo. Scende e si perde di buon passo nella folla.
Scena 3
Nel vagone semivuoto,
due uomini sulla quarantina siedono uno di fronte all’altro. Uno ha i tratti
asiatici. Entrambi stanno telefonando. A
un certo punto squilla una suoneria molto comune, insistente. I due si guardano
interrogativi e cominciano a frugare nelle tasche e nelle borse. Finalmente,
l’asiatico riesce a estrarre un secondo e modernissimo cellulare, e così subito
dopo fa l’altro. I telefoni suonano contemporaneamente, con volume sempre più
alto. I due sospendono le precedenti chiamate e si dedicano alle nuove. Alla
fermata entra una giovane con un microfono, trascinando un amplificatore in un
carrello per la spesa. Inizia uno struggente quanto assordante motivo,
vanificando quell’eccesso di comunicazione.
 |
| Disegno di Filippo Gallipoli |
MINIMA VOLUPTAS
Rubrichetta su cibi e spuntini semplici e semplicissimi da recuperare
di Maurizio Meschia
 |
Maurizio
Meschia (a destra) con Gaccione e Rinaldo Caddeo
alla
BibliotecaVigentina di Milano 2013 (foto: Marla Lombardo)
|
Pane e cipolla: sublime semplicità
Paradigma di frugalità e massima
espressione proverbiale di orgoglio (…piuttosto mangio pane e cipolla!), questo
cibo primordiale afflitto da luoghi comuni è invece una superba delizia oltre
che un concentrato di virtù salutari. Pane e cipolla è stato sostentamento per
generazioni di braccianti e gente umile e a stento –e non del tutto- si è
scrollato quell’aura di povertà e di cibo “volgare” che gli imperanti costumi
alimentari del dopoguerra hanno costruito, forse per rimuovere i ricordi di
ristrettezze e miseria…
Ma l’irresistibile richiamo di una focaccia con le
cipolle o di un fragrante panino imbottito con cipolle sfinite in un po’ d’olio
eccellente, spolverate con sale e pepe ( e un buon bicchiere di vino!) ha
ristabilito la giusta posizione fra i vertici della semplicità e del gusto a
questo cibo che gode di un apprezzamento trasversale per fasce di età e censo. Come si sarà capito, siamo devoti adepti di
questo prodigioso bulbo, in tutte le sue varietà: rosse ,bianche, dorate,
cipolline e cipollotti; e in tutti i suoi utilizzi a tavola, fino all’assoluto
trionfo di un piatto di cipolle rosse e dolci di Tropea affettate in
sottilissime lamelle e macerate in olio, sale e aceto, o a una cipolla bianca
bollita e consumata un po’ croccante con sale, olio e pepe. E pane del
migliore, naturalmente.
Inutile ricordare le proprietà benefiche dell’amata
cipolla: antiossidanti, fluidificanti, stimolatrici del cervello,
antireumatiche e antiallergiche, utili a combattere patologie cardiovascolari,
calmanti e - si favoleggia- afrodisiache, e molto altro. Ma basta e avanza il
fatto che ci piace e che è eletta senza dubbio regina della tavola. I tanto temuti effetti collaterali? Per
questo banale “problema” c’è una soluzione perfetta: masticare un paio di
chiodi di garofano.
Per non sembrarvi esagerati in questo nostro elogio,
chiamiamo a testimonianza la Poesia. Due grandi poeti, premi Nobel, hanno
dedicato versi appassionati alla cipolla.
Ecco cosa scrive il
cileno Pablo Neruda in Ode alla cipolla:
….
Ricorderò ancora come la tua influenza
feconda l’amore dell’insalata,
e sembra che il cielo contribuisca,
dandoti fine forma di grandine,
a celebrare il tuo chiarore tritato
sugli emisferi di un pomodoro.
Ma alla portata
delle mani della gente,
innaffiata d’olio,
spolverata
con un po’ di sale,
uccidi la fame
del bracciante nel duro cammino.
Stella dei poveri,
fata protettrice
avvolta
in delicata
carta, esci dalla terra,
eterna, intatta, pura
come seme d’astro,
e nel tagliarti
il coltello in cucina
spunta l’unica lacrima
non nata da pena.
Ci facesti piangere senza affliggerci.
…
(Da Odi al vino e altre odi elementari – Passigli 2002- traduzione di G.B. De Cesare)
Dall’altro capo del mondo, in Polonia, ecco invece l’omaggio
della grande Waslawa Szymborska
in Cipolla:
La cipolla è un’altra cosa.
Interiora non ne ha.
Completamente cipolla
fino alla cipollità.
Cipolluta di fuori,
cipollosa fino al cuore,
potrebbe guardarsi dentro
senza provare timore.
In noi ignoto e selve
di pelle appena coperti,
interni d’inferno,
violenta anatomia,
ma nella cipolla – cipolla,
non visceri ritorti.
Lei più e più volte nuda,
fino nel fondo e così via.
Coerente è la cipolla,
riuscita è la cipolla.
Nell’una ecco sta l’altra,
nella maggiore la minore,
nella seguente la successiva,
cioè la terza e la quarta.
Una centripeta fuga.
Un’eco in coro composta.
La cipolla, d’accordo:
il più bel ventre del mondo.
A propria lode di aureole
da sé si avvolge in tondo.
In noi, grasso, nervi, vene ,
muchi e secrezione.
E a noi resta negata
l’idiozia della perfezione”.
(Da Elogio dei sogni – Adelphi 2009- traduzione di Pietro Marchesani)
DOMANI
Domani,
poi già un altro, e ancora un altro domani
si
insinua a passi impercettibili, di giorno in giorno,
fino
all’ultima lettera del nome del giorno estremo previsto;
e
tutti i nostri ieri hanno illuminato, follemente, la strada
alla
definitiva polvere.
Spegniti,
presto, candela (sempre più) corta!
La
vita non è che un’ombra che cammina;
un
povero attore che si esibisce compiaciuto,
consumando
il tempo programmato per la sua presenza sul palco:
e
poi si smette di sentirlo;
è
un racconto affannato e roboante, declamato da un idiota:
e
non ha significato.
William
Shakespeare, Macbeth, Atto V, Scena V
[Traduzione di Gianni Bernardini]
DON BURNESS
Poesie inedite
.JPG) |
Don Burness e Angelo Gaccione a Milano Salotto Claudia Azzola 2012
|
Request
In the
middle of the night
Mary-Lou
awakens
turns
towards me
Don-
tell me you
love me
in French
Marilou, ma chère
Marilou de la belle poitrine
je t'aime
vraiment je t'aime
Marilou tu
es adorable
tu es belle tu es généreuse
tu es rayonnante tu es élégante
et tu es
tellement courageuse
tu es
fantasie
artiste de la vie
Marilou, je t'aime
That's
beautiful
she says
and turns
to sleep
Don Burness
Rindge
14 february 2013
Rindge
14 february 2013
Richiesta
Nel mezzo della notte
Mary-Lou si risveglia
si gira verso di me
Don-
dimmi che mi ami
in francese
Marilou, mia cara
Marilou dal bel petto
Ti amo davvero ti amo
Marilou sei adorabile
sei bella sei generosa
sei raggiante sei elegante
e sei così coraggiosa
sei fantasiosa
artista della vita
Marilou, ti amo
che bello
dice
e torna a dormire
Don Burness
Rindge
14 febbraio 2013
Rindge
14 febbraio 2013
Traduzione di Max Luciani
Verona
Looking at Piazza Erbe
from the courtyard
of Palazzo Maffei
how beautiful is Verona
coming here surely
for the last time in my life
how beautiful is Verona
like the beautiful italian young women
singing songs with their bodies.
Don Burness
Verona
17 settembre 2012
Verona
17 settembre 2012
Verona
Guardando Piazza delle Erbe
dal cortile
di Palazzo Maffei
quanto è bella Verona
venendo qui sicuramente
per l'ultima volta nella mia vita
quanto è bella Verona
come le belle e giovani donne italiane
che cantano canzoni con i loro corpi.
Don Burness
Verona
17 settembre 2012
Verona
17 settembre 2012
Traduzione di Max Luciani
 |
Lelio Scanavini-Max Luciani-Don Burness Milano 2012 Salotto Claudia Azzola
|
Muse
Mary-Lou
i do not take care of you
because you are old
and in need of care
Mary-Lou
i do not take care of you
because it is my duty
as your husband
Mary-Lou
i do not take care of you
because others would dump you
in an istant
in a nursing home
Mary-Lou
i take care of you
because
love is the greatest thing in the world
i take care of you
because
you always made my soul sing
i take care of you Mary-Lou
because you are the great poem
in my life.
Don Burness
Rindge
8 september 2012
Rindge
8 september 2012
Musa
Mary-Lou
mi prendo cura di te
non perché sei vecchia
e hai bisogno di cure
Mary-Lou
mi prendo cura di te
non perché è il mio dovere
di marito
Mary-Lou
mi prendo cura di te
non perché altri ti avrebbero scaricata
in un attimo
in una casa di cura
Mary-Lou
mi prendo cura di te
perché
l'amore è la cosa più bella del mondo
mi prendo cura di te
perché
hai sempre fatto cantare la mia anima
mi prendo cura di te Mary-Lou
perché tu sei il grande poema
nella mia vita.
Don Burness
Rindge
8 settembre 2012
Rindge
8 settembre 2012
Traduzione di Max Luciani
 |
| Claudia Azzola con Don Burness Milano 2012 |
Vicenza
Leaving at the station
i tell the man
selling me a ticket
i have been in Vicenza
three hours
i do not like Vicenza
the man
with no expression at all
looks at me
i have been in Vicenza
thirty years
i do not like Vicenza!
Don Burness
Vicenza
17 settembre 2012
Vicenza
17 settembre 2012
Vicenza
In stazione per partire
dico all'uomo
che mi sta vendendo un biglietto
io sono stato a Vicenza
tre ore
non mi piace Vicenza
l'uomo
senza alcuna espressione
mi guarda
io sono stato a Vicenza
30 anni
non mi piace Vicenza!
Don Burness
Vicenza
17 settembre 2012
Vicenza
17 settembre 2012
Traduzione di Max Luciani
 |
| Renato Seregni con Don Burness Milano 2012 |
In attesa del suo nuovo libro che uscirà in primavera 2014, Don Burness parla della sua vita con l'amata
Mary Lou attraverso il giornale americano "Monadnock Ledger":
GILBERTO ISELLA
LA LEGGENDA
DI ATITLÀN*
Silenziosa e immobile era la notte
sulle acque circonfuse di calore
giunse la parola del Serpente Piumato
giunse la parola del Modellatore
e un breve giro di suoni nell’aria
creò allora il mondo
in una notte calda e oscura
tranquillamente il mondo si formò
e parlarono le piante e parlarono le stelle
e parlò la gente Quiché
e urlarono le scimmie sui lunghi rami del ceibà
e urlarono uomini di diversa tribù
venuta da occidente su caravelle
con croci, codici e anfore di sangue
e andò avanti stridendo tzolkin, la grande
ruota del tempo, e nel colore della morte
girarono i giorni, di venti in venti:
imix, ik, akbal, xan
imix, ik, akbal, xan
Il fondale del lago ribaltato
le sue labbra enormi
aperte da una lama-lingua,
l’anguria ancestrale lacerata
con gente che da lei sporgeva
per ammirare la terra
Così cominciò la numeratio
acrobata macumba
il fosco abbaglio vittimale:
colpiti e dai templi scagliati
il sangue e le anime accolti
da comunità fraterne di termiti,
scossi su amache nell’ora di sognare
le orge colorate di Chichicastenango
rovesciati nelle bocche dei vulcani
pugnalati nel fango
ed erano vecchi e donne e bimbi
per cominciare
Giorni sospesi nell’afa nebulenta
forze sovrumane nel basso e nell’alto
coalizzate da secoli
per risvegliare il lunghissimo coltello
ma dove accanto splendevano il sole
l’uccello piumato
che talvolta abbozzava coi raggi
la danza dei Maya.
Conca di Atitlàn:
meccanismo dell’astro caduto
rocce di diavoli agli angoli
contratte falangi umane
che ancora tenevano
la pipa votiva e l’erba degli dèi
Ed ecco l’enorme icosaedro
eretto tra i gorghi del lago
con facce d’onde indurite
grido di vetro ogni spigolo
venatura d’amore impermeabile
inerte lineamento del monsone
Ed ecco punta di cometa
colpire Rios Montt la gòrgone
che tra flutti solleva
una stanga di platino nero
con medaglie al valore scempiate
dagli artigli di Balaam
il santo giaguaro
E ora di nuovo è sovrana
sul pueblo Quiché
la ragnatela di stelle
la riflette il manto dell’ubriaco
che valica la notte col suo grumo
di respiro, materia che gonfia
le narici del tempo,
disco di gioia affiorante
su quel volto in cammino.
Il tempo: diecimila fialette di cenere
in transito sull’altipiano,
silenzio venduto nelle fiere
al ritmo di machete.
Il tempo, lo scalpo di Atitlàn.
imix, ik, akbal, xan
imix, ik, akbal, xan
*Inedito, 2013.
In corsivo versi elaborati dal sacro poema Popol
Vuh.
Rios Montt, presidente guatemalteco di fine Novecento, fu un tiranno
sanguinario.
ANNALISA BELLERIO
RACCONTI
INEDITI
NOTE DI VIOLINO
Non so a che fermata salirono i musicisti mendicanti.
Mi accorsi all’improvviso di quel suono di violino, insieme
vorticoso e struggente, abbastanza aggressivo da farsi largo nel groviglio di pensieri
in cui mi ero persa totalmente durante il tragitto in metropolitana verso la
meta che avrebbe dato una svolta al mio futuro.
Finalmente avevo deciso. Mi sarei iscritta al corso di
marketing che prometteva di inserirmi con un profilo professionale adeguato nel
mondo in cui volevo lavorare, di cui già avevo avuto qualche assaggio. Avevo
fatto da hostess in fiere e congressi, collaborato a semplici indagini di
mercato, curato brevi interviste sui consumi, svolto svariate mansioni pubblicitarie.
Il mio aspetto mi aveva aiutato. Ma gli strumenti di cui disponevo erano
insufficienti. Me l’avevano fatto discretamente notare due persone conosciute
in questo ambiente, che da poco si erano messe in proprio: una piccola società
di promozione e organizzazione di eventi che, mi avevano spiegato, seguiva
operazioni importanti per conto di affermate agenzie. Cercavano giovani da
formare in modo mirato, assicurando in tempi brevi un ruolo interessante, una
solida prospettiva d’impiego e compensi soddisfacenti. I costi dell’iscrizione
al corso erano piuttosto elevati. Dovevo dar fondo a tutti i risparmi, e farmi
anche prestare qualcosa; ma era una forma di investimento su me stessa che sarebbe
stata ripagata. Un sacrificio fruttuoso. Una competenza acquisita.
“Non fidarti, è un inganno.”
Percepii chiaramente quelle parole. Sobbalzai. Guardai
sorpresa la ragazza esile dai lunghi capelli neri appena passata oltre, ma il
suo sguardo d’ombra fisso in un altrove imprecisato era scivolato su di me
senza cercare appoggio. Chi aveva parlato? Mi guardai intorno. Nessuno,
sembrava. Eppure avevo ricevuto quel messaggio, senza alcun dubbio. E non so
come ero certa che provenisse da lei. Si
muoveva muta tra i passeggeri chiedendo un’offerta per lo spettacolo
improvvisato, e io avevo lasciato cadere una moneta nel bicchiere che porgeva.
Non lo faccio quasi mai, ma quel giorno mi sembrò ben augurante.
Il percorso circolare dei miei ragionamenti incoraggianti
era ormai stato interrotto, e non potevo negare la comparsa di una sensazione
di vaga inquietudine. Quando la musica cessò vidi farsi largo tra la folla un
giovane alto e bruno e un ragazzino che con i loro strumenti raggiunsero la
ragazza. Li vidi venire da lontano, lungo una strada interminabile, in una
corriera satura di respiri e di attesa, di tensione, di stanchezza, di paura.
Li vidi scendere insieme e poi sparire alla fermata successiva.
Lasciai che la visione svaporasse, ben decisa a non
lasciarmi suggestionare. Avevo fretta di arrivare. Avevo fretta di uscire da
quel limbo di lavoretti a termine senza costrutto e senza futuro. Non mi sarei
mai perdonata un’occasione mancata. Non la mancai.
Attesi per mesi l’inizio del corso. La data fu posticipata
per sopraggiunte complicazioni organizzative. Ci rassicurarono. La sede venne
spostata. Quando ci andai in cerca di indicazioni, non trovai alcuna traccia
del corso e nessuno che ne sapesse qualcosa. Intanto il vecchio ufficio della
società di promozione era stato chiuso. Al telefono, le spiegazioni si fecero sempre
più vaghe e sommarie. Poi nessuno rispose più.
Mi ritrovai nello studio di un avvocato assieme ad altre
persone nelle mie stesse condizioni. L’atmosfera era satura di respiri e di
attesa. Tornai in metropolitana con alcuni dei miei avviliti compagni discutendo
di tempi e di costi, di perdite e di reali possibilità di recupero. Mi sentivo
un grumo di tensione, di stanchezza, di paura. Assorbita nel groviglio di
pensieri in cui mi ero persa totalmente, mi accorsi all’improvviso di un suono
di violino. Insieme vorticoso e struggente.
ANGELI IN TERRAZZA
Sono tornato a casa quella notte che erano più o meno le tre.
Ero in moto e fortuna che non mi hanno fermato perché avevo bevuto cinque birre
e anche dell’altro, stavo abbastanza da schifo ma più che altro non ne potevo
più dei discorsi di Gabriele. Ero stato da lui il pomeriggio a suonare anche
con gli altri. Mica potevo studiare tutto il giorno, mi avevano dato matematica
a settembre, un’unica materia, proprio stronzi. Così i miei erano in vacanza e
io ero lì come un coglione in agosto a studiare, con appoggio tecnico di una
colf. C’erano di mezzo anche le prove per il concerto a fine settembre,
dovevamo studiare bene le parti, quella era un’occasione per uscire dalla fetida
cantina e proporci a un vero pubblico, insomma non potevamo presentarci da
sfigati. Dovevamo anche decidere il nome del gruppo, ancora non ne avevamo uno
definitivo.
È lì che Gabriele ha cominciato a sclerare sugli angeli. Lui
è appassionato anche di cinema oltre che di musica, va a periodi, ha avuto la
fase fantascienza, horror, western alternativi, cinema francese, cinema
dell’est, cinema d’azione, cinema palloso. Ora ha scoperto Wenders, si è
innamorato di “Il cielo sopra Berlino” e anche di uno del genere venuto dopo,
“La città degli angeli”, con una colonna sonora dei qualcosa come Goo Goo
Dolls, bella ma che ci ha fatto sentire fino alla nausea. Insomma è intrippato
con questa storia degli angeli, dice che tantissimi musicisti hanno fatto
canzoni sugli angeli, Vasco Rossi, Ligabue, De Gregori, Paul Simon, Bob Dylan, Madonna,
Robbie Williams, Lucio Dalla, Lucio Battisti, gli Eurythmics, gli Aerosmith, gli U2 e altri che non ricordo o
non ho mai sentito. Vabbè, dico, lo so anch’io certe son famose, allora facciamo
anche noi una canzone sugli angeli, scrivila tu visto che hai l’ispirazione. Ma
cosa c’entra il nome del gruppo? No, dice lui, gli angeli ispirano non solo
lui, gli angeli attirano, e spara nomi per il gruppo a base di angeli. Io
Vincenzo e Paolo parliamo d’altro, facciamo altre proposte, e lui continua a girarci
attorno.
Brandelli d’angelo. Angeli in riserva. Angeli di riserva. Gli
angeli scaduti. Angeli in canna. Niente, era lì impermeabile e gli avrei
spaccato quella faccia che ha quando non ascolta più nessuno e va avanti per i
cazzi suoi. A quel punto sono venuto via. Meglio andare a dormire. Però a casa
ero troppo fibrillato e anche incazzato, ho fatto una doccia e sono uscito sul
terrazzo e stavo lì a respirare e cercare di sbollire, fuori all’aria. Intanto
Chiara era via coi suoi ma sapevo che non mi aveva raccontato tutto. Era stata
a Parigi una settimana e c’era anche quell’altro, lo so, quella faccia di culo
di prima, lei diceva che l’aveva lasciato che era finita con lui ma non era
vero. Stava con me e anche con lui, io allora la mandavo affanculo e lei si
disperava e giurava che voleva stare solo con me, ma appena ricominciavamo tutto
andava avanti come prima. Lei ha bisogno di avere una riserva in panchina a
disposizione. Non ero più sicuro di essere io il titolare. Ero incazzato con
Chiara, con Gabriele, coi miei, con quella di matematica. Ero incazzato con me
che subivo le decisioni altrui e non sapevo convincere nessuno. Ho preso la chitarra
e mi sono messo a suonare, piano. Era tardi e ci mancava solo che qualche
vicino rompicoglioni venisse a protestare. Pezzi di canzoni che Gabriele aveva
citato e io conoscevo. Poi ho provato dei giri di accordi, mi è venuta un’idea
musicale, un motivo, funzionava abbastanza, ci ho attaccato qualche parola che
mi veniva in mente. Mi sono accorto che stavo inventando una canzone pensando a
Chiara e questo era contro i miei propositi ma non potevo farci niente.
Merda, i fiori. Di colpo mi sono ricordato che mia madre mi
aveva raccomandato di bagnarli e io in dieci giorni non l’avevo mai fatto.
Dovevano essere già belli che rinsecchiti e lei mi avrebbe fatto un mazzo
dicendo che ho quasi diciott’anni ma di me non ci si può fidare, che penso solo
agli affari miei eccetera.
Ho riempito l’innaffiatoio e sono uscito a cercare di
rianimarli. Tutti quei fottutissimi fiori.
È stato allora che l’ho visto. Mi è venuto un accidente e sono
rimasto lì basito, allagando il pitosforo l’oleandro la forsizia o non so cosa
di quei nomi che mia mamma spara credo a caso.
Nel terrazzo di fianco, subito al di là della separazione,
c’era uno, al buio. Solo che stava seduto sul parapetto con le gambe verso
strada. Al sesto piano. Cazzo. Non era un ladro, non vedevo una minchia ma mi
sembrava lui, il vicino, alto, i capelli un po’ a spazzola. Sembrava proprio lui.
Si voleva buttare? Oddio cosa dovevo fare, cosa si fa con uno che si vuole
suicidare? Magari invece era sonnambulo era arrivato lì e se parlavo lui si svegliava
di colpo e cadeva. No, non dormiva. Non era più di profilo, si era voltato
verso di me.
Come si chiama? “F. Saccani”, visualizzo la targa sulla
porta. Non ne so niente, a parte che ha una MV Agusta Brutale 675 e una Audi A5,
l’ho incontrato qualche volta sul pianerottolo o nell’atrio, buongiorno
buonasera. Però mi è venuto in mente che mia mamma tempo fa diceva che era
tanto che non vedeva la tizia di fianco, quella che viveva con l’ingegner
Saccani. E che lui era già separato, chissà cosa è successo, però come si fa a
chiedere, non sono abbastanza in confidenza, insomma quella roba lì.
Forse lei l’ha mollato, sarà per questo che vuole buttarsi?
Magari stava già con un altro, vorrei dirgli che anch’io ho a che fare con una
troia del genere. E anche con quella di matematica. Altro genere.
Insomma non posso stare qui e aspettare che salti. Non posso
aspettare che arrivi non so chi in aiuto, devo arrangiarmi da solo.
“Signor Saccani cosa fa? Ha bisogno di qualcosa?”
Che cazzo sto chiedendo. Cosa fa, cosa vuoi che faccia? Di
cosa può avere bisogno, di una spinta? Non ho esperienza di gente che si
suicida, non so cosa si deve dire in questi casi. Stava lì appollaiato e mi
sembrava un angelo di quelli dei film di Gabriele, sopra Berlino, sopra Los
Angeles eccetera, vestiti normali, che sentono i pensieri. Quelli si buttavano
per diventare uomini. Lui era già un uomo non sapevo se si buttava per diventare
un angelo ma dovevo impedirlo. Chissà Gabriele l’esperto come se la sarebbe
cavata. Ho cominciato a parlare, parlo a ruota libera, straparlo e lui mi
guarda serio ma con curiosità. Se c’è curiosità c’è speranza. Assomiglia un po’
a Nicolas Cage, forse è suggestione. Gli racconto un po’ di fatti miei, finché finalmente
parla anche lui forse per farmi stare zitto e mi sento sollevato. Mi fa delle
domande. Sembra triste, stanco, ma tranquillo. Sorprendente, devo dire. Quando
gli ho mostrato la foto di Chiara sul cellulare mi ha detto carina ma
preferisco quella di fianco. Era Irene. Tipa strana, ma in effetti intrigante. Quando
mi sono sentito a corto di argomenti ho pensato di prendere la chitarra ma
avevo paura ad allontanarmi, magari ne approfittava per saltare. Ma lui mi ha
letto nel pensiero, da bravo angelo, e mi ha chiesto di suonare ancora. Sì però
lei per favore si toglie da quella fottuta posizione e viene di qua. Lentamente
si è girato con le gambe dentro il terrazzo, si è staccato con calma dal
parapetto e si è seduto su una sedia. Molto meglio, ma non mi pareva ancora al
sicuro. La chitarra per fortuna l’avevo lasciata lì vicino, mi sono messo a
suonare io di qua lui di là del divisorio, e ascoltava assorbito nel buio.
A un certo punto ho smesso e gli ho detto che io di lui non
sapevo niente. Ha cominciato a raccontare. Un racconto non proprio allegro,
come si poteva immaginare. Si chiama Fabrizio, ha cinquantadue anni, è separato
e vive solo. Non dice niente della tizia. La società che ha fondato è in fallimento,
questioni di pagamenti, di banche. Devo ricordarmi di dire ai miei di non
tenere i soldi in banca. Almeno i miei. Non mi fido. Gente che lavorava con lui
e ora è a casa. Tante altre storie tristi che derivano dalla sua. Io non so bene
cosa dire. Lui sta zitto un po’ poi dice che fino a vent’anni fa suonava il
basso in un gruppo rock. Un Hofner originale, che ha ancora. Cazzo, dovevo
assolutamente vederlo, è quello che usava Paul McCartney. Sparisce dentro casa
e sento un brevissimo suono alla porta. È lui col basso, dice che me lo regala.
Io non oso quasi toccarlo, ma vorrei sentire lui. Dice che è troppo che non
suona. Provo io ed è uno sballo, se lo dico a Vincenzo lo faccio morire, dopo
un po’ lo prende lui e comincia a sciogliere le dita. Un po’ legato, ma si
capisce che ci sa fare. Vado con la chitarra e lui mi viene dietro. Niente
male. Prendo da bere ma per me niente birra altrimenti sbocco e vedo che fuori comincia
a far luce. Alle nove e mezzo devo andare a lezione e mi sento uno zombie, lui
mi dice manda un messaggio che stai male, quando ti svegli ti do io lezione di
matematica. Non sapevo se fidarmi ma avevo troppo sonno. Mi sono buttato sul
letto e ho dormito fino a dopo mezzogiorno. Ho visto che lui era ancora lì
seduto sulla poltrona, con gli occhi chiusi. Mi sono avvicinato per controllare
e avevo una strizza ma ho sentito il respiro. Non era morto, per fortuna, dormiva
proprio. Ho sperato che si svegliasse di umore un po’ migliore, se si ricordava
mi sarebbe piaciuto davvero fare matematica con lui. Vabbè che con tutti i suoi
casini… Però me lo aveva detto lui.
Guardavo giù nel buio spruzzato dalla luce del lampione. Le
lastre di pietra davanti al portone, l’aiuola del giardino condominiale; o
forse sarei finito sulla cancellata? Da quella posizione bastava un colpo di
reni e avrei chiuso con gli avvocati, con le banche, con i rappresentanti
sindacali, con i creditori. Con i sonniferi. Pochi secondi attraverso il buio e
non avrei più sentito fisso su di me lo sguardo accusatorio di Claudia, quello
insofferente di Roberta, quello ansioso dei miei collaboratori e allo specchio
il mio, irriconoscibile. Mi sollevo appena sulle braccia, porto il peso in
avanti, ed è fatta, pensavo. Passa un’automobile. Vorrei essere il guidatore,
chiunque sia, vorrei essere chi dorme dietro quella finestra di fronte, il
custode di quel portone, la commessa di quel negozio all’angolo. Vorrei
trasferirmi in un’altra vita.
Di colpo è venuta luce dal terrazzo di fianco, c’era qualcuno
in quella stanza. Lì sulla soglia è comparso un ragazzo, in accappatoio, una
criniera di ricci biondi. Si aggirava come un leone in gabbia, parlava da solo,
di angeli, di una riunione con Gabriele e altri angeli. Era Martino, così ho
sentito che si chiama il figlio dei vicini, ma ora mi sembrava un angelo
imbronciato, quello del Bernini con la corona di spine in mano, in Sant’Andrea
delle Fratte a Roma. Dove ci davamo appuntamento io e Claudia, quando lei aveva
un altro sguardo. Non aveva un linguaggio angelico questa apparizione venuta a interrompere
i miei pensieri estremi, inveiva contro qualcuno che stava a Berlino, a Los
Angeles, a Parigi, che era lì con qualcuno e doveva studiare matematica. Continuava
a entrare e a uscire, è ricomparso senza più il panneggio ma con un paio di
boxer e una chitarra.
Suonava
bene quel giovane angelo che parlava di angeli, sentivo qualcosa che si
scioglieva e mi sono accorto che stavo piangendo. Da quando non piangevo? Forse
dai tempi del liceo.
Cantava. “Qui è logico cambiare mille volte idea ed è facile
sentirsi da buttare via…” cantava Vasco Rossi, l’ho riconosciuto, e anche Lucio
Dalla: “Io so che gli angeli sono milioni di milioni e che non li vedi nei
cieli ma tra gli uomini”. “Passa l’angelo, passa l’angelo e ti offre da bere.”
Facile, De Gregori. La musica non l’ho persa completamente, ricordavo anche
molte delle canzoni che cantava in inglese e mi arrivavano a pezzi: “Se Dio
mandasse i suoi angeli, se Dio mandasse un segno, se Dio mandasse i suoi
angeli, andrebbe tutto bene?” Gli U2. “Deve esserci un angelo che sta giocando
col mio cuore…” Eurythmics. “E
io non voglio che il mondo mi veda perché non penso che la gente capirebbe; quando
tutto è fatto per essere distrutto io voglio solo che tu sappia chi sono.” Di questa
non sapevo l’autore ma di sicuro era in un film. “Io mi siedo e aspetto che un
angelo contempli il mio destino…” questo doveva essere Robbie Williams, e poi
Bob Dylan, di sicuro: “Se
tu non fossi caduto non ti avrei trovato, angelo che voli troppo vicino a
terra. E io riparai la tua ala rotta e stetti lì con te, cercando di tenere su
il tuo spirito e di abbassare la tua febbre”.
Poi
si è messo a provare gli accordi di una canzone che non sapeva bene neanche lui
ma forse la stava inventando. Sì, la stava componendo. Ero immerso nella
nostalgia di quello stato di grazia creativo quando lui è balzato in piedi, ha
ricominciato a imprecare e si è messo a innaffiare i fiori. A questo punto ha
guardato verso di me, che mi credevo ormai invisibile, e mi ha visto. Dopo una
breve esitazione ha ricominciato a parlare, a me questa volta, sembrava un
fiume in piena, parlava della sua ragazza, di Gabriele Vincenzo e altri che
suonano con lui, dei genitori che sono via, della professoressa di matematica e
dell’esame a settembre, di Parigi, di Wenders, degli angeli, dei fiori
rinsecchiti, della mia automobile e della mia moto, di cui sapeva cose che io
non so. Non riuscivo a seguire il filo, anche perché non c’era. Capivo che era
spaventato e cercava di distrarmi, come si fa con i bambini per farli smettere
di piangere. Allora gli ho parlato anch’io e gli ho chiesto di suonare ancora
la chitarra perché davvero mi piaceva ascoltarlo e sono ritornato dentro la
terrazza perché mi commuoveva la sua goffa preoccupazione, e quella sua
curiosità sincera quando mi ha chiesto di parlargli di me, e la sua imprevista partecipazione
e i suoi commenti spiazzanti e la sua ammirata sorpresa quando gli ho detto che
suonavo il basso e la sua eccitazione quando gliel’ho portato e il suo sguardo
d’intesa così trasparente quando ci siamo messi a suonare insieme. Uno sguardo
d’intesa. Uno sguardo complice. Pieno di sonno. E quando l’ho visto dormire
come un angelo ho pensato che l’unica persona che in realtà mi sarebbe piaciuto
essere era suo padre. E ho pensato che avevo sonno e dovevo dormire un po’
anch’io perché mi aspettava una giornata dura di appuntamenti; ma soprattutto
dovevo dare una lezione di matematica.
Mancava un’ora all’esecuzione. Un’ora appena.
Il tempo di una cena, di un sigaro, di una partita a carte. Il tempo di una
ballata, di un incontro d’amore. Il tempo che restava di una vita. L’uomo alzò
gli occhi al cortile, alle finestre sbarrate, strette e buie come feritoie.
Guardò la nera sagoma della forca che lo attendeva. Era quasi tutto pronto.
Pensò ad altri cortili, ai suoi giochi di bambino, ai suoi sogni eroici di
ragazzo, ai suoi miseri espedienti di uomo. Come era cominciata? L’uomo si
passò una mano sulla fronte nel gesto ormai stanco di scacciare quei vecchi
pensieri. Con un ultimo strappo misurò la robustezza del cappio e si avviò
verso il patibolo, a finire il suo lavoro.
INSONNIE
-Racconti della crisi-
Suona la sveglia.
Un braccio annaspa per spegnerla,
urtando sul comodino lampada, libro, bicchiere vuoto e scatola di sonniferi.
Lui si alza faticosamente dal letto, aria stravolta, apre la finestra. Di
fronte, i minuscoli giardinetti. Su una panchina, un uomo. Lo stesso quasi
tutte le mattine.
Teso e inquieto, si prepara ed
esce. L’uomo della panchina è ancora lì. Immobile.
“Lorenzo, che ti succede? Hai
bevuto? O ti è passato sopra un camion?”
“Solito, non ho dormito. Va così
da mesi, da quando sono qui. E i sonniferi mi lasciano inebetito. Non capisco
cosa mi succede.”
“Preoccupazioni?”
“Non direi, anzi. Cambiare città
non è stata una decisione facile, ma era una promozione, ne valeva la pena.
Sono passati sei mesi, mi trovo bene. E l’appartamento che la banca mi ha messo
a disposizione è comodo, luminoso, allegro; eppure lì dentro mi sento sempre in
ansia. E non riesco a dormire.”
“Forse hai un’allergia, o
qualcosa che ti disturba. Campi magnetici, punti cardinali, colori. Dovresti
consultare un esperto di Feng Shui. Magari ti basta spostare la radiosveglia, o
ruotare il letto. Va be’, non ti ho convinto. Ci vediamo per pranzo.”
Il collega se ne va e lui si
concentra sul video, lottando contro il mal di testa.
Cena fuori in compagnia, ma niente
cinema. È troppo sfinito e torna a casa. Appena aperta la porta, un fruscio alle
spalle, un uomo dal viso coperto lo spinge dentro l’appartamento, lo segue,
richiude la porta.
Sorpresa, spavento, stanchezza
impediscono a Lorenzo di emettere un grido. Contro di lui è puntata una
pistola.
Indietreggia con cautela fino al
salotto, l’altro avanza. Finalmente l’adrenalina gli torna in circolo.
“Cosa vuoi? Non c’è niente di
prezioso, qui. Ho circa 200 euro in contanti, ecco, e un orologio. E un
cellulare. È tutto. Vattene via subito.”
L’uomo sembra non ascoltare. Si
guarda intorno. Si siede sul divano, appoggia la pistola sul tavolino di
fronte. Rimane lì, in silenzio.
Lorenzo non capisce, eppure gli
sembra di essere tornato in sé.
Passa qualche istante. L’uomo si
toglie la sciarpa e il berretto. “Hai messo qui il divano; forse è più logico.
Arriva più luce. Io qui avevo il tavolo, d’estate aprivo i vetri del balcone,
era quasi come cenare in terrazza, guardando il giardino.”
Lorenzo lo fissa, incredulo. È
l’uomo che al mattino vede seduto sulla panchina di fronte. Si muove, ma subito
si blocca. La pistola.
“ Non preoccuparti, è un
giocattolo. Me ne vado via subito, solo qualche minuto. Volevo rivedere la mia
casa anche dentro, non solo fuori. Non mi avresti mai aperto.”
“Abitavi qui?”
“Sì. Ci piaceva proprio, anche se
il mutuo per noi era molto alto. Lo è diventato sempre di più, e io intanto ho
perso il lavoro. Ho tentato di tutto, non ce l’ho fatta. La Creditpop se l’è
tenuta, ce ne siamo dovuti andare.”
Creditpop. La banca in cui lavora
Lorenzo. E che gli ha offerto l’appartamento.
“Dove state adesso?”
“Dai miei genitori. Io. Anche
lei, all’inizio, poi è andata via.” Pausa. “Ora vive con un altro.”
Lentamente, l’uomo si alza. “Sono
stato bene, qui. Ho passato i momenti più belli della mia vita. Scusami, volevo
ricordare.”
“Senti… non so… Vuoi fermarti
qui, stanotte?”
L’uomo lo guarda. “Non hai paura?
Non mi conosci. Comunque devo andare, è tardi, i miei sono anziani. Si
preoccupano, come quando ero ragazzo. Temono qualche mio gesto sconsiderato.”
Fissa la pistola, rimasta sul tavolino. “E stasera l’ho fatto.”
“Posso fare qualcosa per te?”
“Lasciami venire, ogni tanto.
Qualche minuto. Al mattino sono quasi sempre qui davanti. Non riesco a dormire
e così esco molto presto.”
“Vieni domani sera, invece, a
cena. Così parliamo un po’. Ti aspetto.”
L’uomo annuisce, sorpreso; poi
abbassa lo sguardo, si avvia alla porta ed esce.
Lorenzo si aggira cauto per le
stanze, guardandosi intorno con occhi nuovi. Cogliendo, dietro le ombre
passeggere della notte, quelle, tenaci, del dolore.
Al mattino si sveglia, lucido. Ha
dormito. Oltre i vetri, la panchina è vuota. Sul comodino, il bicchiere è
pieno.
20.02.2002
Mercoledì pomeriggio, per la terza volta in un mese, l'ascensore
era fuori servizio. Elaborando mentalmente argomentazioni corrosive con cui
investire l'amministratore, ho trascinato la spesa fino al sesto piano, acceso
il computer con la furia che le forze residue mi consentono (questa volta gli
scrivo!), impostato la lettera, digitato la data.
20.02.2002. Sospesi nel luminoso
spazio informatico, i numeri in successione si sono messi a danzare davanti ai
miei occhi, ipnotizzandomi. Come il suono di una cantilena che comincia e
finisce, comincia e finisce, andavano e tornavano, si rincorrevano, si
rovesciavano, si inseguivano in un moto circolare dai mistici richiami. Quale
criptico messaggio nasconde questo enigma numerologico? Positivo o inquietante?
Nascerà oggi un futuro Dalai Lama o un Anticristo annunciatore dell'Apocalisse?
Nasceranno bambini dal nome palindromo, come Anna, Ada o Otto, chiamati a
imprese eccezionali? Forse, invece, sta per avvenire qualcosa che cambierà per
sempre la nostra esistenza. Chissà se Nostradamus l'aveva previsto, in
un'oscura quartina. I numeri rimbalzano, si incatenano, si riflettono in uno
specchio immaginario oltre il quale, come Alice, ci introdurranno in un mondo
parallelo dove tutto funziona al contrario, e dove ora c'è guerra ci sarà pace,
dove c'è miseria ci sarà abbondanza, dove c'è intolleranza ci sarà armonia.
Ho spento il computer. La lettera
– ho pensato – la scriverò, forse, domani.
Ho gettato un'occhiata
all'orologio: erano le 20.02.
Annalisa Bellerio

Breve autopresentazione. Lavoro da trent'anni come editor all'interno di case editrici e studi editoriali (Sperling & Kupfer, Franco Maria Ricci, Rizzoli), curando e spesso riscrivendo testi altrui. Come autrice e giornalista, ho scritto un libro di profili letterari femminili (Donne tra le righe, Sperling & Kupfer editore) e molti saggi e articoli per riviste e volumi d'arte, materia in cui mi sono laureata e specializzata ("FMR", "Po", "Alumina", Electa, Rizzoli, Fabbri ecc.). Per mia passione scrivo racconti, di cui ancora non so bene cosa fare. Ho provato a mandarne uno a un concorso letterario, "Racconti nella rete", organizzato da LuccAutori e Scuola Holden, e ho avuto la soddisfazione di vederlo premiato e pubblicato da Nottetempo. Un riconoscimento che mi ha fatto piacere trattandosi di un'organizzazione seria, a differenza di tante iniziative di scarsa qualità che proliferano su Internet. Da tre mesi vivo a Redmond, negli Stati Uniti, dove ho seguito mio marito che ora lavora qui, e continuo a fare collaborazioni giornalistiche ed editoriali a distanza con l'Italia.
Annalisa Bellerio

Breve autopresentazione. Lavoro da trent'anni come editor all'interno di case editrici e studi editoriali (Sperling & Kupfer, Franco Maria Ricci, Rizzoli), curando e spesso riscrivendo testi altrui. Come autrice e giornalista, ho scritto un libro di profili letterari femminili (Donne tra le righe, Sperling & Kupfer editore) e molti saggi e articoli per riviste e volumi d'arte, materia in cui mi sono laureata e specializzata ("FMR", "Po", "Alumina", Electa, Rizzoli, Fabbri ecc.). Per mia passione scrivo racconti, di cui ancora non so bene cosa fare. Ho provato a mandarne uno a un concorso letterario, "Racconti nella rete", organizzato da LuccAutori e Scuola Holden, e ho avuto la soddisfazione di vederlo premiato e pubblicato da Nottetempo. Un riconoscimento che mi ha fatto piacere trattandosi di un'organizzazione seria, a differenza di tante iniziative di scarsa qualità che proliferano su Internet. Da tre mesi vivo a Redmond, negli Stati Uniti, dove ho seguito mio marito che ora lavora qui, e continuo a fare collaborazioni giornalistiche ed editoriali a distanza con l'Italia.
Giulio Stocchi
La
voce ritroverà la sua cadenza
la
sua pietà la sua allegria
riconquistato
numero che splende
nella
corsa precipite dell’acqua
giglio
di mani rosa avventurata
golfo
mio calmo bianca nave e nera
tra
uno scalo e la partenza
una
bella sulla riva la speranza a proravia.
ARTURO SCHWARZ
Poesie inedite 2013
maktub*
non troppo tempo fa se passeggiavo
nei pressi d’un fornaio si alzava
il profumo di caldo pane fresco
tornavo col pensiero all’infanzia
la mia infanzia è sempre con me
la ritrovo nell’essere che amo
nel suo profumo d’aria leggera
nel suo spirito di ribellione
amiamo la saggezza dell’asino
era scritto l’asinello d’Egitto
è nato per l’asinella di Lodi
lo so bene
ovunque gli innamorati
hanno da sempre mormorato
queste parole all'amata
ti adoro
sono pazzo di te
non posso vivere senza te
sei la mia unica ragione d'esistere
cosa fare per trasformare
questi che sono solo suoni
nella carne dell'esistere
nel sangue di una verità
quotidiana mai contraddetta
non è la bocca che pronuncia
queste parole di passione
è il corpo mai sazio di te
il mio essere ti canta
e il mio cuore ti parla
impazienti come mai prima
di raggiungerti nell'unione
che ci lega ora e sempre
Milano, 12 maggio 2013
Quello che Linda mi ha insegnato
dopo il tempo dello studio e del lavoro
dopo il tempo del vivere per crescere
viene il tempo della meditazione
della contemplazione e della saggezza
ma se non avrai vissuto il tempo dell’amore
avrai perso quello che la vita ha voluto darti
non bastano crescere, meditare, contemplare
solo l’amore può darti felicità e saggezza
nella contemplazione dell’essere amato
sta l’unica vera e reciproca iniziazione
29 settembre 2013
devo ancora…
devo ancora vivere
questi miei giovani anni
non so se quelli passati
siano veri o sogni
della fine d’una notte
l’unica mia certezza
è la donna che abita
il mio cuore felice
di potere continuare
ad essere nei domani
di un viaggio senza fine
Milano, 1° dicembre 2013
lei è…
lei è la mia trascendenza
è il reale assoluto
la mia gioia di vivere
nell’estasi della pienezza
so essere soltanto in lei
nella grazia dell’esistenza
condivisa dal quotidiano
che diventa immortalità
questo il dono che m’ha dato:
l’orizzonte di una vita
nell’unica solitudine
del due che diventa l’uno
Milano 7 dicembre 2013
lei è la mia trascendenza
è il reale assoluto
la mia gioia di vivere
nell’estasi della pienezza
so essere soltanto in lei
nella grazia dell’esistenza
condivisa dal quotidiano
che diventa immortalità
questo il dono che m’ha dato:
l’orizzonte di una vita
nell’unica solitudine
del due che diventa l’uno
Milano 7 dicembre 2013
Arturo Schwarz firma un suo libro "Potente come l'acqua è il mio amore"
alla Casa della Cultura di Milano (2011)
per
la Torah…
per la Torah – e cioè l’Insegnamento –
conoscere vuol dire fare l’amore
riconoscersi nell’essere amato
ci trasforma in esseri immortali
con la completezza del due in uno
con la saggezza dell’indivisibile
Milano 9 dicembre 2013
per la Torah – e cioè l’Insegnamento –
conoscere vuol dire fare l’amore
riconoscersi nell’essere amato
ci trasforma in esseri immortali
con la completezza del due in uno
con la saggezza dell’indivisibile
Milano 9 dicembre 2013
ho trovato…
ho trovato la strada per le stelle
nei suoi occhi dove si alza perenne
l’unico mattino che mai tramonta
la loro luce è la mia vita
è la certezza del nomade che ha
scoperto un giorno sempre unico
Milano, 23 dicembre 2013
FRANCO FALZARI
Furlana della
Terra di Mezzo
Abito la terra di
mezzo friulana da anni, tanti quanti bastano per farmi finalmente sentire a
casa, dopo la vita peregrinando. Tutto andrebbe ben, madame la marquise, se non
fosse che da quando TERRA DI MEZZO diventa un marchio, si scatena la lotta dei
politichetti bipolari, che, mimando i fratelli maggiori, fanno a queste terre
danni ancor peggiori. La danza Furlana ha origini nell’antico Friuli appunto, e
diventa popolare a Venezia già nel XV secolo, per poi diffondersi nell’Europa
dei due secoli successivi: facciamola diventare parte del marchio, per meriti
acquisiti !
Sorgenti
tratturi a primavera
terra nera
annusata a caso
da amalgamare con le mani
divora le sementi
Parnaso
di androni e corti
famiglie a sciami
e latrar di cani
Serate colte
accanto ai tini
pieni ogni stagione
o intorno al camino
che sembra lontano dai mercanti
paladini
di un padrone
e dalla lunga onda delle rivolte
affondate nel pantano.
Qui
chi si crede un messia
con fascia tricolore
recita la stanca parodia
del ruolo
di aspirante mattatore
e di certo
ha capito molto poco
di questo suolo
La Piccola Patria freme
al rumore del cannone
al rimbombo del magma che preme
ma qui
non si smerciano parole
questa è terra amata
senza necessità di mediatori
crede nei suoi fantasmi
sponda celebrata
nella scuola
di maestri-attori
simili a padri
con il rigore del bastone
e la ricchezza
di un’incontenibile parola.
Risorgiva delle Muse
sintesi di mille
frasi mai concluse
retorica e scintille
miscelate in gesti sublimi
lobbies da lupanare
cocktails di quadri senza autore
arresi alla freschezza
del raccontare.
Ricreazione
immersi nelle profondità di un mondo
ruvido e matto
navigando
in silenzi da meditazione
scolpiti dai pioppeti
a cavallo di argini senza fine
annegare nell’odore
dell’erba
qualche gatto
tra i vigneti vagabondo
improvvisi esteti
e sintesi sonore
dell’oro di giornata,
l’immenso celeste
da spartire
con gli amici della vita.
Con una sola veste
colorata
sebbene un po’ sbiadita.
*
Machiavelli insegna
come allearsi col leone
ed il serpente
e rovesciare il mondo
sottosopra
che sembri Marte
ma sempre dalla parte
del potente
Così l’italico facondo
appena può s’ingegna
a fare:
fotter la gente
e contemporaneamente
baciare il didietro a Paperone
facendo di tutto questo
un’arte
Machiavelli cresce
e in fretta
fino a fare del mezzo un fine
- Principi e non princìpi -
giostrando in sintonia
con qualche letta
semina mine
compra oro
dalle disgrazie altrui
oppure azioni
di chi controlla moody
piazza trote o pippo
o un principe del foro
nei pirelloni
e in parlamento
per essere presente
ad ogni scippo
e se ancora manca
avere cento occhi mille mani
e centomila ciarlatani
da digerire a stento
nel parastato dei giorni bui
o in ogni banca
Machiavelli
fa l’informazione in rete
si nasconde
con secolare abilità
nei blog traversi
risponde
con parole che sembrano
concrete
ma sono passi persi
riesumando ad ogni istante
l’eternità dei chiostri
ove tuttavia
persino si pensa sottovoce
suggerendo mostri
alla regìa
figli di terre sprofondate
in alluvioni
e nell’assurdo dell’incomunicabilità
tra generazioni malmenate
caste
e pericolosa nostalgia
dei dinosauri
circondati da cataste
di voraci carrozzoni
Machiavelli
non è mai morto
ma oggi si fa idiota
Ha il fiato corto
non si accorge
che sposando trota
restituisce forza e dignità
a un’immensa lista
spina dorsale
del consenso
anima della nostra storia
protagonista
poderosa realtà
che domina la comunicazione
- mare
torbido e melenso
-
ma infine colossale comunione
Oggi in rete
è Machiavelli store
ognuno compra
il suo pezzo di potere
la sua fetta di visibilità
toreando ore ed ore
con il verbo
quasi fosse Manolete
ma privo di buonumore
spesso
via per la tangente
lontano
- seppure onnipresente -
a dispensare massime
di seconda mano
bestemmie a volontà
saggezze da sedere
Tutto questo
Machiavelli non lo sa
sommerso com’è
dalle provocazioni
così che
oggi raccoglie solo scherno
e umiliazioni
calvari
per chi crede
di riordinar l’umanità
meglio del padreterno.
 |
| Permetti un ballo? |
ORNELLA FERRERIO
Aforismi inediti
*
Perdonare è una vittoria.
*
Per amare sinceramente non basta la passione:
bisogna avere anche molto coraggio.
*
Tante volte si dice era
scritto nel destino.
E, spesso sfortunatamente,
il destino ha troppa libertà
di scrittura!
*
A proposito di media…
Su certi personaggi
politici sarebbe
vitale, se non la damnatio memoriae,
almeno l’urgente e deciso mutismo
di un fermo immagine.
*
È il mondo a formare le parole,
o sono le parole a formare il mondo?
*
Lo smog.
Come è triste pensare a un cielo sudicio!
*
Una grande e vera bellezza sta in quello che dài,
non in quello che ricevi.
*
Sono inquietanti le persone che hanno
nello sguardo - insieme - stupore e presagio.
*
I ricordi sono sempre al
presente.
*
Gettare rifiuti in qualsivoglia
specchio d’acqua è come gettarli
anche nel cielo.
*
Realtà.
Sembra solo una parola, ma rappresenta
tutto ciò che veramente vive.
*
La matita rossa e blu dei professori.
Quanta ansietà solo per due colori!
*
A volte il cielo è così basso che si teme
di esserne assorbiti.
*
La lettura di certi libri ci può cambiare
al punto da pensare di avere subìto l’innesto
di necessarie protesi mentali.
*
È possibile che l’uomo diventi veramente
(e eternamente) se stesso solo arrivando
all’ultima stazione,
quando tutto cambierà?
*
Scrivere aforismi dà la sensazione
Di poter evitare, nel proprio essere,
temibili implosioni di pensieri inquietanti.
*
È basilare che tanti aspetti della vita
vengano capiti e non solo percepiti.
*
Forse, civettando con la vita,
si può arrivare a qualcosa di
veramente creativo.
*
Dover ascoltare certa gente dà
la sensazione di sprofondare
in qualcosa di fangoso.
*
Ci sono momenti in cui il senso di
ogni cosa sembra arretrare e allontanarsi
pericolosamente da noi.
*
Nella tragedia greca i personaggi
non sono mai colpevoli e non sono
mai innocenti. Non c’è una vera
soluzione.
*
Al mattino, il momento del risveglio
è spesso l’ora di punta dei brutti
pensieri.
*
Un augurio per l’anno nuovo?
Speriamo che un apparente canto di cigno
non si trasformi in una nuova
sciagurata aurora.
Laura Margherita Volante
Aforismi inediti
*
“Dove c’è un amico il tempo scompare”
*
“La semplicità rende felici nonostante tutto”
*
“La dignità è la fermezza dei giusti”
*
“Quante scale!
Quella dei valori ha perso i pioli”
*
“L’umiltà scoraggia ogni forma di umiliazione”
*
“Tasse per il popolo:
paga e tasi!”
*
“In un mondo senza cuore, anche la resistenza
di 3000 wolt può saltare nel vuoto”
*
“La vita è un soffio,
che sia dunque di profumo di rose
e non di ortiche”
*
1) Il paese degli estremi dove i moderati saltano la corda ma non il salto in alto
Laura Margherita Volante

Nella foto: Laura M. Volante
*
1) Il paese degli estremi dove i moderati saltano la corda ma non il salto in alto
2) Quando uno Stato seppellisce i suoi morti non conosce il
rispetto per i suoi vivi
3) Alluvioni: lo stivale è la zattera del continente
4) Crollano i ponti...quello di Messina è il ponte che non
c'è in un paese inesistente fra baroni malati di assenteismo
5) La lettura interattiva è un invito al desiderio di
nutrire lo spirito; infatti, la fame vien mangiando
6) Lo scardinamento dei valori rompe gli argini in ondate di
fango
7) Nelle sabbie mobili nemmeno le unghie salvano...
8) Antipedagogia: adultizzazione dei fanciulli fra genitori
infantili
9) La solitudine me l'ha consegnata questo mondo, per non
tradire me stessa
10) Effetto deculturizzazione: dissociazione disarmonia delitto
11) Il vittimismo è il punto di forza di chi non si mette
mai in discussione
12) Luogo comune: l'amore non ha età. Ce l'ha eccome! Nasce
cresce muore
13) L'ipertrofia dell'ego distorce la realtà fino al suo
precipizio
14) Figli "piezze
e' core?" Alcuni lo fanno a pezzi il cuore!
15) Gioco d'azzardo? La rovina. Il gusto viene dal mettersi
in gioco
16) La potenza creativa si esprime nella libertà.
Diversamente esplode con forza titanica distruttiva
17) Antidoto all'invidia: tenere in casa un rododendro
18) Negazione dell'IO: chi si fa governare dall'ego fino a
perdere di vista l'altro
19) L'abuso sessuale è un tatuaggio a fuoco del volto della
morte nell'anima
20) Sulla mia lapide: finalmente
libera dagli infami!

Nella foto: Laura M. Volante
COROLLA DI LUCI
Ho ricevuto così
poco amore che
la notte fra tenere braccia
accese le stelle
in un girotondo alla luna.
Ancora oggi il ricordo
rivive di dolce abbraccio
corolla di luci
nel buio della solitudine,
ancora oggi l'anima inferma
si risveglia ad un respiro...
Laura Margherita
Volante
ON CAN
Eren
cinqu o ses ann che se trovavom
sera
e mattina sul porton de cà.
Lù
strapelaa, con l’aria de spend pocch,
giacchetta
lisa, cavei sbaruffaa.
El
gh’aveva on amis, l’unich, domà
on
cagnin zoppignent color nagott
ch’el
se tirava adree de dì e de nott.
Cont
i orecc bass e i oeucc on poo tobìs,
el
pareva scusass de vess al mond.
L’hoo
mai sentì boià e anca la vos
del
sò padron la se sentiva pocch,
o
mej, per dilla proppi fin in fond,
“bondì
bondì”, e tutt feniva lì.
Da
on poo de temp, però, ’na quai parolla
al
bondì-bonasera le giontava,
semper
reguard al can: “El sta nò ben…”,
“l’è
semper fiacch, el struzzia cont i gamb”.
I gamb, e minga “i sciamp” l’aveva dii.
E
allora mì hoo cominciaa a capì.
Dopo
el “bondì” ghe domandavi nient,
ma
on dì l’hoo vist che le ruzzava sù,
on’altra
volta ghe l’aveva in brasc:
“El
riess pù a fà i scal, se gh’hoo de fà?”.
On
dì via l’alter l’era semper pesg,
e
‘l sò “bondì” l’era pien de magon.
“Fin
tant ch’el mangia e ‘l se lamenta nò…”.
Incoeu
eren tucc duu denanz a cà
dent
in del noster giardinett stremii:
el
can l’era pù bon de tirass sù,
el
sò padron, in genoeugg ‘dòss a lù
l’era
el ritratt de la disperazion.
El
faseva tusscoss per trall in pé:
e
massaggiagh i sciamp, scrusciass con lù,
e
carezzagh i orecc… de tutt, de pù.
‘Sto
poer cagnoeu el stava sù on moment
e
poeu l’andava giò longh e tirent:
el
guardava el missee con l’oeucc tobìs,
ghe
tremaven i orecc, el coo, i barbìs;
pareva
ch’el voress dì: “Lassa stà…
t’el
vedet nò? L’è ‘l mè moment de andà…”
Dedree
di veder mì s’eri sbasii,
gh’avevi
nò el coragg de famm vedè
anben
che l’era l’ora de sortì.
Sont
andaa foeura, lù el m’ha saludaa
e
‘l m’ha dii, con duu oeucc de disperaa:
“L’aveva
mai piangiuu in tutt ‘sto temp,
‘dess
hinn duu dì ch’el piang, continoament…”
Poeu
se l’è tolt in brasc ‘me on fantolin,
l’ha
quattaa giò cont el sò paltò lis
e,
magonent, con vos de fà paura:
“Adess
el porti là…per la pontura”.
OMM IN GIARDIN
Vedi da la finestra del mè studi
el portinar, angiol custòd del verd
de la mia cà, di roeus e del pitòsfor.
El lavora content…e me domandi
‘se l’è ch’el ghe ved dent in ‘sto tocchell
de verd, in ‘sto girell per paisan
nostalgich de la terra. Omm senza sogn?
No, no, pensi el contrari, mì hoo capii:
per on’ora, ogni dì, lù s’en impippa
del gatt del ragionatt, de la ruera,
de la posta, de l’amministrador.
Per on’ora, ogni dì, lù el torna a cà.
E quell meter quadraa condominial
per lù (forza incredibil del penser)
l’è quell praa grand del sò mond de bagaj,
sotta l’argin del Po, l’è la “soa” terra,
la terra di sò vecc. El rest l’è… nient.
El loeugh dove se sta l’è minga “noster”
perché l’è scritt inscì in on quai canton.
E allora quel freguj de giardinett
per lù l’è la pianura del sò fiumm,
la terra di sò vecc, quella che gh’ha
per confin domà l’erba, i pobbi e ‘l ciel.
*
UOMO IN GIARDINO
Vedo dalla finestra del mio studio
il portiere, angelo custode del verde
Lavora contento…e io mi chiedo
cosa ci trova in questo pezzettino
di verde, in questo girello per contadini
nostalgici della terra. Uomo senza sogni?
No, no, penso il contrario, l’ho capito:
per un’ora, ogni giorno, lui se ne infischia
del gatto del ragioniere, della spazzatura,
della posta, dell’amministratore.
Per un’ora ogni giorno, lui torna a casa.
E quel metro quadrato condominiale
per lui (forza incredibile del pensiero)
è quel gran prato del suo mondo di bambino,
sotto l’argine del Po, è la “sua” terra,
la terra dei suoi vecchi. Il resto è…niente.
Il posto dove stiamo non è “nostro”
perché così sta scritto da qualche parte.
E allora quella briciola di giardinetto
per lui è la pianura del suo fiume,
la terra dei suoi vecchi, quella che ha
per confine soltanto l’erba, i pioppi e il cielo.
(Testo e traduzione di Pier Luigi Amietta)
GLI ORSI VOLANTI
Una fiaba di
Filippo Senatore
Tanti e tanti
anni fa c’erano una volta gli orsi volanti che vivevano in pace sulla Terra.
Questi animali erano molto laboriosi e facevano il mestiere degli apicoltori.
Volando da un emisfero all’altro raccoglievano le api e le sistemavano nelle
loro cellette. Quando gli uomini vennero sulla terra gli orsi volanti insegnarono
loro il segreto per allevare le api e per ottenere il miele dalle loro
casette di cera. Presto gli uomini non sopportarono la presenza degli orsi
accusandoli di mangiare troppo miele. Così un bel giorno vennero scacciati.
Alcuni feriti volarono sulla Luna e i sopravvissuti con le ali ferite si
allontanarono sulle Montagne alcuni e altri si trascinarono fino al Polo Nord.
Questi ultimi per evitare brutti incontri con gli uomini si tinsero di bianco
la loro pelliccia così si mimetizzarono con il colore del ghiaccio
perenne. Quelli di montagna si tinsero
la pelliccia di marrone per mimetizzarsi con la terra e la foresta. Tutti
persero le ali per mancanza di miele Intanto sulla Luna un’orsa per allattare
tre cuccioli mentre volava nello spazio perse alcune gocce di latte. Così
nacque la scia luminosa delle galassie detta Via Lattea. L'orsa e la sua
sorella minore che l'aiutava a raccogliere il latte perduto e i piccoli si
trasformarono in stelle segnando a nord
il cammino dei marinai. Essi furono riconoscenti e giurarono di non fare
più del male agli orsi di terra. Ma presto tutti bene e le orse per vendicarsi
crearono le aurore boreali, fasci di luce violente che accecavano la navigazione.
Ma per non essere crudeli le aurore comparvero per brevi periodi solo sulle
calotte polari.
TIZIANO ROVELLI
LA STORIA DI SERENO E
CLOE
C'era
una volta… questo è il classico inizio delle favole, ciò che io or ora mi
accingo a raccontare è una favola anomala; la distingue dalle altre il finale.
In questa storia non vi è un lieto fine.
Inizio di nuovo: c'era una volta, non molto tempo è trascorso, in un villaggio, un giovane uomo, il cui nome suonava Sereno. Sereno di nome non di fatto. Pareva triste, a tratti cupo, il suo sguardo metteva inquietudine alle donne. In paese la gente sapeva che quell'uomo non era normale. Diremmo noi oggi: soggetto con ritardo psichico. Lavorava come muratore e alla domenica si consolava spesso bevendo un bicchiere di troppo. Penso che non fosse soddisfatto della sua vita in fondo al cuor suo, uguale e monotona nel piccolo grigio villaggio senza svaghi dove era nato e cresciuto. Lo si vedeva spesso nei giorni di festa per le strade, solo e ubriaco, guardando nel vuoto, gli occhi fissi. Amava però la vita e avrebbe voluto avere una compagna. Le ragazze del posto certo non lo guardavano. I suoi genitori allora gli trovarono una moglie: Cloe. Lui fu felice e da quel momento la sua vita parve ritrovare un po' di gioia e avere una maggiore pienezza. Cloe stessa fu contenta quando lo vide. I genitori raccomandarono ai due giovani di non avere figli, perché anche Cloe soffriva di un ritardo mentale. Pensavano che potevano nascere figli con problemi.
Inizio di nuovo: c'era una volta, non molto tempo è trascorso, in un villaggio, un giovane uomo, il cui nome suonava Sereno. Sereno di nome non di fatto. Pareva triste, a tratti cupo, il suo sguardo metteva inquietudine alle donne. In paese la gente sapeva che quell'uomo non era normale. Diremmo noi oggi: soggetto con ritardo psichico. Lavorava come muratore e alla domenica si consolava spesso bevendo un bicchiere di troppo. Penso che non fosse soddisfatto della sua vita in fondo al cuor suo, uguale e monotona nel piccolo grigio villaggio senza svaghi dove era nato e cresciuto. Lo si vedeva spesso nei giorni di festa per le strade, solo e ubriaco, guardando nel vuoto, gli occhi fissi. Amava però la vita e avrebbe voluto avere una compagna. Le ragazze del posto certo non lo guardavano. I suoi genitori allora gli trovarono una moglie: Cloe. Lui fu felice e da quel momento la sua vita parve ritrovare un po' di gioia e avere una maggiore pienezza. Cloe stessa fu contenta quando lo vide. I genitori raccomandarono ai due giovani di non avere figli, perché anche Cloe soffriva di un ritardo mentale. Pensavano che potevano nascere figli con problemi.
Sereno e Cloe invece erano spensierati
e felici. Erano giunti ad amarsi. La loro vita trascorreva raggiante e quieta.
Il giusto coronamento del loro amore fu la nascita di una bambina. Erano
oltremodo contenti. Sereno trovava in quella bambina e in Cloe tutto il senso
della sua vita. Presto si
accorsero che la loro figlia non camminava. Passò il tempo ed ella giaceva sempre
in un letto. Fu uno strazio ma Sereno e Cloe amavano molto la loro creatura. La
bimba cresceva ma il suo corpicino era assai debole. L'uomo si avvicinava al
letto e le baciava la fronte teneramente. A volte avvertiva uno strazio al
cuore per quella sua figliola e nulla diceva a Cloe. Guardandola negli occhi
gli pareva di vedere riflessa la sua angoscia; solo qualche volta.
A quindici anni la bambina moriva. Il suo debole corpo e
la sua mente parevano inadeguati ad affrontare la vita. Cloe si chiuse in un
mutismo, si ripiegò sempre più in sé stessa, il dolore la stava distruggendo.
Sereno non sapeva cosa fare e d'altro canto assisteva alla penosa afflizione
della moglie senza poter far nulla.
Un giorno, in preda alla più cupa
disperazione, Cloe fece un gesto estremo. Sola, bevve una bottiglia colma di
candeggina e affrontò una morte tremenda e dolorosissima. In agonia morì tra
gli spasmi.
Poco tempo dopo Sereno pensò che gli era stato tolto
tutto dalla vita, non vi era più alcun senso di continuare a vivere e si
uccise. Più precisamente la gente narra che volle imitare la moglie e trangugiò
soda caustica.
Tiziano Rovelli
 |
| Opera di Giuseppe Denti |
RACCONTO
LA SERENITÀ DEL “CONTE” CONTADINO
 |
| Foto di Dario Pericolosi |
Si raggiungeva detta località percorrendo una stradina dissestata in salita che si dipartiva da una via più grande sterrata che collegava due paesi; in quel punto si trasformava in una discesa serpeggiante nella foresta. Erano quattro case e due cascine su di una collinetta il cui bordo volto ad est sud-est digradava in una piccola valle boschiva in fondo alla quale vi era l’alveo di un torrente dal nome altisonante di Tenore. Era stato denominato in tale modo, credo, dalla musica derivante dallo scrosciare dell’acqua sui ciottoli. Nome azzeccato pensando alla lirica naturalistica prodotta da tal suono nelle estati immerse nel silenzio della circostante boscaglia. Vi è però da connotare una situazione non del tutto bucolica nella descrizione di tale paesaggio. In quel torrente vi venivano sversate le immondizie che non solo lo colmavano, ma invadevano parte della ripa nella valle che saliva verso le cascine di S. Romedio.
Erano gli anni,
in quei luoghi, di trasformazioni industriali. I contadini abbandonavano il
lavoro dei campi per impiegarsi nelle industrie locali. Veniva così a cessare la vocazione agricola di
quella terra: non più stalle, non più piccolo allevamento di tre o quattro
vacche per famiglia, ci si stava in qualche modo avvicinando ad una situazione
sempre più urbanizzata. I contadini, divenuti operai, si costruivano la
domenica la propria villetta. Si ponevano le fondamenta di ciò che è la Lombardia
attuale, nel bene e nel male; anche per il problema dei rifiuti e della raccolta
differenziata.
Tomiamo al
piccolo agglomerato di case e cascine, a S. Romedio (in dialetto del posto San Rumé; Romedio il santo
eremita che andò a Trento a cavallo dell’orso).
Io che conoscevo quel luogo vi
fui attratto vieppiù dall’amicizia con un mio coetaneo
che ivi abitava. Era figlio di
quell’uomo che nel titolo ho nominato “conte” contadino. I miei mi mandavano a
comperare le uova fresche e così conobbi quel ragazzino.
Ora vi descriverò
il padre. Uomo anziano. Scarponi malandati inzaccherati di fango
e di sterco. Portava pantaloni di
fustagno, sporchi e sdruciti, decolorati, di una tinta
indecifrabile, tendente ad
incorporare le diverse colorazioni delle materie indecenti
con cui venivano a contatto, una
giacchetta anch’essa vecchia e sdrucita, una camicia di flanella dal collo
diremmo oggi alla coreana, più verosimilmente contadina. La barba bianca non
fatta ed un cappello di paglia grossolano tipico agricolo. Non ricordo il nome,
forse Emilio o Emiliano. In quel posto si parlava dialetto varesotto, lui
parlava italiano forbito, scandendo le parole e parlando piano. Ciò lo rendeva
inviso agli altri, un estraneo, una specie di extraterrestre. Diceva di venire dall’Emilia,
ma non aveva nessun accento. Allevava maiali a cui forniva nella mangiatoia abbondanti razioni di
minestrone fatto
in
casa con aggiunta di molte patate.
“Vedi” diceva, “ho fatto
costruire quell’impiantito di legno nella stalla, sollevato da
terra, perché i miei maiali soffrono
di artrite e reumatismi”. C’era un maiale a cui più
era affezionato e lo chiamava e
si faceva dare delle leccate in faccia, come baci.
“Voglio bene al mio maiale e
qualche volta vengo qui a dormire con lui. Non voglio
assistere quando l’ammazzano”. Sì perché lui produceva in
proprio salumi e cotechini.
 |
| Foto di Dario Pericolosi |
attorno all’albero, più si
avvolgeva la catena. “Ma così si fa male” dissi io;
“No, è così che deve essere, l’adrenalina fa la carne più buona”.
“No, è così che deve essere, l’adrenalina fa la carne più buona”.
Amava I suoi porci al punto di dividere con
loro la lettiera, alcune notti. La sua casa molto rustica ancorché rusticana, era
composta da una grande cucina e una camera da letto anch’essa grande; ospitava normalmente
galline, anatre e conigli che razzolavano liberi e ovviamente sporcavano. Del
resto la pulizia non si annoverava tra le sue virtù; i miei lo chiamavano in dialetto “el vunciun”, colui che è sporco e vive
nello sporco. Giravano in casa anche dei gatti, ciechi, sciancati e un cagnolino,
un canino, un meticcio piccolo che una volta andò in punto di morte, salvato
dal veterinario, perché aveva mangiato una pantegana, un ratto proveniente
dalla vicina discarica, come ho accennato. Una piccola alta pentola sul fuoco da cui
fuoriuscivano due zampe di gallina; “Sto bollendo un pollo; sai, un po’ di
brodo”.
Ad una mia richiesta prese una gallina e senza che me ne
accorgessi, con gesti
precisi e quasi invisibili, le
tirò il collo senza che questa avesse il tempo di dire beh.
Un artista. Mi fece vedere una fotografia
alquanto ingiallita e stropicciata, ed era
commosso: “Questo è mio fratello
morto nella prima guerra mondiale”.
Suo figlio, a cui avevano
regalato un microscopio giocattolo, si divertiva con me ad
osservare le formiche. Occhio
alla luce e alla messa a fuoco. Tipo straordinario e inconsueto da quelle
parti, un piccolo scienziato, intellettuale.
La moglie parlava anch’essa un
italiano pulito. Diceva di essere malata e se ne stava
tutto il giorno a letto con le
galline che zampettavano sopra le coperte. Anche d’estate.
È strano come la gente di quei posti sia diversa, certamente non mi considerava, essendo io un ragazzino, lui invece mi chiamava per nome e mi parlava come ad un par suo, nonostante la differenza d’età. È passato molto tempo, ma io continuo a ricordarlo con simpatia.
È strano come la gente di quei posti sia diversa, certamente non mi considerava, essendo io un ragazzino, lui invece mi chiamava per nome e mi parlava come ad un par suo, nonostante la differenza d’età. È passato molto tempo, ma io continuo a ricordarlo con simpatia.
DIALOGO TRA UN DOCENTE ED UN ALLIEVO
La
vicenda si svolge in esterno, lontano dall'abitato, sotto un cielo plumbeo,
un'atmosfera ferma che ricorda certi film in bianco e nero del regista svedese
Ingmar Bergman. Si trovano singolarmente a discorrere uno studente ed il suo
maestro. Come? Così vuole il caso.
“Che cos'è
la morte? Io penso proprio di esserne immune”.
“Pensi bene alla tua età. Quando ti accorgerai, una
mattina alzandoti, che tutto è mutato intorno a te e con angoscia non
riconoscerai più i luoghi noti e vedrai i visi familiari deturpati dagli anni,
rifletterai con rammarico che la tua vita è a tempo determinato, ha una
scadenza, un termine. (Come il lavoro che oggi al più trovano le agenzie
interinali). Anche il ricordo di te scemerà dalla faccia della terra quando non
ci sarai più. Gioisci, adesso qualcuno ti ama ma forse un giorno te ne sarai
dimenticato”.
“Tu questo lo hai sperimentato?”
“Sì, certo”.
“Perché hai un pappagallo sulla spalla?”
“Si era perduto e l'ho trovato in un bosco sopra un
albero. Da allora non mi ha più lasciato”.
“E gli vuoi bene?”
“L'altro giorno l'ho portato dal veterinario per una
visita, si è messo a strillare molto forte stretto nella presa del medico, con
il suo tipico verso gracchiante. Mi si è stretto il cuore. Piccolo uccello
dalla fervida intelligenza”.
“Dunque lo ami”.
“L'amore. Cos'è l'amore? A volte osservo mio figlio e
mi domando quale strana alchimia genetica ha fatto nascere un essere che ha
qualificato e sostanziato il rapporto genitore e generato. Io certo non ho
realizzato alcun profondo pensiero né un titanico sforzo. Semplicemente senza
che me ne accorgessi è nato. Mi somiglia? Di volto o di carattere? Sento che
comunque è un'altra persona, altro da me. L'evoluzione ha dato inizio a tutto,
io, mio figlio, il pappagallo. È tale un cerchio, una circonferenza, la cui
linea non ha inizio né fine, è chiusa e racchiude ogni cosa: la vita, la morte,
l'amore, il tempo che passa, l'evoluzione biologica, l'essere unicellulare, il
grande mammifero, i volatili, l'uomo e la sua prole. Tutto giustifica e ne
conferisce un senso, una logica. Non esiste altro. Ciò non toglie che io ami
mio figlio”.
“Non capisco bene, credevo che si trovasse non
illogico scopo in un intervento metafisico, in un essere superiore, nella
divinità. O anche questo rientra nel cerchio?”
Tiziano Rovelli
Da sinistra: Gaccione- Vergati- Rovelli
(foto: Fabiano Braccini - Milano 2013)
Giù quell'arma, sei circondato!
“Ho sempre
pensato che l’intelligenza
fosse un’arma, ma non immaginavo
di essere circondato da così tanti pacifisti”
Giovanni Bonomo
Due poesie di Ferruccio Brugnaro
INCONTRO CON LOU REED A CONEGLIANO
Era una sera d’autunno fredda e buia
come
non mai.
Il teatro era strapieno di ragazze ragazzi
elettrizzati
tutti in piedi
con le mani
protese.
Tu eri al centro della scena
seduto
su un minuscolo
sgabello
con la testa tra le mani
e chissà quali
pensieri….
Sembrava tu non avessi voglia
né di suonare né di cantare
sembravi
irremovibile
e la Pivano ti supplicava.
Quando imbracciasti la chitarra
si sentì
subito
un amore profondo straziante
nel cuore della tua musica
del tuo
canto.
Quando toccò a me proseguire
ero
fortemente intimidito.
A un certo punto chiedesti a Fernanda
cosa
dicevano
le mie grida di dolore.
Alla fine ti avvicinasti, mi guardasti
con
intensità.
Mi sembra ieri anche se è passato
molto tempo
e
in questi giorni te ne sei andato
da questo mondo
torbido e violento.
Non dimenticherò mai più
il tuo
abbraccio vibrante.
Ferruccio Brugnaro
(Ottobre 2013)
FRAMMENTI DI UN SOGNO
Il
giorno è grande
come
in nessun’altra
estate.
Il
tempo
arde
selvaggio.
Non
c’è memoria di orizzonti
così larghi
di un fuoco
così
immenso.
Il sole a un tratto
si
stacca
dal centro del cielo
come una palla
di granito nero
precipita sulla terra
tracciando un
largo solco
di sangue.
Il giorno
diventa notte
profonda
le stelle si scontrano
fragorose
assordanti
schianti duri
scontri
sibili
schegge
taglienti
missili e
missili
bombe e bombe
miste
a grida
tremende, forti grida
poi silenzio
buio intenso
silenzio
poi un alito leggero
da oscuri
lontani fondali
s’alza con un
cerchio verde
fiammeggiante
intorno al mondo.
 |
| Dario Pericolosi |
In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne che si terrà il 25 novembre prossimo, Dario Pericolosi dedica a tutte le lettrici e ai lettori di “Odissea” questi versi scritti per loro.
DALLA TUA PARTE
Ho la pelle fredda come la vendetta
una ciocca di vergogna copre il viso
adesso il mio corpo è carne senza
sensi
sono un angelo con due ali di follia
mi portano via dal luogo fatale
ma la mente resta sulla scena dello
scempio
voglio rivivere l'ultimo brandello di
vita
quando la violenza senza senso mi è
caduta addosso
il letto di erba è ancora caldo di te
o idiota di buona famiglia cosa hai
fatto
mi hai strangolata con il vile destino
dopo avermi strappato di dosso la
dignità
ora sarò la tua eterna ombra
ti seguirò fino all'inferno dove sarà
un gioco trovarti o infame futuro
e finirti con una dose letale di amore
Dario Pericolosi

Un racconto di Adamo Calabrese
NELLA GIUDEA
Marco XIII,16. Vangelo apocrifo
Quando vedrete avvicinarsi l’idolo della devastazione tappatevi le orecchie, chiudete gli occhi, nascondetevi sotto le coperte.
Quando vedrete avvicinarsi l’idolo della devastazione tappatevi le orecchie, chiudete gli occhi, nascondetevi sotto le coperte.
Tutti coloro che si trovano nella Giudea fuggano ai monti se
ci sarà ancora un treno che passa. Chi spia l’orizzonte non perda tempo, non
torni nella casa per salvare la stilografica del padre e gli aghi della madre:
non è più tempo per scrivere poesie, né tempo per abiti nuziali. Chi si trova
nella Giudea bruci i dizionari e le enciclopedie. È tardi per sapere come si
formano le maree e dove galleggiano gli iceberg. Tardi per conoscere dove vivono
l’armadillo e l’ornitorinco. Guai a chi frugherà i cassetti cercando le lettere
di chi se ne è andata. Quei fogli sono stati rosicchiati dai topi e non c’è più
traccia né di baci né di carezze. E ancora vi dico: chi è nel campo non torni
indietro a prendere il mantello, lasci che il vento agiti gli stracci come fossero
abitati da anime in pena. Soprattutto pregate perché ciò non accada d’inverno,
le ombre sono furbe delatrici:
“Io so dove è fuggita…”
“Dove? Parla!”
“Non posso, mi ha pagato per tacere”
“Ti do l’anello di mia madre. Parla!”
“Troppo poco.”
“L’orologio di mio padre. Parla.”
“Troppo poco.”
“Cosa vuoi?”
“Vederti piangere.”
Via, via! È arrivato l’inverno, la neve ha chiuso i passi. Chi
abita nella Giudea non perda l’ultimo treno.
AFORISMI
Graziella Poluzzi
Le multinazionali marciano sui colossali ricavi del
petrolio, mentre i popoli marciscono nel degrado ambientale del cambiamento
climatico.
*
La morale dell’uomo sulla pelle delle donne, si chiama
misoginia.
*
Parità uomo-donna? Il diritto c'è o c'è soltanto il
(mal)rovescio?
*
Il burqa è un involucro che nasconde un essere femminile
deambulante, oggetto impacchettato di proprietà dei maschi di casa. Difficile
che sia una scelta, senz'altro è una prova evidente dell’oppressione maschile.
*
Il sangue mestruale è il più grande simbolo di vita e di
morte, di potenza femminile. Eppure ce ne vergogniamo, lo nascondiamo: è
vissuto come un tabù. Chi ha deformato in tal modo il nostro pensare nei
millenni lontani? Le paure dei maschi? Non possiamo essere state noi stesse a
buttarci la zappa sui piedi.
*
Nei maschi circolano dei virus preoccupanti, come la
violenza, lo stupro, istinti non controllati, le perversioni sessuali e
psichiche, la pedofilia, il desiderio di voler ridurre la donna a essere
inferiore avvalendosi della forza fisica e delle deformazioni mentali singole e
di gruppo.
*
C'è un solo processo in cui a essere indagata è la vittima:
il processo per stupro.
MARIA CARLA BARONI
Un piccolo, tenero,
toccante, canzoniere amoroso,
che sa custodire il
bene prezioso della memoria.
POESIE PER ALESSANDRO MUSSI
Di Maria Carla Baroni
QUANDO SI AMA
Quando si ama
pare
di poter vincere qualunque muro
e possedere il mondo.
UNIONE
Navigo nei tuoi sguardi
nei tuoi sorrisi
sulle onde del tuo corpo
nella sacra unione di donna e uomo
ritorno ricorrente
all’unità primigenia.
TU E IO
Il mio amore per te
è l’acqua
che ha fatto rinverdire
e fruttare
la tua terra
compressa di semi inariditi.
Tu sei
l’illuminazione
e lo scintillio della mia vita
le fondamenta
su cui innalzo
la cattedrale della mia speranza.
SE QUESTO AMORE DOVESSE
FINIRE
Se questo amore
tenero fiore d’aprile
abisso profondo di luce
dovesse finire
proverei sgomento
come per una cattedrale
sbriciolata sulle sue fondamenta.
AMO TE
Amo il profumo
dolcemente aspro
dei tuoi genitali
amo il tuo corpo
ora statuario
ora arrotondato
dalla vita sedentaria
amo il tuo viso
segnato dagli anni
e da un’amara filosofia
amo i tuoi lunghi capelli d’argento.
Amo te.
LECCATE DI SOLE
Un’infinita languida dolcezza
nei tuoi gesti d’amore
leccate di sole
i tuoi baci
al mio corpo
alla mia mente
al mio olistico tutto.
DECENNALE
Lo stormire della vita al tramonto
mi ha donato il tuo amore
chiarore cangiante di raggi dorati
e la tua arte
che trasforma luce e sogni
in emozioni di colore.
Ignoro
quanto questo dono
potrà durare
ancora.
Rassegnata all’eterno divenire.
IL CASO FEROCE
Il caso feroce
che dona e toglie
e quando toglie
pare che sia
in modo da fare più male
mi ha tolto il tuo amore
che
stoltamente
pensavo sarebbe stato per sempre.
EREDITÀ
Arrovellìo di mente
continuo
mancamento di respiro
e visceri attorti
a tratti
mi ha lasciato
la morte del tuo amore.
DOPO L’ABBANDONO
Molti anni d’amore
mi paiono ora
solo un cumulo di poveri giorni
io straniera alla mia stessa vita
amputata di metà della mia vita.
Ma continuano a scorrere
le acque del tempo
lungo le ore e i giorni
rintocchi di campane a morto
e la passione
faticosa
di continuo rinascente
per il mondo da cambiare.
LUCE E PROFUMO
La splendente luce della luna
che dilaga dall’alto nella notte
e il profumo dei tigli
ascendente alla mia terrazza
avrei voluto donarti
insieme alla mia casa e alla mia vita.
ERA UN SOGNO D’AMORE
Era
un sogno d’amore lungo una vita
la porzione di vita
che avremmo ancora avuto in questa forma
per poi continuare
due scintille di Energia
vaganti insieme nell’infinito eterno.
ACQUA E LUCE
Io
per te
acqua di vita.
Tu
per me
splendore di luce.
MORTE
L’evento più naturale che ci sia
il più terribile
inconoscibile
finché t’avvolge ti stringe e ti consuma.
AD ALESSANDRO MUSSI POST MORTEM
I
Per una manciata d’anni noi
due lembi di un’unica fiamma.
Sotto la cenere dei giorni andati
amore mio perduto
il rimpianto
su sabbie mobili di morte.
Anni sono colati goccia a goccia
sperando una speranza che non c’era.
Tu – lontano – pure eri vivo.
Ora anche tu sei cenere
avvolta di silente suolo oscuro.
II
Impossibile a me pare il tuo morire
delitto di natura
matrigna
il morire del tuo genio.
Mai più nulla potrai
piantare narrare sognare.
Impossibile a me pare dirti addio
senza sapere
se la tua arte e il tuo nome rimarranno
cippi di luce
nell’infinito tempo divoratore.
III
Tu
solo
nei tuoi quadri
nei tuoi libri
nella mia mente
impotente
angoscia ricorrente.
Accetto la morte: la mia
quando verrà.
Non posso accettare
la tua.
PAROLE NEL VUOTO
Nelle notti di luna oscura
nelle notti di plenilunio
parlo con il mio morto amore
cenere in un vaso sepolto.
Parole a spirale nel vuoto oscuro.
CENERE
Amore mio
inerte morta cenere sepolta
mio tutto ridotto al nulla
solo punta di freccia improvvisa
lacerante nella mia mente accesa.
Mistero al lago di Staz
L'Engadina nel giallo di Ettore Comi
Ettore Comi è un'artista polivalente: fotografo, regista e
scrittore; ed è uomo cosmopolita che ha vissuto a Milano, Roma, Londra e ora
per motivi familiari e affettivi è tornato nella sua terra natia, la Valmalenco
e la Valtellina. In questo ultimo periodo si sta dedicando intensamente alla
stesura di romanzi, di cui uno, Mistero al lago di Staz. L'ultima regina
dell'Engadina è già stato pubblicato e oggi si trova nelle librerie in una
nuova versione grafica. La Pro Grigioni Italiano della Valposchiavo,
interessata da vicino ai luoghi del romanzo, ha sentito l'autore.
Conosciamo il suo
romanzo nella prima edizione. Oggi ha una veste grafica differente e una nuova
casa editrice. Come mai questo cambiamento?
Un motivo semplicissimo. La totale inefficacia del
precedente. Una scarsa qualità nella stampa e, soprattutto, nella distribuzione
e produzione. Onesto, certamente ma non all'altezza per rappresentare un
romanzo "meritevole" come Mistero al lago di Staz. Il precedente l'avevo scelto perché lo
pensavo più professionale ed efficace e, nonostante non avessi visto alcunché
di loro produzione, mi sono fidato lo stesso. Inoltre non avevo molto tempo e
ho dovuto decidermi per questo, come fatto e in buona fede.
Ci spieghi di cosa
tratta questo libro?
È un romanzo che definirei un noir a tinta rosa. Non è un
vero e proprio giallo che comporta un’indagine approfondita da parte della
polizia o del commissario, e in cui il colpo di scena iniziale solitamente è un
omicidio. Qui c’è invece la figura di un docente universitario di criminologia,
Luigi Delle Valli, che proverà a sciogliere il mistero della sparizione di
Rossana, una sua studentessa, che lo ha invitato in Engadina. All’inizio, non
incontrandola, l’uomo pensa a uno scherzo, a un dispetto, a una propria
illusione. Ma che significa tutto ciò? Si chiede, infatti, e non pago si
“impunta” in maniera esagerata per sbrogliare questa situazione critica. Credo
che sia una storia originale che non usa gli espedienti più banali del libro
giallo.
Penso che Luigi Delle
Valli sia un personaggio costruito molto bene a livello psicologico e ciò rende
ancora più intrigante lo svolgimento della storia e lo scioglimento del
mistero. Il lettore continua a chiedersi se è una persona lucida oppure se vive
in uno stato di follia. Ci sveli fin da ora chi è Luigi?
Luigi è un uomo concreto, tutto d’un pezzo, fermo nelle
proprie convinzioni. È un grande testardo che deve arrivare alla meta a costo
di rischiare la propria pelle. È una persona coerente che non si arrende di
fronte a nulla, però è anche un gran sognatore. Quando va in slitta in Val
Roseg, attorniato dalla corona di cime rosa, si sente in un sogno come il
Dottor Zivago, ma la realtà cruda talvolta lo risveglia, prende una bastonata
sul collo e subito dopo si rialza più forte. A un certo punto del romanzo,
preso dallo sconforto, vuole andarsene da quel mondo di “cupole sfavillanti” e
tornare nella mediocrità della sua vita abituale, ma basta un’occhiata e
osservare una finestra illuminata nella Villa del mistero, che improvvisamente
ritorna la forza per proseguire la sua ricerca indagando con maggior
determinazione nei fatti di cronaca, nelle tradizioni, fra i segreti e i
pregiudizi delle famiglie locali e nell’arte di Segantini.
Come è nata l’idea di
ambientare un romanzo in Engadina?
È un posto che ho sempre amato, ci venivo fin dall’infanzia
con i miei genitori. Allora del paesaggio tutto mi sembrava ingigantito e
meraviglioso: il treno mi sembrava un’astronave e la tratta del Bernina fino a
Sankt Moritz sembrava un percorso infinito. Due anni fa a febbraio, in
occasione del Centenario della Ferrovia Retica, io e mio padre abbiamo fatto la
stessa gita, purtroppo senza la presenza di mia madre, morta da poco. Naturalmente
dopo 40 anni la mia visione del mondo è cambiata completamente, ma mi resi
conto che la bellezza di alcuni luoghi mi avevano accompagnato per tutta la
vita. Proprio alla stazione di Tirano, alle 7.30 di mattina, in un ambiente
straordinario da set cinematografico, ho pensato: “un giorno o l’altro devo
scrivere qualcosa di bello su questo luogo”. Poi in quel viaggio ho scattato
delle foto e mi sono divertito. Pochi giorni dopo ho rivisto le fotografie
scattate e in particolar modo ho notato un corteo di carrozze trainate da
cavalli…
Appunto, ha
incentrato la storia attorno alla “Schlitteda”, tradizionale manifestazione
engadinese di costume che si tiene ogni anno nel mese di gennaio!
Sì, infatti, pochi giorni dopo mi capita di leggere in un
giornale – pensa che combinazione – la descrizione della “Schlitteda” che
significa slittata. Ho letto avidamente l’articolo e mi è venuta in mente
l’idea di prendere questo corteo come riferimento per un invito nei territori
engadinesi. Un invito che si rivela un’esca per attirare e coinvolgere una
persona con una scusa banale e allo stesso tempo questa esca è il perno attorno
al quale ruota tutta la storia.
Molti sono i film e i
romanzi che abbinano il mistero all’ambiente boschivo. Anche il suo romanzo
fonde questi due aspetti. C’è effettivamente una relazione?
Sì, il chiaro e scuro, la luce e l’ombra del bosco danno il
senso del mistero. Infatti ignoro molte volte la neve per concentrarmi sul
bosco. Gli alberi escono prepotenti perché racchiudono in sé questa equivocità
sensitiva: vedi e non vedi, ti nascondono, ti proteggono ma possono ostacolarti
o farti male mentre corri. Nel mio romanzo, in effetti, ci sono inseguimenti e
aggressioni nel bosco, quindi posso ben dire che è lo spazio ideale per tenere
alta la tensione.
Quali sono brevemente
le immagini più rappresentative del Mistero
al lago di Staz?
Ho già accennato a “La schlitteda” e sicuramente molto
importante è la figura del pittore Segantini. Ho visitato il museo di Sankt
Moritz dedicato all’artista e lì mi sono appassionato alle sue pitture. Per la
riuscita dell’enigma romanzesco ho preso spunto da un suo quadro inesistente,
ossia inventato dalla mia fantasia. Mi rendo conto che ho utilizzato, magari
con un po’ di presunzione, il nome di questo grande artista e spero che non mi
mandi una maledizione dall’Aldilà, ma non ho fatto altro che rendergli onore.
Poi rilevante è l’Ultima Regina d’Engadina, epiteto che doveva comparire come
sottotitolo al romanzo, ma l’editore ha deciso di tralasciare. Ironicamente mi
sono immaginato una regina di cuori in Engadina, una sorta di principessa che
non è mai esistita a livello storico e legislativo, ma che la tradizione locale
ha tramandato nei secoli come una bellissima figura nobile che merita di
dominare su tutti e insegnare al popolo. Forte è anche l’immagine della ferrovia retica…
Esattamente, nel
primo capitolo Lei descrive il paesaggio che percorre il trenino rosso del
Bernina. Quali impressioni vuole suscitare nel lettore?
Nell’intero lavoro credo di esser riuscito a dare risonanza
a certi aspetti paesaggistici. Il trenino rosso è un marchio di bellezza del
paesaggio svizzero a differenza di molte ferrovie italiane e questo scarto l’ho
voluto suggerire nella scena dello scambio dei treni alla stazione di Tirano.
Inoltre mi interessava dare l’impressione d’elevazione usando la scrittura,
come nel caso del passaggio al Viadotto di Brusio: «Improvvisamente vidi,
davanti a me, la testa del treno che ci affiancava (…) Sembrava che il
locomotore si fosse voltato verso di noi per avvolgerci in un impetuoso
abbraccio (…) » e così guadagnare quota attraverso questo monumento a spirale.
E poi volevo far risaltare l’aspetto vertiginoso del panorama mozzafiato,
passando – metaforicamente parlando – dal girone dantesco all’esplosione di
luce del paradiso, lassù dove finiscono i boschi. Luigi Delle Valli è talmente
catturato e affascinato dalla bellezza del paesaggio che lungo il viaggio non
pensa più a Rossana. Tutta la sua attenzione si focalizza sulla novità di
questo splendore e ogni scorcio è uno spettacolo meraviglioso ai suoi occhi.
Diciamo che questo percorso, che ho cercato di descrivere senza dilungarmi
troppo, è la via che innalza il protagonista dalla stantia mediocrità urbana
alla bellezza dell’Engadina e nel contempo all’azione di una vita vissuta al
massimo.
Cosa Le piace della
Svizzera, in particolare della realtà valposchiavina e engadinese?
Possiedo moltissimi ricordi di famiglia; infatti venivamo
spesso a Poschiavo per prendere i gerani e ricordo che mio padre diceva a mia
madre che durante l’anzianità gli sarebbe piaciuto essere accolto in Casa
Anziani. Io ci verrei a vivere subito. Tante volte la bellezza si coglie da un
giardino fiorito, da un bell’orto, dalla pulizia, si capisce dal rispetto verso
il proprio territorio, verso la propria cultura e le proprie radici. In
Valposchiavo, infatti, c’è tutto questo e si respira pace e armonia. Qui non
c’è l’impressione della deflagrazione del territorio stesso come è successo in
molte zone italiane, purtroppo devastate. In Valposchiavo la bellezza è esibita
con discrezione. Di Sankt Moritz direi la stessa cosa ma portata a livelli
superiori – anche se personalmente preferisco Pontresina – nel senso che è
racchiusa in una bolla di straordinarietà come, per esempio, Venezia o Firenze,
e tutto è talmente bello che, pur essendo esasperato, non cade nel cattivo
gusto.
Lei è uno scrittore
prolifico. Sappiamo che sta già lavorando a diversi romanzi. Ci può dare delle
indicazioni sulla sua prossima opera che sarà pubblicata?
È una storia d'amore, di vendetta e di terrorismo ambientata
in una Milano moderna. Un romanzo molto profondo e ricco di suspence. Una lotta
di nervi tra il protagonista e se stesso, il suo credo e molti altri aspetti
psicologici. Un eroe che prenderà il protagonista per mano e lo porterà ad
essere felice, ma nello stesso tempo lo renderà un oggetto devastante, per poi
pentirsi di ciò in un finale a sorpresa. Un astuto e caparbio commissario che,
intuito il dramma, fa ogni cosa per evitarlo, ma il destino arriverà prima di
lui. E una donna aggredita e ridotta in coma che sarà il motivo scatenante di
odio e vendetta e un Dio che sorveglia tutti loro senza purtroppo farsi mancare
una vittima designata. Un romanzo importante, lo definirei così. Un tema
importante: la religione, purtroppo adoperata nei suoi effetti più radicali,
fanatici ed estremistici. Ma anche e tanto la bontà dei personaggi che sanno
dare tutto loro stessi per il proprio credo. Questo è il titolo: "Alba a
Milano". Per la pubblicazione se ne sta occupando il mio agente Enzo
D'Elia, un vero agente, conosciuto e definito uno dei migliori sulla piazza.
Nelle sue mani, sono certo, Alba a Milano troverà la giusta collocazione sul
mercato.
(Intervista a cura di
Giovanni Ruatti)
RACCONTI PENDOLARI
NERO MILANO
Si alzò, facendo
scricchiolare di sollievo le molle dell’ottomana. Da quando sua moglie, la
Cesarina, era morta, si era come un po’ ransignito,
ma pesava sempre i suoi bei centodieci e passa chili. E dire che lei era uno
scricciolo di donna. Ridendo diceva sempre che si sarebbe potuta sdraiare su
una delle sue manone. Eppure, con quelle manone li, vederlo lavorare alla fresa
o al tornio di precisione, eeh...
Cupo in volto pensò che l’aveva già fatto una volta. Anche
se quasi settant’anni fa. Sessantotto, per la precisione. Aveva ucciso tre
persone. Tre fazzoletti. Appena prima della fine della guerra. Che aveva appena
tredici anni. Uno sgarzolino di si e
no quaranta chili. Pesava più il fucile di lui. I compagni del gruppo erano
indecisi. In fuga da un rastrellamento congiunto di tedeschi e repubblichini,
erano finiti in un vallone e avevano sorpreso quelle tre camicie nere.
Lasciarli andare non si poteva, avrebbero messo gli altri sulle loro tracce.
Portarseli dietro meno che meno. Nessuno dei suoi sembrava propenso a farlo,
così, a freddo. Si fece avanti serio e disse lo faccio io. Finora aveva fatto
solo la staffetta, era dovuto restare su in montagna che gli avevano fatto la
spiata. Sparare però era capace. E di morti, compresi tre suoi zii, ne aveva
visti tanti, sparati appesi con il cartello banditi appeso sopra. O peggio, nei
fossi, lasciati li come i topi. Così, con il cuore duro e la sguardo cattivo,
un colpo per uno e ciao. Non si era mai pentito, anche se, tornando indietro
non l’avrebbe più fatto. Forse quei tre non se lo sarebbero meritato. Come
peraltro tanti di quelli uccisi da fasci e toderi
per rappresaglia. Ma erano tempi così. Dopo la guerra non ne aveva più parlato
con nessuno. Solo alla Cesarina.
- Ho fucilato tre uomini. Se mi vuoi sposare devi saperlo -
Da allora non aveva più fatto del male a nessuno.
Questi tre invece se lo meritavano. Proprio.
Aveva scoperto la faccenda un pomeriggio tardi, verso la
sera, passando in bici - usava una bici da trasporto che prima era del
prestinaio, data la sua mole - per le strade verso Vaiano. Facendo una sterrata
aveva sentito delle voci forti e dei gemiti di donna. Si era inoltrato un venti
metri in un macchione di sambuco. Di tra il fogliame si vedeva una baracca e,
sullo spiazzo davanti, due sacramenti che malmenavano una ragazza. Altre tre
ragazze stavano vicine vicine impaurite un po’ più in là. La prima tentazione
era stata quella di buttarsi in mezzo e di prenderne uno per picchiare l’altro.
Ma a ottantun anni, anche se di forza gliene sarebbe magari bastata... Fortuna che era riuscito a
trattenersi e a stare schiscio. Dalla
baracca ne era uscito un terzo, trascinando per un braccio una biondina, che
venne sbattuta a terra e si prese anche lei la sua ripassata. Anche se aveva la
morte nel cuore i suoi occhi rimasero asciutti. Mai aveva pianto in vita sua.
Neppure al funerale della Cesarina. Lui, che non aveva mai sopportato che si
facesse del male alle donne, quelle li poi erano appena poco più che bambine, stette
a guardare tutta la scena fino in fondo senza fare una piega. Solo gli occhi
diventavano via via più foschi. Aveva tenuto d’occhio la casupola per una
settimana, botte e stupri compresi. Se voleva, anche grosso e vecchione,
riusciva ancora rendersi invisibile nel fogliame folto di fine estate. E poi si
era deciso. Quelle tre bestie li non andava bene lasciarli al mondo. E oggi era
il giorno. Tirò fuori dal cassetto il mattarello della Cesarina, inutilizzato
da quando... Fece un sorriso storto, a pensare, ironia della sorte, che avrebbe
usato l’arma femminile di tante barzellette. Chi femmina ferisce, di femmina
perisce... più o meno. Almeno, speriamo. Se anche avesse avuto lui la peggio,
beh, avrebbero dovuto ammazzarlo. E ne sarebbe venuto fuori comunque un bel
casino per i tre bigoli. O almeno per quelli sopravvissuti. Segò a malincuore
il mattarello di un terzo, per renderlo più maneggevole. Legno di faggio bello
duro, stagionato dagli anni e liscio dall’uso. Ehh, Cesarina... Prese dall’armuar la tuta dell’officina, bella
lavata e stirata dal giorno della pensione. Gli era diventata un pelo larga, ma
sopra i vestiti sarebbe andata a
pennello. Anche un cappello a maglia scuro, per nascondere i capelli bianchi.
Fece tutto su in un sacchetto dell’Upim, arma e indumenti.
A mezzanotte se ne stava seduto appoggiato alla
baracca, invisibile, vestito di scuro.
Di solito riportavano le ragazze verso le due, le tre, ma si sa mai. Ogni tanto
si stirava, facciamo scricchiolare le vecchie ossa. Spero solo non mi si incricchi la spalla proprio sul più
bello, pensava. Quando da lontano sentì la macchina arrivare si mise in piedi
nascosto all’angolo vicino alla porta. Li c’era un cespuglione che faceva
un’ombra buia nel chiarore della notte di mezza luna. Aveva dovuto aspettare la
sera giusta, con quel tanto di luce per vederci e quel poco per non essere
visto.
Arrivarono in due, a rinchiudere le ragazze nella baracca.
Il terzo di solito aspettava in auto, ascoltando musica di merda. Mentre uno
sprangava la porta si portò silenzioso dietro di loro. Il colpo che stese il
più vicino, girato di spalle, lo sentirono magari fino a Chiaravalle. Non si
era ancora afflosciato per terra che fece partire il mattarello verso il
secondo. Ma con l’età era diventato lento. Agile come un serpe quello si era
spostato quel tanto per prendere il colpo sulla spalla invece che in testa.
Probabilmente gli ruppe la clavicola. Per non farlo gridare lo afferrò per la
gola con la sinistra e strinse, mentre quello ravanava nelle tasche, riuscendo a
tirar fuori un serramanico. Ma non in tempo. Quando sentì che non si muoveva
più lo lasciò andare giù. Tirò anche a lui una mattarellata, sul collo. Sentì
le ossa rompersi. Poi aspettò. Il terzo, non vedendo i compari arrivare, prima
fischiò, poi, magari pensando che stessero facendosi una sveltina di buona
notte, pensò bene di partecipare. Lui lo aspettava al buio, al limite della
radura.
Fatto.
Tirò un paio di respiri. Non sentiva niente. Ne
soddisfazione ne rimorso. Solo male alla spalla. Si calcò il berretto fin sugli
occhi, alzò il bavero della tuta fin sopra il naso. Divelse la porta facendo
leva col mattarello. Dentro le ragazze, alla luce di una pila, guardavano
spaventate quella grossa figura incombente. Facendo gesti, sperava,
rassicuranti, fece capire di raccogliere le loro cose e andarsene. Mentre le
accompagnava sulla strada asfaltata illuminò con la torcia i tre corpi distesi.
Voleva fossero sicure che, almeno da quei tre, non avrebbero più subìto del
male. Le vide avviarsi verso il Vigentino, alla luce fioca dei lampioni
distanziati. Prima indecise poi sempre più svelte. Una volta sparite recuperò
la bicicletta dal folto e si avviò anche lui, senza accendere la dinamo.
Arrivato a casa mise la tuta da lavare.
Poi si sedette, facendo scricchiolare di fatica le molle
dell’ottomana.
Giancarlo Bonizzoni
UNA STREGA MILANESE[1]
Per aver fatto
tre ad un filo nodi[2]
fu condannata al
rogo la fantesca.
Il confessore
traditore innesca
l’orrenda fine
dai gentili modi.
Si è ammalato il
suo nuovo padrone[3],
ma certo è stata
lei, la fattucchiera.
Un precedente
aveva la megera,
l’antico amante[4]
come testimone.
Già subito
confessa, convincenti
son per chiunque
le tenaglie ardenti.
Non hanno scampo
gli animi innocenti,
la chiesa vuole
sangue… Complimenti!
Pietosamente
prima impiccata[5],
solo da morta
salirà sul rogo.
Alla sete di
sangue dare sfogo
una cultura deve,
alienata.
Chi meglio di
una donna incarna il Male,
lei che la mela
accettò dal serpente?
La bibbia fonte
sacra che non mente,
facciamo un bel
falò per carnevale.
Lorenza Franco
Milano, 3
novembre 2013
[1] Caterina de Medici, uccisa il 4 marzo 1617
[2] Consigliata da una maga per
avvincere a sé l’amato. Ma poi andò a confessarsi…
[3] Il senatore Luigi Melzi d’Eril
[4] Il capitano Vacallo
[5] Trasportata al patibolo su un
carro mentre il carnefice la torturava con tenaglie roventi.
Biblioteca Vigentina, foto di gruppo con scrittori, in
occasione della presentazione del libro di Angelo Gaccione La signorina
"volentieri", 28 ottobre 2013
Foto di Marla Lombardo
IL PANE E LE ROSE
POESIE
di Franco Toscani
(a Gianni Zambianchi)
novello dioniso
traboccante
un satiro danzante
sei
amico caro
grande fortuna
serbare in sé
il dio della vita
dell’amore
la bella potenza
l’ebbrezza sana
la felicità ai mortali
accessibile
la feconda parola
dei creatori
tra il faggeto
e il crinale del monte
si staglia la luna
sussurra
all’inquieto cuore
parole di miele...
rischiara nella notte
la bianca sfera
sonnecchia il Ragola
un freddo silenzio
sovrasta...
il suono delle foglie
dove vuole
soffia
libero e forte
il signor vento
d’ogni umana cosa
dei sordi filosofi
incurante
Wallace Stevens
il suono
ascolta
delle foglie
del vento
il segreto
carpisce
la musica
le alate parole
l’addio
il paesaggio
della valle
a lungo
osservo
il verde colma
il cuore appaga
ma sopravviene
il pianto
pace non danno
negletta bellezza
ciechi viandanti
aspri addii
la bianca farfalla
nel lutto
e nel sole
la bianca farfalla
il cuore conforta
la pena allevia
è il volo dell’amico
l’amico nell’aria
l’amore tenace
per il gioco del mondo
nelle notti
di luna piena
dell’alta valle
a sé stessi
accendono
i mortali
un lume
i cuori
alla speranza
inclinano
nel chiaroscuro
notturno
amabile pare
il mondo
nell’attesa
e nel ricordo
dimoriamo
tarda il sonno
esserci
lucciole
nelle notti
di monte Armano
grazia
e magia
di natura
tremiti del bosco
dal vivo mistero
e quand’appare
Aurora
dalle dita di rosa
gaio
avvia il giorno
un canto d’uccelli
giochi
quando
la boccuccia
di geisha
inizia
la danza
con far di gattina
giochi
m’avviluppi
e mordicchi
il bischero
grato
al piacer
m’abbandono
notte quieta
(a Monique)
distese boschive
chiarisce la luna
nell’alta valle
alla finestra
della casa silvana
col cuore ricolmo
scrive l’amante
alla sua cara
mésso di baci
e abbracci
il monte
si staglia
nella notte serena
e la luna
muta presenza
contempla
mentre il gioco
medito
del mondo
e le parole
del cuore
sondo
con mille domande
sulla dolce follia
della vita mia
m’interrogo
sull’amore tenace
del pensiero
d'esistenza
passione
*Franco
Toscani (1955), saggista e docente di Filosofia a Piacenza, fa parte del
consiglio di redazione della rivista “Testimonianze” ed è redattore della rivista
“Filosofia e Teologia”. Nel 2003 ha pubblicato, presso l’editrice Blu di
Prussia di Piacenza, una plaquette di poesie, dal titolo La benedizione del semplice (“Prefazione” di C. Sini). Ha
collaborato a riviste e a giornali come “aut aut”, “Alfabeta”, “Nuova
Corrente”, “Studi Piacentini”, “Città in controluce”, ”dalla parte del torto”,
“Testimonianze”, “Filosofia e Teologia”, “Dharma”, ”Odissea”, “Koiné”, “La
Stella del Mattino”. Ha pubblicato testi
filosofici presso le case editrici Jaca Book, Odissea e Bompiani di Milano,
Petite Plaisance di Pistoia, Cleup di Padova, CFR di Piateda (Sondrio). Fra le
sue ultime pubblicazioni, il volume (co-autore S.Piazza) Fede e pensiero critico nell’età globale. Testimonianze per una civiltà planetaria,
Cleup, Padova 2010; per le edizioni Odissea di Milano (2011), i saggi Gandhi e la nonviolenza nell’era atomica e Luoghi
del pensiero. Heidegger a Todtnauberg ; il libretto ‘L’azzurro della scuola degli
occhi’. Terra e cielo di Hölderlin e
di Heidegger, CFR, Piateda (So), 2012.
di Adam Vaccaro
Notazioni in avvio
della II Maratona del 28 settembre 2013 allo Spazio ScopriCoop di Milano,
manifestazione collegata con 100 Thousand Poets for Change.
Queste notazioni si ricollegano a quelle che feci in
avvio della Maratona dello scorso anno, nello stesso intento di sottolineare
qualche tratto del viaggio di sensi, di pensiero e di eros, che si svolge tra
Poesia e Esistenza, “in direzione dell’esistenza”, come diceva Antonio Porta.
Tale tensione è, in altri termini, tensione alla
totalità, lievito del bisogno di relazioni gioiose (Spinoza) tra parte e
totalità della vita. Che non possono esserci senza comunicazione, col senso di
condivisione e capacità di mettere in comune. Operazione intesa perciò della
massima complessità (“non è un piroscafo di linea”, dice ancora Porta), che
nulla ha a che fare con i “messaggi arresi al senso comune del comunicare
piatto” (Niva Lorenzini) della prassi quotidiana. Che spesso genera più scie di
travisamenti e miraggi che non quel senso cercato di comprensione profonda e
presenza, dentro noi stessi e nel mondo. Parafrasando Platone (che nel Timeo
definisce il tempo “immagine mobile dell’eternità”) è nella fortuna di tali
momenti che sentiamo di vivere attimi di infinito, che ci cambiano e
(r)esistono in quanto generati da relazioni amorose nel senso più alto e ampio,
che coinvolgono parte affettiva e razionale e fanno sentire adiacenza e non
distanza alienata tra i soggetti.
La tensione a esserci qui e ora è la scommessa più difficile
nella realtà attuale, inondata com’è da un mare di messaggi apparentemente
chiari ma falsi provenienti dal sistema dei poteri e da gran parte dei media.
Il prodotto è una distruzione di senso (umano), che chiede con ciò all’Arte e
alla Poesia reinvenzioni inattuali, che tendano a re-istituire il senso negato,
nel paradosso di un progetto ignoto. Tale peraltro per qualunque ricerca –
filosofica, politica, economica ecc. – che voglia esercitare azione critica
verso i dettami ideologici dell’esistente, se è vero che “L’orizzonte sociale è
connaturato all’atto critico” (Romano Luperini).
Questa serie di osservazioni (ricorrenti nei miei scritti
critici) spingono a rilevare che non solo la classe dirigente nazionale
(politica e no), spesso così distante e indegna, ma anche gran parte di coloro
che operano nei vari ambiti della Cultura, non riescano a testimoniare una
risposta adeguata alla crescente deriva decadente dell’Occidente in genere, e
in particolare dell’Italia.
Rispetto a tale deriva cerchiamo scritture coinvolgenti,
estranee sia a una autoreferenziale illeggibilità, sia all’illusione della
semplicità (le due rive prevalenti delle scritture contemporanee). Per questo,
da parte mia ho parlato di Terza riva, capace di coniugare complessità e
transitività.
Beninteso, ciò non vuol dire inventare forme di
“‘politicizzazione dell’arte’”, contrapposte alla “estetizzazione della
politica” (Benjamin), vedi le statue di cera di molti politici; e non vuol dire
nemmeno riproporre le inutili dispute nominalistiche dei poeti su poesia pura o
poesia tout-court (le forme poetiche sono sempre state tante, come del resto
quelle della musica e di ogni arte) e poesia civile o impegnata. Ciò che sto
dicendo credo indichi chiaramente altro. C’è un vuoto di “progettazione alternativa”
(Francesco Leonetti) e in tale vuoto possono agire tutti i linguaggi, compresi
quelli creativi, con la libertà e i caratteri che gli sono propri, purché i
soggetti che li utilizzano incarnino profondamente quel bisogno. Il problema
sta qui: chi incarna una necessità è liberamente incatenato ad essa e alla
ricerca dei modi di darle forme e altra vita.
Ora, non c’è dubbio che tutti stiamo al mondo, ma c’è
modo e modo. C’è chi è concentrato sul proprio ombelico e chi pensa di andare
oltre la propria casa-identità, tendendo a inglobare in essa il Resto. Per chi
fa arte, poesia, questo vuol dire fare dei propri segni materia di tale
tensione che è di conoscenza, impossibile senza eros e amore, nemici di
indifferenza e separatezze. Il che implica per me che, al di là del sogno
utopico di (contribuire a) cambiare il mondo, è vitale per i propri segni il
(bi)sogno di una polis che non smetta di volersi elevare all’umano.
È il senso delle tematiche poste da questa iniziativa
internazionale, che abbiamo condiviso, partendo da un atteggiamento di umiltà
quale quello dell’insegnamento socratico: io so di non sapere – opposto alle
dominanti arroganze o hybris secolari contro la natura e altri esseri umani.
È un atteggiamento conscio delle difficoltà e della necessità
dura di imparare da ciò che succede. Tutti i sogni e le resistenze del senso
umano devono ripartire sempre di ciò che accade, che oggi vede una distruzione
crescente degli equilibri auspicabili, nell’utilizzo delle risorse naturali,
nei diritti dei più, e nella distribuzione ignobile della ricchezza, per cui il
10% della popolazione ne possiede il 70%, legittimato da un sistema
socio-economico che si dice democratico.
È una realtà sociale che sta producendo violenze
economiche contro aree, paesi e settori sociali, rispetto alle quali la
sinistra storica è stata corresponsabile negli ultimi decenni della gestione di
scelte coperte da una ideologia di libertà, che distrugge relazioni,
discrimina, disgrega e aliena, territori e persone e, non da ultimo come già
accennato, il senso umano del lavoro per un arricchimento non solo materiale di
tutti.
Ora, la distruzione del senso umano passa dalla
distruzione del senso di tante parole, in particolare di quelle che sono nodi
fondanti le categorie mentali costituenti la nostra identità, come individuato
da Kant e poi approfondito nel ‘900 dalla Metodologia Operativa e dalle scienze
cognitive in genere. Nodi che sono al centro del poièin, della poesia nel senso
più ampio, del fare di ogni azione creativa.
Vale forse la pena, in proposito e in chiusura di queste
notazioni, ricordare alcune delle parole che nell’arco degli ultimi anni sono
state completamente stravolte o dimenticate o perdute nei loro sensi originari,
profondi e quotidiani.
Anche con qualche sorriso, ricordiamo che solo alcuni
decenni fa parole come “cellulare” o “escort”, riguardavano, la prima, le
camionette della polizia, la seconda, un modello di auto della Ford. Solo
qualche decennio fa, sintagmi come “giustizia sociale” avevano un senso che oggi
è pressoché cancellato.
Oggi campeggia la parola libertà, declinata
dall’ideologia dominante del neoliberismo e rivendicata dai potenti di turno,
come copertura e diritto di farsi gli affari propri. Così anche, a seguire,
parole come verità, equità, responsabilità, stabilità, tutte declamate per
renderci supini, immobili, quasi morti, mentre viene detto il contrario e chi
non ha potere impari!
E potremmo proseguire con tante altre parole che scorrono
spesso sulle bocche aperte negli schermi televisivi o scritte su giornali al
servizio di questo o quello. Come ad esempio rivendicare innocenza, anche se
condannati e per la legge si è delinquenti ma…fa niente! Non insistiamo,
altrimenti è una persecuzione!
Pensiamo piuttosto alla coesione (nazionale), alla Costituzione!
Pensiamo alla ripresa, perché vediamo la luce in fondo al tunnel! Crescita, ci
vuole crescita, che richiede una grande intesa, per cui ci vuole un tavolo,
dentro il Palazzo, circondato da un codazzo e perenne mucchio selvaggio di
microfoni …
Ma occorre rispetto, e non facili ironie, per Saggi e
paggi e Tv che dicono, non dicono, ci dica ci dica ma non mi dica?! Certo!
Liberismo! Certo! Che altro? Non c’è altro pensiero, pardon, altra ideologia!
Fabiano Braccini
 |
| Fabiano Braccini |
VINEIDE
Canto del vino (rosso, sia ben chiaro,
ché il bianco a me poco s’addice!)
le grandi doti e il bene che può fare
a chi ne sa dosare la misura
senza varcare il limite di guardia
tra puro godimento e perdizione.
Con dedizione quasi maniacale,
affido al sole, all’aria al temporale
quei grappoli gonfi e pesi che pare
debbano scoppiare tanto son tesi
e resto nell’attesa fiduciosa
che scocchi l’ora della libagione.
Allora sarà festa in me e nel mondo
e danzeranno i chicchi l’euforia
di giungere alla culla dei bicchieri,
alle papille di chi assaggia e gusta,
con spirito devoto e immenso amore,
il sapore di-vino della poesia.
VINO e POESIA
Al mio Amico,
che con passione amatoriale
coltiva una vigna in Toscana
e produce tre qualità di ottimo vino,
ho proposto
il brindisi enologico/culturale
seguente:
“I tuoi vini diversi
per i miei versi divini“
In occasione
dell’incontro sul libro di Federico La Sala “Della terra il brillante colore” (Edizioni Nuove Scritture)
tenutosi alla Libreria Popolare di via Tadino, a Milano, la serata è proseguita
con un simposio filosofico-poetico e gli autori ed i lettori presenti, sono
stati invitati
a leggere testi
poetici sul vino, racconti, raccontare aneddoti e così via. Il tutto mentre si
beveva del buon vino e si conversava in gioiosa amicizia. Giorgio Aleardo
Zentilomo, da appassionato e cultore dell’opera lirica, ha affrontato, in una
efficace sintesi, la presenza dell’elemento vino all’interno di alcune delle
più celebri Opere del repertorio musicale italiano. Ma ci ha deliziato anche
con veri e propri accenni canorici, che il numeroso pubblico presente ha
mostrato di apprezzare. Proponiamo ai lettori uno stralcio del suo intervento.
(A.G.)
“L’indicazione è scaturita durante la
presentazione di un libro dove si faceva cenno alla presenza di tralci di vite
in Valsesia fin dal settecento A.C. avendo ritrovato acini d’uva rinsecchiti in
anfore dell’epoca.
Si è manifestato così l’interesse ad approfondire
l’argomento “vino”, attingendo a quanto testimoniato in poesie e prose di vari
autori e non solo opere dedicate alla cultura dell’enologia con trattati
tecnici e didascalici per addetti ai lavori.
Per parte mia, grazie alla passione nei confronti del
buon vino e della musica, è scaturito il significativo titolo per una serata
“diversa” ad essi dedicata: “IL VINO ALL’OPERA”.
Dando fondo alle esperienze canore vissute, ho cercato di
individuare in quali opere liriche viene citato il vino e in quale fraseggio
musicale. Qui appresso segue un elenco, suggerendo se possibile, un
accompagnamento di testimonianza sonora cantata con le motivazioni storiche
della trama, come poi attuato dal sottoscritto per una più incisiva
memorizzazione dell’uditorio. Si pensi, ad esempio, alla subdola iniziativa da
parte di Jago di far ubriacare Cassio e così metterlo in cattiva luce agli
occhi di Otello che di conseguenza lo defenestrerà dal ruolo di Capitano;
oppure alla melliflua proposta da parte di Scarpia per riarmonizzarsi con Tosca
o all’ingenuo entusiasmo di Nemorino per l’Elisir (semplice bottiglia di vino)”.
A parte FALSTAFF
di Verdi che nell’opera impersona di per sé il ruolo di un cantiniere
impenitente “beone”, in molte opere liriche si accenna al vino con convincenti
motivazioni.
La prima per eccellenza e certo che tutti l’abbiate
cantata almeno una volta, va citata:
TRAVIATA (Verdi)
I atto Alfredo-Valerie-Coro “libiamo, libiamo ne’ lieti calici”
OTELLO (Verdi)
I atto Jago a Cassio “ragazzi del vino: beva, beva”
ERNANI (Verdi)
I atto Coro “beviam, beviam del vino beviam”
RIGOLETTO (Verdi)
III atto Duca a Sparafucile “una stanza e del vino”
BOHEME (Puccini)
I atto Rodolfo a Mimì “aspetti, un po’ di vino; poco, poco così”
TOSCA (Puccini)
II atto Scarpia a Tosca “è vin di Spagna, un sorso per rincuorarvi”
ELISIR D’AMORE
(Donizetti) I atto Nemorino a Dulcamara “bevanda amorosa della Regina Isotta”
BARBIERE DI
SIVIGLIA (Rossini) II atto Figaro a
Conte d’Almaviva “e dal vino casca già”
CAVALLERIA
RUSTICANA (Mascagni)II atto Turiddu “viva il vino spumeggiante” (max
elogio).
E per chiudere, ma qui siamo già più vicino ai nostri
tempi:
MADAMA BATTERFLAY (Puccini) II atto Pinkerton al Console
“Whisky? Un altro bicchier”.
Giorgio Aleardo
Zentilomo
Ostaggi della realtà nel teatro di Gaccione
di Alessandra Paganardi
 |
| Alessandra Paganardi |
Guiducci ha
scritto, nella prefazione a La porta del
sangue, a proposito del genocidio valdese, che la rappresentazione di
Gaccione assurge a simbolo di tutti i genocidi effettuati dai Poteri. Questo giudizio
è in qualche modo vero per tutte le rappresentazioni di questo libro, di cui ho
tracciato un abbozzo di indice. La rappresentazione di Gaccione è simbolica non
nel senso di una tipicità, di un’astrazione, ma proprio all’opposto: per
eccesso di concretezza, per la passione di calarsi così profondamente nelle
situazioni da mimetizzarsi in esse, scomparire come voce narrante e renderle
universali. Lo sguardo dell’autore è così affilato da sconfinare a volte nel
voyeurismo, come in certe atmosfere di Magritte, che queste scene spesso
ricordano. E la sua capacità mimetica, già messa alla prova sul versante della
sensibilità femminile in opere come Lettere
ad Azzurra, raggiunge l’apice nel medesimo senso con il monologo Hermana.
La mimesi,
tuttavia, non si ferma a un soggetto singolo. Tocca la società e la storia.
Gaccione è un polemista del nostro tempo, per quanto spuntato sia costretto ad
essere quel suo punteruolo un po’ alla Karl Kraus, che ha fatto uscire dalla
sua penna anche aforismi memorabili. Non può smettere di esserlo, perché ciò
che suscita la sua indignazione è in primo luogo il Potere in tutte le sue
declinazioni. Una volta che questa indignazione è suscitata, essa non può più
spegnersi e la si ritrova nei luoghi più impensati, in apparenza inutili: è la
protesta sotterranea di Exodus, che il mondo indifferente calpesta; è il grido
della donna stuprata, che al processo-farsa è costretta a rivivere il trauma,
con in più la beffa di essere giudicata colpevole di provocazione; è la voce
collettiva della Porta del sangue, vero e proprio coro tragico oltre che doxa tòn pollòn e, naturalmente, voce
dell’autore.
.JPG) |
| Gaccione con Russo, Azzola e Paganardi |
Angelo Gaccione,
Ostaggi a teatro 1985-2007, Ferrari
Editore 2013, Pagg. 208, € 15,00.
Per richieste: info@ferrarieditore.it, Tel. 0983-512347,
Cell. 393-3329564
“Il massacro del popolo valdese nella Calabria cosentina del
Cinquecento (La Porta del Sangue); la
bieca violenza del ‘branco’ su una donna indifesa e l’altrettanto agghiacciante
epilogo dell’evirazione e dell’esecuzione di uno degli stupratori di Temmy
Werth (Stupro); l’enigmatica e
dolorosa condizione esistenziale di Exodus (Dal
fondo); l’abolizione della memoria per tenere a bada la sofferenza da parte
dello scienziato, del matematico protagonista de La sedia vuota; il cinismo di Jenny, sigle metropolitana bella,
colta e sicura di sé dell’omonimo testo; la malinconica disperazione di Hermana
per un abbandono senza spiegazioni; il perfido esito di Ostaggi a teatro che ha incredibilmente anticipato un drammatico
fatto di cronaca internazionale, e poi ancora Lo sbaglio, La seduta, L’uomo che ha perso la voce, fino allo
scintillio spumeggiante e raffinatissimo di una commedia brillante come Tradimenti, con la sua fatale ammaliatrice,
la contessa O’Brian… Sono solo alcuni spunti di un teatro esigente,
ricchissimo, denso, pregnante, di uno dei più lucidi e interessanti
drammaturghi contemporanei. Per la prima volta raccolto in un unico volume
nella Collana Hybris dell’Editore Ferrari, il lettore può godere ora, la
lettura integrale di tutto il teatro di Gaccione”.
 |
| Torre Velasca Marina Previtali Olio su tela 2013 |
JENNIFER FABRIS
Visioni infrante
grondano sofferenza.
Sanguinano i ricordi
imbrattati di dolore.
Perdona ancora una volta
la mia ostinazione.
Perdona gli errori,
sangue cremisi sgorga copioso e denso.
Cura il petto e l’anima straziate
con lacrime rosso sangue.
Esangue la pelle, svuotate le vene.
Resta inerme.
Resta fermo.
Non ti muovere.
Dormi,
un sonno senza sogni
aspettando il dissolversi della notte.
19/09/13
L’immagine di un giorno normale,
resta impressa nella mia mente come una fotografia.
Una mattina come tante,
la luce chiara del mattino
illuminata dal sole di gennaio.
L’affaccendarsi della quotidianità
resta nel mio pensiero come un tesoro prezioso.
La luce gialla, tenue,
scalda l’aria gelida delle giornate invernali,
resto sospesa nel malinconico eco di un sorriso.
Il lento scorrere dei giorni,
risuona tra i nebbiosi pomeriggi.
Giorni trasparenti come un velo
si perdono tra le ombre del tempo
ed attendo al di là del vetro.
Jennifer Fabris
19/09/13
Raffaella Bonetti
LIBRI
“LA
TERRA di RANIA, REGINA di GIORDANIA”
La Giordania, meglio il Regno hascemita di Giordania, non ha né petrolio né materie preziose:e credo che
questo sia anche la sua fortuna in
quanto la pone al riparo dalla cupidigia delle Grandi Potenze. Dipende il suo nome dal fiume
Giordano, da noi conosciuto per il battesimo di Gesù.
L’autore nota come non sia
alcunché di contraddittorio: primo perché il fiume,cui dà il nome,
fa parte di un altro Stato
,secondo perché la sua popolazione in
schiacciante maggioranza proviene dalla Palestina e dall'Higiaz, terra
d'origine della famiglia regnante.
Caratterizzano questo popolo la calda accoglienza verso
il turista e al tempo stesso la riservatezza. Del Giudice è particolarmente efficace nel
sintetizzare le informazioni:“Culla di una sola civiltà, quella araba. Due
religioni, l'islamica e la cristiana, due etnie: beduini e palestinesi; quattro
minoranze: circassi, ceceni, armeni e curdi.”
La Giordania ospita nei suoi 90mila Km quadrati, compresa
la fascia desertica, 6 milioni di abitanti
di cui la sola capitale Amman ha
un numero di abitanti che si
aggira intorno ai 3 milioni.
Interessante il contrasto tra le due dimensioni temporali,
passato e futuro, che convivono nella città colmandola
di fascino con la coesistenza nel centro storico di moderni quartieri
accanto ai vecchi mentre è già in atto un nuovo centro di moderni grattacieli.
Una città pulita, non caotica grazie anche a una rete
stradale scorrevole e funzionale che non ha nulla da invidiare alle grandi
metropoli. Per il turista distratto,
solo il canto del muezzin lo riconduce alla realtà della cultura araba.
Il Paese è in continua evoluzione. Accanto ai mussulmani
(in stragrande maggioranza) convivono in tranquillità anche i Cristiani. Riferendosi
ai Palestinesi, Del Giudice evidenzia una curiosità. La loro presenza incrementa la popolazione
sino ad arrivare al80%. Questo si spiega
in quanto chi nasce in Giordania è considerato ipso-facto cittadino giordano
anche se da genitori palestinesi. Al contrario chi è palestinese può cambiare cittadinanza
ma resta comunque palestinese. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare pur
essendo un paese mussulmano, in Giordania non esiste la sharia ovvero la giusta
via, la legge coranica che vuole la donna sottomessa all'uomo. I diritti della
donna sono considerati. Tant'è vero che nel biennio 2007-2009 con il Governo di
Nader Dahali, importanti dicasteri come la Cultura, il Turismo nonché lo
Sviluppo Sociale e Cooperazione Internazionale sono stati affidati a quattro
donne.
In seguito il numero delle donne è salito a sette nel
Parlamento. Come una ragnatela, l'elemento femminile si estende
progressivamente ad occupare posti dirigenziali sia in aziende pubbliche che in
quelle private. Di forma istituzionale monarchica,la Giordania ha in Abdallah
II al Thani Hashem figlio di Hussein e
Rania,la sua coppia reale. Un re moderno,sportivo, di educazione e cultura anglosassone e una bellissima regina estroversa,ben acculturata che sa
usare egregiamente gli strumenti dell’informatica. E ora qualche cenno di Rania,
la Regina. Figura carismatica ammalia anche oltre i confini del suo Paese. Notevole l’abilità dell’autore nel
tratteggiane il ritratto, facendola scendere dal piedistallo, senza per questo
comprometterne l’innata regalità e il comportamento. La dipinge come
l'amica della porta accanto che non dimentica nonostante i molteplici impegni
l’ essere madre di quattro figli che lei
stessa amorevolmente segue. Non trascura i suoi hobby come gli
sport acquatici, la musica e il cinema condividendoli con il regio consorte.. Curiosamente appassionata di basket e di scacchi, non le
manca il vezzo femminile della golosità per la cioccolata fondente. Nata a
Kuwait City il 31 agosto1970 da una famiglia borghese originaria della
Palestina, Rania, ha compiuto gli studi universitari al Cairo laureandosi in
gestione d'Impresa e Informatica presso una prestigiosa Università Statunitense.
Trasferitasi ad Amman trova lavoro prima alla City Bank e poi presso una multinazionale. Come una qualsiasi telenovela
che si rispetti, tra la ragazza borghese e il principe Abdallah II il classico colpo
di fulmine scocca tramite l'acquisto di un Computer. A questo punto è d'obbligo
una divagazione. Anche un computer pur nella sua fredda tecnologia può
rivelarsi romanticamente “galeotto”, al pari del libro di Paolo e Francesca di
dantesca memoria. Rania e Abdallah si sposano il 10 giugno 1993, lei 23enne e
Lui di anni 31. Trascorrono 6 anni negli Stati Uniti per il perfezionamento militare
di Abdallah. Dall'intimità di coppia traspare una concezione moderna, democratica,
al passo con i tempi. Come una qualsiasi famiglia borghese, prendono in affitto
una casa e il principe non disdegna di
aiutare la giovane moglie nelle quotidiane necessità. Dopo la morte del re
Hussein, Abdallah e Rania nel 9 giugno 1999 diventano ufficialmente Re e Regina
di Giordania. Amata dal popolo per la
sua umana personalità
avvolgente, per nulla supponente, quando opera nel sociale la Regina fa
breccia anche per il suo dinamismo. Presidente dell’ “Associazione Giordana per i Diritti Umani” con un
particolare riguardo alla situazione carceraria,come rappresentante dell'U.N.I.C.E.F ha compiuto qualcosa di incredibile: è
riuscita a strappare al Presidente Barak Obama, la promessa di investire 2
miliardi di dollari nel “Fondo Internazionale per l'Istruzione” per realizzare
l’ ambizioso progetto di dare entro il 2015 una valida istruzione a tutti i
bambini del mondo. Verrebbe così a
crearsi a livello mondiale la prima generazione senza analfabeti.
Rifacendosi ai diritti delle donne, e alla discriminazione nei loro confronti, Rania ha
denunciato più volte i delitti d'onore definendoli “assassinii senza processo e
contrari all'Islam”. Si è prodigata, anche coadiuvata dal Re Abdallah, per far
varare una legge al fine di infliggere una condanna più severa agli autori di
tali reati. Del Giudice sottolinea come “Rania essendo professionalmente una
manager,una economista e una esperta informatica, sia la più adatta
collaboratrice del Re nel processo di modernizzazione del paese”.
Nel giugno del 2006 la Regina ha lanciato il primo numero
verde per denunciare gli abusi familiari. Caratteristiche della sua personalità
emergono dalle sue stesse frasi: “ non voglio essere considerata per la mia
immagine ,ma per quello che faccio.” e “ogni donna può fare la differenza”
Rivolgendosi a un migliaio di studentesse universitarie dice:” le pagine della
vita appartengono a voi. Servite una storia che vi renda felici e orgogliose” e
ancora “la flessibilità è l'arma per
combattere le frustrazioni e risollevarsi dai fallimenti”.
Sono pillole di saggezza che catturano la nostra stima.
Per superare gli stereotipi riguardo allo “scontro di civiltà” che è dettato
dalla paura delle varie culture e irresponsabilmente porta a una ideologia di
odio, Rania ha aperto nel 2008 una
pagina web su you tube.
Un'altra iniziativa originale è un progetto che risale al
2008: “Madrasati” cioè la “Miascuola” che coinvolge il pubblico e il privato perché,dice
Rania, “l'educazione è una responsabilità nazionale e non può essere affidata a
una sola entità”. Oltre essere
Presidente del Consiglio Nazionale per le Problematiche della Famiglia, la
Regina ha creato e presiede la”Jordan River Foundation” cui fanno capo tutte le
iniziative relative ai diritti alle donne, alla protezione dei minori, agli
aiuti ai bisognosi. Nonostante ami viaggiare in diversi paesi , nutre particolare
simpatia per l'Italia.
“Il mio sogno è di ritornare in Italia per contribuire a
plasmare un futuro di pace” disse il 3 settembre 2005 a Milano ricevendo la
cittadinanza onoraria. In quell'occasione ebbe anche dall'Università di Pavia
la Laurea honoris causa in Scienze Politiche. E aggiunse parlando del suo Paese
: “Nell'ultimo decennio abbiamo cercato di costruire una società civile
rispettosa dei valori e amante della pace, sapendo che l'Italia era al nostro
fianco. Anche onorando il passato, i nostri paesi sono aperti al futuro. Nel
suo impegnarsi poi per la modernizzazione del regno,Rania si scaglia più volte
contro la cosiddetta palla al piede:l’inquietante fenomeno del “delitto
d'onore”. Del Giudice nel suo sondaggio- inchiesta ne elenca a iosa questi episodi raccapriccianti nei quali la
giustizia si mostra tollerante applicando
pene risibili giustificandole con il ripristino della onorabilità familiare. Ma anche l'Italia purtroppo non è
esente. Talmente vero che il delitto passionale
è stato privato delle sue attenuanti solo in tempi recenti. Ritorniamo
alla Giordania. Mi si perdoni se preferisco fare un cenno al pensiero perverso che anima questi reati pur
senza descrivere nei particolari
l'efferatezza di questi crimini. Comunque ritengo opportuno non fare lo struzzo
di fronte alla realtà rinviando il lettore ad una attenta lettura delle
testimonianze precise di Del Giudice.
In Giordania pesano come macigni gli articoli 340 e 98
del Codice Penale, mantenuti caparbiamente inamovibili dal parlamento
nonostante le pressioni a getto continuo della coppia reale. Per l'articolo 98
è il comportamento disonorevole della donna che dà, a chi uccide,diritto a una
riduzione della pena. Per l'articolo 340, in caso di adulterio, l'uccisore
beneficia dell'esonero dalla condanna. Se inizialmente si pretendeva la
flagranza dei fatti, poi si è platealmente degenerato.
Basta semplicemente un sospetto, una disobbedienza come
ad esempio uscire di casa senza il
permesso dei genitori per incorrere nella terribile punizione. Immediatamente
l'assassino si consegna alla Polizia e usando come “passepartout” per la
riduzione della pena, la frase :“Ho ammazzato perché ero furioso” spesso
provocando ad arte un litigio con la vittima per evidenziare l’eccesso di
furia. Crea sconcerto il fatto che il reo-confesso usufruisca di una pena che
va da 2 mesi a 2 anni di carcere a fronte di 20 anni per furto e sino alla pena
capitale per impiccagione in caso di omicidio premeditato. Una pseudo giustizia
parallela, il cui giudizio è insindacabile, viene poi praticata dal “Consiglio di famiglia”, il quale emette sentenze
in nome della necessità di
purificare l’ onore della famiglia
attraverso il sangue della
“colpevole”. In molti casi viene rivelata dalla casistica, l'innocenza delle
vittime. Aberrante è l'uso del filo del telefono o del cavo della televisione,
per effettuare l’omicidio. E’ uno stridente contrasto tra la tecnologia che
dovrebbe essere il frutto di scoperte di un' evoluzione dell'uomo sapiens e il
degrado infimo di un pensare indegno
dell'essere umano. E' sorprendente come
Mimmo del Giudice, con un lavoro arduo e coraggioso, oserei dire
pignolo, ma nel senso elogiativo del termine,
descriva quantitativamente questi
episodi a raffica, senza sosta, non dando respiro al lettore scosso nell’intimo già
dalle prime battute. Considerandosi “eroe”l’assassino con arroganza
immediatamente si autodenuncia. Non è
raro che addirittura festeggi con amici
e con spari distribuendo dolci,
quasi fosse capodanno, l’accaduto. Solitamente la vittima è ignara di tutto e
le è preclusa ogni autodifesa. Ma quando
la donna come un cane braccato intuisce “il pollice verso” del Consiglio di
Famiglia,e lo fugge costituendosi, la protezione che riceve è l'alloggio
(gentile eufemismo) in un braccio del carcere. Qui sperimenterà la morte civile
nell’anonimato. Per associazione di idee, l'accostamento di manzoniana memoria
è inevitabile. La donna è un ingombro nelle famiglie nobili. Meglio il
Convento. Basti pensare alla storia della Monaca di Monza, crudele nella
sottrazione di libertà. Se fa rabbrividire questo concetto ai giorni nostri tanto
più intollerabile è il “diktat” della legge di matrice beduina, essendo un
autentico assassinio premeditato. Una spada di Damocle penderà per tutta la
vita sul capo di queste donne sventurate in quanto i parenti non si rassegnano
e sono in spasmodica attesa di una loro eventuale uscita dal carcere per
procedere all’ efferato progetto di
morte. A parte lo spessore del contenuto,in questo libro lo stile di Mimmo Del
Giudice è brillante, scorrevole e come i best-seller di tutto rispetto invoglia
a leggerlo tutto di un fiato.
Raffaella Bonetti
RACCONTI ANORMALI
Due
racconti inediti di Rinaldo Caddeo
**
O.K.
Eravamo in macchina io, mio figlio Davide di
sei anni e mia madre: dovevo portarla in ospedale ma ogni scusa era buona per
fare delle soste e fermarsi a fare qualcosaltro. Fare la spesa. Andare in posta
e al bar. Ecco, quella sosta, la sosta al bar, non finiva mai. Mia madre
attacca bottone con tutti, spiegava la sua malattia, raccontava che doveva
andare in ospedale e che, forse, l’avrebbero ricoverata. E tutti: «ma no, che
cosa dice, vedrà che torna a casa, non c’è di cui preoccuparsi e anche se la
ricoverano, vedrà che non è nulla, che è solo per fare degli accertamenti e
poi, dopo una settimana ritorna a casa. La prenda come una vacanza. E poi… e
poi… e poi…»
Mia madre dava importanza a quelle parole.
Si rivolgeva a me: «spiégalo tu. Spiégalo che non è una cosa da poco, che io
non mi sento più bene, che sono allergica a quasi tutti i medicinali che mi
danno, che io non posso… non posso»
«Mamma sbrìgati, dobbiamo andare, siamo in
ritardo, l’orario di visita sta per scadere!» rispondevo. Ma lei parlava,
parlava, s’intratteneva con gli sconosciuti che le davano retta perché offriva
loro brioches e cappuccino. Davide
l’assecondava, spiegando anche lui a chi gli capitava a tiro che cosa dovevamo
fare: «la nonna deve andare in ospedale, mia nonna fa la visita».
A un certo punto s’era perso. «Dov’è Davide?
Davide Davide!». Non lo trovavo. Ero disperato. Mi ero messo le mani nei
capelli: la macchina era in mezzo al bar e gli avventori c’entravano e
uscivano.
Una donna-botte s’era piazzata al posto di
guida e non se ne voleva levare. La pregavo: «ci aspettano all’ospedale.
Abbiamo un appuntamento e siamo in ritardo. Mia madre è malata, è molto malata.
Non sembra ma è molto più malata di quello che sembra. Deve essere visitata. La
prego è urgente. È malata… è malata molto».
Ma la donna-botte non ne voleva sapere. Non
mi ascoltava. Si era attaccata al volante e lo girava, lo girava, a destra e a
mancina, gridando: «che bello, ma che bello. Io non ho mai avuto una macchina.
Io non ho mai guidato. Me lo insegna lei come si fa? Che bella macchina, ma che
bello guidare, come si accende il motore? Come si accendono le luci? Come si
suona il clacson?»
Altri tizi e tizie entravano nella macchina,
si portava via dei pezzi, tutto quello che gli capitava a tiro: penne, cuscini,
specchietti, dischi, dischi-orario. Era un saccheggio.
Intanto mia madre, in mezzo al bar,
spiegava, rispondeva, interrogava. Davide era riapparso e scomparso di nuovo,
giocando con una bambina. E mia madre parlava, parlava. Ma perché, perché non
vuole farsi visitare, mi chiedevo.
La donna-botte gridava sempre più forte,
tirava dei fili, staccava dei pezzi, troncava delle leve.
Basta!
Avevo aperto la portiera della macchina e
cercavo di tirare giù la donna-botte, ma le dita delle mie mani scivolavano
nelle ascelle piene di resina della donna-botte. La donna-botte aveva delle
braccia sottili come grissini ma il corpo era massiccio e rotondo. Una rotondità
uniforme, come quella di una botte, appunto. Tiravo, tiravo, ma non la smuovevo
di un millimetro. Era rigida e pesante. Un corpo rotondo, levigato, senza
appigli.
S’era messa a urlare, a urlare sempre più
forte: «mi lasci, mi fa il solletico! Ah ah ah». A un certo punto s’era messa
anche a ridere con un singhiozzo sfrenato con cui saltellava e urlava: «AHH!
AAHHHH! AAAH!»
Cercavo di sfruttare qualcuno di quei
saltelli che la distaccavano per qualche centesimo di secondo dal sedile per
infilare una mano sotto il culo e per spingerla fuori, ma io avevo le mani
piene di resina appiccicaticcia e le mie dita slittavano come se dovessi
maneggiare del ghiaccio.
Qualcosa di molto robusto mi era saltato
alle spalle infine. Mi tirava il collo e mi sussurrava in un orecchio: «lascia
stare babbuino. Lascia stare dov’è. Non è cosa. Non è cosa. Non è cosa»
Mi sentivo svenire ma potevo ancora dire,
con l’ultimo respiro che mi era rimasto in gola: «o.k.»
LA FOLLA
Avevano messo la fermata del bus davanti
alla mia camera da letto. Tra la camera da letto e la strada, c’era un
terrazzino, elevato di un metro e mezzo sopra il marciapiede. L’altezza di un
ammezzato.
Le attese dell’autobus erano lunghe e alcuni
avevano preso l’abitudine di appoggiarsi al mio terrazzino con un gomito o con
la schiena e poi, con il passare dei giorni e delle settimane, sempre più
spesso, i più agili, si tiravano su e si sedevano sul margine di 25 cm tra la
ringhiera e l’orlo dell’ultima fila di piastrelle che sporgeva dal terrazzo,
causandone la graduale rovina.
Stavano lì per qualche minuto o per delle
mezzore. Stavano zitti o chiacchieravano o cantavano. Qualche volta c’era uno
che fischiava o bestemmiava.
Ma io non intendevo dare importanza al
fenomeno. Era un periodo che problemi più gravi e urgenti molestavano assai di
più la mia esistenza: il negozio, il mio negozio, era fallito. Mio figlio aveva
perso il lavoro e non riusciva a trovarne un altro. Mia moglie mi aveva
lasciato per un altro. Non erano cose da poco, cose di poco conto, quelle che
rendevano difficile la mia vita, il mio sonno.
Una notte, però, mi svegliai per gli
schiamazzi. Mi alzai e vidi che un gruppo di fantasmi aveva scavalcato la
ringhiera, non alta, del terrazzo e si era stravaccato sulle piastrelle lucide
del mio terrazzo, chi bevendo, chi mangiando, chi facendo tutte e due le cose,
chi completamente sdraiato, chi in ginocchio o seduto con la schiena
pericolosamente appoggiata al vetro della finestra.
Ero uscito in pigiama dalla camera e avevo
gentilmente pregato quella folla che occupava il mio terrazzo di andarsene ma
nessuno si allontanava.
Anzi qualcuno aveva assunto un’aria
aggressiva e aveva dichiarato: «che non gliene fregava un cazzo della proprietà privata, che lui stava aspettando
l’autobus da un sacco di tempo senza dare fastidio a nessuno e che quando
l’autobus arrivava, lui se ne andava con l’autobus senza rompere il cazzo a
nessuno». Molti dei presenti fecero cenni di assenso, altri dei fischi, dei
risolini, guardandomi le dita delle mani che si stringevano a pugno e si
allargavano di nuovo.
Rimasi ammutolito.
«Piuttosto, signor proprietà privata, perché non rifornisci il tuo terrazzo di merda con
una macchinetta del caffè?» aggiunse un altro tizio, buttando per terra la
cicca di una sigaretta ancora accesa e scagliando una bottiglia di vino che
andò in frantumi.
«Chi siete? Che cosa volete?»
«E un cesso, anche un cesso ci vorrebbe»
fece un altro, pisciando sul muro. L’orina si spandeva intorno, adagiandosi a grumi
giallastri e collosi.
Tutti ridevano. Qualcuno mi spingeva. Le
dita delle sue mani erano inconsistenti, ma gli anelli affilati e le borchie
puntute, di cui erano coperte, facevano male e mi avevano tagliato, facendomi
sanguinare in diversi punti del mio corpo di carne, rivestito di pelle. Pelle
soggetta a lacerazione.
Guardavo scendere i liquidi del mio sangue e
delle loro pisciate, mescolarsi sulle piastrelle del terrazzo, formare una
minestra verdastra, striata di vene rosse.
Avrei dovuto disinfettarmi subito se volevo
evitare qualche grave infezione. Invece le ferite si allargavano. C’erano brecce
in fondo a cui vedevo il bianco dell’osso. Non lo sapevi? Che cosa speravi?
C’era anche una bestiaccia tra loro che
ringhiava. Più che cane sembrava una iena. Non aveva dei contorni, era come una
nuvola fluttuante di pelo ispido. Però, facendo attenzione, vidi delle zanne e
quelle erano zanne vere, gialle, infilate in gengive rosse, macchiate di bava
candida, spumosa e gocciolante.
E vedevo il naso nero e vibrante, enorme. La
forma dello scheletro sotto la pelliccia maculata, le costole, la spina
dorsale, il bacino basso e nervoso, tipico della iena, le cosce grosse e
scattanti. Quelle non fluttuavano, sembravano di muscolo quelle.
«Ma è già un cesso, non vedi? Il mio cane ci
sta cagando».
«Ma quello non è un cane, è una iena, è un
animale selvatico, non si può portare un animale così senza guinzaglio e… senza
museruola». Chissà perché dissi una cosa, una cosa così stupida, in quella
situazione, mentre la iena stava cagando, sul mio terrazzino, uno stronzo
marron: lo guardavo uscire lentamente dal buco del culo della iena e
arrotolarsi, mentre la iena mugolava, con larghe spire, sulle piastrelle come
una gigantesca ciambella puzzolente di fiera.
Che cosa ti aspettavi da quella vita? Qualunque
cosa, purché finisse.
Tutti si sganasciavano dal ridere, chi
sputando, chi rovesciando la propria lattina di birra, chi pulendo le mani unte
di patatine fritte sul vetro della mia finestra, chi sfasciando la maniglia e
lo zoccolino a pugni e calci. Chi rotolandosi e dando manate che schizzavano
birra e piscio secco come calcina umida dappertutto.
«Qualcosa in contrario? Non ti piace la mia
belva?»
«No no, anzi…»
«Testa di mongho, non ti piace come tratto
la tua proprietà privata?» e dando
calci con gli anfibi stava sbriciolando i battenti e spaccando il vetro. La belva si stava intrufolando in camera.
Altri la seguivano. Altri mi avevano circondato.
Mi resi conto che non c’era più niente da
fare. Scappare, forse dovevo scappare. Ero circondato dalla folla. L’unica era
scappare, tagliare la corda al più presto. Già ma come? Forse non c’era nemmeno
più tempo per scappare. Mi sentivo prendere per la collottola. E poi… come
avrei fatto a ritornare e che cosa avrei ritrovato?
Ero circondato e loro non sembravano molto
intenzionati a lasciarmi passare attraverso… mi sentivo stringere alla gola…
accesi la luce: mi ero svegliato da un sogno, era solo un sogno, un brutto
sogno, ma davanti alla finestra, sul terrazzino, c’erano delle ombre…
Sento una voce: «per adesso
basta. Ritorneremo in forze, la notte dei meteoriti.LA TERRA E LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA
di Michele Zarrella *
Federico La Sala, DELLA
TERRA IL BRILLANTE COLORE Parmenide, una ”Cappella Sistina”
carmelitana con 12 Sibille (1608), le xilografie di Filippo Barbieri
(1481) e la domanda antropologica
Edizioni Nuove Scritture, Milano 2013, pp. 156, € 15,00
Edizioni Nuove Scritture, Milano 2013, pp. 156, € 15,00
Un libro di eccezionale rarità che tenta a grandi linee, di mettere in evidenza una inedita prospettiva di ricerca e una possibile via di uscita da duemila e più anni di labirinto: un’ontologia non più zoppa e segnata dalla cieca cupidigia del sapere-potere, ma chiasmatica e illuminata dal sapere-amore.
Il luogo di inizio del ’viaggio’ è
dalla chiesetta di S. Maria del Carmine (monastero carmelitano dal
1561 al 1652) di Contursi Terme (SA), e dall’antica Elea (Velia,
Ascea), ma subito ci si trasferisce a Firenze, a Rimini, a Siena, a
Roma, e, infine, fuori dal pianeta Terra, da dove, finalmente, è
possibile vedere "il brillante colore"! Il pianeta in cui
viviamo non è una caverna e, con lo sbarco sulla Luna, ora tutti lo
sappiamo - anche fisicamente! Siamo tutti nella stessa barca e che
siamo tutti fratelli, ... è ora di cambiare strada, di riorganizzare
e riformulare tutto il nostro sapere - a partire da questa nostra
nuova consapevolezza acquisita”: il pianeta è un granello
nell’Universo ed è necessario un cambiamento radicale di
prospettiva altrimenti non riusciremo mai a capire chi siamo.
La società moderna non può più
accontentarsi di una filosofia e di una scienza ancora legate alla
catena della dea Giustizia-Necessità di Parmenide e ancor più non
deve contare sul sapere che il Platone o il politico di turno porta a
noi prigionieri nella «caverna». Abbiamo preso coscienza di dove
siamo nell’Universo e non possiamo più far finta di nulla. Sarà
compito nostro mostrare come è la nostra casa: non era e non è né
una caverna, né un’arena per gladiatori.
Sulla base di questa coscienza l’autore
ci spinge a lavorare a una nuova cultura e a una nuova scienza che
siano all’altezza del nostro orizzonte. “Non è più concepibile
né possibile (il rischio è altissimo - la fine della nostra
avventura, quella dell’intero genere umano) seguire le tracce di
Parmenide, né di Platone.”
Il nostro orizzonte si è elevato e non
è più possibile pensare che: «Per lo scienziato esiste solo
l’essere, non il desiderio, il valore, il bene, il male,
l’aspirazione» (Einstein, 1950). La posizione einsteiniana è
parziale, unilaterale, e soprattutto pericolosa, perché ci fa vedere
e agire - rispetto a noi stessi e rispetto agli altri e rispetto alla
natura che ci circonda e sostiene - ancora con gli occhi e la mente
di chi vede il pianeta Terra ridotto a un campo di guerra ove i
mortali che nulla sanno giocano le loro battaglie. La Terra è di un
colore brillante: è azzurra. «La Terra è blu [...] Che meraviglia.
È incredibile», esclamò Jurij AlekseeviÄ Gagarin quando, il 12
aprile 1961, la vide, primo fra tutti gli uomini, dallo spazio.
Se vogliamo migliorare non è a
Parmenide che dobbiamo pensare. Ma, se si vuole, a Talete, il quale
sapeva che l’azzurro circondava la Terra. E Federico La Sala, al
pari di Gagarin, ci invita ad uscire fuori a guardare dalla reale
prospettiva la questione della nascita nostra, del nostro pianeta,
del nostro sistema solare e del nostro Universo. La Sala si pone, al
pari di Talete, la domanda delle domande: qual è il principio di
tutte le cose? Questi sono i problemi così nasce la filosofia, così
nasce il suo bellissimo libro DELLA TERRA IL BRILANTE COLORE.
Come Talete, La Sala riporta a galla
dalle profondità oceaniche dell’essere i due problemi fondamentali
del sapere (tutte le cose e il principio) e soprattutto sollecita a
pensarli insieme. Spesso l’uomo moderno dimentica il secondo: il
principio. L’autore, sulla base delle nuove conoscenze acquisite,
invita a partire, anzi, a nascere nuova-mente - da capo, guardando al
nostro ombelico e a ri-pensare l’Uno a partire dal Due. Noi (ognuno
e ognuna) siamo uno ma siamo nati da due: nati da un uomo e una
donna, e di entrambi siamo portatori non tanto e non solo dei loro
geni, quanto e soprattutto lo spirito delle loro Unità.
E allora, conclude l’autore, il
problema dei problemi non è più né quello metafisico («che cosa
posso sapere?») né quello morale («che cosa devo fare?») né
quello religioso («che cosa posso sperare?»), ma quello
antropologico («che cos’è l’uomo?»).
Il problema dei problemi è rispondere
alla domanda «chi siamo noi in realtà?» (Nietzsche). A questa
domanda l’autore risponde in termini di speranza e di salvezza e ci
invita a guardare al nostro ombelico, a qual è la nostra origine?
Riconosciamoci, come siamo, figli di un uomo e una donna, di una
maternità e di una paternità alla pari e che la Terra sia il luogo
del nostro fiorire e non il luogo delle nostre dualistiche
contrapposizioni e scissioni.
A tale permeante domanda non può
rispondere solo un genere che domina sull’altro, ma insieme con le
Due metà del genere umano. Solo così, con la parità, autonomia e
dignità fra uomo e donna, potremo dar vita a una nuova antropologia
(e, con essa, a una nuova scienza e, ovviamente, a una nuova
politica) - oltre l’edipo e oltre il capitalismo - finalmente degna
del nostro pianeta dal brillante colore.
Buona lettura.
Michele Zarrella
Gesualdo, 30-09-2013
* Il dialogo, Lunedì 30
Settembre, 2013
Di
Gianni Bernardini
Marina
di Grosseto. L’evento
che ha motivato il libro oggetto di questa presentazione, è uno di
quelli che non vorremmo accadessero mai: la perdita imprevista di una
persona ancora giovane; un’amica la cui presenza poliedrica colmava
vari spazi di iniziative felici.
Avremmo
voluto Luciana tra noi, non un libro. Avremmo voluto Luciana e
il
libro: non un libro “in memoria”, ma un libro “in onore”.
Credo
infatti che vadano onorati
i vivi,
non
i morti.
Con i “grandi” accade anche questo - p. es., tipicamente, in
università -. Invece, tra la “gente”, è diffusa la strana attitudine a
onorare i morti, piuttosto che i vivi: anche solo andando a trovarli
al cimitero; come se ce ne fosse bisogno, per ricordarli, e non... (clicca qui per continuare a leggere)
LIBER
I LIBRI DI ADAMO CALABRESE
I LIBRI DI ADAMO CALABRESE
Adamo Calabrese è scrittore, autore di teatro e illustratore di libri.
 |
| Autoritratto |
- Ha pubblicato il romanzo “Il libro del Re” (Einaudi), i racconti “L’anniversario della neve” e “La cenere dei fulmini” (Albatros editore), i racconti “Paese remoto” (Joker editore).
- Ha illustrato “Il profeta” di Gibran (Joker editore), le poesie di Romano Pascutto e i Proverbi milanesi (Graphot editore).
- I suoi ultimi lavori teatrali hanno messo in scena opere di Brecht, Joyce, San Francesco e, dalla Bibbia, il Salmo 136.
- La sua elaborazione teatrale di Iacopone da Todi è stata trasmessa nel 2012 dal Terzo Programma della RAI.
- Nello stesso anno è stato finalista del premio internazionale di disegno satirico “Novello”.
Adamo Calabrese scrive e disegna per il quotidiano “Il Cittadino” di Lodi, per le riviste “Vorrei” di Monza e “Odissea” di Milano.
AL MOTEL DELL’AEROPORTO
 |
| Illustrazione di Adamo Calabrese |
Adamo Calabrese
FRANCO MANZONI
CONVERSA CON IL MAESTRO
ALDO BERNARDI
di Franco Manzoni
“ Nostro compito primario è portare la musica di Mozart a
tutti. A settembre, presso la casa di riposo Verdi, proporremo il Quartetto in
la maggiore KV298 (per flauto violino , viola e violoncello), mentre nella
basilica di San marco, il 5 dicembre, giorno anniversario della morte del
divino salisburghese, l’Orchestra dell’AMI-Milano eseguirà il Requiem in re
minore KV 626 per quattro solisti, coro, orchestra e organo nella forma
tradizionale completata da Franz Xavier Suessmayr. Altri nove concerti sono in
locandina per il 2014, ma il mio sogno è di portare in aprile all’Arena civica,
dirigendole, dieci tra le migliori giovani orchestre italiane in una
maratona-omaggio a Mozart.”
· E il comitato per
l’educazione musicale nelle scuole?
“Lo sto formando, con le personalità più sensibili al
problema. Più di 500 intellettuali ed artisti a Milano hanno aderito, quasi
tremila in Italia. Lo scopo? Arrivare a costruire una coscienza civica
nazionale che riesca a far approvare in Parlamento una legge, norme certe che
introducano l’educazione musicale di base nella scuola di ogni ordine e grado.”
· Ma con l’attuale
crisi economica, del lavoro e della politica, caro maestro, quale bisogno ed urgenza
c’erano di dar vita a questo Comitato?
“Comincerò a risponderle citando il secondo comma
dell’Articolo 4 della Costituzione italiana che dice: ”Ogni cittadino ha il
dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
una attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della società”. Ecco, proprio il
progresso spirituale della società trovo sia quasi totalmente dimenticato dai
nostri, politici, dai nostri governanti e spesso anche da tanti, troppi intellettuali
e artisti, assai preoccupati del loro narcisistico e egoistico progresso di
carriera e del personale conto in banca, più che dell’evoluzione spirituale del
mondo in cui vivono e operano! Il progresso di un Paese si rileva non solo
dalla misurazione dell’avanzamento del benessere materiale delle persone, ma
anche da quello spirituale! Sono fortemente convinto che le due cose siano
inscindibilmente unite e, quindi, che non possa esistere nessun vero e duraturo
progresso materiale senza quello spirituale e viceversa. A questo punto bisogna
intendersi su cosa sia il progresso spirituale e soprattutto su come lo si
costruisca. Vedo il progresso spirituale non come un’astratta entità, simile ad
esempio allo Spirito Santo nella teologia cristiana, certo indispensabile al
Padre e al Figlio per portare la Fede e il Bene all’umanità, ma assai poco
definibile, tangibile e misurabile, bensì come un ingrediente concreto al pari
della farina per fare il pane attraverso cui costruire la Strada maestra verso
la felicità degli individui. Come si costruisce prima e nutre poi lo Spirito?
Semplice. Prima di tutto attraverso la Conoscenza e quindi l’Istruzione che
nella modernità significa attraverso la Scuola. Nel nostro strano Paese, culla
del sapere occidentale (basti pensare ad Eraclito, Pitagora, Socrate, Platone e
Aristotele, ma anche ad Omero, Saffo, Virgilio, Catullo fino al sommo Dante
senza dimenticarsi di Galileo, Volta, Giotto e Monteverdi… ), è sempre esistito
un errato ma persistente dualismo tra Cultura scientifica e Cultura umanistica.
Divisione assai errata ma all’origine di una forma mentis, di una mentalità
comune responsabile di tante scelte fatte dai politici del passato e del
presente, anche quando operate in buona fede. Quando poi entra in gioco la cenerentola
delle Arti, cioè la Musica, il dualismo diventa addirittura triadico
trasformandosi così in un “trialismo insanabile”, sempre riferendomi
all’anormale e paradigmatica realtà del nostro bel Paese. E sì, perché la
Musica prima e l’Educazione musicale a seguire, prescindendo dal genere - sia
chiaro che hanno pari valore e dignità artistica democraticamente tutti i
generi musicali, dal pop al jazz, al rock, dalla canzone d’autore all’opera
lirica, dalla musica popolare ed etnica a quella classica e d’avanguardia,
purché costruita con onestà, sapienza e genuina ispirazione -, è sempre stata
considerata una realtà a sé stante, quasi fosse un’entità autonoma, che può
servire a produrre spettacolo ed intrattenimento e non come dovrebbe essere a
pieno diritto una tra le diverse branche del sapere e della cultura. Ma non
dimentichiamoci che il più grande umanista di tutti i tempi è stato proprio
Leonardo da Vinci, che definirei la summa teologica incarnata tra i saperi, uno
dei più grandi geni dell'umanità, si occupò di architettura e scultura, fu
disegnatore, trattatista, scenografo, anatomista, musicista e, in generale,
progettista e inventore. Infatti all’epoca non c’erano affatto distinzioni tra
i saperi, non esistevano una cultura scientifica ed una letteraria divise e
quasi in antitesi tra loro come oggi. Sicuramente organizzeremo tramite il
Comitato e l’Associazione Mozart Italia di Milano un Convegno di Studi ad hoc
che faccia luce sul problema. Per l’utilità di questa intervista il lettore
riconosca come un dato di fatto e assuma su di sé l’assioma che oggi la musica
in Italia, nella mentalità corrente e storicamente di quella almeno degli
ultimi 150° anni, è assolutamente divisa dalla cultura umanistica così come la
cultura umanistico-letteraria lo è da quella scientifica. Naturalmente questo
“trialismo insanabile” è un errore storico e di metodo e se si vuole
correggerlo bisogna riconoscerlo; così come bisogna sapere e credere che lo
sviluppo del pensiero letterario, filosofico, musicale e artistico, cioè che il
progresso spirituale, concorre a pieno titolo al miglioramento della società e
all’evoluzione degli individui che la compongono, almeno al pari di quello
scientifico-tecnologico. Ribaltando una celebre frase di un altrettanto
illustre esponente del mondo politico ed economico che qualche anno fa stava
per dimezzare i fondi nostrani del FUS (Fondo unico dello spettacolo), dicendo
che “Con la Cultura non si mangia”, potrei affermare che la poesia e la musica
sono indispensabili al nutrimento spirituale del cittadino tanto quanto lo sono
il pane e l’acqua che gli garantiscono la vita materiale!”
 “Per due importanti ragioni: una ideale e l’altra più
formale e gestionale. La prima è che per tutto quello che ha rappresentato
nella sua epoca e per quello che rappresenta oggi e in futuro il genio del
“divin salisburghese”, col suo immenso portato culturale, ci auguriamo che
Wolfgang Amadeus Mozart, il più prolifico e divino tra i grandi compositori
della storia della musica colta occidentale, sia di buon auspicio per il
raggiungimento dello scopo del Comitato, vale a dire che, nonostante le enormi
difficoltà di ogni genere, si arrivi davvero tra uno, dieci o cento anni, a
costruire una coscienza civica nazionale che riesca a portare in Parlamento un
disegno di legge prima e la sua conseguente approvazione poi, a prescindere dal
colore o dai colori politici che amministreranno l’Italia in quel momento, di
norme certe che introducano lo studio dell’Educazione musicale di base nella
scuola di ogni ordine e grado. Ovviamente siamo ben consapevoli che tutto ciò
richiederà una considerevole copertura finanziaria. Basterà cambiare qualche
priorità di spesa. Oggi, per esempio, basterebbe rinunciare non dico a tutti ma
solamente alla metà degli acquisti per l’ammodernamento degli armamenti
militari, che si coprirebbe per più di un decennio il costo del progetto
educativo auspicato. Il secondo è di carattere pratico gestionale. Infatti il
Consiglio Direttivo dell’Associazione Mozart Italia di Milano amministra anche
il Comitato in quanto lo Statuto lo prevede; inoltre tutte le autorevoli, competenti
e prestigiose personalità, che fanno parte già oggi dell’Associazione Mozart
Italia di Milano e dei suoi Comitati scientifici declinati in Dipartimenti di
studio, sono co-fondatori e co-gestori assieme al Consiglio Direttivo, del
Comitato stesso”.
“Per due importanti ragioni: una ideale e l’altra più
formale e gestionale. La prima è che per tutto quello che ha rappresentato
nella sua epoca e per quello che rappresenta oggi e in futuro il genio del
“divin salisburghese”, col suo immenso portato culturale, ci auguriamo che
Wolfgang Amadeus Mozart, il più prolifico e divino tra i grandi compositori
della storia della musica colta occidentale, sia di buon auspicio per il
raggiungimento dello scopo del Comitato, vale a dire che, nonostante le enormi
difficoltà di ogni genere, si arrivi davvero tra uno, dieci o cento anni, a
costruire una coscienza civica nazionale che riesca a portare in Parlamento un
disegno di legge prima e la sua conseguente approvazione poi, a prescindere dal
colore o dai colori politici che amministreranno l’Italia in quel momento, di
norme certe che introducano lo studio dell’Educazione musicale di base nella
scuola di ogni ordine e grado. Ovviamente siamo ben consapevoli che tutto ciò
richiederà una considerevole copertura finanziaria. Basterà cambiare qualche
priorità di spesa. Oggi, per esempio, basterebbe rinunciare non dico a tutti ma
solamente alla metà degli acquisti per l’ammodernamento degli armamenti
militari, che si coprirebbe per più di un decennio il costo del progetto
educativo auspicato. Il secondo è di carattere pratico gestionale. Infatti il
Consiglio Direttivo dell’Associazione Mozart Italia di Milano amministra anche
il Comitato in quanto lo Statuto lo prevede; inoltre tutte le autorevoli, competenti
e prestigiose personalità, che fanno parte già oggi dell’Associazione Mozart
Italia di Milano e dei suoi Comitati scientifici declinati in Dipartimenti di
studio, sono co-fondatori e co-gestori assieme al Consiglio Direttivo, del
Comitato stesso”.
· In questa fase
iniziale quali consensi è riuscito a registrare? Quali le principali
resistenze?
“In questa fase d’esordio i consensi sono stati pressoché
unanimi. Ai molti che me lo hanno domandato spesso ho risposto che il consenso
al progetto è stato finora più che bipartisan. Cioè non vi è una connotazione
partitica nel senso etimologico del termine “di parte” del Comitato. Infatti i
consensi sono stati e provengono da tutti gli schieramenti politici in quanto è
apparso immediatamente chiaro ai più che il Comitato Nazionale sia stato creato
appositamente per il miglioramento delle generazioni future. Da parte di alcuni
la resistenza è stata un vizio tipicamente italiano: quello di credere che il
Comitato, e la mia persona in particolare, sia strumentalizzato o
strumentalizzabile da qualche forza politica e partitica specifica e
soprattutto che, dietro al progetto politico dell’istituzione della legge
nazionale sull’Educazione musicale di base, si voglia nascondere un progetto
politico globale. Nulla di tutto ciò! E’ mai possibile che in Italia il clima
sia così viziato e corrotto da far sì che nella mente delle persone che si
occupano di politica, di amministrazione e di informazione non passi neppure
per l’anticamera del cervello che delle persone fanno tutto questo
semplicemente per migliorare la società in cui viviamo e soprattutto per dare
una chance di miglioramento alla società futura, quella di esclusiva
“proprietà”, per ovvie ragioni anagrafiche dei nostri nipoti e dei figli dei
loro figli?”
· Perché i partiti
politici dovrebbero cambiare la loro agenda mettendo come tema prioritario ed
urgente l’istituzione di una legge che introduca l’Educazione musicale in ogni
ordine e grado di scuola, quando sembra proprio che, aldilà del colore politico
dei governi che si sono succeduti negli ultimi vent’anni, l’istruzione intera
sia l’ultima delle preoccupazioni dei governanti, tranne quando serve per fare
rapida cassa, tagliando ore d’insegnamento, materie e docenti ? Come è stata
accolta finora l’iniziativa? Può farci qualche nome di illustre personaggio o
Istituzione che ha aderito al Comitato?
“La musica è, tra le arti, la più effimera, la più
evanescente, quella meno afferrabile. Per essere percepita ha bisogno del tempo
in cui propagarsi e ripetersi in modo che l’ascoltatore ne possa intuire la sua
forma nascosta e quindi il suo spazio intrinseco. Ma, a differenza di molti
altri linguaggi, non ha bisogno di mediazioni razionali perché raggiunge
direttamente la sfera delle emozioni umane permettendo così l’espressione
profonda. Costruita da un lato secondo un sistema di segni rigorosamente
aritmetico-matematici dall’altro intrattiene rapporti con la sfera delle
emozioni ma anche con quella dei linguaggi e della creatività. Perciò, secondo
le moderne neuroscienze, essa contribuisce armonicamente ad intessere legami
profondi sia con l’emisfero sinistro che con quello destro del nostro sistema
nervoso centrale. In pratica stimola i processi nervosi e sinaptici attivando
l’intero encefalo dell’individuo, quando ad esempio lo studio della matematica
stimola quasi esclusivamente l’emisfero sinistro del cervello e lo studio
dell’italiano quasi solo quello destro.
 Anche solo per questa importantissima
ragione meramente neurofisiologica non si capisce perché in Italia lo studio
della musica di base non debba essere considerato formativo almeno al pari
delle citate discipline presenti da sempre nel curricolo scolastico di tutti
gli ordini e gradi di scuola e cioè dalla scuola materna all’università. Ecco
perché i governanti dovrebbero rivoluzionare la propria agenda politica e
mettere tra i primissimi posti, assieme al lavoro e alla sanità, l’istruzione e
nella fattispecie l’introduzione dove non c’era (scuole materne, elementari
licei e tutte le scuole superiori ad esclusione degli ex Istituti magistrali e
turistici) e riproposizione dove c’era ed ora è stata cancellata (ex Istituti
magistrali e turistici) dell’educazione musicale di base, cioè quell’uso ed
insegnamento della musica non per gli specialisti (per quelli che faranno della
musica la propria professione, il che richiede peraltro una forte
predisposizione e talento iniziale) ma di quella che tutti possono avvicinare
ed apprendere senza possedere particolari doti. Ricordo solamente che
l’insegnamento della musica nelle scuole in Italia, paese di Monteverdi,
Vivaldi, Rossini Verdi e Puccini, è tra le ultimissime posizioni al mondo,
dietro anche all’America Latina! Per quanto riguarda gli aderenti al Comitato,
nomi singoli non ne faccio per non dimenticarne qualcuno che senz’altro si
offenderebbe. Per il resto, segnalo l’adesione di: quasi tutto il mondo
musicale ed artistico italiano, compresi i mensili musicali di settore
attraverso i loro direttori responsabili, la SIAE, importanti Uffici Scolastici
provinciali, alcuni Sindacati della scuola, diversi Enti territoriali
provinciali e comunali, oltre alla Curia Arcivescovile di Milano, che ha
dimostrato grande interesse e sensibilità verso la proposta”.
Anche solo per questa importantissima
ragione meramente neurofisiologica non si capisce perché in Italia lo studio
della musica di base non debba essere considerato formativo almeno al pari
delle citate discipline presenti da sempre nel curricolo scolastico di tutti
gli ordini e gradi di scuola e cioè dalla scuola materna all’università. Ecco
perché i governanti dovrebbero rivoluzionare la propria agenda politica e
mettere tra i primissimi posti, assieme al lavoro e alla sanità, l’istruzione e
nella fattispecie l’introduzione dove non c’era (scuole materne, elementari
licei e tutte le scuole superiori ad esclusione degli ex Istituti magistrali e
turistici) e riproposizione dove c’era ed ora è stata cancellata (ex Istituti
magistrali e turistici) dell’educazione musicale di base, cioè quell’uso ed
insegnamento della musica non per gli specialisti (per quelli che faranno della
musica la propria professione, il che richiede peraltro una forte
predisposizione e talento iniziale) ma di quella che tutti possono avvicinare
ed apprendere senza possedere particolari doti. Ricordo solamente che
l’insegnamento della musica nelle scuole in Italia, paese di Monteverdi,
Vivaldi, Rossini Verdi e Puccini, è tra le ultimissime posizioni al mondo,
dietro anche all’America Latina! Per quanto riguarda gli aderenti al Comitato,
nomi singoli non ne faccio per non dimenticarne qualcuno che senz’altro si
offenderebbe. Per il resto, segnalo l’adesione di: quasi tutto il mondo
musicale ed artistico italiano, compresi i mensili musicali di settore
attraverso i loro direttori responsabili, la SIAE, importanti Uffici Scolastici
provinciali, alcuni Sindacati della scuola, diversi Enti territoriali
provinciali e comunali, oltre alla Curia Arcivescovile di Milano, che ha
dimostrato grande interesse e sensibilità verso la proposta”.
 Anche solo per questa importantissima
ragione meramente neurofisiologica non si capisce perché in Italia lo studio
della musica di base non debba essere considerato formativo almeno al pari
delle citate discipline presenti da sempre nel curricolo scolastico di tutti
gli ordini e gradi di scuola e cioè dalla scuola materna all’università. Ecco
perché i governanti dovrebbero rivoluzionare la propria agenda politica e
mettere tra i primissimi posti, assieme al lavoro e alla sanità, l’istruzione e
nella fattispecie l’introduzione dove non c’era (scuole materne, elementari
licei e tutte le scuole superiori ad esclusione degli ex Istituti magistrali e
turistici) e riproposizione dove c’era ed ora è stata cancellata (ex Istituti
magistrali e turistici) dell’educazione musicale di base, cioè quell’uso ed
insegnamento della musica non per gli specialisti (per quelli che faranno della
musica la propria professione, il che richiede peraltro una forte
predisposizione e talento iniziale) ma di quella che tutti possono avvicinare
ed apprendere senza possedere particolari doti. Ricordo solamente che
l’insegnamento della musica nelle scuole in Italia, paese di Monteverdi,
Vivaldi, Rossini Verdi e Puccini, è tra le ultimissime posizioni al mondo,
dietro anche all’America Latina! Per quanto riguarda gli aderenti al Comitato,
nomi singoli non ne faccio per non dimenticarne qualcuno che senz’altro si
offenderebbe. Per il resto, segnalo l’adesione di: quasi tutto il mondo
musicale ed artistico italiano, compresi i mensili musicali di settore
attraverso i loro direttori responsabili, la SIAE, importanti Uffici Scolastici
provinciali, alcuni Sindacati della scuola, diversi Enti territoriali
provinciali e comunali, oltre alla Curia Arcivescovile di Milano, che ha
dimostrato grande interesse e sensibilità verso la proposta”.
Anche solo per questa importantissima
ragione meramente neurofisiologica non si capisce perché in Italia lo studio
della musica di base non debba essere considerato formativo almeno al pari
delle citate discipline presenti da sempre nel curricolo scolastico di tutti
gli ordini e gradi di scuola e cioè dalla scuola materna all’università. Ecco
perché i governanti dovrebbero rivoluzionare la propria agenda politica e
mettere tra i primissimi posti, assieme al lavoro e alla sanità, l’istruzione e
nella fattispecie l’introduzione dove non c’era (scuole materne, elementari
licei e tutte le scuole superiori ad esclusione degli ex Istituti magistrali e
turistici) e riproposizione dove c’era ed ora è stata cancellata (ex Istituti
magistrali e turistici) dell’educazione musicale di base, cioè quell’uso ed
insegnamento della musica non per gli specialisti (per quelli che faranno della
musica la propria professione, il che richiede peraltro una forte
predisposizione e talento iniziale) ma di quella che tutti possono avvicinare
ed apprendere senza possedere particolari doti. Ricordo solamente che
l’insegnamento della musica nelle scuole in Italia, paese di Monteverdi,
Vivaldi, Rossini Verdi e Puccini, è tra le ultimissime posizioni al mondo,
dietro anche all’America Latina! Per quanto riguarda gli aderenti al Comitato,
nomi singoli non ne faccio per non dimenticarne qualcuno che senz’altro si
offenderebbe. Per il resto, segnalo l’adesione di: quasi tutto il mondo
musicale ed artistico italiano, compresi i mensili musicali di settore
attraverso i loro direttori responsabili, la SIAE, importanti Uffici Scolastici
provinciali, alcuni Sindacati della scuola, diversi Enti territoriali
provinciali e comunali, oltre alla Curia Arcivescovile di Milano, che ha
dimostrato grande interesse e sensibilità verso la proposta”.
· Quali sono le
prossime iniziative che il Comitato intende compiere per avvicinarsi a questo
ambizioso, arduo ma necessario traguardo legislativo?
“A questo punto del discorso mi sembra chiaro che la musica
possa realmente cambiare il futuro dei giovani nel nostro Paese. Il Comitato
Nazionale investirà tutte le energie, i mezzi, le risorse, ma soprattutto le
menti e i cuori di chi già ne fa parte e di tutti i cittadini che si vorranno
unire in questa battaglia di civiltà, organizzando convegni di studi, Concerti-Lezione
per la scuole sul modello di quello fatto al Liceo Classico “Parini“ di Milano
nel marzo scorso, in cui erano gli stessi giovani esecutori che spiegavano il
brano e l’autore al pubblico di liceali e dei rispettivi genitori appena prima
di interpretarlo. Si effettueranno anche Concerti-Lezione per adulti (tutta la
Stagione 2014 dell’Associazione Mozart Italia di Milano è costruita con taglio
rigorosamente didascalico-pedagogico) e altri eventi come l’esecuzione in
importanti città italiane del Requiem di W. A. Mozart, assunto come evento
simbolico perché capace di richiamare sia moltitudini di cittadini dai più
eterogenei gusti musicali sia per esorcizzare, prima che sia troppo tardi, la
paura dell’imminente morte totale dello studio dell’Educazione musicale di base
nelle scuole italiane”.
SUL REALISMO IRONICO DI GRAZIA NIDASIO
Al “Corriere dei Piccoli”
degli anni Cinquanta e Sessanta collabora assiduamente (sino a
diventarne una sorta di tratto distintivo, un elemento
caratterizzante, come capitò anche a Rubino e a Sto) Grazia Nidasio.
Di gran bravura verrà giudicata, e molti encomi di lei si
scriveranno (un’eterna ragazza, elegante come sono eleganti i suoi
disegni, eccetera). Ma noi non staremo ora a ripetere queste lodi,
che pur rispondono ad assoluta e certa verità, e cercheremo invece
di fermare Grazia Nidasio in alcuni punti del suo percorso e definire
così, in qualche modo, il suo operare. Il disegno nidasiano ha una
cifra inconfondibile, comunque, pur attraversando, nel tempo, vari
modi, varie declinazioni: sia quando l’autrice lavora su proprie
invenzioni sia quando disegna su testi altrui.
Quante cose ha disegnato Grazia
Nidasio. Ecco le tavole piene di gente (ma nessuno è gente, tutti
sono caratterizzati e riconoscibili) al mare o in città. I presepi.
I grandi riquadri che rendono visivi i racconti di Piero Selva alias
Mino Milani. Ecco i giochi, le strip in forma di mini-film, i disegni
didattici. E le illustrazioni per il libro di Antonio Faeti, Antonia
e le bottiglie di Morandi, del 1993…
Sfogliamo qualche sua pagina.
Questo nostro piccolo viaggio inizia quando sul “Corrierino” le
storie a fumetti sono ancora rare, e sono invece assai diffuse le
pagine composte (di norma) da otto riquadri accompagnati da testi
narrativi rimati, avendo ogni vignetta (di norma) due versi posti
come didascalia.. E così, cioè debitamente filastroccati, si
presentano tanti personaggi nidasiani negli anni Cinquanta: oltre ad
Alibella (su testi di Franco Bianchi) compaiono, in quel decennio,
Gelsomino, Nonno Ruby, Fortunino, Curiosetto, Pierino Novecento e
persino (“Corriere dei Piccoli” n. 45 del 7 novembre 1954), per
festeggiare Trieste italiana, Italino e Redentina.
Allora, cominciamo. “Corriere
dei Piccoli” n. 17 del 26 aprile 1953: una coppia in attesa di un
figlio riceve da una cicogna una cesta di fiori. Fra i fiori compare
una bimba alata, “un caso troppo strano”, per cui la donna è già
pronta a recidere quelle ali con un colpo di forbici. Ma basta un
risolino e un leggero volteggiare della bimba per far desistere la
mamma e anzi suggerirle il nome per la piccola creatura. Da allora i
genitori (una coppia borghese, garbata, con un papà in giacca e
cravatta) vedranno Alibella come una bimba normalissima, senza mai un
moto di sorpresa o di disagio per la sua conformazione. Alibella,
piuttosto, come sua aggravante, spesso fugge in mondi fiabeschi, in
dimensioni parallele. E con un filo di gioioso anarchismo: nel n. 21
del 22 maggio 1955 una nobile signora raccoglie la bimba per strada –
Alibella ama giocare fra le pozzanghere – e la porta a casa sua,
vestendola come una bambola ma impedendole di volare. Naturalmente
Alibella fugge, con la complicità di una lucciola.
Fra i compagni di avventura della
bimba ci saranno un aeroplanino rosso, un orsacchiotto di pezza, il
Poeta (che vola su un aquilone e distribuisce doni). Alibella
incontra Rosadeiventi e il “gatto stivalato”, visita il mondo dei
Balocchi abbandonati e la Città dell’Alfabeto. Nel Paese delle
Nuvole (n. 26 del 28 giugno 1953) sperimenta la parvenza multiforme
delle nubi, la loro capacità di tramutarsi da una figura in
un’altra. In altre tavole viaggia con un elettrotreno fra le
costellazioni, la storia si scioglie in un volo giocoso della
fantasia.
Poi Alibella scende sulla terra e
trova la tenera amicizia di Bimbo, un elefantino azzurro. Chissà se
la Nidasio all’epoca sapeva che Bimbo era il nome di un gatto di
Paul Klee. La realtà è oramai quella quotidiana ma l’inventiva
folle e lunare dell’autrice è scatenata. Nel n. 7 del 14 febbraio
1960 Bimbo lascia l’esercito e, col foglio di congedo, fa un
cappello per una sirena vezzosa che, riconoscente, lo copre di
gioielli. Il disegno ha raggiunto un segno maturo, perfetto: è
stilizzato, arguto, corsivo. Nel n. 18 del 1° maggio 1960 Alibella
“ha il gusto fine / nel tagliare figurine” e Bimbo disegna un
castello che “diventa, tale e quale, / grande proprio al naturale”.
Ma, tagliando a pezzi il disegno dell’orco subito apparso, lo si
sbaraglia. È una sorta di ars poetica: Nidasio ci dice che l’artista
può creare e disfare mondi fantastici, a suo piacimento. E nel n. 31
del 31 luglio 1960 Bimbo crea un omino di fumo: forme tondeggianti si
mischiano a spigolosità geometriche, a visioni e allucinazioni, a
segni astratti, in una fantasmagoria che può avere una sua fonte –
ma in Nidasio c’è una leggerezza tutta sua – nella sequenza
dell’elefante rosa in Dumbo.
Gelsomino è un ladro. Seguiamo
alcune sue imprese dell’annata 1954. Nel n. 14 del 4 aprile ruba
una nuvola per fare il giaciglio a un bambino vagabondo, nel n. 26
del 27 giugno cattura una saetta per illuminare il faro e portare in
salvo due marinai, nel n. 28 dell’11 luglio ritaglia una striscia
candida da un ghiacciaio, un pezzo di verde smeraldino da una
collina, un poco di rosso da un cielo al tramonto, e così fa la
bandiera italiana per una scuola di campagna. Il brigadiere
Gianlucerna, che gli dà perennemente la caccia, rimane sempre
sconfitto: “Eh, l’autore non si arresta / d’un’impresa come
questa!”. Nel n. 34 del 22 agosto Gelsomino, per aiutare un poeta a
trovare l’ispirazione (“chè l’immagine potente / non gli
brilla ancora in mente”), ruba “idea molto opportuna, / un pochin
di chiar di luna” e poi “coglie a volo / la canzon d’un
usignolo” – e anche questa volta ovviamente Gianlucerna non
riesce ad arrestarlo, non sa chi arrestare, non sa perché arrestare.
Billi detto il Patata è un
ragazzino nero, perennemente rifiutato dai ragazzi bianchi, che si
esprimono con frasi dichiaratamente razziste. Nel n. 27 del 3 luglio
1960 Billi vuol recarsi al Grande Cine: “Ma una frotta di ragazzi /
con gran gesti e sciocchi lazzi, / lo respingon: «Per piacere, / via
di qui le facce nere!»”. Nidasio dà alle vignette un taglio
cinematografico, come se stesse lavorando a uno story-board: sceglie
gli angoli di ripresa, crea il montaggio delle scene. Billi viene
inquadrato da un punto di vista all’altezza del marciapiede sul
quale è seduto, lo sfondo si unisce mirabilmente alle figure umane
tagliate dall’inquadratura, le silhouettes dei protagonisti si
stagliano sulle immagini proiettate sul grande schermo.
Poi arriva Violante, su testi di
Guglielmo Zucconi. Nidasio adotta le vignette con il balloon, disegna
vicende in cui sono immessi i fenomeni e le inquietudini del mondo
moderno. Con pochi tratti riesce a dar vita a quello che con Roland
Barthes definiremo l’“effetto di realtà”. I protagonisti sono
scelti fra gli adolescenti di una Milano contemporanea (sono gli anni
del boom economico, della musica beat). Il disegno è ironico,
bidimensionale, asimmetrico: possiamo trovarne forse una qualche
parentela con Ward Kimball e con una certa grafica pubblicitaria ma
tutto ha la sua origine da quel Picasso post-cubista che lavora sulla
Costa Azzurra, fra Cannes, Antibes, Vallauris e Juan-les-Pins:
coloratissimo, deformato, appiattito.
Con il personaggio di Violante
comincia un’epopea borghese, con al centro la famiglia e i suoi
valori. E con una sottile capacità d’introspezione,
un’osservazione attenta della psiche adolescenziale. Le puntate
sono brevi, in genere di una pagina. Si procede a piccoli bocconi.
Nel n. 40 del 6 ottobre 1963, per fare un esempio, una puntata di
Violante e il gemon di Dolabella consta solo di cinque vignette. Con
la narrazione costretta in sì rigida misura (la costrizione diventa
stimolo creativo) tutto diventa ancor più intenso, e la brevità fa
scaturire nuovi ritmi narrativi, scanditi da parti raccontate dalle
didascalie e parti illustrate dalle vignette.
Valentina Mela Verde, cioè
Valentina Morandini e la sua famiglia, è un nuovo capitolo della
saga borghese con effetto di realtà. E il rapporto con il sociale è
ormai così forte da prospettare persino un’inchiesta (nn. 20 e 21
del 16 maggio e 23 maggio 1971) su questioni ecologiche. I personaggi
sono caratteri compiuti, ben definiti, e fuoriescono dalla pagina,
evidenti, nitidi. Sono singole esistenze individuali che diventano
elementi tipici. E Nidasio si può permettere tutto: anche la mimesi
del disegno infantile (cioè un citazionismo di stile) nella storia
del Mauri (“Corriere dei Ragazzi” n. 6 del 6 febbraio 1972), con
il precedente del Romano Scarpa di Topolino e la collana Chirikawa e
con anni di anticipo sullo Stephan Pastis di Pearls Before Swine.
Ci sono tante cose che si possono
rilevare. Ad esempio, i neo-vocabolari: Dolabella, cugina di
Violante, parla con un suo gergo: zerbolò significa un mucchio di
tempo; ramugani sono le storie, le noie, che è meglio evitare;
spanganare significa mettere sotto i piedi, soggiogare; bruvetta è
la bicicletta, bolò è il telefono, gemon è un segreto. Del
linguaggio di Violante – che fa suo quello di Dolabella –
redigerà un repertorio lessicografico lo stesso direttore del
“Corrierino”, Carlo Triberti, rispondendo alla lettrice Maria
Denis Dall’Olio, nel n. 23 del 5 giugno 1966. Invece il linguaggio
di Stefi, sorella minore di Valentina, è semplicemente impacciato
per l’ancor scarsa conoscenza della lingua. Eppure ha esiti
fantasiosi, come capita con i bambini. Nel n. 17 del 25 aprile 1971:
il vestito da “damigilla”, “lei sa tutti i racconti di
fantasmi, di sposalizi e di mazzamenti”, “non sono bambita”
sino alla fusione con parole dotte: “Ma cosa c’è da ridere? Non
vi piace il mio discorso sintomatico?”. Con i balloon che talvolta
si dilatano a riempire mezza vignetta (che a loro volta rendono
fluidi i loro contorni o li perdono), parole fluttuanti, parole che
debordano e fuoriescono dalla nuvoletta: vari stilemi del littering
nidasiano. Che nel “Corriere della Sera” arriverà poi ad
accorpare più balloon, ad accumularli, a farli scomparire.
Stefi vivrà in molte dimensioni:
la posta sceneggiata, i disegni animati in tv, l’informazione
ecologica (nel 1990 Mondadori pubblica Parliamo di ecologia con
Stefi, con il patrocinio della Regione Lombardia, anche in una
versione con caratteri braille), la satira politica. Sul “Corriere
della Sera” del 23 luglio 2013: “Il royal baby sta per nascere –
Il papa è partito con l’aereo – E gli altri due re magi, quando
arriveranno?”. Caustica, feroce, anarchica, la Stefi
“commentatrice” è il punto d’arrivo, estremo, del candore
contestatario della piccola Morandini. Le vignette sono firmate con
l’indirizzo e-mail di Nidasio: proprio perché l’autrice –
persona usualmente riservata, aliena da ogni protagonismo – si
aspetta risposte, vuole conoscere il pensiero altrui, sentire le
reazioni.
Nidasio disegna sul “Corriere
dei Piccoli”, fra le suo mille pagine illustrate, una tavola
spiritosa ma edulcorata sulla naia, il famigerato servizio militare.
E anni prima (sul n. 51 del 18 dicembre 1960) illustra “Il natale
del bravo bambino”, un elogio dei buoni sentimenti così smaccato
da far quasi sorgere il dubbio di una parodia. E ci si chiede: da che
parte sta Grazia Nidasio? Tesse l’elogio di una piccola borghesia
ben pensante e per bene o è una giocosa, trasgressiva contestatrice
del mondo contemporaneo?
È certo che quello che lei ritrae
è un mondo borghese, seppur ricco di componenti di diversità: per
restare alle tavole di Valentina Mela Verde ecco (tutto sul “Corriere
dei Ragazzi” n. 1 del 2 gennaio 1972) l’hippie Donald, il Mauri
che proviene da una classe differenziale, il prof Capanno
(chiaramente di estrema sinistra, anche se cita Dumas e non Mao), i
cartelloni contro il consumismo inalberati dal fratello Cesare e dai
suoi amici. Ma non sono, questi, veri elementi di disturbo sociale e
ideologico: semplicemente dimostrano la curiosità e l’apertura di
Nidasio, che esercita una satira bonaria (non scevra talvolta da
simpatia) verso fenomeni delle moderne lotte sociali.
Quello che è davvero innovativo è
quella sorta di registro adolescenziale o infantile, adottato come un
punto di vista da cui osservare e decrittare il mondo, con moduli in
sospeso fra cronaca e diario. Ne deriva il tratteggio delle varie
figure: il padre tradizionalista e autoritario (che era quasi una
caricatura in Violante, ed ora non è molto più moderno), la Stefi
con i suoi valori non compresi dagli adulti e neppure dagli
adolescenti, i comprimari, mai superflui e sempre ben incisi. E poi
l’autoriflessione dei personaggi, che raccontano e si raccontano.
Sempre resi in pochi tratti, come sa fare la Nidasio, con una grande
capacità di sintesi psicologica e grafica. È questo il suo realismo
borghese: cattivo e asciutto.
Marco Innocenti
IL PANE E LE ROSE
di Giovanni Bianchi
Giovanni Bianchi
“Lo smog non tramonta”
Edizioni Nuove Scritture
Pagg. 96 € 5,00
Giovanni Bianchi, nato a Sesto San Giovanni (Milano), laureato in scienze politiche presso l’Università Cattolica, insegnante di filosofia e storia nei licei. Democratico d’ispirazione cristiana, da sempre è impegnato in politica e nel sociale. Per molti anni presidente, prima lombardo e poi nazionale, delle ACLI, è stato tra i fondatori del P.P.I. ricoprendo la carica di presidente nel 95 e 96. Eletto Deputato alla Camera dal 94 al 2006, ha fatto parte della Commissione Esteri ed è stato relatore della legge per la remissione del debito estero. Nel 2008 ha coordinato il Partito Democratico milanese. È attualmente presidente del Circolo Dossetti di Milano promotore di corsi di formazione alla politica e del Centro Studi Problemi Internazionali con sede in Sesto San Giovanni. Collabora da molti anni al giornale “Odissea” di Milano.
Milano 2013 (foto liviaci)
Aninu, la forza del destino
“Lo smog non tramonta”
Edizioni Nuove Scritture
Pagg. 96 € 5,00
“L’intelligenza e la memoria sono
ostinatamente narrative e verità è quella elaborata da una mente
brada, capace di autoplagio e di astute dimenticanze. Ognuno - prima
di essere novellista, teologo, storico - è anzitutto narratore
inconsapevole di se stesso. Eppure non basta. Non basta ancora. Il
raccontare è un dono dell’Altissimo elargito ai suoi. Si
accompagna ai tuoi giorni, inatteso, cammin facendo. E come ogni dono
è gratuito e dovrebbe essere offerto gratuitamente: altrimenti
degrada in prostituzione. E invece corrono il mondo e trionfano i
bestseller!”
Giovanni Bianchi, nato a Sesto San Giovanni (Milano), laureato in scienze politiche presso l’Università Cattolica, insegnante di filosofia e storia nei licei. Democratico d’ispirazione cristiana, da sempre è impegnato in politica e nel sociale. Per molti anni presidente, prima lombardo e poi nazionale, delle ACLI, è stato tra i fondatori del P.P.I. ricoprendo la carica di presidente nel 95 e 96. Eletto Deputato alla Camera dal 94 al 2006, ha fatto parte della Commissione Esteri ed è stato relatore della legge per la remissione del debito estero. Nel 2008 ha coordinato il Partito Democratico milanese. È attualmente presidente del Circolo Dossetti di Milano promotore di corsi di formazione alla politica e del Centro Studi Problemi Internazionali con sede in Sesto San Giovanni. Collabora da molti anni al giornale “Odissea” di Milano.
Consumismo e povertà
Milano 2013 (foto liviaci)
Aninu, la forza del destino
di Giovanni Bianchi
Non
volano soltanto cigni neri nei cieli della letteratura. Anzi, per quel che
riguarda il romanzo, la crisi, conclamata da tempo, non cessa di stupire, nel
senso che moltiplica le sorprese con inesauribile fantasia, quasi intendesse
danzare tra un salutismo incredibilmente ritrovato e la pandemia del genere
bestseller da intrattenimento. In effetti il romanzo s’è ulteriormente dilatato
nei generi e nelle prove, chiamando in campo esperimenti supercommerciali ma
anche il candore professionale e creativo di un artigianato dalle antiche
radici e dai mille mestieri. Per cui se sugli scaffali degli empori e perfino
degli autogrill impazza il genere di consumo (snack al volo più libro al volo),
in insospettati ateliers rinasce la vita del romanzo attingendo a linfe nascoste, non tutte recenti, al riparo dal
chiasso e dalla pubblicità, in un'umile e accorata attesa di un lettore
attento, non schiavo cioè della dittatura del tempo breve e tanto meno di
quella del mostro mite.
È
in uno di questi orti del pensare e dello scrivere che deve essere stato
coltivato "Aninu", che è la
storia di una prostituta sacra dell'isola vulcanica di Santorini, prima della
grande eruzione del XVII secolo avanti Cristo che ha cancellato la civiltà
minoica nello spazio di un giorno e di una notte tremenda. E la quarta di
copertina si serve nientemeno del Timeo
di Platone, con un riferimento alla mitica Atlantide. La protagonista è in fuga
dal tempio e da una religione che, sostituendo gli arcana imperii al mistero quotidiano, domina l'isola con pugno di
ferro e sacrifici di bambini. Aninu è una sorta di anticipazione del ribellarsi
è giusto, per cui fonda una comunità ideale di vita chiamata Thera,
identificandosi con la tragica fine dell'isola.
Stiamo
cioè facendo i conti, nel senso che li fa Oliviero Arzuffi, l'autore, con gli
eventi fondativi della cultura occidentale (perché tutto quel che viene dalla
Grecia ha carattere universale), ripercorsi con un’acribica competenza che
poggia su una meticolosa ricerca archeologica. In essa la descrizione dei
luoghi e la rappresentazione dei costumi va di pari passo con la rievocazione
delle credenze e dei miti del misterioso popolo cretese che vanta, come
antenati, gli abitanti della più antica città del mondo situata nell'odierna
Turchia e dichiarata oggi patrimonio dell'umanità.
I
discendenti, delle cui origini si occupa l'Arzuffi, sono le popolazioni della
Grecia classica, all'interno di un combattuto Mediterraneo cui si sono
affacciate le civiltà al punto da farlo assurgere a culla della civiltà
medesime. Una terra fertile ma anche avara nella quale, secondo la stupenda
espressione di Braudel, il mare s’inoltra come pianure liquide tra i monti.
L'isola
di Santorini viene così sottratta al turismo mordi e fuggi e ricostruita come
doveva essere prima dell'eruzione vulcanica, datata appunto agli ultimi decenni
del XVII secolo avanti Cristo, che ha determinato la scomparsa della civiltà
minoica e sconvolto l'intero bacino del Mediterraneo. Qui si collocava il più
importante centro religioso delle isole Cicladi, dal quale la ex prostituta
sacra Aninu prende drammaticamente le distanze e la fuga, spinta da un daimon interiore che la rende
appassionata innovatrice sia sul piano religioso come su quello civile.
L’incipit
del romanzo di Arzuffi racchiude, senz'altro volutamente, il senso arcano della
vicenda, così come la ghianda contiene lo sviluppo dalla quercia:
"Aninu se ne stava
accovacciata per ore sulla riva del piccolo lago, con il corpo asciutto e
snello che si rifletteva nello specchio d'acqua. Gli occhi attenti a scrutare
la vita che pullulava dentro il grande stagno acuivano il dolore per un figlio
mai avuto, per una vita tutta sua inesorabilmente negata. Allora si accarezzava
il ventre lasciandosi invadere dal rimpianto nella solitudine di
quell'altipiano e scrutava la scura montagna davanti a sé come aspettando da
lei una risposta".
Arzuffi ha il genio di evocare insieme il sentimento personale e quello che può
essere attribuito alla natura circostante: una fusione che i moderni (troppo
disposti al tramonto) tentano invano di recuperare, che l'ecologismo e la
cultura verde si affannano a ricostruire, e che la Grecia classica ci
riconsegna nei suoi reperti con il
canone di una bellezza che proprio per questo riesce ad essere, in tutte le
espressioni, anche quelle scultoree, insieme umana e allusione a una misura
divina.
Il
romanzo di Arzuffi ha il coraggio di scavare nella fase precedente a quella che
abbiamo imparato a leggere nei canoni della classicità, dalla quale l'Europa
detronizzata si sta separando con un disprezzo pari alla superficialità. Dove
il mistero è più diffuso e drammatico e, usando una categoria nietzschiana, il
dionisiaco prevale decisamente sull'apollineo. Un mix che non può non
attraversare insieme il foro interno, lo spazio personale e quello pubblico,
peraltro intrecciati e confusi in maniera pressoché inestricabile da una
frequentazione del mistero che i protagonisti hanno tutti in comune.
Come
per un giallo, non ha senso e sarebbe addirittura disdicevole narrare la trama.
Quel che mi pare più appropriato a una lettura spericolatamente anarchica è
individuare il senso dell'opera e della
costruzione, quasi a fornire al lettore se non la ratio, almeno una chiave inglese che consenta di entrare nei
meccanismi del libro.
Vi
leggiamo: "Ad ogni gradino per
accedere ai ripostigli dell'anima, sentiva il dolore crescere quanto più si
affacciavano alla memoria le vicende che si allontanavano nel tempo, e percepiva
la mente vacillare, quando considerava le sue azioni recenti (p. 90) ... Comprendeva ormai chiaramente come le
parvenze fossero in grado di confondere il retto discernimento del bene e del
male (p. 91) ... Se le leggi e le
consuetudini della sua gente potessero essere comprese nella pietra e lasciate
in eredità per sempre, Ciatal potrebbe sopravvivere al tempo e rimanere immune
dalle mutazioni (p. 93) … E il
sacrificio dei bambini? – domandò Batto. Aninu, puntando l'indice su una delle
tavole di arenaria, lesse ad alta voce: "Non verserai il sangue in nome di
nessun dio, perché il sangue dei viventi è sacro al Cielo e la vita è la linfa
della Terra. Non sopprimerai perciò la vita, se non vuoi che essa ti abbandoni.
Così sta scritto! "Quindi... – continuò incuriosito Batto – "E’ stata
un'invenzione, il sacrificio dei bambini"... "Nessuno sa quando è
cominciata questa follia, - rispose Aninu con tono dolente - né chi l'abbia
inventata né come né perché" (pp. 98-99).
Comparare
aiuta a capire. E i temi e l'atmosfera di questo romanzo mi hanno rimandato a Le città invisibili di Italo Calvino.
Vuoi per l'assenza di paura ad affrontare questioni eterne, con la
consapevolezza che la letteratura è insieme ripetizione, variazione e
approfondimento. Con la disponibilità a ricominciare daccapo e dagli inizi. È
un modo peraltro per costringere il lettore a confrontarsi direttamente con i
dubbi e gli interrogativi che costellano la ricerca dell'autore.
Anche
la scientificità degli strumenti e talvolta perfino l'aridità dell'approccio
finiscono per fornire materiali e creare l'atmosfera. Il mito così è di casa e
si fa elemento quotidiano. Pertanto l'adozione di un punto di vista lontano,
straniante in massimo grado, e lontanissimo da ogni normalità quotidiana,
sciolgono lo scrittore dalle remore psicologiche del presente e lo sospingono
quasi inavvertitamente a creare una quotidianità altra e altrettanto credibile.
Dove i sentimenti riemergono mantenendo tutta la loro distanza nel tempo,
eppure finiscono per risultarci credibili e quotidiani.
È
così che la voce dell'autore giunge a noi sommessa, come alterata dagli echi
delle grotte sul mare amico e infido dei Greci, ma presente e capace di
colloquio.
Potrebbe
forse anche funzionare l’allusione a pezzi di opere famose dell'antichità, volta
a determinare un effetto di acronia,
e a farci partecipi di quella sensazione di disorientamento, di vuoto e di
saturazione a un tempo, su cui veniamo sollecitati a meditare dal ritmo insieme
lento e drammatico degli avvenimenti. E’ così che il racconto di un'avventura
si trasforma pagina dopo pagina nell'avventura di un racconto.
Aninu non richiede tuttavia al lettore una
competenza culturale specifica: pretende piuttosto la disponibilità a una
lettura meditativa, quasi a suggerire che è la lettura stessa che viene a noi,
pur nel dedalo, quasi un corto circuito, di spunti ruminativi chiamati ad
entrare in relazione con quanto è sedimentato nella nostra memoria, e magari
perfino in qualche affrettato ricordo turistico.
L’Arzuffi
insomma non consente nessuna lettura veloce. Vale anche nel suo caso il celebre
sarcasmo di Woody Allen: "Ho fatto un corso di lettura veloce. Ho letto Guerra e pace. Parla della
Russia"...
Un
altro paragone e un altro confronto mi paiono consentiti, e sempre con Italo
Calvino.
Non
si tratta di affinità di argomento questa volta, ma dell'andamento generale
della scrittura e dell'intenzione delle pagine. Sto pensando infatti a La giornata d’uno scrutatore.
Faccio
riferimento cioè a una confessione autobiografica ma anche da
"intellettuale organico" del grande scrittore ligure e cosmopolita,
laddove confida di aver voluto realizzare con La giornata non un romanzo d'azione, ma di riflessione sui
comportamenti e sul senso di una stagione della nostra storia. Lo sconsolato,
elegiaco e dolente (come si usa oramai per le consultazioni elettorali viste da
sinistra) Amerigo Ormea di Calvino e la drammaticamente dolente, forse più faustiana
che elegiaca, Aninu di Oliviero Arzuffi.
Qui
infatti anche la natura, la cui inimitabile bellezza è tale da condurci fuori
di noi stessi, finisce per essere sconvolta, alla maniera dei protagonisti, da
uno spirito che sembra disordinare il mondo per riconsegnarlo ad uomini che
vogliano provare a riordinarlo. Emblematica e certamente non casuale la
circostanza, tutta moderna in tanto scialo d'antichità, che l'eroina sia una
donna.
Un
dramma con radici antichissime e che non cessa di riproporsi. Forse anche per
questo il tentativo qui condotto di ricostruire una memoria alle radici dell'Occidente
è un modo per inseguire semi di futuro che non abbiano la non commestibilità
della plastica.
Davvero
bisogna voltarsi indietro per spingersi sensatamente avanti. È la figura, ma
anche la lezione dell'Angelo della storia di Walter Benjamin. Per questo leggere
un romanzo scritto in questo modo dà riposo mentre riattiva nella mente e
nell'inconscio una ineliminabile e sana inquietudine.
Oliviero Arzuffi
Aninu –Romanzo storico-
Oltre
Edizioni
Pagg.
274 € 19
Richieste
a:
tel:0185-459133


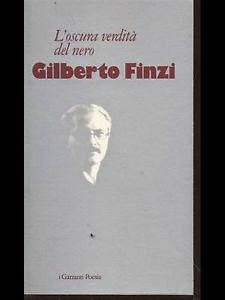


.jpg)



.jpg)




.jpg)



























































