L’ANNIVERSARIO
 |
| La locandina di "Odissea" nella bacheca della Biblioteca "Sormani" di Milano |
Nell’estate
del 2013 “Odissea” cartacea compiva 10 anni di vita. Il 27 Settembre di quello stesso anno, alla presenza di
tanti amici e collaboratori, in una Sala del Grechetto della
Biblioteca Sormani di Milano bella piena, un incontro pubblico tirava le
somme di quella esperienza, e decideva di passare ad una nuova fase: dal
cartaceo alla Rete; da Gutenberg a Bill Gates, come avevamo titolato la prima
pagina dell’ultimo numero, con la lettera ai lettori che abbiamo poi
riprodotta sulla prima pagina dell’edizione on line. In quell’incontro, presero la
parola diversi amici: dal filosofo Fulvio Papi al filosofo Gabriele Scaramuzza;
dal saggista e scrittore Giovanni Bianchi al saggista e critico d’arte Giorgio
Colombo, dal filosofo Roberta De Monticelli al sociologo Nando Dalla Chiesa.
Tante anche le testimonianze di affetto, i messaggi, le presenze qualificate in quella
Sala.
Dalla Chiesa, che intervenne subito dopo il direttore
Angelo Gaccione, accolse la decisione di quel passaggio con molto entusiasmo, e
predisse un’espansione esponenziale di contatti e di lettori a seguito dell’immissione in
Rete del giornale. Cosa che è davvero e fulmineamente avvenuta, sia per la disponibilità di
“Odissea” a sostenere tutte le battaglie civili e culturali possibili come aveva fatto con
l’edizione cartacea, sia per la sua autorevolezza morale che ne fa un punto di riferimento e di vicinanza
ideale per gli strati sociali e culturali più diversi. Ora siamo qui a festeggiare un altro
anniversario: il primo di “Odissea” in Rete, testata rossa come il suo appassionato rosso cuore. In
questo primo anno gli scritti ospitati sono stati tantissimi (solo la prima
pagina ne ha ospitati circa 500) e i contatti sono diventati decine di
migliaia. Probabilmente sono cambiati i lettori, altri se ne sono aggiunti e
sicuramente il mezzo virtuale della Rete è molto diverso dallo strumento
cartaceo. In più, concepito come strumento di Rete, “Odissea” ha finito per svolgere, accanto alla
funzione di analisi e riflessione a più lungo termine che aveva già, anche una
funzione tipica del quotidiano. Da questo punto di vista è incredibile la
quantità di materiale che arriva dalla società civile, dai movimenti sociali e
dagli ambienti culturali. “Odissea” ha sempre sostenuto questa ricchezza e
questa pluralità e continuerà a farlo. Sarà sempre dentro la conflittualità
dialettica, fuori dagli intrighi di potere che combatterà, e in prima fila per la difesa dell’etica pubblica e degli
interessi collettivi. Più di un amico ha segnalato che fra i meriti di
“Odissea”, c’è quello di aver messo al centro della sua azione, la moralità
pubblica; per noi è un motivo di orgoglio e di onore, soprattutto in anni di
degenerazione etica della politica. È un compito che ci siamo assunti e a cui
non verremo meno. “Odissea” continuerà ad essere la coscienza critica e morale
della Nazione, ai lettori chiediamo di essere solidali e di difendere assieme a
noi queste ragioni.
Angelo Gaccione
 |
| A sin. Max Luciani, a des. Angelo Gaccione |
CENTO AUTORI PER ODISSEA
Grande successo per: “Cento autori per Odissea”
per festeggiare il
1° anniversario in Rete del giornale
dopo 10 anni di
vita cartacea. (Ottobre 2013 – Ottobre 2014)
Cari amici, possiamo dirlo, è stato un successo: abbiamo superato il traguardo che ci eravamo prefisso. Oltre 100 gli interventi giunti alla nostra Redazione dall'Italia e dall'estero. La Rubrica “Fuori Luogo” è
completa e comprende 37 autori in totale; è completa anche la Rubrica “Campi
Elisi” con 48 autori; mentre la Rubrica “La Carboneria”
ospita il resto degli autori.
1.Fulvio Papi
2.Morando
Morandini
3.Arturo Schwarz
4.Giuseppe Bonura
5.Tomaso Kemeny
6.Laura Margherita
Volante
7.Pier Luigi
Amietta
8.Franco Manzoni
9.Don Luigi Ciotti
10.Giulio Stocchi
11.Attilio Mangano
12.Fabio Minazzi
13.Adamo Calabrese
14.Franco
Dionesalvi
15.Adele Desideri
16.Stefano
Raimondi
17.Dino Ignani
18.Adam Vaccaro
19.Paolo Maria Di
Stefano
20.Dario
Pericolosi
21.Maria Carla
Baroni
22.Livia Corona
23.Rinaldo Caddeo
24.Meeten Nasr
25.Annalisa
Bellerio
26.Lisa Albertini
27.Fabiano
Braccini
28.Ornella
Ferrerio
29.Graziella
Poluzzi
30.Tiziano Rovelli
31.Leonardo Nobili
32.Alberto
Casiraghy
33.Giuseppe De
Vincenti
34.Angela
Passarello
35.Roberto Carusi
36.Maria Gabriella
Carbonetto
37.Maria Cristina
Spigaglia
Elenco degli autori inseriti nella Rubrica “Campi Elisi”
38.Emilio Molinari
39.Gabriele
Scaramuzza
40.Emilio Renzi
41.Giorgio Colombo
42.Lidia Sella
43.Cesare Vergati
44.Ottavio Rossani
45.Giuseppe Denti
46.Luca Marchesini
47.Cataldo Russo
48.Francesco
Piscitello
49.Franco Esposito
50.Claudia Azzola
51.Francesca
Romana Di Biagio
52.Giovanni
Bianchi
53.padre Alex
Zanotelli
54.Maurizio
Meschia
55.Roberto Marelli
56.Marilena Vita
57.Gilberto Finzi
58.Mauro Della
Porta Raffo
59.Luigi Caroli
60.Anita Guarino
Sanesi
61.Renato Seregni
62.Raffaele Talarico
63.Pino Corbo
64.Antonio Lubrano
65.Silvana Borutti
66.Michela
Beatrice Ferri
67.Valerio
Fantinel
68.Tiziana Canfori
69.Gilberto Isella
70.Alessandro
Zaccuri
71.Alice Cappagli
72.Luigi Tasso
73.Felice Carlo
Besostri
74.Donatella
Bisutti
75.Gio Ferri
76.Giacomo
Guidetti
77.Barabara
Gabotto
78.Lelio Scanavini
79.Leandro Fossi
80.Mariella De
Santis
81.Alessandra
Paganardi
82.Tiziano Rossi
83.Vittorio Sedini
84.Carlo
Cipparrone
85.Edoardo Walter Pozzi
85.Edoardo Walter Pozzi
Elenco degli autori inseriti nella Rubrica "La Carboneria"
86.Franco Toscani
87.Mario Rondi
88.Çlirim Muça
89.Elio Veltri
90.Alberto Figliolia
91.Dante Maffìa
92.Luigi Marsiglia
93.Noam Chomsky
94.Sergio Azzolari
95.Giuseppe Puma
96.Michele Sangineto
97.Carlo Rovelli
98.Vincenzo Guarracino
99.Giovanna Rosadini
100.Piero Lotito
101.Alice Scialoja (Legambiente)
102.Filippo Gallipoli
103.Medici Senza Frontiere
104.Roberto Cicala
105.Fiorenza Casanova
106.Giorgia Monti (Greenpeace)
107.Christian Eccher
108.Jacopo Gardella
109.Angelo Gaccione
JACOPO GARDELLA
“IDEA DI CITTÀ”
“Idea di città” è espressione che compare
di frequente negli scritti e nelle conversazioni di urbanistica. Molto usata ma
non molto chiara per i meno informati sulla disciplina. Che significa “Idea di
città”? Significa avere in mente due visioni ben distinte: anzitutto come si
configura lo spazio fisico della città; ed in secondo luogo come si organizza
la vita all'interno della città. Per avere una “Idea di città” che non sia una
vuota espressione priva di un contenuto concreto e chiaro, occorrono due
precise condizioni: immaginare l’aspetto con cui la città di presenta alla
nostra vista; conoscere il complesso delle attività che nella città vediamo
esplicarsi. Sarebbe velleitario voler creare la forma spaziale e architettonica
della città senza saper concepire la vita cittadina che in essa si svolge;
sarebbe irreale pensare allo svolgimento della vita cittadina senza acquisire
una visione degli spazi e delle architetture che a quella vita devono dare
accoglienza. I due aspetti che costituiscono la realtà urbana sono
indissolubilmente connessi fra loro; non esiste città senza abitanti e non
esistono abitanti senza città. Nel primo caso si avrebbero gusci vuoti; edifici
deserti; dimore spettrali; nel secondo caso comparirebbero tribù di nomadi,
raggruppamenti instabili, popolazioni mobili, erranti, non radicate a nessuna
terra. La città è uno spazio fisico formato da un insieme di edifici a da una
comunità di cittadini: unità inscindibile di costruzioni e di persone.
Se si vuole proporre una “Idea di città” che non sia
una formula astratta, imprecisa, vaga, occorre avere in mente entrambi questi
concetti, chiarirsi queste idee: una idea della forma edilizia che si desidera
realizzare; ed una idea del modo di vivere che si intende istituire. Occorre
prevedere una struttura urbanistico-architettonica e nello stesso tempo
concepire una organizzazione economico-sociale; entrambe le condizioni sono
interdipendenti e reciprocamente condizionate; ad ogni configurazione urbanistico-architettonica
si adatta e conviene un corrispondente sistema sociale; ad ogni modo di vivere
dei cittadini corrisponde un appropriato
insieme urbanistico-architettonico. In ogni epoca storica la forma delle città
si modifica, si evolve, si adegua alla natura della società e degli abitanti.
Se cambia la costituzione politica della società cambia la struttura spaziale
delle città.
La città dell'Antica Grecia abitata da una società
democratica riservava ai suoi abitanti residenze uniformemente simili ma
metteva in risalto gli edifici di interesse collettivo, sedi delle principali
attività pubbliche: attività politiche che si svolgevano nell'Agorà, luogo
delle Assemblee Popolari; attività religiose che si esplicavano nel Tempio; attività
sportive che si esercitavano nello Stadio; attività culturali che si tenevano
nel Teatro. Tutti questi luoghi erano veramente pubblici cioè aperti a tutto il
popolo e non solo ad una sua parte privilegiata di esso; godevano di una
visibile e chiara collocazione nella planimetria della città; spiccavano con
evidenza all’interno del tessuto urbano (FOTO 1). L’"Idea di città"
sanciva la eguaglianza dei cittadini nella somiglianza delle abitazioni;
riconosceva la dignità del loro Potere nell’emergenza degli edifici pubblici.
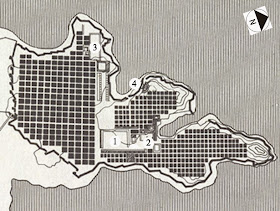 |
| Foto 1 |
Nella Roma Imperiale avvengono radicali mutamenti: i
luoghi collettivi, divenuti gli spazi di esaltazione e celebrazione
dell’Imperatore, denunciano l'avvenuta trasformazione dell’ordinamento
politico. L’“Idea di città” dà visibilità concreta al luogo dove risiede il
Potere e dove avviene la sua celebrazione. L’Agorà democratica si trasforma nel
Foro Imperiale; da luogo di discussione pubblica diventa sede di esaltazione
del Potere, visibile manifestazione dell’autorità assoluta (FOTO 2). Le
abitazioni cessano di essere tutte uniformemente simili e si differenziano in
due categorie nettamente distinte: edifici popolari, o “insule”, abitate da
strati sociali poveri ed ininfluenti; edifici di lusso, o “domus”, occupate da
ceti ricchi e potenti.
 |
| Foto 2 |
Nel Medioevo la città è contrassegnata da due visibili
edifici monumentali. Essi emergono al di sopra del tessuto fitto e compatto
delle case popolari ed accolgono e nello stesso tempo rappresentano le due massime
autorità di governo: da un lato il Castello, sede del potere politico-militare;
dall’altro la Cattedrale, sede del potere politico-religioso. Il tessuto delle
residenze non segue un piano geometrico come avveniva nella città greca; al
contrario si adatta alla conformazione irregolare del terreno su cui sorge la
città e segue la variabile configurazione geografica del posto scelto per la
fondazione. Se collocata in prossimità di un lago la città si sviluppa lungo la
riva del lago; se posata su di un colle la città segue la pendenza del colle;
se posata vicina ad un fiume la città si dimezza ed occupa le due sponde del
fiume. La trama geometrica scelta dalla città greca -in omaggio ad un desiderio
di chiarezza, di regolarità, di ordine- viene sostituita da una conformazione
flessibile ed irregolare, propria di un atteggiamento pratico, disposto ad
accettare la situazione naturale e a modellare la forma della città
conformemente a quella situazione. A Mileto la trama viaria -rigida, uniforme,
ossessivamente ripetuta- si sovrappone ad un terreno movimentato di cui ignora
le irregolarità altimetriche e trascura le articolazioni planimetriche. La
mente dell’urbanista greco impone una visione di assoluta regolarità, sorda ed
indifferente alle particolari conformazioni fisiche che offre la natura del
luogo. Idealista è la città greca così come naturalista o meglio organica è la
città medioevale; dove il termine “organico” indica una similitudine con gli
“organismi” che vivono nel mondo naturale. Come gli organismi viventi si
adattano alle necessità imposte dal sito, dal clima, dalla meteorologia
dell’ambiente in cui abitano, così anche la città medioevale si conforma ai
caratteri geografici, alla natura dell’ambiente, alle particolarità fisiche del
luogo in cui sorge. L’Idea di città che viene realizzata nel Medioevo non è né
democratica né assolutista; è la rappresentazione di una città retta da una
diarchia, cioè governata dal bilanciarsi di due poteri in reciproca condizione
di accordo-disaccordo. La presenza di questi due Poteri viene manifestata
dall’emergere al di sopra dell’uniforme tessuto urbano di due unici ed
emblematici edifici: il Castello e la Cattedrale (FOTO 3).
 |
| Foto 3 |
Nel breve periodo di autonomia politica la città del
Medioevo mantiene la Cattedrale ma sostituisce il Castello con il Palazzo del
Popolo o Palazzo Pubblico (FOTO 4). Nasce la sede del Potere popolare
felicemente adottato dai Liberi Comuni in Italia del Nord; dalle Repubbliche
Marinare nell’Italia meridionale; dalle Città Ansetiche sul Mare Baltico.
Mentre il Potere ecclesiastico rimane immutato, il Potere laico cessa di essere
autoritario e monocratico, cioè concentrato nella persona del Feudatario, e
diventa plebiscitario e democratico, cioè affidato alla Assemblea del Popolo. L’“Idea
di città” afferma e conferma nell’evidenza data all’edificio appartenente al
popolo il Potere demandato a quello stesso popolo. Nella planimetria della
città medioevale resta l'edificio del culto, la Cattedrale, che subentra al
tempio pagano; ma scompare l'Agorà sostituita dal Castello del feudatario;
scompare il luogo dei giochi sportivi, lo Stadio; scompare il luogo delle
recite, il Teatro. Lo sport cambia natura: non è più gara ma diventa
spettacolo; non diversamente dallo spettacolo che offrono oggi alcuni noti
sport di massa. L'agone sportivo dei tornei cavallereschi si svolge nella
piazza principale della città; così come ancora oggi in Piazza del Campo a
Siena si disputa il Palio cittadino. La recita cambia aspetto: non più tragedia
di uomini ma rappresentazione di parabole evangeliche e di avvenimenti biblici;
le rappresentazioni si tengono davanti al sagrato delle principali chiese
cittadine. La vita religiosa sostanzia il mondo medioevale e ne impronta tutte
le manifestazioni civili. I grandi avvenimenti popolari, quando non sono
politici o religiosi, occupano gli spazi pubblici della città; le cortine
edilizie che circondano questi spazi diventano l'involucro e la cornice
destinati ad accoglie le feste del
popolo. Tutto cambia quando dal Medioevo si passa al Rinascimento. Il Teatro
ricompare non più come edificio urbano ma come salone situato dentro al Palazzo
del Signore. Il Teatro Farnese a Parma ne è uno degli esempi più noti. Chi fa
uso del Teatro è il seguito di cortigiani che sta intorno al Principe; non è la
gente del popolo esclusa e tenuta lontana. Nel passaggio dal Rinascimento
all'epoca delle monarchie assolute il Teatro viene inglobato nella Reggia del
Re e riservato al Sovrano ed alla sua corte; al popolo continua ad essere negato
l'accesso. Occorre arrivare all'Età dell'Illuminismo e al periodo che segue la
Rivoluzione Francese per tornare ad avere un edificio teatrale aperto ad un
pubblico popolare, anche se gli spettatori erano rigidamente divisi per classi
sociali, così come lo era la città borghese nel corso del secolo XIX. Mentre
nei teatri greci o nei luoghi destinati agli spettacoli medioevali questa
divisione non esisteva, essa nel teatro borghese era meticolosamente osservata:
la gente comune rimaneva in platea, le famiglie aristocratiche si distribuivano
nei palchi; il Sovrano ed il suo seguito occupavano il palco reale.
 |
| Foto 4 |
Quale è l’"Idea di città" che si concretizza
in epoca barocca? Qual è immagine urbana che viene concepita per la capitale di
un Potere assoluto? Una immagine centripeta; un fascio di raggi convergenti
verso un centro unico e monumentale. La trama viaria della città viene
orientata e diretta verso quel centro, così come la popolazione della città si
rivolge e si assoggetta a chi in quel centro risiede. L’esempio più noto di
città assolutista è dato dalla Reggia di Versailles: verso la Reggia convergono
i tre principali viali dell'unico accesso; di fronte alla Reggia si arrestano e
si inchinano i cittadini-sudditi dell'intera nazione (FOTO 5). A differenza dei
Fori imperiali di Roma antica, circondati dalla popolazione cittadina e
bisognosi di grandi folle per esibire la loro potenza ed il loro splendore, le
Reggia di Versailles si allontana e si tiene distante dal centro abitato; fa
capire che della popolazione non sente il bisogno, può fare a meno, non intende
servirsi. Tutte le funzioni dello Stato sono concentrate e riunite nella
Reggia, alla capitale non viene concessa nessuna partecipazione al governo
dello Stato. Nella “Idea di città” concepita dalla monarchia assoluta la
planimetria urbana, da qualsiasi luogo si provenga, indica la unica direzione
in cui muoversi per raggiungere la sede del Potere.
 |
| Foto 5 |
Un analogo schema urbano ha guidato la costruzione
della città di San Pietroburgo, dove le tre principali arterie cittadine
convergono sul Palazzo dell’Ammiragliato, sede del potere civile e militare
(FOTO 6). In uno stato monocratico la città si configura e si modella sulla
natura propria di quello Stato: in un unico Potere è concentrato il privilegio
di comandare, ad un unico potere si ha il dovere di ubbidire. La raggiera di
assi viari che si dipartono dalla sede dello Zar rappresentano simbolicamente
la volontà imposta a tutta la nazione; la stessa raggiera che converge verso la
sede dello Zar rappresenta altrettanto simbolicamente la sottomissione che
viene accettata da tutta la nazione.
 |
| Foto 6 |
Molto prima di Versailles e di San Pietroburgo un
medesimo schema a tre assi convergenti è stato realizzato a Roma nella
monumentale Piazza del Popolo: le tre vie che in essa confluiscono sono dirette
verso il fulcro della composizione, l’alto obelisco egiziano posto al centro
della piazza. Alle spalle dell'obelisco la piazza è chiusa delle due facciate
identiche di S. Maria del Popolo e del Convento degli Agostiniani: due edifici
religiosi che rispecchiamo l’assolutismo del potere confessionale (FOTO 7).
 |
| Foto 7 |
Un esempio di impianto urbano preso a prestito
dall'Idea di città autoritaria lo si trova anche a Milano là dove tre larghe
vie si dirigono e convergono verso lo slargo di Piazza Piemonte.
Nell’intenzione di imitare un impianto autoritario ci si è dimenticati di
assegnare un perno a tutta la composizione e si è trascurato il fulcro
generatore dei tre assi convergenti. Invece del cortile d’onore che precede la
Reggia di Versailles, invece della guglia dorata che sormonta l'Ammiragliato di
San Pietroburgo, invece dell’obelisco che si eleva in Piazza del Popolo, a
Milano si presenta la anonima distesa di Piazza Piemonte, priva di un perimetro
esattamente definito, povera di edifici sufficientemente monumentali (FOTO 8).
Ai due pregevoli palazzi in stile Decò, posti nei vertici delle tre strade, non
corrisponde sul lato opposto della piazza né un palazzo né un monumento di
adeguata importanza. I tre assi viari muoiono nel vuoto, mancano di un visibile
punto di convergenza. Gli architetti milanesi hanno imitato lo schema
urbanistico offerto delle più note capitali europee, ma lo hanno assunto
frettolosamente senza capirne la funzione simbolica e rappresentativa. L’“Idea
di città” adottata a Milano è una infelice imitazione di schemi ormai superati
e anacronistici.
 |
| Foto 8 |
Con criteri del tutto contrari è stata progettata la
capitale degli Stati Uniti d’America, la città di Washington (FOTO 9). La città
nasce in un clima di libera democrazia, di democrazia borghese e non popolare.
Pur adottando un impianto barocco, formato da grandi arterie rettilinee, da
viali monumentali, da assi prospettici imponenti, la capitale Washington non
rientra nello schema delle città barocche, non ha nessuna analogia con le città
dell’Assolutismo, non presenta nessuna affinità con un impianto autoritario. Le
arterie principali dalla città non convergono su di un solo luogo, centro di un
Potere assoluto, ma si dirigono verso più luoghi distinti e separati, sedi
delle maggiori Istituzioni pubbliche: il Campidoglio, sede del Parlamento; la
Casa Bianca, dimora del Capo dello Stato; la Biblioteca Nazionale, tempio della
Cultura; il Parco Lincoln, memoria del Presidente che pose fine alla schiavitù.
La forma della città rispecchia la costituzione dello Stato. Le sedi dei
massimi organi statali (Camere, Presidenza, Alta Corte di Giustizia) pur
essendo distaccate e distinte non si presentano appartate ed isolate, ma sono
messe in reciproca connessione da grandi assi viari che convergono su di loro;
allo stesso modo i Poteri fondamentali della Stato (legislativo, esecutivo,
giudiziario), pur restando autonomi ed indipendenti non operano scissi e
staccati, ma si mantengono in stretta correlazione attraverso una rete di
controlli incrociati saggiamente previsti dalla Costituzione. La distribuzione
dei Palazzi del Governo all''interno della capitale corrisponde alla divisione
dei Poteri all'interno dello Stato; la connessione viaria tra i vari Palazzi
riflette la integrazione bilanciata dei vari Poteri. La “Ideologia di città”
formata da più centri collegati rispecchia la costituzione di uno Stato fondata
su più poteri coordinati.
 |
| Foto 9 |
Nella città dell’Ottocento, nata con l’affermarsi della
classe borghese, si attua la separazione fra quartieri ricchi abitati da ceti
benestanti e quartieri poveri occupati di classi indigenti. La precedente
storia urbanistica non aveva mai registrato una divisione di censo così netta e
marcata, una emarginazione così evidente e visibile: i palazzi dei signori, le
dimore dei ricchi, le residenze di lusso sorgevano vicino alle abitazioni dei
poveri, di fianco alle costruzioni popolari. Lungo una stessa via il maestoso
Palazzo aristocratico era preceduto, seguito, fiancheggiato dalle case della
gente comune. Qualunque fosse la forma di governo, non importa se democratico o
assolutista, non esisteva nella città del passato il pregiudizio classista, non
si verificava una deliberata suddivisione della città in quartieri ricchi e
quartieri poveri. Il ricco si chiudeva nel suo palazzo, creava la sua corte,
abbelliva ed arricchiva la sua dimora, ma non pensava di appartarsi e di
rinchiudersi in un quartiere isolato, appartato, abitato esclusivamente da
persone ricche come lui. Vi sono, è
vero, alcune eccezioni che precedono la nascita della città borghese
ottocentesca. Una di queste, notata dallo storico contemporaneo Ennio Poleggi,
è la via Nuova, oggi via Garibaldi, che attraversa il centro di Genova e che
nasce nel corso del XVI secolo in seguito ad una iniziativa edilizia concepita
ad esclusivo uso di una classe aristocratica e ricca (FOTO 10). La via,
fiancheggiata su entrambi i lati da lussuosi palazzi nobiliari, dà vita ad un
percorso trionfale, ad una parata di dimore affiancate le une alle altre e tutte monumentali.
 |
| Foto 10 |
La città borghese, che si è espressa nella suddivisione
classista dei quartieri e nella separazione di zone abitate da soli ricchi o da
soli poveri, si è oggi rapidamente evoluta (o meglio involuta) ed è diventata
la città neo-capitalista al cui interno il costo stratosferico delle residenze
non lascia più posto per le classi popolari. Gli abitanti meno abbienti vengono
allontanati ed espulsi dal centro della città e fatti dirottare nel territorio
circostante. L'"Idea di città" neocapitalistica privilegia il Potere
del denaro ed ignora il valore insito in una comunità unita ed integrata, e
nello stesso tempo al suo interno varia e diversificata. Il centro storico
della città neocapitalista, espulsa la popolazione originaria, si riempie di un
nuovo tessuto sociale. Milano non cambia solo la pelle, il volto della sua
edilizia; perde anche l'anima, la sostanza del suo popolo. Privato dei
tradizionali residenti storici l'antico cuore della città si atrofizza e muore.
Di giorno la città è frenetica, di notte spopolata.
Di qualunque tipo fosse la città -o democratica o
autoritaria o borghese- la sua configurazione edilizia era costantemente
formata da strade, piazze, viali, ossia da spazi aperti delimitati da
costruzioni allineate e continue. Per secoli la maglia viaria della città,
sebbene con trame di volta in volta diverse, e con volti architettonici rinnovati
ripetutamente, è rimasta una maglia sostanzialmente stabile, una successione di
spazi aperti delimitati da cortine ininterrotte di case. Strade, piazze, viali
portavano assumere tracciati difformi, potevano esibire architetture diverse,
ma erano sempre riconoscibili come strade, come piazze, come viali: le strade
si presentavano rettilinee o in curva, le piazze quadrate o circolari, i viali
alberati o recintati, ma sempre questi elementi costitutivi della città erano
delimitati da cortine edilizie continue, da edifici disposti in successione, da
caseggiati allineati lungo entrambi i margini della via.
Se adesso guardiamo i quartieri costruiti nella seconda
metà del XX secolo o nella prima decade del XXI restiamo sorpresi e stupiti:
sono scomparse le strade, mancano le piazze, sono assenti i viali, non si
vedono più incroci. Gli elementi costitutivi della urbanistica conservatisi
stabili per secoli - sebbene attraverso i secoli manifestatisi in forme di
volta in volta diverse - sono oggi irreperibili nei complessi urbani di nuova
costruzione, sono scomparsi dalla città contemporanea. Non esistono più strade,
ma volumi dispersi disordinatamente; non più piazze ma vuoti senza forma; non
più viali, né incroci stradali, né vie rettilinee o curve, ma soltanto percorsi
per auto tracciati con libertà tra volumi edilizi sparsi e disuniti. La città
moderna si disgrega, si frantuma, si trasforma in un ammasso disordinato di
costruzioni disarmoniche. È diventata un accostamento di singoli fabbricati:
isolati, distaccati, separati gli uni dagli altri (FOTO 11). L’“Idea di città”
riferita ad una forma così disintegrata ha origini lontane e parte da premesse
non tanto architettoniche quanto scientifiche; o meglio trae origine da una
applicazione del metodo scientifico distorta e falsa. L’“Idea di città” non più
legata alla tradizione, non più derivata da precedenti modelli storici, risale
al positivismo ottocentesco; è figlia di uno scientismo diventato imperante a
partire dalla metà del secolo XIX. La esaltazione della scienza e delle sue
applicazioni, le entusiasmanti promesse fatte sperare dal progresso scientifico
invitano a favorire processi mentali analitici e a vedere in essi i soli metodi
obiettivi e sicuri per risolvere i problemi dell’Universo. I processi analitici
per definizione distinguono, circoscrivono, isolano. Il metodo scientifico per
necessità scompone la realtà e la studia in sezioni accuratamente separate;
soltanto così la Scienza può trovare fra le possibili cause del fenomeno l’unica
risposta che sia certa e vera. Il carattere analitico proprio del metodo
scientifico e la fiducia salvifica riposta nella scienza inducono il pensiero
contemporaneo a concepire la realtà e a rappresentarla sotto forma di elementi
distinti, di processi separati, di componenti singoli isolati ed indipendenti. Non
sorprende che anche l'attuale pensiero urbanistico concepisca la città e la
rappresenti composta da volumi singoli, da corpi di fabbrica distinti, da
porzioni tra loro isolate ed indipendenti. In un mondo dominato dalla scienza e
dalle sue applicazioni tecniche, la “Idea di città” contemporanea è una visione
di più volumi separati non di un organismo unico e integrato; è la figura di
uno spazio riempito di atomi non di un ambiente coordinato ed unitario.
 |
| Foto 11 |
Un esempio lampante di dissoluzione delle città
tradizionali è offerto oggi a Milano da due recenti realizzazioni immobiliari:
il quartiere della Fiera Campionaria e il quartiere di Porta Garibaldi. Due
interventi urbani sconcertanti; due tristi esempi di incongruenza e di
irrazionalità; eppure due realizzazioni concordemente apprezzate tanto da
maggioranze di critici esperti quanto da folle di comuni osservatori. Il gusto
estetico della gente si è palesemente modificato (o meglio è degenerato).
Nessuno avverte più la sostanziale differenza fra il gelido, asettico,
scostante spazio di Piazza Aulenti (FOTO 12), inaugurata di recente, e la
accogliente, affettuosa, invitante atmosfera di tanti luoghi storici
distribuiti nella nostra città: piazzette di S. Sepolcro, di S. Alessandro
(FOTO 13), dei Mercanti, dei Borromeo.
 |
| Foto 12 |
 |
| Foto 13 |
Camminando ai piedi di lucenti ed alti grattacieli
-ricoperti di vetro, alluminio, plastica, acciaio- ci sentiamo smarriti,
angosciati, annichiliti; mentre se ci muoviamo tra le facciate di intonaco
delle basse costruzioni tradizionali respiriamo un'aria confidenziale,
benevola, rassicurante. Perché l’architettura di oggi, pur usando forme nuove,
non è capace di ricreare lo stesso clima accogliente offertoci dalle città
antiche? Perché l’urbanistica attuale, pur adeguandosi alle nuove necessità,
non sa riproporre le stesse composizioni spaziali, le uguali visuali
prospettiche, i medesimi rapporti proporzionali riscontrabili nelle città del
passato? La risposta è pronta ed immediata: perché oggi manca una "Idea di
città". Manca la fantasia capace di immaginare una avvincente forma fisica
della città, manca la volontà disposta a proporre per la città una sana
organizzazione di vita. Una "Idea di città" non è soltanto un insieme
di costruzioni, un agglomerato di case; è anche una concezione di vita
collettiva, una promozione di rapporti sociali. La città può essere immaginata
in modi tra loro radicalmente diversi: può essere formata da edifici in
prevalenza alti oppure da edifici preferibilmente bassi; può servirsi di
veicoli in maggioranza privati oppure di trasporti prevalentemente pubblici;
può contenere vaste e distanziate zone di parco oppure piccole e ravvicinate
aree di giardino; può apparire densa e fittamente costruita, oppure dispersa e
molto diradata; può essere ricca di verde oppure interamente occupata da
costruzioni; può presentarsi suddivisa in centri urbani secondari, oppure
estendersi uniforme, compatta, continua. Ognuna di queste scelte è legittima,
anche se non tutte sono di equivalente valore culturale. Tuttavia ognuna, per
essere soddisfacente, deve potersi realizzare in modo pieno e completo. L'esito
peggiore, la soluzione più infelice è la operazione interrotta a metà; il
progetto lasciato incompiuto; la visione perseguita con poca convinzione e
senza determinazione. La vera sfortuna di una città è la incapacità tecnica di
prefigurare uno scenario di spazi e di architetture ordinate e funzionali; è la
impreparazione politica ad organizzare una vita cittadina che sia armonica,
appagante, gradita. Questa sfortuna è la causa del degrado di Milano; è
all'origine della sua decadenza. La città è orfana tuttora di programmi di
sviluppo, priva di rigorosi limiti demografici, incapace di prevedere una crescita
equilibrata e graduale, carente di una visione lungimirante che ne regoli e
disciplini la espansione sul territorio.
Sotto l'aspetto della planivolumetria non esiste nessun piano di crescita concepito con chiarezza e proiettato a lunga scadenza. Milano si ingrandisce seguendo direzioni casuali e disordinate; una volta si allarga verso sud (Quartiere incompiuto di San Felice), una volta verso ovest (complesso in costruzione della Nuova Fiera), una volta verso nord (probabile lottizzazione dello Scalo Farini). Nonostante la condanna che da decenni i migliori urbanisti stanno rivolgendo allo sviluppo urbano definito “a macchia d’olio”, Milano continua imperterrita a crescere “a macchia d’olio”; ad allargarsi incessantemente in tutte le direzioni; ad ampliare progressivamente il suo perimetro; a sottrarre inesorabilmente terreni agricoli alla campagna per convertirli in aree di densa edificazione. Anche il Parco Agricolo Sud, magnifica iniziativa ambientale volta a salvaguardare l’unica fascia di territorio non ancora contaminata da lottizzazioni disordinate ed eterogenee, è seriamente minacciato da un progetto di espansione subdolo e pericoloso, destinato in futuro a diventare un brutto precedente difficile da contenere ed arrestare. Il centro medico IEO, situato ai margini del parco Agricolo nella periferia sud della città, prevede di ingrandirsi e di occupare estese porzioni di terra da coltivo. Sarà difficile in futuro, una volta realizzato l’ampliamento della rinomata Istituzione Sanitaria, impedire ulteriori espansioni urbane, fermare nuovi nuclei edilizi, vietare altri agglomerati di cemento; sarà quasi impossibile salvaguardare la ampia zona di verde oggi ancora tenacemente difesa e protetta alle porte di Milano.
Sotto l'aspetto della planivolumetria non esiste nessun piano di crescita concepito con chiarezza e proiettato a lunga scadenza. Milano si ingrandisce seguendo direzioni casuali e disordinate; una volta si allarga verso sud (Quartiere incompiuto di San Felice), una volta verso ovest (complesso in costruzione della Nuova Fiera), una volta verso nord (probabile lottizzazione dello Scalo Farini). Nonostante la condanna che da decenni i migliori urbanisti stanno rivolgendo allo sviluppo urbano definito “a macchia d’olio”, Milano continua imperterrita a crescere “a macchia d’olio”; ad allargarsi incessantemente in tutte le direzioni; ad ampliare progressivamente il suo perimetro; a sottrarre inesorabilmente terreni agricoli alla campagna per convertirli in aree di densa edificazione. Anche il Parco Agricolo Sud, magnifica iniziativa ambientale volta a salvaguardare l’unica fascia di territorio non ancora contaminata da lottizzazioni disordinate ed eterogenee, è seriamente minacciato da un progetto di espansione subdolo e pericoloso, destinato in futuro a diventare un brutto precedente difficile da contenere ed arrestare. Il centro medico IEO, situato ai margini del parco Agricolo nella periferia sud della città, prevede di ingrandirsi e di occupare estese porzioni di terra da coltivo. Sarà difficile in futuro, una volta realizzato l’ampliamento della rinomata Istituzione Sanitaria, impedire ulteriori espansioni urbane, fermare nuovi nuclei edilizi, vietare altri agglomerati di cemento; sarà quasi impossibile salvaguardare la ampia zona di verde oggi ancora tenacemente difesa e protetta alle porte di Milano.
Sempre sotto l'aspetto della forma urbana ci si domanda
quale figura architettonica, quale volto edilizio, quale struttura spaziale gli
amministratori abbiano deciso di adottare e di attuare. Desiderano avere una
città fatta di alti condomini? Di vertiginosi grattacieli? Di aree pubbliche
informi ottenute come superfici di risulta, ossia come zone residue fra un
volume costruito e l’altro? Il Piano Regolatore Generale recentemente approvato
e pomposamente denominato “Piano di Governo del Territorio” non dà nessuna
indicazione sullo sviluppo edilizio della città: non specifica dove essa debba
allargarsi, in che direzione espandersi, quali dimensioni assumere; e non
fornisce nessuna previsione sulla crescita socio-economica della popolazione:
quale tipo di industrie promuovere, come organizzare i servizi urbani, dove
dislocare le nuove attività, quali limiti imporre alla crescita demografica. La
stessa denominazione “Piano di Governo del Territorio”, che sostituisce la
precedente denominazione “Piano Regolatore Generale”, è una formula poco
chiara, distorta, non appropriata; ed induce a malintesi e confusioni. Come ci
illustra l’affresco gotico di Ambrogio Lorenzetti nel Palazzo Pubblico di Siena
il Governo può essere cattivo o buono a seconda delle Regole che vengono
applicate; sono le Regole e ciò che esse impongono la vera e unica garanzia
capace di assicurare il rispetto delle leggi e di attuare il pensiero del
legislatore. La espressione “Piano Regolatore”, che significa “Piano delle
Regole”, implica certezza, obiettività, chiarezza, ed evita interpretazioni
incerte o equivoche. Al contrario la espressione “Piano di Governo” lascia
adito a molteplici e contrastanti applicazioni normative e non offre nessuna
garanzia di imparzialità. Soltanto quando esistono Regole certe e buone il
Governo sarà sano e stabile. Una ulteriore confusione lessicale, un’altra
imprecisione linguistica è contenuta nella parola “territorio”: essa indica
infatti sia l’area urbana propria della città sia l'area extra-urbana estesa
nei dintorni; e comprende sia la superficie costruita sia la distesa di campi
coltivati. Lo strumento urbanistico recentemente emanato e denominato “Piano di
Governo del Territorio” si limita a considerare l’area cittadina e non prende
in esame l’area della fascia extra-urbana. Così facendo il tanto esaltato Piano
del Territorio non contempla ciò che per convenzione si intende per Territorio,
non prende in esame l’estensione inedificata posta nei dintorni e al di fuori
del perimetro costruito. È un Piano mendace; un piano che si definisce del
Territorio ma che in realtà non si estende all’intero Territorio; copre le aree
urbane non le aree extra-urbane; disciplina il tessuto già costruito non la
campagna intatta e non ancora deturpata da lottizzazioni.
Si usa attribuire all’avidità dei costruttori la colpa
della crescita caotica, sregolata, selvaggia che ha deturpato la tradizionale
fisionomia di Milano. La vera colpa in realtà è da attribuire ai politici
Amministratori; a chi è responsabile dello sviluppo urbano; a chi ha il dovere
di padroneggiare ed incanalare nella giusta direzione le molteplici iniziative
private. E’ triste constatare che né le passate giunte di destra, né l’attuale
giunta di sinistra siano state capaci di formulare per la loro città un
programma di larghe ed illuminate vedute urbanistiche. L’Ente Pubblico, che
avrebbe il potere di contenere le spinte speculative e gli interessi dei
privati, rimane del tutto assente, muto, immobile. O per incapacità o per
connivenza il Comune non interviene e non indirizza la produzione edilizia
secondo criteri studiati ed approfonditi; non la controlla, non la guida, non
la contiene. La subisce, accondiscendente. La tollera, complice. La favorisce,
colpevole. Eppure nessuno chiede al Comune di ostacolare la attività di
imprenditori e di costruttori; attività di per sé benefica e salutare,
indispensabile per garantire la vita della città, per favorire la crescita
della popolazione, per offrire continue e molteplici occasioni di lavoro. Al
Comune si chiede soltanto (ma non è richiesta di poco conto) che quella in sé
benefica attività edilizia sia regolamentata e diretta verso gli obiettivi
indicati dagli strumenti urbanistici, purché tali strumenti siano redatti
nell’interesse della collettività e non soltanto a vantaggio di alcune
categorie privilegiate.
Colpevoli i politici e gli amministratori pubblici, ma
altrettanto colpevoli i committenti ed i finanziatori privati. In tempi passati
il Principe – che era contemporaneamente uomo politico, amministratore,
committente e finanziatore – sapeva a chi rivolgersi, conosceva da chi
servirsi, capiva quali erano i fornitori e gli artisti migliori. Lorenzo il
Magnifico non si faceva ritrarre dall’ultimo imbrattatele; sceglieva il maestro
Botticelli. In tempi passati Cultura e Potere procedevano insieme. Oggi sono
scissi, lontani, ostili. La Cultura è senza Potere, il Potere è senza Cultura.
Quanti hanno scelto di realizzare il progetto “City Life” sul terreno della
Fiera Campionaria, hanno preferito anteporre un gretto calcolo economico alla
qualità dei progetti presentati; hanno dato il premio al concorrente peggiore
ignorando ed escludendo la soluzione giudicata di maggiore pregio da parte dei
critici più seri. Quanti hanno commissionato e finanziato la carcassa metallica
accartocciata sul tetto della Nuova Fiera Campionaria possiedono denaro ma sono
privi di gusto, di sensibilità, di istruzione. Sono anche pessimi uomini
d’affari perché per un’opera che non è degna di accogliere dignitosamente chi
arriva ed entra in Milano (FOTO 14) sono disposti a pagare al progettista
parcelle salate e saldare al costruttore fatture costosissime.
 |
| Foto 14 |
Alcune realizzazioni ultimate di recente sono
sufficienti a dimostrare la mancanza di una visione urbana chiara, lucida,
illuminata. Il complesso di Porta Garibaldi, trasformato oggi in un campionario
di grattacieli incoerenti e discordanti, se fosse stato progettato con
competenza e lungimiranza, avrebbe potuto svilupparsi intorno ad un imponente
asse cittadino. Tracciato sul prolungamento di viale Tunisia, e fatto terminare
contro l’edificio moderno della Stazione Garibaldi, questo asse urbano avrebbe
introdotto nell’area rimasta fino ad oggi semiabbandonata un percorso stradale
facilmente identificabile, un tracciato ordinatore di grande efficacia
scenografica. Niente di tutto ciò è stato né pensato né realizzato. Il
complesso di alti ed eterogenei fabbricati collocati disordinatamente
sull’area; il tracciato confuso e poco percepibile di strade in superficie o in
sottopasso; la stessa stazione ferroviaria interamente occultata ed emarginata
mentre avrebbe potuto diventare un decoroso fondale prospettico; gli esigui
lacerti e i miseri frammenti del poco verde superstite, pomposamente presentati
come parco sopraelevato; in conclusione tutto il complesso di Porta Garibaldi
può considerarsi un esempio di cattiva visione urbanistica, di pessima
progettazione urbana, di disegno cittadino pieno di presunzione ma povero di
idee (FOTO 15). La via di scorrimento veloce che oggi attraversa il complesso
di Porta Garibaldi nell'avvicinarsi alla Stazione Ferroviaria si abbassa
progressivamente di quota, fino a sprofondare e scomparire dentro una lunga
galleria sotterranea. Si può dire perciò che l’asse portante di tutto
l’intervento invece di rimanere ben visibile e facilmente percepibile ha scelto
di sottrarsi alla vista, di nascondersi, di fare naufragio: naufragio in senso
letterale se riferito all’inabissarsi della strada, naufragio in senso
metaforico se confrontato con la auspicata occasione urbanistica
irrimediabilmente perduta.
 |
| Foto 15 |
Come manca per Milano una idea spaziale della città,
una visione della forma che si vuole dare allo spazio fisico in cui si vive
allo stesso modo manca una concezione di come organizzare la vita nella città,
di come fornire una gamma di servizi pubblici essenziali per una comunità
attiva e numerosa. Viabilità e trasporti, cultura ed istruzione, verde e
ricreazione, sono servizi primari, basilari, irrinunciabili eppure non ancora
adeguatamente predisposti e messi in funzione. In una grande città è necessità
fondamentale poter usufruire di un sistema di trasporti sicuro ed efficiente;
ma per realizzarlo occorre anzitutto fare una scelta preliminare e risolutiva:
decidere se sviluppare il trasporto pubblico o se favorire il trasporto
privato. La scelta non è né secondaria né indifferente: il trasporto pubblico
esige un certo tipo di investimenti, quello privato investimenti del tutto
opposti. Milano non ha sputo scegliere né per l’una né per l’altra soluzione:
da un lato fornisce un trasporto pubblico indegno di una metropoli europea (il
confronto con grandi capitali come Londra, Parigi, Vienna, è sufficiente a
rivelare le imperdonabili carenze dei mezzi pubblici milanesi), dall’altro lato
non offre al trasporto privato necessarie attrezzature ed adeguate
infrastrutture. Per poter usufruire di un buon trasporto pubblico occorre che
esso consenta di raggiungere senza esclusioni né omissioni tutti i luoghi della
città: la rete metropolitana milanese, la MM, non copre neanche un terzo
dell’area che dovrebbe servire; lascia privi di servizio larghe e numerose zone
del territorio urbano; offre a tutt’oggi soltanto scarse e insufficienti linee
sotterranee, mentre si sa che per raggiungere tutti i punti della città le
linee dovrebbero essere almeno dieci volte più numerose. Purtroppo le linee
esistenti non solo sono insufficienti , sono anche sotto-utilizzate. La carenza
di una rete completa, la mancanza di un servizio che sia esteso capillarmente
all’intera area urbana è un inconveniente molto più dannoso di quanto non possa
sembrare perché assomma due gravi e contemporanei svantaggi: da un lato le
linee mancanti sono un danno per tutte le zone della città che da quelle linee
non sono ancora servite; dall’altro lato le linee mancanti riducono e
compromettono l’uso e la potenzialità delle linee già esistenti; queste infatti
non possono essere impiegate come percorsi di transito intermedio
indispensabile per raggiungere altre linee della rete, proprio quelle tuttora
mancanti. Una persona priva di un braccio è molto più invalida di quanto non
appaia; il braccio mancante non solo rende impossibili tutti i movimenti
compiuti da quel braccio, ma impedisce anche tutti i movimenti che per essere
eseguiti richiedono l’uso dei due bracci impiegati insieme e
contemporaneamente.
A Milano il servizio di tram e di autobus ha una frequenza esasperatamente bassa; durante l’orario di lavoro si è costretti ad attendere parecchi minuti fra una corsa e l’altra: nelle capitali europee il tempo massimo di attesa non supera i pochi minuti. Gli orari notturni sono eccessivamente diradati; usare il trasporto pubblico dopo l’ora di cena significa rassegnarsi a lunghe attese sia alle fermate di superficie sia nelle stazioni delle linee sotterranee. Potenziare il trasporto pubblico significa prevedere investimenti non trascurabili; significa impiegare le risorse cittadine in quantità consistente e per periodi di lunga durata. La fornitura di nuove vetture, l’assunzione di nuovo personale, la costruzione di nuove infrastrutture sono tutte operazioni impegnative che incidono pesantemente sulle finanze della Municipalità. Occorre prevedere un piano di lunga scadenza; progettare tempestivamente le operazioni tecniche, programmare preventivamente le risorse finanziarie. Si è mai visto da parte del Comune di Milano affrontare seriamente questo compito così vasto ed impegnativo? Si è mai udito che gli uffici tecnici comunali abbiano iniziato un progetto completo ed esaustivo che contempli il futuro trasporto pubblico sia urbano che extraurbano? Si è mai venuti a conoscenza di un grafico esplicativo che indichi luoghi, tempi, finanziamenti necessari a realizzare le prossime linee di trasporto metropolitano? Ogni tanto occasionalmente e inaspettatamente si viene a sapere che è stata decisa la costruzione di un nuovo tronco di ferrovia sotterranea; un tronco denominato con colori vivaci e brillanti (viola, arancione, blu); ma difficile da inquadrare in quel piano generale di trasporti che a tutt’oggi è ancora mancante. Le aggiunte dei nuovi tratti di metropolitana sembrano calate casualmente dall’alto, senza un quadro di riferimento complessivo, senza una visione del trasporto cittadino prevista a lunga scadenza ed estesa a tutto il territorio. Ne consegue che alcune nuove linee vengono iniziate e poi interrotte, e lasciate incompiute per mancanza di finanziamenti adeguati. Manca una “Idea di città”, manca una previsione globale di quale debba essere il futuro sistema dei trasporti. Come in un organismo vivente la circolazione sanguigna è condizione primaria di sopravvivenza, così in un organismo urbano il movimento dei veicoli è premessa imprescindibile di funzionalità. Fermare il flusso del sangue significa la morte; non garantire il movimento dei veicoli provoca la paralisi.
A Milano il servizio di tram e di autobus ha una frequenza esasperatamente bassa; durante l’orario di lavoro si è costretti ad attendere parecchi minuti fra una corsa e l’altra: nelle capitali europee il tempo massimo di attesa non supera i pochi minuti. Gli orari notturni sono eccessivamente diradati; usare il trasporto pubblico dopo l’ora di cena significa rassegnarsi a lunghe attese sia alle fermate di superficie sia nelle stazioni delle linee sotterranee. Potenziare il trasporto pubblico significa prevedere investimenti non trascurabili; significa impiegare le risorse cittadine in quantità consistente e per periodi di lunga durata. La fornitura di nuove vetture, l’assunzione di nuovo personale, la costruzione di nuove infrastrutture sono tutte operazioni impegnative che incidono pesantemente sulle finanze della Municipalità. Occorre prevedere un piano di lunga scadenza; progettare tempestivamente le operazioni tecniche, programmare preventivamente le risorse finanziarie. Si è mai visto da parte del Comune di Milano affrontare seriamente questo compito così vasto ed impegnativo? Si è mai udito che gli uffici tecnici comunali abbiano iniziato un progetto completo ed esaustivo che contempli il futuro trasporto pubblico sia urbano che extraurbano? Si è mai venuti a conoscenza di un grafico esplicativo che indichi luoghi, tempi, finanziamenti necessari a realizzare le prossime linee di trasporto metropolitano? Ogni tanto occasionalmente e inaspettatamente si viene a sapere che è stata decisa la costruzione di un nuovo tronco di ferrovia sotterranea; un tronco denominato con colori vivaci e brillanti (viola, arancione, blu); ma difficile da inquadrare in quel piano generale di trasporti che a tutt’oggi è ancora mancante. Le aggiunte dei nuovi tratti di metropolitana sembrano calate casualmente dall’alto, senza un quadro di riferimento complessivo, senza una visione del trasporto cittadino prevista a lunga scadenza ed estesa a tutto il territorio. Ne consegue che alcune nuove linee vengono iniziate e poi interrotte, e lasciate incompiute per mancanza di finanziamenti adeguati. Manca una “Idea di città”, manca una previsione globale di quale debba essere il futuro sistema dei trasporti. Come in un organismo vivente la circolazione sanguigna è condizione primaria di sopravvivenza, così in un organismo urbano il movimento dei veicoli è premessa imprescindibile di funzionalità. Fermare il flusso del sangue significa la morte; non garantire il movimento dei veicoli provoca la paralisi.
Se invece di adeguare e potenziare il trasporto
pubblico il Comune decide di facilitare il trasporto privato, come avviene in
alcune città degli Stati Uniti e in particolare nella megalopoli di Los
Angeles, in tal caso gli investimenti comunali devono avere obiettivi del tutto
diversi; il danaro servirebbe non più a fornire nuove vetture, nuovo personale,
nuove attrezzature logistiche, ma a realizzare nuove arterie autostradali,
nuovi parcheggi a rotazione, nuove gallerie in sotto e sovrappasso, nuovi
percorsi di scorrimento veloce. Al momento attuale il Comune di Milano, così
come è carente nell’adeguare il trasporto pubblico, è anche inadempiente nel
facilitare il trasporto privato. Le deficienze sono gravi e numerose: semafori
poco coordinati e spesso mal temporizzati; durata delle luci troppo breve o
troppo prolungata; corsie ostruite da auto in sosta e quindi poco scorrevoli;
parcheggi in numero insufficiente e male distribuiti; incroci a più livelli
carenti o inesistenti; mancanza di un servizio stabile e permanente di polizia
urbana; come se il vigile, ora che il funzionamento dei semafori è tutto
meccanizzato, non abbia anche il compito di ammonire e multare i trasgressori,
di sorvegliare il flusso degli automezzi, di intervenire in casi di ingorgo; di
fornire chiarimenti a chi chiede informazioni; di dare aiuto ad anziani
insicuri o ad invalidi menomati quando devono attraversare pericolosi incroci
stradali.
La scelta fra adeguamento del trasporto pubblico oppure
facilitazione del trasporto privato è una scelta irreversibile e definitiva.
Una scelta che impegna, vincola, condiziona il futuro delle città; e che non
ammette alternative perché la realizzazione contemporanea dei due tipi di
trasporto non è né concepibile né attuabile sia per ragioni costruttive sia per
ragioni economiche: le opere e le infrastrutture necessarie ad un tipo di
trasporto sono di ordine particolare e specifico e quindi non usufruibili
dall’altro tipo; i finanziamenti necessari ad un tipo di trasporto esauriscono
le riserve di bilancio e quindi non restano disponibili per l’altro tipo.
Il traffico urbano è strettamente connesso con il
traffico extra-urbano. Non si risolve l’uno senza risolvere contemporaneamente
anche l’altro. Il tratto di autostrada compreso tra il casello di Rho ad ovest
di Milano e quello di Agrate ad est è costantemente ostruito. Il traffico misto
di autocarri ed automobili rimane bloccato per ore. Su quel tratto di strada si
sovrappongono quattro tipi di traffico del tutto diversi: uno internazionale
tra Francia ed Austria; uno nazionale fra Piemonte e Veneto; uno provinciale
fra Lombardia occidentale e orientale; uno locale tra periferia est e periferia
ovest della città. Possibile che in più di trent’anni le Autorità competenti,
non abbiano mai pensato di eliminare la irrazionale confluenza di tanti flussi
veicolari tra loro così diversi? La nuova strada Milano-Bergamo-Brescia
accorcia è vero il percorso in direzione di Venezia, ma non risolve il
persistente ingorgo sul tratto Rho-Agrate. È un’opera stradale del tutto
inutile; ed è anche nociva perché distrugge ampie porzioni di fertile campagna.
Eppure la soluzione del problema nel tratto Rho-Agrate non sarebbe difficile.
Esclusa la possibilità di allargare la sede stradale a causa del fitto tessuto
edilizio presente lungo entrambi i lati dell'attuale percorso non resta che
sovrapporre alla prima autostrada ormai antiquata una seconda di nuova
costruzione: gli autocarri continueranno a percorrere l’attuale corsia posta al
piano di città; le automobili transiteranno nella nuova interamente
sopraelevata. Sorgerebbero è vero molti problemi costruttivi all’incrocio con
gli esistenti viadotti sopraelevati; e sarebbe difficoltoso il tracciamento
delle rampe di salita e discesa nei punti di interscambio con le principali
arterie cittadine. Un buon progetto stradale tuttavia saprà superare queste ed
altre difficoltà. Chi possiede una “Idea di città” non può limitarsi a prendere
in esame i soli problemi cittadini, ma deve saper vedere al di là dei confini
strettamente urbani. L’imbottigliamento costante di veicoli pesanti e leggeri
nel tratto di autostrada Rho-Agrate rappresenta un problema apparentemente
extra-urbano ma in realtà pesantemente dannoso anche per la città.
Per anni è rimasto insoluto il grave problema delle
auto domenicali al rientro dalla Brianza. Sulla
superstrada Milano-Lecco tre semafori allineati appena fuori Monza a
breve distanza l’uno dall’altro provocavano lunghe, estenuanti, interminabili
code: le auto rimanevano bloccate ed immobili per ore. Il problema è stato
recentemente risolto con la costruzione di un lungo sottopasso interrato. Ci
sono voluti trent’anni per ideare ed attuare questa semplice ed elementare
soluzione: trent’anni di tempo sciupato, di inquinamento crescente, di
estenuante logorio psichico per i viaggiatori di ritorno dalla giornata di
svago. Se l'Amministrazione cittadina avesse avuto una vera “Idea di città” e
si fosse preoccupata del benessere dei cittadini avrebbe difeso la loro
giornata di ricreazione; avrebbero tutelato il loro prezioso e meritato tempo
libero. Non sarebbe rimasta cieca ed ottusa, inerte ed insensibile di fronte a
disfunzioni così vistose come quella tuttora esistente nel tratto Rho-Agrate,
oppure come l’altra prolungatasi per anni sulla superstrada Milano-Lecco.
In questi giorni gli ingorghi lamentati fuori Milano si
stanno ripetendo con intensità altrettanto drammatica anche nel centro della
città. Dopo la sconsiderata chiusura del traffico di Piazza Castello. tutti i
veicoli che prima vi transitavano hanno dovuto dirottare in Foro Bonaparte; con
il risultato che lungo questo percorso vi è una permanente stasi del traffico
mentre in prossimità di Piazza Cairoli si verificano costanti e lunghe code.
L’Assessore addetto al traffico non ha previsto il guasto che avrebbe causato
la irresponsabile chiusura di una importante strada centrale (FOTO 16)? Non ha
valutato il contraccolpo provocato sul restante traffico cittadino da una
violenta modifica della viabilità principale? Dove sta l’"Idea di
città"? Cioè di organismo che può essere tenuto in vita soltanto da una
circolazione scorrevole, fluida, agevole?
 |
| Foto 16 |
Milano si estende tutta in pianura: è una città che si
presta all'uso di biciclette. Da anni le poche piste ciclabili sono rimaste
interrotte, incomplete, non utilizzate. La maggior parte delle strade è
tutt'ora sprovvista di piste ciclabili. Per non essere travolti delle
automobili che sfrecciano e li sfiorano i ciclisti salgono sui marciapiedi ed
investono i pedoni. La colpa dell'infrazione tuttavia non va attribuita alla
loro indisciplina ma alla colpevole inadempienza del Comune. Una “Idea di
città” cosciente e responsabile non obbliga gli abitanti ad incerte e
pericolose acrobazie ciclistiche; non li costringe a ricercare espedienti di
guida per difendere propria incolumità. Prende in esame il problema, lo
affronta, lo risolve. Tracciare una linea verniciata che separi la corsia delle
biciclette da quella delle automobili non è operazione complessa. È invece
complesso nelle strade tortuose e strette del centro affiancare e far
coesistere il transito di auto in parallelo al percorso delle biciclette. Che
aspetta il Comune ad affidare a professionisti competenti il progetto non
facile ma urgente di una rete ciclabile sicura, agevole, estesa all'intera
città?
Se nella politica urbanistica del Comune si constata la
totale assenza di una "Idea di città", e quindi la scoraggiante
incapacità di prendere decisioni conformi a quella idea, è triste dover
riconoscere che anche in altre città, sia di vecchia data sia di nuova
fondazione, sia insediate da secoli nel Vecchio Continente, sia sorte di
recente nei Continenti emergenti, l’"Idea di città" che va affermandosi
è sconcertante e deludente. Milano, volendosi adeguare rapidamente alle altre
città del mondo, si è gettata un’orgia di grattacieli stravaganti ed
acrobatici: alcuni presso il casello autostradale di Rho sono tanto inclinati
da apparire sul punto di crollare (FOTO 17); altri sul terreno della ex-Fiera
Campionaria hanno l'aria di scatenarsi in una danza indemoniata (FOTO 18): uno
avvitato su sé stesso sembra imitare le contorsioni di un acrobata; un altro
ripiegato e curvo sembra soccombere sotto il peso di una enorme gobba; un terzo
rigonfio come un gigantesco pneumatico ricorda la pubblicità dell'uomo
Michelin. Di fronte alla Stazione di Porta Garibaldi ve ne è uno che perde la
pelle come un ciclopico rettile in periodo di muta, e drizza verso il cielo un
turgido pleonastico pungiglione (FOTO 19). La grottesca rassegna non è altro
che il campionario di ciò che sta avvenendo in tutto il mondo civilizzato (o
meglio imbarbarito). Un mondo in cui l’“Idea di città” si è o perduta o
involgarita.
 |
| Foto 17 |
 |
| Foto 18 |
 |
| Foto 19 |
E intanto nelle capitali storiche dei vari continenti
le tracce del passato vengono sistematicamente rase al suolo; Ad Istanbul sono
scomparse le vecchie abitazioni in legno dal pittoresco stile balcanico; a
Singapore vengono demoliti quartieri ottocenteschi occupati da eleganti case
coloniali; in Cina si procede alla distruzione di secolari residenze popolari;
a Parigi interi isolati sono abbattuti e sostituiti da ingombranti, grevi,
sproporzionati volumi moderni; a Bruxelles l’eccezionale ed unico campionario
di case “liberty” è ormai quasi interamente scomparso. La città del futuro
sembra modellata per soddisfare una umanità di provenienza spaziale non più di
origine terrena; sembra destinata ad accogliere esseri calati da pianeti
siderali non più nati nel nostro globo terraqueo; sembra concepita per essere
abitata da asettici robot, dimentichi di ogni memoria storica e sprovvisti di
ogni calore umano. Tuttavia non vi è motivo di disperare. Come dopo
l'apocalisse del Diluvio Universale e dopo il fallimento della Torre di Babele
l'umanità sopravvissuta ha continuato ad esistere e a creare, così dopo la
minaccia dell’era atomica, dopo il naufragio delle Tradizioni, dopo il disinteresse
per la Storia, l’uomo del futuro riscoprirà gli eterni valori umanistici,
rivendicherà la sua insopprimibile aspirazione estetica, continuerà a
progettare nuovi insediamenti urbani, e dimostrerà, così facendo, che
l'"Idea di città" non è destinata a morire.
Elenco delle foto:
Mileto. Idea
di antica città democratica. Abitazioni dei cittadini tutte uguali; soltanto
luoghi pubblici messi in evidenza 1. Agorà, 2. Tempio, 3. Stadio, 4. Teatro
Roma. Idea
di antica città autoritaria. Abitazioni dei cittadini non tutte uguali:
"domus" per ricchi, "insule" per poveri. I Fori Imperiali,
imponenti luoghi del Potere, primeggiano nel centro della città 1. Mercati
Traianei, 2. Foro di Traiano, 3. Foro di Augusto, 4. Foro di Cesare, 5. Foro di
Nerva
Ferrara. Idea
di città medioevale retta da una diarchia autocratica: Potere feudale nel
Castello, Potere ecclesiastico nella Cattedrale. 1. Castello Estense, 2.
Cattedrale
Siena. Idea di città
medioevale retta da una diarchia democratica: Potere popolare nel Palazzo
Pubblico, Potere ecclesiastico nella Cattedrale. 1. Palazzo pubblico, 2.
Cattedrale
Versailles.
Idea di città barocca. Assolutismo monarchico: vie principali convergenti nel
luogo del Potere unico e autoritario; popolazione urbana tenuta distante dalla Reggia.
1. Reggia
San Pietroburgo. Idea di città barocca. Assolutismo cesareo. Vie principali convergenti
nel luogo del Potere unico ed autoritario; popolazione urbana insediata in
vicinanza del Palazzo dello Zar. 1. Ammiragliato
Roma. Idea
di città barocca, Piazza del Popolo. Assolutismo confessionale: vie principali
convergenti nei luoghi del Potere. Potere clericale: Chiesa di S. Maria del
Popolo; Potere monacale: Convento degli Agostiniani. 1. Piazza del Popolo, 2.
Convento Agostiniani, 3. Chiesa S. Maria del Popolo
Milano. Idea
di città pseudo-monumentale, Piazza Piemonte. Assolutismo contraffatto: vie
principali convergenti nel luogo di un Potere inesistente. 1. Piazza Piemonte
Washington.
Idea di moderna città democratica. Sedi dei Poteri collegate da strade
convergenti ed incrociate; rapporti fra i Poteri assicurati da relazioni
intrecciate e complementari. 1. Campidoglio, 2. Casa Bianca, 3. Biblioteca
nazionale, 4. Parco Lincoln
Genova. Via
Garibaldi: passeggiata di soli ricchi
Torino.
Quartiere Falchera: disgregazione della città tradizionale: scomparsa di
strade, piazze, viali, incroci
Milano.
Piazza Gae Aulenti: spazio algido e scostante
Milano.
Piazza San Alessandro: spazio cordiale ed accogliente
Milano.
Nuova Fiera Campionaria: gigantesco rottame accartocciato sulla copertura
Milano.
Quartiere Garibaldi: occasione urbanistica perduta. 1. Stazione ferroviaria
Garibaldi, 2. Asse viario naufragato
Milano.
Piazza Castello e Foro Bonaparte: percorsi gemelli e complementari. 1. Piazza
Castello, 2. Foro Bonaparte, 3. Largo Cairoli
Rho.
Grattacieli pendenti. Per evitare il crollo costi esorbitanti
Milano.
Grattacieli alla Fiera Campionaria. Danza di tre indemoniati.1. Grattacielo
ritorto, 2. Grattacielo gobbo, 3. Grattacielo rigonfio
Milano. Grattacielo
a Porta Garibaldi. Fronte sfogliato come gigantesca squama.

NOAM CHOMSKY
 |
| Noam Chomsky |
IL BASTONE DI WASHINGTON
“L’aggressione è il supremo crimine internazionale che differisce
dagli altri crimini di guerra in quanto contiene in sé il
male accumulato dall’intera guerra” (dagli atti del Processo di Norimberga). L’invasione
dell’Iraq da parte di Stati Uniti e Gran Bretagna è stata un esempio da manuale
di ciò che è un’aggressione. Gli apologeti della guerra invocarono nobili intenzioni,
cosa irrilevante anche se i motivi erano sostenibili. Ai tribunali della
Seconda guerra mondiale non importava un accidenti che gli imperialisti
giapponesi volevano portare un “paradiso in terra” ai cinesi che stavano
massacrando, o che Hitler nel 1939 inviò truppe in Polonia per difendere la Germania
dal “terrorismo selvaggio” dei polacchi. Abdel Bari Atwan, editore di un sito
web panarabo, osserva che “il principale fattore, responsabile del caos attuale
in Iraq, è l’occupazione USA/Occidentale e il sostegno arabo ad essa. Qualsiasi
altra affermazione è fuorviante e mira a distogliere l’attenzione da
questa verità.” Irak. In una recente intervista al programma televisivo di Moyers & Company, lo
specialista in questioni irachene Raed Jarrar ha delineato ciò che noi, in Occidente, dovremmo sapere. Come
molti iracheni, Jarrar è mezzo sciita e mezzo sunnita, ma prima dell’invasione
a malapena conosceva l’identità religiosa dei suoi parenti perché “la
differenza etnico-religiosa non faceva parte della coscienza nazionale”.
Jarrar ci ricorda che “questa
lotta settaria che sta distruggendo il paese, è chiaramente iniziata con
l’invasione degli Stati Uniti e con l’occupazione. “Gli aggressori hanno
distrutto “l’identità nazionale irachena rimpiazzandola con identità etniche e confessionali”,
operazione iniziata immediatamente dopo che gli Stati Uniti istituirono un
governo basato su identità etniche, una novità per l’Iraq. Ormai, sciiti e
sunniti sono acerrimi nemici, grazie al bastone brandito da Donald Rumsfeld e Dick
Cheney (rispettivamente l’ex segretario della Difesa e vice presidente durante
l’amministrazione di George W. Bush) e da altri come loro, che non capiscono
altro se non violenza e terrore, e che hanno contribuito a creare conflitti che
affliggono la regione, ora a brandelli.
Afghanistan. La rinascita dei talebani in Afghanistan.
La giornalista Anand Gopal
spiega le ragioni del suo straordinario libro, No Good Men Among the Living: America, the Taliban, and the War through
Afghan Eyes [Nessun buono tra i vivi:
Stati uniti, il talebano e la guerra vista con occhi afghani]. Nel 2001-2002,
quando il bastone degli Stati Uniti colpì l’Afghanistan, gli outsider di
al-Qaeda si dileguarono e i talebani si dissolsero.
Molti scelsero, come da
tradizione, di accomodarsi dalla parte dei conquistatori. Ma Washington era
alla disperata ricerca di terroristi da schiacciare. Gli uomini forti, che si
imposero come governanti, ben presto scoprirono che
potevano sfruttare la cieca ignoranza di Washington e attaccare i loro nemici,
compresi quelli che collaboravano con entusiasmo con gli invasori americani. Ben
presto il paese si ritrovò governato da signori della guerra senza scrupoli
mentre molti ex talebani, che avevano cercato di entrare nel nuovo ordine,
ricrearono l’insurrezione.
Libia.
Più tardi il bastone è stato
raccolto dal presidente Obama per “condurre da dietro le quinte” la distruzione
della Libia. A marzo del 2011, durante la rivolta (o primavera araba) contro il
leader libico Muammar Gheddafi, il Consiglio di sicurezza dell’Onu approvò la
risoluzione 1973, chiedendo “un cessate il fuoco, la fine della violenza e di
tutti gli attacchi e gli abusi sui civili”.
Il triumvirato imperiale
-Francia, Inghilterra, Stati Uniti- decise all’istante di violare la risoluzione, trasformandosi nella forza
aerea d’appoggio ai ribelli e intensificando la violenza. Il loro intervento è
culminato nell’assalto al rifugio di Gheddafi a Sirte, città che lasciarono
“completamente devastata”, secondo testimoni oculari della stampa britannica:
“reminiscenza delle scene più truci di Grozny, verso la fine della sanguinosa
guerra della Russia in Cecenia”. A costo di tanto sangue il triumvirato
raggiunse il suo obiettivo di cambiare il regime, in violazione dei suoi
pietosi pronunciamenti.
L’Unione Africana si oppose
fermamente all’assalto del triumvirato in Libia. Come informò Alex De Waal,
della rivista britannica International Affairs, la UA aveva proposto un cessate
il fuoco e una “road map” per l’assistenza umanitaria, per proteggere i
migranti africani (molti dei quali sono stati uccisi, i più fortunati espulsi)
e altri cittadini stranieri, nonché la richiesta di riforme politiche per
eliminare “le cause della crisi”, stabilire un “governo ad interim per arrivare
ad elezioni democratiche”. All’inizio la proposta della UA fu accettata da
Gheddafi, ma disdegnata dal triumvirato, che “non era interessato ad un vero
negoziato” scrisse De Waal.
Il risultato è che la Libia è
ormai lacerata dalla guerra tra milizie, mentre il terrore jihadista si è scatenato in gran parte
dell’Africa insieme ad una marea di armi, arrivando anche in Siria.
Congo.
Esistono evidentissime prove
delle conseguenze di tale politica del bastone. Prendiamo la Repubblica
democratica del Congo, ex Congo Belga, un grande paese ricco di risorse -e con
una delle peggiori storie dell’orrore contemporaneo. Aveva avuto una
possibilità di sviluppo dopo l’indipendenza nel 1960, sotto
la guida del primo ministro Patrice Lumumba. Ma l’Occidente non voleva nulla di
tutto questo. Il direttore della Cia, Allen Dulles, a proposito di Lumumba
disse “La sua rimozione deve essere un obiettivo urgente e primario” dei
servizi segreti, soprattutto perché gli investimenti statunitensi nel paese
erano considerati in pericolo a causa di documenti interni che parlavano della presenza di
“nazionalisti radicali”. Sotto la supervisione di ufficiali belgi Lumumba fu assassinato,
realizzando il desiderio del presidente Eisenhower che gli aveva augurato “di cadere
in un fiume pieno di coccodrilli”. Il Congo fu consegnato al favorito degli
Stati Uniti, il dittatore sanguinario e corrotto Mobutu Sese Seko, e da lì
l’attuale naufragio di ogni speranza africana.
Centro America. In luoghi più vicini è più difficile chiudere gli
occhi sulle conseguenze del terrorismo
di Stato di Washington. Oggi regna la preoccupazione
dell’esodo dal Centro America di bambini
che stanno inondando gli Stati Uniti. Il “Washington post” informa che
questi piccoli migranti arrivano “in gran
parte da Guatemala, Salvador e Honduras”, ma non dal Nicaragua. Perché? Può essere
perché quando il bastone di Washington colpiva la regione, negli anni ’80, il Nicaragua era l’unico paese
che poteva contare su un esercito per difendere la popolazione dai terroristi inviati dagli Stati
uniti, mentre negli altri paesi i terroristi che devastavano la popolazione erano gli eserciti addestrati
ed equipaggiati da Washington?
Il presidente Obama ha
proposto una soluzione “umanitaria” alla tragica migrazione: una deportazione
più efficiente. Vi viene in mente qualche alternativa?
Le multinazionali.
Sarebbe ingiusto però omettere
quanti esercitano il “potere soft” nel ruolo del settore privato. Un esempio significativo
è la decisione di Chevron di abbandonare il suo tanto pubblicizzato programma di
energie rinnovabili, perché i combustibili fossili sono molto più redditizi. ExxonMobil
a sua volta ha annunciato, dalle pagine del Bloomberg Businessweek , che “il
suo obiettivo di usare il laser sui combustibili fossili è una buona strategia,
indipendentemente dal cambio climatico, perché il
mondo ha gran bisogno di energia e significative riduzioni di carbonio sono
molto improbabili”. È quindi un errore ricordare ai lettori, giorno dopo giorno,
la sentenza di Norimberga. L’aggressione non è più considerata il “crimine internazionale
supremo”, non si può mettere a confronto con il suo costo -in termini di distruzione
della vita di generazioni future- se l’obiettivo è quello di
ottenere guadagni sempre maggiori oggi.
(Trad. per Odissea di Martha Barry)
CHRISTIAN
ECCHER
 |
| Christian Eccher |
TRITTICO
DALLA GEORGIA
(come una sinfonia)
Reportage
Strada
militare della Georgia (andante sostenuto)
La strada statale
M3, meglio conosciuta come Strada Militare della Georgia, è un nastro d’asfalto
a due corsie sconnesso e corroso dal gelo; collega Kazbegi (il nome ufficiale è
in realtà Stepantsminda), il primo grande centro urbano georgiano per chi venga
dalla Cecenia, a Tbilisi. Prosegue poi verso la capitale armena Jerevan. I
margini polverosi della corsia di destra sono costellati di Tir e camion con
targhe russe, turche e armene che rimangono immobili e aspettano la notte per
passare la frontiera, quando il traffico automobilistico è meno sostenuto e le
attese alla dogana sono più brevi. Trasportano frutta, verdura e metalli destinati
al mercato russo ed europeo. La colonna di camion è una fila interminabile,
lunga fino alla paura, che talvolta comincia già alle porte di Tbilisi. Se i
Tir si mettessero in movimento all’improvviso, tutti insieme, bloccherebbero
immediatamente la M3, che è una delle arterie più importanti del Caucaso. In
territorio georgiano, la M3 si snoda fra i fondovalle dei fiumi Tekhena e
Aragvi, dominati dal picco del Monte Kazbek, alto più di 5000 metri. Nelle
giornate limpide, la forma tozza del Kazbeg è visibile anche dal centro di
Tbilisi. Formatosi contemporaneamente alle Alpi, il Caucaso è il prodotto della
collisione fra la placca tettonica euroasiatica e quella araba, che milioni di
anni fa chiuse in una morsa fatale il mare Tetide. Lo spartiacque meridionale
del Caucaso è aspro e brullo, anche a quote relativamente basse. Quello
settentrionale invece, in territorio russo, ha pendii più morbidi e boscosi; in
corrispondenza della zona di subduzione, lì dove a grande profondità le rocce
della placca araba si insinuano sotto quelle della placca euroasiatica, ci sono
dei piccoli vulcani. Anche il Kazbeg può essere considerato un vulcano, anche
se inattivo: il magma non raggiunge mai la superficie e non c’è alcun rischio
che la sommità del monte esploda ed erutti lava. Intorno alla vetta ci sono
però fuoriuscite di acqua calda, che nel 2002 hanno causato lo slittamento
improvviso di un ghiacciaio che si è riversato sulla città di Kazbegi,
provocando un’inondazione con diversi morti. L’acqua spesso blocca anche la M3:
bastano precipitazioni piovose un po’ più abbondanti del solito e i pendii
scoscesi si trasformano in torrenti, che riversano a valle e sulla strada
quantità enormi di terriccio e di pietrisco. A volte sono le vacche a
interrompere il flusso del traffico: si siedono a decine al centro della
carreggiata, sonnacchiose e tranquille. Ci vogliono ore prima che la situazione
torni alla normalità; gli automobilisti rassegnati scendono dalle proprie auto
e raggiungono uno dei piccoli ristoranti che si trovano lungo la Statale: il
Kaciapuri (una sorta di pizza al formaggio), le melanzane ripiene di crema alla
nocciola, i Kinkhali (enormi ravioli farciti di carne e di funghi) e verdure di
ogni tipo convincono i viaggiatori stanchi a sedersi attorno ai piccoli tavoli
di legno delle taverne, dalle cui finestre verdeggiano i greppi dei monti
interrotti da piccole cascate ad alta quota. Il vento, che in queste regioni
soffia per lo più da nord, corrode i picchi, aspri e brulli, che prima di aver
raggiunto il blu del cielo hanno abitato le viscere della terra: paurose
pressioni e temperature infuocate hanno sciolto le rocce che costituivano la
superficie della placca araba: i minerali si sono liquefatti in un magma fluido
per poi ricomporsi in rocce metamorfiche chiamate gneiss, che la forza della
terra ha scagliato verso il cielo in tempi geologici rapidissimi, circa 25
milioni di anni. L’acqua, il vento, corrodono le sommità e gli gneiss
polverizzati tornano a valle, dove formano i conoidi, ovvero immense losanghe
nere ai piedi dei pendii più scoscesi.
D’estate, nelle
ore più calde della giornata, l’umidità si condensa ad alta quota: graziosi
cumuli bianchi fanno capolino sulle alture più alte, impercettibilmente si
gonfiano, crescono, per poi trasformarsi in mostruosi cumulonembi che
nascondono il sole; il Kazbeg con il Santuario della Trinità, a picco sul
nulla, sono le prime vittime a essere inghiottite dal nero temporalesco,
illuminato solo da brevi e fredde scariche elettriche, saette che emergono
dalle tenebre acquose delle nuvole. Non resta che scappare verso valle,
raggiungere Ananuri e la sua chiesa, che sorge sulle rive del lago omonimo,
costruito per garantire una riserva d’acqua costante a Tbilisi e ai paesi e le
città più a valle. Il santuario, che risale al XVII secolo, è rassicurante,
caldo, le sue mura proteggono dai temporali e dai venti che spesso soffiano
impetuosi, scompigliando la superficie del lago. Un affresco sulla parete
rappresenta l’aldilà, con l’inferno in cui animali feroci mangiano i peccatori.
I turisti si assiepano lungo le mura del complesso in cui la piccola basilica è
compresa; un gruppo di tedeschi cammina sul sentiero scosceso che porta al
lago. La loro pelle chiara, i capelli biondi rimandano a certezze di paesi
lontani; i loro passi fermi e cadenzati tradiscono la sicurezza di chi non teme
i temporali di alta montagna e neppure il magma sotterraneo che si agita come
un serpente arrabbiato nelle viscere della terra, alla ricerca di un varco per
raggiungere finalmente la superficie e riprendersi le rocce e i cristalli che
hanno osato raggiungere le altezze celesti.
Tbilisi (Kraftig
bewegt, doch nicht zu schnell - andantino)
Tbilisi si
presenta all’improvviso: d’un tratto le montagne lasciano spazio a colline di
arbusti e di alberi le cui cime sono seccate dal sole; a valle, il fiume
Mtkvari scorre placido e mansueto. Alcuni palazzi di architettura socialista si
ergono solitari e metafisici su una piccola altura e, come uno squillo di
tromba all’inizio di un concerto, annunciano la capitale georgiana. La M3 si
insinua fin dentro la città, il traffico è anarchico, gli automobilisti non
conoscono regole; le auto sorpassano i camion, gli autobus e le “marschrutke”
gialle (furgono privati che fanno concorrenza al trasporto pubblico) senza curarsi
dei veicoli che arrivano in direzione opposta, i quali, senza scomporsi, si
fermano nel bel mezzo della strada o invadono persino i marciapiedi pur di
continuare la propria marcia. Il suono dei clacson è interrotto solo dalla voce
roca dei poliziotti che, seduti nelle proprie auto bianche e azzurre e immersi
nel traffico insieme a tutti gli altri, dirigono la circolazione per mezzo di
microfoni collegati ad altoparlanti, a loro volta posizionati vicini al
lampeggiante blu sul tettino. Il caos che regna le strade è una metafora
perfetta dei rapporti sociali in Georgia. Subito dopo la proclamazione di
indipendenza, nel 1991, cominciò la guerra in Abcasia e in Ossezia del Sud, due
regioni contese con la Russia. L’Europa era troppo impegnata a cercare una soluzione
per i Balcani e dimenticò il Caucaso: nessun paese occidentale aiutò la giovane
democrazia georgiana a fronteggiare le enormi difficoltà davanti a cui si
trovava. I disordini, che inizialmente erano limitati ai due territori
coinvolti nel conflitto, si diffusero presto in tutto il paese: l’opposizione parlamentare
organizzò una manifestazione di protesta che il governo represse nel sangue. Da
quel momento fu la guerra civile, una delle più caotiche mai esistite, in cui
non era facile capire chi fossero le parti in causa, da che parte stesse
l’esercito e per chi combattessero le varie milizie comparse dal nulla, al
servizio di mafiosi e affaristi senza scrupoli. Levan, docente di germanistica
all’Università di Tbilisi, ricorda ancora la mancanza di elettricità, il pane
quasi crudo che si comprava nelle piccole botteghe dopo ore e ore di fila (i
forni erano elettrici e funzionavano a singhiozzo), i balordi armati che
terrorizzavano la popolazione; all’inizio degli anni Novanta, omicidi e rapine
erano all’ordine del giorno non solo a Tbilisi, ma anche nel resto della
Georgia. Nel ’92 il primo presidente democraticamente eletto, Zviad
Gamsakhurdia, venne destituito ed Eduard Shervarnadze, già ministro degli
esteri ai tempi dell’URSS, prese il suo posto. La battaglia che portò
all’esilio di Gamsakhurdia fu cruenta: la via principale di Tbilisi, via
Rustaveli (ora costellata di panchine su cui splendide fanciulle dai capelli
nerissimi e dalle gonne a fiori mangiano il gelato), venne quasi completamente
distrutta. 113 persone rimasero a terra (Sono i morti per la libertà. I morti.
Per la libertà. Sono tutti sepolti). L’Abcasia e l’Ossezia del Sud erano però
de facto diventate indipendenti. Sempre nel corso degli anni Novanta, l’Agiaria
(o Adzharia), un’altra regione autonoma al confine con la Turchia e abitata da
una forte minoranza turca, diede segni di irrequietudine che portarono il
parlamento locale a proclamare l’indipendenza fiscale e a chiudere per un certo
periodo le proprie frontiere, in un tentativo di affrancarsi dal controllo
politico di Tbilisi. Il governo centrale riuscì però a domare la protesta e
l’Agiaria è tuttora in territorio georgiano. Nel frattempo la guerra, la
povertà, la corruzione, l’insicurezza che regnavano sovrane avevano portato gli
abitanti di Tbilisi alla disperazione. Nel novembre del 2003, nell’attuale
piazza della Rivoluzione, in pieno centro, dove adesso sorge il palazzo di
vetro che ospita il lussuoso hotel Radisson, migliaia di persone si radunarono
per protestare contro Shevarnadze, il quale diede immediatamente le dimissioni,
evitando così un inutile spargimento di sangue. La cosiddetta Rivoluzione delle
Rose portò a nuove elezioni e nel gennaio del 2004 salì al potere Mikhel
Saakashvili, che diede un’impronta filo-occidentale alla politica estera (anche
oggi, tutti gli edifici pubblici della Capitale espongono non solo la bandiera
georgiana, ma anche quella europea, a rimarcare non solo un desiderio di
appartenenza all’Europa e alla sua cultura, ma anche un allontanamento dalla
Russia e dalla politica espansionista e imperialista di Valdimir Putin). Il
nuovo presidente inaugurò una serie di riforme che hanno fatto della Georgia un
paese più stabile. Da allora Tbilisi è una città sicura, la polizia è presente
in tutte le strade, le risse e gli omicidi sono davvero solo un ricordo del
passato. Nei vicoli della Città Vecchia, lontano dal traffico, la calma regna
sovrana, ma in Caucaso la pace è sempre fragile e illusoria. Nelle viscere
della terra, il magma non smette mai di agitarsi e cerca disperatamente di
guadagnare la superficie, e nel far ciò riscalda le polle d’acqua sotterranea,
che fuoriesce copiosa dalle fontane delle terme pubbliche situate proprio nel
centro della capitale: Tbilisi rimane così fedele al proprio nome, che in
lingua georgiana antica significa “luogo caldo”.
Nella piazza
della Rivoluzione, l’Università Ilia ha organizzato un concerto rock: nella
tiepida sera settembrina si esibiscono gli studenti e i docenti che nel tempo
libero cantano o suonano uno strumento musicale. A destra, dietro l’hotel
Radisson e al di là del fiume, c’è la Tbilisi occidentale, con i palazzi
costruiti in stile parigino; in periferia, invece, ci sono gli edifici quadrati
in stile socialista. A sinistra della piazza, aggrappata al Monte Santo,
biancheggia la città vecchia, con le sue case basse in stile persiano, con le
verande a picco sulle stradine sconnesse su cui, di giorno, si affacciano
timide bambine, che per guadagnare il parapetto si alzano sulle punte dei
piedi, come ballerine ancora acerbe. Guardano i passanti e fanno smorfie
arricciando le labbra prima di scappare rumorosamente e di rifugiarsi ridendo
nell’ombra fresca della casa. Sulla sommità del monte, collegato alla città con
una funicolare (una funicolare nella notte, amici, dove porta?) troneggia il
grande traliccio della televisione, costituito da un telaio di acciaio a tre
tubolari: uno, quello portante, è perpendicolare al suolo, gli altri due sono
inclinati e si saldano al principale proprio sotto la torre di controllo, una
sorta di enorme collare, posto a metà del traliccio, in cui lavorano i tecnici
delle telecomunicazioni. Le lampadine a intermittenza collocate lungo la
costruzione conferiscono dinamicità e leggerezza all’intera struttura e fanno
del Monte Santo, così chiamato perché a mezza costa sorge un Santurio, un luogo
simile a un luna park, complice anche la grande ruota panoramica che lentamente
gira e nel cielo fa compagnia al ripetitore.
Il pubblico si
infiamma quando Giorgi, trentenne impiegato all’Ufficio Internazionale
dell’Università, sale sul palco con il suo basso e comincia a suonare insieme
al complesso di musica heavy metal che lui stesso ha contribuito a fondare. Con
il suo sguardo sincero da bambino un po’ smarrito, i capelli lunghi lasciati
cadere sulle spalle e la barba ispida e incolta, Giorgi è una persona molto
amata dagli studenti, dai professori e gode di una buona reputazione in tutta
la città. La musica heavy metal è per lui un modo per esprimersi e anche per
incanalare l’aggressività che caratterizza tutti coloro che da adolescenti
hanno vissuto in prima persona i tragici fatti degli anni Novanta. Il fratello
di Giorgi ha preso parte alla guerra dei 5 giorni, che si è consumata
nell’agosto del 2008, quando la Russia ha invaso l’Ossezia del Sud. Dopo il
successo in Agiaria, infatti, il governo georgiano si era illuso di essere
abbastanza forte da poter riprendere lentamente possesso di tutti i territori
perduti negli anni Novanta con una semplice operazione di polizia e di
diplomazia, senza neppure bisogno di schierare l’esercito. I carri armati di
Putin avanzarono non solo in Ossezia, ma anche lungo la Strada Statale M1, che
collega il Mar Nero con Tbilisi e occuparono Gori, la città natale di Stalin.
La capitale si chiuse in sé stessa, i riservisti furono schierati sulle alture
della periferia, di nuovo vennero a mancare l’acqua e l’elettricità. Tutta la
cittadinanza era pronta per la difesa estrema, per il sacrificio finale. La
Georgia aveva già perso una volta la propria indipendenza nel 1921, quando
l’URSS annetté quella che a Mosca veniva chiamata la Siberia del Sud mettendo
così fine alla prima repubblica socialdemocratica al mondo, nata nel 1918
proprio a Tbilisi. Come le nubi nere che dal Kazbeg cercano di guadagnare la
valle fino a lambire la capitale, senza però raggiungerla davvero, e a sera si
sgonfiano innocue, così anche la minaccia russa svanì nel giro di pochi giorni.
Le milizie di Putin si ritirarono nel nord del Caucaso, grazie anche alla
mediazione dell’allora presidente francese Sarkozy, ma l’Ossezia del sud era
perduta per sempre. Anche se non è riconosciuta dalla Comunità Internazionale,
la regione appartiene a tutti gli effetti alla Federazione Russa. Alla fine
della guerra dei cinque giorni, colonne di profughi georgiani si sono riversate
dall’Ossezia verso Tbilisi; per loro il governo ha costruito villaggi che oggi,
visti dall’autostrada, somigliano a lager o ad accampamenti militari: case
piccole, ma molto dignitose, ordinate per file regolari su pianta quadrata. Dal
2008 i rapporti con la Russia sono diventati estremamente tesi. Putin ha dato
ordine di rimpatriare tutti i cittadini georgiani che lavoravano nel Nord del
Caucaso o a Mosca e ha introdotto un sistema di visti molto severo. I rapporti
fra Georgia e Russia sono in realtà molto ambigui: lo stesso Giorgi, come quasi
tutti i georgiani, sa perfettamente il russo, anche se si rifiuta
categoricamente di parlarlo. Solo le nuove generazioni non conoscono l’idioma
di Dostojevski: da quando Saakashvili ha invitato professori americani e
inglesi a lavorare nelle scuole delle principali città, l’inglese ha conosciuto
una grande diffusione; anche il georgiano, una lingua appartenente al gruppo
cartvelico (che non è indo-europeo), ha riguadagnato il prestigio perso durante
la dominazione sovietica. Non sarà comunque facile cancellare l’impronta che la
Russia ha lasciato dietro di sé: i legami culturali fra i due paesi affondano
le proprie radici già nel XVIII secolo, quando la Georgia, nazione
cristiano-ortodossa, chiese la protezione degli zar per difendersi dalle
invasioni turche e persiane. Nel 1801 il paese entrò a far parte dell’impero
russo e anche i nazionalisti georgiani dell’’800 si formavano nelle Università
di Mosca e di San Pietroburgo: il loro non era un nazionalismo anti-russo,
tutt’altro. La Georgia ha ancora bisogno della Russia e, nonostante le tensioni
che anche oggi sussistono, il nuovo governo, in carica dal 2013 e guidato da
Irakli Garibashvili, sta cercando di trovare un accordo commerciale con Mosca,
che fino al 2008 era il principale partner economico di Tbilisi. Attualmente,
nonostante le sanzioni, la Russia continua ad acquistare il vino georgiano
grazie alla mediazione dell’Uzbekistan.
Alla periferia
ovest della città, che è possibile raggiungere solo in autobus, dato che la
metropolitana costruita ai tempi dell’Unione Sovietica viaggia sull’asse
nord-sud, Ghia (diminutivo di Gregori) siede nella sua guardiola davanti al
Ministero dello Sport. Lavora come guardiano, al mattino presso il Ministero e
al pomeriggio per conto di un’azienda americana, che lo paga molto bene ma in
nero, senza contribuiti e senza assicurazione medica. Con Saakashvili la
Georgia ha riformato non solo il sistema dell’istruzione e la polizia, ma anche
l’economia: nel 2005 è stata varata una nuova legge sul lavoro. Su pressione
dell’America di George Bush padre, il cui appoggio era fondamentale in un
momento in cui l’Europa era assente dal Caucaso e la Russia minacciava
l’invasione, lo stato sociale è stato completamente smantellato. Il
neocapitalismo ha mostrato in Georgia il suo volto più selvaggio e ha reso i
lavoratori veri e propri schiavi. A George Bush è stato anche dedicato un
importante boulevard di Tbilisi non lontano dall’aeroporto. Le cose però stanno
lentamente cambiando: il nuovo primo ministro (la riforma costituzionale del
2012 ha tolto il potere al presidente per darlo al governo ed il premier è
diventata una figura cruciale della politica georgiana) sta cercando di
reintrodurre delle garanzie per il lavoratori, grazie anche alla pressione che
l’UE e la Germania esercitano sulle Istituzioni di Tbilisi da qualche anno a
questa parte.
Ghia
parla russo e rimpiange i tempi dell’Unione Sovietica. Gli occhi chiari e
malinconici, il volto solcato da rughe profonde, ha 55 anni ma ne dimostra
venti di più. Racconta la propria storia centellinando le parole. Di tanto in
tanto si interrompe, accende una sigaretta e lo sguardo si perde in un punto
indefinito, verso l’alto, verso immagini lontane e irrimediabilmente perdute. Suo
padre era impiegato in qualità di dirigente presso un’azienda petrolifera con
sede a Batumi, il capoluogo dell’Agiaria. Ghia è nato in una casa in riva al
mare, con una veranda affacciata sul Mar Nero e coperta da un pergolato su cui
selvaggia cresceva la vite. Ricorda ancora il gusto intenso e succoso degli
acini neri e polverosi. Una volta, da bambino, lavò in mare un grappolo che sua
madre aveva raccolto per lui e il succo dolce della frutta si mischiò al sale
marino, in un contrasto stridente e indimenticabile. Era settembre, faceva
ancora caldo e una coppia di russi attempati camminava sulla battigia. Quando è
diventato maggiorenne, Ghia si è trasferito a Tbilisi e fino all’indipendenza
della Georgia ha lavorato in una ditta pubblica come impiegato. La fabbrica è
stata privatizzata negli anni ’90 e nel giro di pochi mesi è fallita. Ghia si
era nel frattempo sposato e per mantenere il figlio Irakli, nato subito dopo il
matrimonio, ha cominciato a lavorare come guardiano. La paga però era miserrima
e ha dovuto trovare altri impieghi. Per garantire un futuro al proprio bambino
ha anche venduto la casa di Batumi e comprato un secondo appartamento a
Tbilisi. Il figlio, ora ventisettenne, è la sua preoccupazione più grande: il
ragazzo ha cercato di impiegarsi come istruttore di calcio, il suo sogno sin da
bambino, ma ha ben presto capito che senza una raccomandazione non sarebbe
riuscito a trovare il lavoro che desiderava. Si è lasciato andare, a cominciato
a bere e a disprezzare i genitori. Rabbia, frustrazione, rassegnazione,
depressione sono i sentimenti tipici di tutti coloro che erano adolescenti
negli anni Novanta e non soltanto di Irakli: una situazione che la regista Nana
Ekvtimishvili ha magistralmente rappresentato nel film “In Bloom”. Ghia
vorrebbe sistemare il figlio prima di diventare troppo vecchio. Sente che le
forze cominciano a mancargli, vorrebbe che il ragazzo emigrasse, che trovasse
lavoro in Italia come badante di una persona anziana o malata. Ghia ha legami a
Mosca e a Ekaterinburg, ma non è riuscito a far sì che Irakli ottenesse un
visto lavorativo per la Russia. Dal 2008 in poi, molti georgiani, soprattutto
le donne, quando hanno visto che Putin faceva sul serio e non concedeva loro i
permessi di soggiorno, hanno optato per quella che Kofi Annan ha definito
“Emigrazione circolare”. I georgiani partono, lavorano per qualche mese
all’estero, soprattutto in Italia e in Grecia, tornano a casa e dopo qualche
tempo emigrano nuovamente. Sui monti della Tuscezia, una regione al confine con
il Daghestan, le donne, abituate a vivere da sole anche in passato dato che i
mariti nei mesi invernali transumavano a valle, si spostano ogni anno in massa
verso l’Europa occidentale. Trascorrono l’inverno all’estero e poi l’estate
nelle proprie case, dove aiutano i mariti nei lavori dei campi o nella
pastorizia. Ghia non permetterebbe mai che la sua consorte partisse senza di
lui, ma vorrebbe che il figlio lasciasse la Georgia. Magari per sempre: l’URSS
era la patria della sua famiglia, la nuova patria e la retorica nazionale e
nazionalistica sono per lui solo una carnevalata, utilizzata dai politici come
Shevarnadze per rubare ciò che apparteneva al popolo. Dopo aver parlato per
ore, ci salutiamo a lungo e affettuosamente; Ghia rimane fuori dalla sua
guardiola, in cui ci sono solo una televisione e un materasso di spugna, e mi
guarda mentre mi allontano; la mano sulla fronte a ripararsi dal sole, le gambe
arcuate verso l’esterno, piegate da un’artrosi precoce e inarrestabile. Poi si
gira, accende una sigaretta ed entra nel parcheggio dall’asfalto sconnesso nel
Ministero, dove, sulla rete di ferro che separa il cortile dalla strada,
grappoli d’uva dai chicchi turgidi pendono pesanti. La luce solare fende l’aria
illuminando minuscole particelle di polvere sospese nell’aria calda del
pomeriggio settembrino.
Deserto del
Gareja (Lento e pensoso – finale: come una suggestione)
A sud di Tbilisi,
verso Rustavi, le colline sono ricoperte di rigogliosa vegetazione; campi di
grano e frutteti si snodano nella valle lungo il corso del fiume Mtkvari. Poi,
all’improvviso, attraversato il corso d’acqua, gli alberi si diradano; il manto
erboso dei prati lascia il posto a chiazze di terra marrone e arida. A mano a
mano che si sale sulle alture del Gareja, il paesaggio si fa sempre più lunare;
l’ultimo paese prima del deserto, Udabno, è arso dal sole. Le case sono
semplici, piccole e con il tetto ondulato in lamiera o in eternit. Ogni
abitazione ha sulla terrazza un grosso serbatoio cilindrico che funziona da
riserva d’acqua, dato che le precipitazioni sono estremamente rare. Udabno è
ormai quasi disabitata, gli abitanti si sono trasferiti a Tbilisi o all’estero.
Il deserto che si estende verso sud è costituito solo da rari arbusti bassi. Il
silenzio ovatta persino l’asperità dei rilievi ed è interrotto solo dal fruscio
del vento che alza nuvole di polvere verso il cielo. Non il canto degli
uccelli, non il latrare di un animale, non una voce umana; i gechi e i serpenti
scivolano muti sui sassi quando avvertono un pericolo e si rifugiano nei buchi
del terreno. Al confine con l’Azerbaigian sorge il complesso religioso di
Davit-Garej che risale al VI secolo d.C. ed è costituito da un chiostro molto
grande e da 19 monasteri. Il versante meridionale della catena del Gareja è
punteggiato da piccole grotte, un tempo abitate da monaci e pastori, le cui
pareti sono affrescate con immagini di santi e scene sacre. I dipinti risalgono
per lo più al Medioevo e sono stati restaurati di recente. Quest’area era
all’epoca fertile e ubertosa, come testimoniano le numerose terrazze costruite
a fini agricoli e ormai ricoperte di sterpaglie e polvere terrosa. Sulla vetta
più alta una graziosa cappella domina il paesaggio. Il chiostro maggiore è
assai particolare: le abitazioni dei monaci sono infatti scavate nella pietra.
Ogni anno le migliaia di pellegrini che visitano il complesso di Davit-Garej,
dopo aver pregato nella chiesa del Chiostro maggiore, si inerpicano sulla
montagna per raggiungere le grotte affrescate e la cappella. Nella società
georgiana la religione ha un ruolo importantissimo, e non a caso il patriarca
della Chiesa Ortodossa Georgiana Ilia può essere considerato l’uomo più
importante del paese. Dopo la caduta dell’URSS, la Chiesa ha assunto un peso
sempre maggiore e il Governo di Tbilisi ha addirittura firmato un Concordato
con il Patriarca: i Concordati si firmano solo fra Stati sovrani e
indipendenti, non fra gruppi di potere che fanno parte dello stesso Stato; in
Georgia, però, l’istituzione ecclesiastica ha preteso di avere una voce in capitolo
in tutte le decisioni governative e che il suo ruolo fosse riconosciuto
addirittura da un articolo della Costituzione. “La religiosità dei georgiani è
in realtà solo di facciata, è mera forma”, dice Maria, una studentessa al terzo
anno della facoltà di psicologia dell’Università Ilia, mentre osserva il
chiostro dalla cella più alta. “Ogni volta che passano davanti a una chiesa, i
georgiani si fanno il segno di croce, per mostrare agli altri la propria
devozione. Il dramma è che le parole “ortodosso” e “georgiano” sono ormai
diventate sinonimi”. Maria ha vent’anni, ha un viso squadrato ma allo stesso
tempo delicato; qualche capello bianco fa capolino dalla folta chioma castana.
Lo sguardo sveglio e gli occhi accesi non riescono a nascondere un disagio, una
sofferenza che affondano le radici in chissà quale angolo del suo passato ma
che allo stesso tempo hanno contribuito a fare di lei una ragazza sensibile ed
estremamente intelligente. Racconta che in alcuni villaggi della Tuscezia
(regione a nord del paese, al confine con il Daghestan) la popolazione ha
letteralmente esiliato il prete, che pretendeva di imporre il credo e le
funzioni ufficiali, per poter continuare ad esercitare i propri millenari riti
religiosi che mantengono degli elementi pre-cristiani, eredità delle credenze
pagane e animiste (la Georgia è stata cristianizzata nel IV secolo d.C.).
L’eccessiva religiosità è un fenomeno che si è sviluppato solo dopo
l’Indipendenza dall’URSS; anche nei secoli passati, il credo ortodosso era
aperto a influssi non solo pagani e animisti, ma anche di altre religioni, come
testimonia il Monastero di Alaverdi, che si trova vicino alla città di Akhmeta
ed era un vero caravanserraglio, dove una volta all’anno, in occasione della
celebrazione annuale di Alaverdola, ortodossi appartenenti alla Chiesa russa,
georgiana e armena commerciavano e mangiavano insieme nel territorio del
Monastero con i musulmani del Daghestan e dell’Azerbaigian, finché negli anni
Novanta il Patriarca Ilia non ha cerimonializzato e istituzionalizzato la festa
vietando l’uso del santuario per intenti non finalizzati al mero culto. La
Chiesa però è sacra anche per i Musulmani e, secondo Florian Mühlfrieden,
docente di etnologia a Jena e studioso delle tradizioni georgiane, accanto alle
mura del Monastero sorgeva un tempo una Moschea. Ancora oggi i fedeli si
incontrano, ma sono esclusivamente cristiano-georgiani e la ricorrenza ha perso
l’importanza che aveva un tempo. Maria è molto critica nei confronti delle
decisioni del Patriarca. Il 94% della popolazione ha totale fiducia nella
Chiesa e ciò crea e creerà non pochi problemi alle forze politiche che
vorrebbero fare dello Stato georgiano un’entità laica e multiculturale.
A Davit-Garej i
pellegrini che vogliano raggiungere la cappella sulla vetta sono costretti ad
arrampicarsi sulla montagna ai piedi della quale sorge il chiostro maggiore e
poi a oltrepassare di qualche metro la cima che segna anche lo spartiacque dei
monti Gareja; dall’altra parte, che guarda verso sud, si snoda l’unico sentiero
percorribile e lì si trovano anche le grotte affrescate. Una ringhiera
metallica – simile a un corrimano – attraversa a zig zag il viottolo sterrato;
i fedeli devono più volte scavalcare questa ringhiera che nell’ultimo tratto si
perde e lascia il posto a degli innocui paletti conficcati nel terreno,
utilizzati dai viandanti come appoggi per l’arrampicata. Ringhiera e paletti
segnano in realtà la frontiera con l’Azerbaigian. Il confine è conteso da anni;
Baku vorrebbe annettere la sommità dei monti Gareja e la ragione è evidente: da
quassù è possibile controllare il deserto azero fino al lago di Semkir, una
riserva d’acqua molto importante. La Georgia ha invece unilateralmente
stabilito che lo spartiacque le appartiene; la chiesetta contesa è sorvegliata da
due soldati georgiani che, annoiati, imbracciano il fucile e guardano i
pellegrini farsi tre volte il segno della croce mentre girano intorno
all’edificio sacro. L’Azerbaigian tollera che i fedeli ortodossi invadano il
proprio territorio e miliziani azeri da queste parti non ce ne sono. Verso
sud-est, in direzione Baku, si apre una spianata immensa di polvere e sabbia,
interrotta soltanto da venature di calcare bianco sulla cresta delle alture che
si innalzano a ovest dell’orizzonte. In lontananza, tremolante e incerto, si
intravvedono la valle del fiume Kura e la fine del deserto. Il Caspio è da lì
distante solo 200 km; la Georgia cristiana e l’Azerbaigian musulmano dividono
non solo il nulla del Gareja, ma anche legami culturali ancestrali, dato che la
frontiera un tempo non esisteva e l’osmosi fra le popolazioni che abitavano
queste terre era continua e naturale. La sommità dei monti Gareja è un ponte
che permette di comunicare e allo stesso tempo una diga serrata, è apertura e
chiusura, è bandiera di pace e forte di guerra. Come l’intero Caucaso.
 |
| Christian Eccher |
Sotto il sole
cocente Maria guarda pensierosa l’orizzonte azero, piatto e monotono. Dietro di
lei, le alture georgiane appaiono striate e aspre. In inverno, dicono, per
pochi giorni la bolla di alta pressione che sempre staziona fra Georgia e
Azerbaigian si rompe; piove, anche se poco. Per questo in primavera migliaia di
piccoli e delicati fiorellini rossi ricoprono il deserto, per pochissimi
giorni, e salgono, salgono, salgono su fino al cielo, e forse i due soldati
alla frontiera appoggiano i fucili a terra e fanno il girotondo insieme ai
pellegrini, e forse anche i monaci del Chiostro diventano più indulgenti e
perdonano i peccati propri e quelli di coloro che li vanno a trovare.
MEDICI
SENZA FRONTIERE
Medici Senza
Frontiere è la più grande organizzazione medico-umanitaria indipendente al mondo. Nel 1999 è stata insignita del Premio Nobel per la Pace. Opera in oltre
60 paesi portando assistenza alle vittime di guerre, catastrofi ed epidemie.
Ebola: la forza
di Mary
Il triangolo della morte, così mi viene da descrivere questa parte di mondo dove l’equipe MSF sta
lottando giorno e notte per fermare l’epidemia di Ebola. Mi trovo a Guéckédou,
una cittadina nella foresta della Guinea, non lontana dal confine con la Sierra
Leone e la Liberia. Il virus Ebola sembra non voler arrestare la sua avanzata. Nel
nostro ospedale da campo a fatica riusciamo a trovare i letti e lo spazio per
ammettere tutti i casi d’ebola. Qui i morti si contano giornalmente: è
un’ecatombe. Il numero più basso di morti che abbiamo avuto in una giornata
è stato quattro ed il numero maggiore sette.
Il giorno
del mio arrivo abbiamo ammesso una famiglia intera, padre, madre e Ie
loro tre figlie di 7, 10 e 13 anni. Il padre è deceduto dopo qualche ora dall’arrivo,
lasciando sole la moglie Geneva e le 3 figlie. Geneva era terrorizzata
dall’idea di morire e di dover lasciare le sue tre bellissime bambine orfane.
Ma le sue condizioni sono subito apparse gravi. Ha iniziato a perdere sangue
dal naso e poi dalla bocca fino a che non è spirata, tra i pianti e le urla
delle sue tre bambine che l’hanno vista morire in questo modo orribile. Il
padre era stato ad un funerale di un fratello (successivamente si è capito che
era affetto da ebola), e durante la cerimonia della preparazione del corpo,
eseguita senza protezione, era venuto a contatto con il virus. Una persona
infetta con l’ebola ha il virus in tutte le secrezioni del corpo: sudore,
lacrime, saliva, sangue, feci, vomito e perfino nel latte materno. Ed il
luogo dove il virus si propaga maggiormente è proprio durante i funerali, dove
il corpo del morto viene toccato da tutte le persone che partecipano al
funerale. Una volta rientrato a casa, il padre ha trasmesso il virus a tutta la
famiglia.
Mary, la più
grande delle tre, mi ha subito colpito per il suo sguardo maturo, per
quell’aria da ‘dura’ con la quale mi guardava. Sola ad accudire le sue due
sorelline, passava ore
a darle da bere e da mangiare, le spronava a sforzarsi, ma per loro era un
calvario anche solo aprire la bocca. La diarrea ha iniziato a manifestarsi
nella sorellina piu piccola che dopo una notte di agonia se n’è andata.
Mary e
Jetta, le due superstiti si sono allora chiuse in un silenzio totale. Non mi guardavano neppure quando
entravo nella tenda. Si rifiutavano di mangiare nonostante Mary avesse
ancora la forza per farlo. Entravamo a turno nell’unità di isolamento, per non
lasciarle troppo tempo da sole. Faceva caldissimo e con la tuta di protezione
che indossiamo e non riuscivamo a stare all’interno per molto tempo. Mary e
Jetta non parlavano l’inglese e quando chiedevo loro come si sentissero o se
avessero mangiato non mi guardavano neppure.
Jetta si è
addormentata, di un sonno profondo, dal quale non si è più svegliata. Che tristezza nei nostri cuori,
quanta rabbia abbiamo provato. Il senso di impotenza in questi casi prende il
sopravento, e la rabbia la senti salire e vorresti urlare.
Mary era lì,
apparentemente indifferente alla morte della sorella, non guardava il suo
corpo, non piangeva. Avrei voluto
abbracciarla e per questo mi sono avvicinato ma Mary con uno movimento brusco
si è girata dall’altra parte. Mentre l’équipe si preparava a portare via il
corpo della sorellina, Mary, fissava con lo sguardo la parete della tenda.
Non si è mossa da quella posizione per ore, e così l’ho ritrovata quando alle
sette di sera sono rientrato per portarle la cena. Le ho messo il piatto
davanti e le ho chiesto di fare uno sforzo, spiegandole che mangiare e bere
aiuta l’organismo a combattere l’ebola. Non ha mosso la testa di un millimetro.
Il giorno
seguente quando sono entrato nella sua tenda l’ho trovata sdraiata per terra,
che dormiva. L’ho chiamata, ha riconosciuto la mia voce perché mi ha fissato
come se aspettasse una delle mie domande. Le ho preso la mano destra e
mentre la stringevo le ho detto che non mi sarei arreso, e che sarei rimasto lì
accanto a lei fino a che non avesse assaggiato il cibo che le avevo portato.
Poi mi sono detto «perché non parlarle in italiano?», la nostra bella lingua
così musicale da incantare anche chi non la conosce. Sono rimasto al suo
fianco raccontandole un po’ di cose: da dove venivo e cosa facevo nel suo
Paese. Sono poi passato a raccontarle della mia famiglia e di mio nipote Matteo,
e di quanto bene gli volessi. Mary mi guardava, la sua mano nella mia, immobile
come rapita da un testo stupendo di una canzone ascoltata per la prima volta.
Mi sono fatto coraggio e le ho avvicinato il piatto e subito si è girata
dall’altra parte. Le ho fatto capire che il caldo mi stava torturando e che la
tuta era tutta bagnata di sudore all’interno, gli occhialini erano quasi tutti
appannati. Faticavo a respirare, eppure mi sforzavo a starle accanto perché
volevo vedesse che m’importava davvero di lei. Poi non ce l’ho fatta più e
mentre mi allontanavo ho sentito la sua mano afferrate il mio braccio. Mi sono
girato e ho visto le sue labbra muoversi, ma non capivo. Un’altra paziente ha
tradotto per me: Mary mi chiedeva di farle il bagno. Mi sono sentito subito
pieno di energie e pronto per fare questo ultimo sforzo prima di uscire
dall’unità di isolamento.
Era debole,
a stento riusciva a stare in piedi, « io ho fatto un grande sforzo per
farti il bagno ed ora ti chiedo di fare lo stesso per
mangiare » . Le ho avvicinato il piatto e sono rimasto altri minuti
ad aspettare che lei aprisse la bocca e finalmente mangiasse qualche boccone di
riso.
Non so
descrivere il senso di vittoria che ho provato in quel momento, una grande
gioia e contentezza. Certo non era
il segno della guarigione, ma comunque un grandissimo passo in avanti, una meta
che non avrei mai creduto di raggiungere. All’uscita dall’unità di isolamento
ho urlato a tutta l’équipe la grande novità, erano increduli. Allora li ho
fatti avvicinare alla tenda da dove si intravedeva Mary masticare piccolissimi
bocconi di riso.
Il giorno
dopo sono tornato, Mary sembrava non volesse mangiare ma dopo il bagno, si è
seduta sul letto ed ha iniziato a mangiare il pane inzuppandolo nel tè. Non
stava proprio bene, era molto debole, ma vedevo che si sforzava ed ero sicuro
che sarebbe migliorata. Nel pomeriggio mi è arrivata la notizia che il
giorno dopo sarei dovuto partire per una missione esplorativa in Liberia, dove
l’ebola continua la sua avanzata. Che rabbia! Proprio ora che Mary reagiva
volevo seguire i suoi progressi e starle accanto. Prima di partire sono andato
a salutarla. Mi ha guardato, ha preso il piatto ed ha iniziato a mangiare,
mentre ero seduto al suo fianco. Prima di uscire dalla tenda le ho fatto ciao
con la mano dicendole che sarei partito ma che ogni giorno avrei chiesto sue
notizie.
È davvero
strano come ci si possa legare ad una persona che si è conosciuta da poco, con
la quale non puoi neanche comunicare. Eppure quella bambina mi emozionava tutte
le volte che la guardavo, non me la tolgo dalla mente.
Sono stato
costantemente informato, ed oggi la grande notizia : « Mary è uscita,
ce l’ha fatta ». Non avevo
parole per esprimere la gioia che provavo e così mi sono coperto il volto con
le mani e come un bambino ho pianto. Non ho la presunzione di pensare di aver
salvato la vita a quella ragazzina che non rivedrò mai più, ma sono certo che
l’incoraggiamento, la vicinanza e la mia testardaggine le siano state da
spinta. Mary poi ha fatto il resto e forse il fato , finalmente, ha dato
il suo contributo.
Non vedo
l’ora che sia domani per iniziare una nuova sfida al fianco di chi soffre e
stimolare il cambiamento che voglio vedere nel mondo.
Massimo
Galeotti, Infermiere MSF in Guinea
Mohamed, Yatta,
Isatta... Bambini positivi al virus Ebola
Mohamed,
Yatta, Isatta, Fatimata, Tamba, Charles, Salomon, Suma, Jusu, Bendu,
Ngebeh...Sono i nomi di alcuni dei bambini positivi al virus dell'ebola nel
nostro centro di trattamento a Kailahun in Sierra Leone. Molti arrivano con le
loro famiglie e poi pian piano ne assistono al decesso o si spengono prima dei
loro familiari. La mortalità tra i bambini è più elevata che per gli adulti (80
90% contro il 70%). Chi è riuscito a sopravvivere ci ha dato lezione di coraggio
e generosità.
Sono stati i
bambini, prima degli adulti, a prendersi cura degli altri bambini positivi
rimasti orfani vincendo la paura di toccare un altro paziente. Hanno
iniziato a rompere il silenzio e con il rumore dei loro giochi e risate hanno dato
speranza a tutti noi.
Abbiamo
assistito alla dimissione di Yatta e Salomon, primi bambini guariti nel centro,
li abbiamo visti salutare gli altri pazienti, ne abbiamo ascoltato la storia di
come l'ebola sia entrata nelle loro vite. Chi per primo nella loro famiglia si
è ammalato e come sono arrivati da noi. Ancora confusi hanno scelto il
loro vestito e i loro giochi prima di rientrare a casa, ci hanno chiesto
chi si sarebbe occupato degli altri bambini ora che loro sarebbero partiti.
Hanno dato una dimensione umana ad un'epidemia che di umano ha poco. A
Kailahun, non ci sono solo bambini, ci sono donne, anziani, intere
famiglie, infermieri, che si sono infettati cercando di aiutare i loro amici,
familiari o pazienti.
L‘ebola
uccide, questo è noto. Quello che non è così noto è che uccide i legami e la
fiducia nei villaggi. Uccide creando la paura di toccare chi si ammala o
salutare chi muore. Nelle settimane trascorse sul campo, ho visto la paura
diffondersi come l‘infezione, ma ho anche visto il serio e dedicato lavoro
di MSF, villaggi e pazienti ringraziarci per il lavoro che facciamo per fermare
ciò che è più grande noi, paura compresa.
Grazia,
Epidemiologa MSF in Sierra Leone
Ebola. Come
assistiamo i nostri pazienti
Questa è la
prima epidemia di Ebola che mi trovo ad affrontare. Ho trascorso le ultime tre
settimane in Guinea, e appena due giorni fa sono arrivato in Sierra Leone
per lavorare nel Centro MSF per il Trattamento dell’Ebola da 65 posti letto.
Sono responsabile della cura del paziente: vado con i medici a fare il giro dei
reparti, somministro flebo se necessario e mi occupo della formazione del
personale locale sulle procedure che bisogna conoscere per trattare questa
malattia.
In Guinea
abbiamo trattato una giovane donna risultata positiva all’ebola, incinta del
suo primo figlio. La maggior parte delle volte, quando una donna incinta si
ammala di ebola, lei e il suo bambino muoiono. Questa donna, invece, ha
perso suo figlio ma è riuscita a sopravvivere. Era visibile come
l’esperienza l’avesse cambiata quando, una volta guarita, è uscita dal Centro
per il trattamento dell’ebola. Era straordinaria.
Il
trattamento per l’ebola è molto semplice e l’assistenza infermieristica è forse
uno degli aspetti più importanti di esso. Inizia con l’igiene: è necessario
lavare i pazienti nel letto e tenerli puliti. Somministriamo loro cibo e
liquidi, a volte sono così deboli che non riescono neanche a mangiare e bere da
soli. È difficile: in Italia, le unità di cura intensiva sono di alta
tecnologia, con monitor e attrezzature di tutti i tipi, mentre qui devi fare
tutto da solo.
Non lavoro
più in Italia da quando, 11 anni fa, ho iniziato a lavorare con MSF. MSF è
il mio lavoro a tempo pieno. Sono stato in Liberia, Angola, tre volte in
Sud Sudan, Bangladesh e Myanmar. Quello che mi piace di questo lavoro è la
vicinanza con le persone, il fatto che sto facendo del mio meglio per
migliorare la loro salute, come se stessi davvero “facendo la differenza” in
questo mondo. Anche qui in Sierra Leone contro l’Ebola.
Massimo,
infermiere MSF, in Sierra Leone
Tute di protezione, forza e tanta
esperienza contro l’Ebola
La piccola
Mary mi guarda con i suoi occhioni grandi, spesso gonfi di lacrime, a volte
assenti come se fissasse il vuoto. Forse non mi ha riconosciuto, del resto
credo sia quasi impossibile riconoscere chi si nasconde dietro una tuta di
protezione, l’uniforme che dobbiamo indossare quando entriamo nel Centro per il
Trattamento del Ebola.
Si tratta di
una tuta di materiale plastico impermeabile, stivali di gomma, due paia di
guanti, una maschera che copre bocca e naso (molto spessa), un copricapo di
materiale plastico che ti deve coprire dalla testa fino sotto le scapole e che
lascia solo gli occhi senza copertura. Poi ovviamente per riparare gli occhi
usiamo occhiali che sembrano maschere da sub e per finire indossiamo un
grembiule di plastica spessa che dal collo ti copre fino ai piedi.
È difficile
descrivere come si lavora quando si indossano tutte le protezioni, ma credetemi
è molto faticoso. All’ interno delle
tende fa caldo e con tutta la plastica che ti porti dietro potete immaginare
quanto si sudi all’ interno della tuta.
Dopo 5
minuti senti le goccioline di sudore che scendono dappertutto. Tutti i
movimenti devono essere lenti, per evitare sforzi ma anche per evitare cadute
accidentali che potrebbero esporti a un possibile contatto con il virus.
Tutte le
procedure invasive (mettere un catetere venoso per esempio) vengono fatte solo
da personale molto esperto e selezionato perché il rischio di contrarre il
virus durante la manipolazione di aghi e sangue è elevatissimo.
La prima
volta che ho fatto un prelievo non nascondo di aver avuto tantissima paura; l’
importante è sempre spiegare bene al
paziente quello che si intende fare e come il paziente si deve comportare
(nessun movimento brusco, restare immobile etc.), avere sempre vicino un
raccoglitore per gli aghi usati, avere un collega che ti passa il materiale,
avere la mano ferma e sentire di avere la situazione sotto controllo.
Quando siamo
dentro, cerchiamo sempre di avere tutto il materiale con noi (medicinali,
antibiotici già diluiti) per risparmiare tempo. Anche respirare è faticoso, non
devi mai cercare di farlo in modo veloce.
Proprio come
succede al mare, le nostre maschere dopo un po’ si annebbiano e non si riesce
più a vedere correttamente. Se a questo aggiungi gli sforzi eccessivi (come
chinarsi più volte per aiutare un paziente a bere o aiutare qualcuno ad
alzarsi) che aumentano la frequenza respiratoria diminuendo l’ossigeno che
entra nei polmoni (ricordatevi che indossiamo una maschera che ci copre la
bocca) capite bene che il senso di soffocamento può avere il sopravvento e
gettarti nel panico.
Bisogna
conoscere i propri limiti, sapere quanto possiamo chiedere al nostro corpo e
quando arriva il momento di fermarsi. Mai prolungare la permanenza nel reparto
d’isolamento oltre i propri limiti.
Alzare la
testa per guardare l’orologio affisso alla parete della tenda, ripetere a un
collega una frase due volte, chinarsi a raccogliere una tazza vuota per dare da
bere a un paziente, aiutare un malato a mangiare sono esempi di azioni
quotidiane semplici ma che se vengono effettuate con la tuta di protezione ti
stancano, ti sfiniscono fino a che non senti il bisogno di uscire.
Quello è un
momento bellissimo… ovviamente c’è una procedura speciale per togliersi la
tuta: tutte le diverse protezioni vengono rimosse una per volta in un ordine
specifico, la maschera è la penultima cosa che togliamo, alla fine l’ultimo
paio di guanti.
È duro e
faticosissimo lavorare con questa tuta, ma non c’è alternativa: la protezione
prima di tutto!
Lavorare
nell’emergenza Ebola ti fa imparare tantissime cose, e sorprendentemente mi
sono accorto di avere più energie e forze di quanto credessi.
Purtroppo la
mortalità è altissima (fino al 90%),
solo il 10% dei pazienti infettati con l’Ebola sopravvive ma senza il nostro
intervento non ci sarebbero neppure quelli… e il virus si propagherebbe
causando una catastrofe. Sono loro che ci danno la forza per continuare, quelli
che riescono a sopravvivere al terribile virus.
Quanta gioia
nei loro occhi quando gli viene detto che sono guariti e quante lacrime…. Il momento della
dimissione è il più bello: tutto lo staff di turno all’ospedale si ritrova di
fronte all’uscita dell’isolamento, e quando il paziente esce tutti iniziano ad
applaudire, cantare e ballare ! È una gioia per tutti. È lì che ti dimentichi
di quanto hai sofferto all’interno dell’isolamento.
Massimo Galeotti, Infermiere MSF in Guinea
“Non ti faremo del male, siamo qui per curarti”
Mi chiamo Ernestina Repetto, sono un
medico infettivologo, ho 33 anni e sono partita con Medici Senza Frontiere in
Guinea a Gueckedou su un progetto Ebola.
La cosa più difficile per un medico che
parte su una Missione Ebola è dover stravolgere completamente il normale
rapporto che si ha tra medico e paziente. Perché ti devi proteggere, tu in
prima persona, e quindi utilizzi dispositivi di protezione individuale (la
tuta, la maschera, gli occhiali, il copri capelli, etc). Quindi i pazienti che
visiti non hanno la possibilità di vederti, vedono solo i tuoi occhi e
ascoltano la tua voce. È molto importante ogni volta che entri ripetere il tuo
nome, il tuo cognome, dire chi sei, se sei un medico o se sei un infermiere,
che sei lì per lui e che gli farai delle domande per sapere come va e se ha dei
sintomi particolari e così via. Devi affidarti al tono della tua voce e basta.
Quando si entra in un Centro di
Trattamento Ebola, la cosa che colpisce di più rispetto a un ospedale
convenzionale è la presenza di barriere. Ogni settore è diviso dall’altro da
doppie barriere con una distanza minima di due metri. Questo permette agli
operatori sanitari e ai visitatori e parenti dei pazienti di avere una certa
sicurezza, una distanza minima per evitare il contagio con i malati, anche in
assenza di protezioni individuali. Chi non è ancora entrato nella zona ad alto
rischio può stare al di fuori e vedere i propri cari e i propri parenti senza
utilizzare la protezione.
Per un paziente che non ha alcuna nozione
di protezione individuale, non sa come siano i guanti o le mascherine, vedere
tre o quattro persone che si avvicinano come degli astronauti, fa molta paura
quindi è molto importante prima di fare qualsiasi cosa con la protezione
individuale spiegare a tutti il perché si utilizzano tali strumenti, che non
siamo degli alieni ma siamo delle persone normali… e farsi vedere sia prima sia
dopo. Da fuori dici: “Io entrerò, sono il tuo medico, mi vestirò con la tuta
per proteggermi e non ti preoccupare non ti faremo niente di male, anzi siamo
qui per te e per curarti”.
Ernestina Repetto, infettivologa MSF
In Sierra Leone
tra i bambini di Gondama e l’emergenza Ebola
Con
Barbara, Kathleen e altri parlo francese. Con Alejandra e Miguel spagnolo. Con
Yuma ed Esther qualche parola di swhaili. Inglese tutto il giorno. La babele di
lingue e la tastiera inglese non mi aiutano certo a scrivere qualcosa di buono
in italiano. Mi chiamo Luca e da quasi due mesi mi trovo nel calore
della Sierra Leone. Lavoro come esperto di potabilizzazione
dell’acqua (watsan manager) tra l’ospedale pediatrico di Gondama,
l’ufficio di Bo e la coordinazione di Freetown. Sono arrivato qui dopo quasi
quattro anni tra Congo, Rwanda, Uganda e Perù. Ma ogni missione è unica e
speciale.
L’ospedale
pediatrico a Gondama
L’ospedale
pediatrico è un progetto di lunga data. Essendo nato come campo profughi non si
trova a Bo, la seconda città del Paese, ma a Gondama, un piccolo villaggio a
poche miglia dalla città. L’ospedale è a pochi passi dal centro, il mercato.
All’ingresso
dei bassi reparti la vita ha la stessa intensità di sempre.
Donne che lavano i vestiti dei bambini chiacchierando tra loro a voce alta,
uomini seduti in cerchio discutono mangiando da un solo piatto, ragazze giovani
con il viso invecchiato si scambiano favori pettinandosi a vicenda. Nonostante
i rumori, le grida e i profumi si sente che qualcosa manca. Bambini.
I
nostri 200 letti spesso non bastano. Tra i reparti abbiamo rubato spazio per le
tende bianche. All’interno le voci restano basse. I pochi bambini che
riescono a camminare non hanno ancora la forza per giocare. Restano
vicini ai letti, spesso una mano ancorata al ferro bianco per non cadere.
L’ospedale è
l’ultima scelta.
Prima c’è la vecchia del villaggio, nel caso abbiano qualche risparmio la
curatrice, qualche erba, piccole incisioni sulla pelle per far uscire il
male. Sono quasi dieci anni che siamo qui.
In
dieci anni una goccia d’acqua può scavare una grotta. Forse le idee sono più
dure ma il fatto non cambia. I bambini continuano ad arrivare tardi,
spesso troppo tardi. Per fortuna anche la gente che lavora con noi è dura
come le idee. Ogni giorno una lotta silenziosa, spesso lunga, a volte contro
qualcosa che nemmeno riusciamo a definire. I risultati però arrivano.
Li vediamo rincorrere una vecchia ruota tra i muri bianchi dei reparti, li
sentiamo ridere e gridare con la voce cristallina che solo i bambini hanno.
Momenti che riescono a ripagare tutti gli sforzi fatti, le frustrazioni e i
capelli bianchi.
Emergenza
Ebola
Stavo
quasi per trovare il mio equilibrio quando è arrivata la notizia. Un caso
di Ebola confermato a Koindu. Un piccolo villaggio vicino al confine
con la Guinea. Mi viene chiesto di partire con un logista e una dottoressa per
valutare la situazione.
La
voglia di dimostrare a me stesso di essere un professionista nella giusta
organizzazione, la responsabilità che pesa su chi ha gli strumenti per
intervenire, un tocco di curiosità e una buona dose d’incoscienza, come direbbe
mia nonna, mi convincono ad accettare. Nel giro di poche ore la “filovirus haemorrhagic fever guideline”
diventa la mia lettura preferita. Tutta l’esperienza di MSF, dei migliori
esperti al mondo, racchiusa in 150 pagine e due soffici copertine rosse.
La
stessa sera carichiamo tre macchine per il viaggio. Tutti in ufficio si muovono
decisi, efficienti, pronti per sostenerci. Le macchine quasi scompaiono sotto
il peso delle tende da campo, centinaia di scatole di medicinali, secchi di
cloro e strumenti vari. Non sono ancora passate 12 ore dalla
conferma del primo caso e noi siamo pronti. Un team per valutare la
situazione e centinaia di articoli per sostenere i piccoli centri di salute
coinvolti.
Dopo
quattro giorni di missione tutti quanti concordiamo che la situazione non potrà
che peggiorare. I villaggi sono vicino al confine con la Guinea dove da marzo è
in corso l’epidemia di Ebola.
Scopriamo
che la presenza del virus in Sierra Leone è dovuta a un funerale.
Cosa abbastanza comune in questo genere di epidemie. Alla morte di una famosa
guaritrice tradizionale molte donne hanno partecipato al funerale. Qui la
tradizione vuole che il defunto venga lavato dai conoscenti dello stesso sesso
e che venga commemorato con pianti, abbracciando il corpo. La famosa guaritrice
era morta giusto dopo un viaggio in Guinea per assistere una paziente affetta
da Ebola. Dagli abitanti dei villaggi veniamo a conoscenza dei nomi delle donne
che hanno partecipato al funerale. E qui è iniziata la lotta
per fermare l’epidemia.
Luca, esperto
MSF di potabilizzazione dell'acqua in Sierra Leone

ALICE SCIALOJA
 |
| Alice Scialoja |
TRIVELLE
La
ricerca di greggio nel mare italiano secondo il presidente del consiglio Matteo
Renzi è un elemento determinante per giocare un ruolo decisivo nel dibattito
energetico internazionale. Opposto il parere di Legambiente che la ritiene,
invece, una scelta energetica assurda e scellerata, un ennesimo regalo alle
compagnie petrolifere.
A
sostegno del proprio punto di vista l’associazione ambientalista cita i dati
che il ministero dello Sviluppo economico pubblica annualmente sulle riserve
certe di petrolio. Le quantità stimate sotto il mare italiano sono, infatti, di
appena 10 milioni di tonnellate, e visto che il nostro
consumo annuo è pari a 61 milioni, si esaurirebbero in soli due mesi. Considerando
anche quelle presenti nel sottosuolo, si arriverebbe a 82
milioni di tonnellate di riserve certe, anche in questo caso però durerebbero
per poco meno di 17 mesi. Numeri che, per Legambiente, sono più che sufficienti
a dimostrare l’insensatezza della strategia che il governo si
ostina a portare avanti. Senza contare che a richiedere permessi di ricerca e
di estrazione sono per lo più compagnie straniere, e che le aree già interessate
dalle attività petrolifere occupano una superficie marina di circa 24mila kmq.
Anche
sul fronte dell’occupazione, secondo Legambiente il confronto non tiene: investire
oggi in efficienza energetica e fonti rinnovabili porterebbe nei prossimi anni
i nuovi occupati a 250 mila unità, cioè 6 volte di più di quello che si
otterrebbe con le nuove trivellazioni.
“Invece di ragionare su
come aumentare la produzione di petrolio nazionale, avremmo potuto mettere in
campo adeguate politiche di riduzione di combustibili fossili -dice il
presidente di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza-
Ad esempio utilizzando
i 4 miliardi euro circa che ogni anno regaliamo al settore dell'autotrasporto,
come avvenuto nell’ultimo decennio, per una mobilità nuova e più sostenibile. Di
certo avremmo avuto riduzioni della bolletta petrolifera e delle importazioni
di greggio ben maggiori e durature rispetto al contributo che possono dare le
poche quantità presenti nei mari e nel sottosuolo italiano. Continuare a rilanciare
l’estrazione di idrocarburi non ci garantisce nessun futuro energetico.
Se veramente si vuole
rompere con il passato -prosegue Cogliati Dezza- e giocare un ruolo strategico
nel dibattito energetico internazionale, il premier deve portare ben altri dati
nel dibattito internazionale. Partendo, ad esempio, dai dati sulle fonti
rinnovabili che con oltre 700 mila impianti hanno garantito un terzo dei
consumi elettrici del Paese”.
Legambiente
insiste sulla necessità di restituire voce e possibilità di scelta ai territori
e alle popolazioni interessate dalle richieste di estrazioni avanzate dalle
compagnie petrolifere. Tra le aree maggiormente colpite dalle trivelle ci sono
il mare Adriatico (con 11.944 kmq interessati dalle attività delle compagnie
petrolifere, tra cui 2 istanze di concessione, 17 di ricerca e 7 permessi già
rilasciati per l’esplorazione dei fondali marini), il canale di Sicilia (dove da
5 piattaforme attive sono estratte 301.471 tonnellate di greggio, il 42% della
produzione nazionale a mare, e vi sono 3 richieste di concessione e altre 10
istanze di ricerca), lo Ionio dove oggi non si estrae petrolio ma vi sono 16
richieste per la ricerca di greggio (per un’area complessiva di 10.311 kmq) nel
Golfo di Taranto, un’area marina vietata alle attività di ricerca di petrolio
fino al luglio 2011. Sono da aggiungere poi i 76419 kmq richiesti dalle società
per avviare attività di prospezione, la prima fase di indagine per individuare
le aree su cui poi eseguire ricerche più approfondite. Sette le richieste: 3
riguardano l’Adriatico, una lo Ionio, due il canale di Sicilia e una il mar di Sardegna.
Non
a caso la sicurezza delle estrazioni petrolifere off-shore è al centro
dell’attenzione dell’Unione europea già dal 2010, dopo il disastro ambientale
della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon nel Golfo del Messico. La
moltiplicazione di queste attività nel Mediterraneo aumenterebbe il rischio di
inquinamento da idrocarburi; senza considerare l’impatto che le estrazioni
possono avere sulla pesca. Intorno a una sorgente sonora che utilizza airgun,
la tecnica geofisica di rilevazione di giacimenti nel sottofondo marino, la
diminuzione del pescato può arrivare al 50%.
Ecco
perché Legambiente ritiene che l’Italia debba giocare la sua capacità competitiva
internazionale promuovendo politiche internazionali di tutela
di tutto il mare Mediterraneo invece di seguire le scelte petrolifere di altri Paesi.
E, per garantire l’indipendenza energetica al nostro Paese, debba spostare
attenzione e risorse su rinnovabili, efficienza e risparmio.
GIORGIA MONTI
 |
| Giorgia Monti |
GREENPEACE:
NEL TONNO IN SCATOLA MOLTE PROMESSE
E
TROPPI DOPPI STANDARD, POCHI I PASSI AVANTI VERSO
LA
SOSTENIBILITÀ
ROMA. Dopo Italia, Austria,
Inghilterra, Canada, Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda, la “classifica
rompiscatole” sulla sostenibilità delle scatolette di tonno di Greenpeace
arriva anche in Francia, dove molti dei produttori più importanti sono
compagnie ben note anche sul nostro mercato. Purtroppo –nonostante le promesse
fatte – il mercato francese evidenzia come l’industria si sia mossa ben poco, e
come siano ancora troppi i doppi standard. C’è tanta strada da fare perché si
abbandoni una pesca eccessiva e distruttiva che sta svuotando i nostri mari.
Agli
ultimi posti della classifica francese Petit Navire, marchio del colosso MWB,
che possiede nel Regno Unito il marchio John West e in Italia Mareblu. Colosso
anche nei doppi standard! Mentre in Italia e nel Regno Unito si era impegnato
negli scorsi anni ad avere entro il 2016 nel cento per cento dei propri
prodotti tonno sostenibile, scopriamo che in Francia non vi è ombra di tale
impegno, e alcune delle flotte da cui arriva il tonno sono state coinvolte in
episodi di pesca illegale.
Da
quanto abbiamo potuto vedere – grazie a un’indagine svolta dai nostri volontari
sei mesi fa nei supermercati italiani – anche Mareblu non sta facendo
abbastanza: la maggior parte del tonno continua a essere tonno pescato con reti
a circuizione, senza alcuna garanzia che non vengano usati dei sistemi di
aggregazione per pesci (FAD) che causano la cattura accessoria di squali,
tartarughe e balene. Meno del 4 per cento dei prodotti esaminati indica in modo
chiaro che il tonno è stato pescato “a canna”, uno dei metodi con minor impatto
ambientale.
Non
brilla neanche Bolton Alimentari, colosso italiano del tonno in scatola,
proprietario del marchio Riomare. L’azienda aveva promesso di avere entro il
2013 solo tonno sostenibile pescato a canna o senza FAD nel 45 per cento dei propri prodotti, ma in Francia non ha
rispettato tale impegno e il suo marchio Saupiquet, il cui tonno è catturato
con metodi di pesca distruttivi, scende nella classifica francese al settimo
posto. Purtroppo la nostra indagine nei supermercati ci fa dubitare che in
Italia la situazione sia tanto diversa: solo il 6 per cento dei prodotti Riomare
trovati nei nostri supermercati conteneva tonno pescato a canna. Se questa è la
“qualità responsabile” di Bolton si conferma il nostro timore che un impegno
poco chiaro, come quello preso sul cento per cento della propria produzione per
il 2017, possa portare ben poco tonno sostenibile nelle loro scatolette.
“Le
aziende devono dimostrare di mettere in pratica le loro promesse, e di farlo
allo stesso modo nei diversi Paesi. Greenpeace controlla con attenzione il loro
comportamento e non permette che i consumatori siano presi in giro” afferma
Giorgia Monti, responsabile della campagna mare di Greenpeeace Italia.
Le
grandi aziende del tonno non sono le sole ad applicare due pesi e due misure.
Nella classifica francese troviamo il tonno di due supermercati francesi,
Carrefour e Auchan, leader nella distribuzione anche nel nostro paese. Al terzo
e quarto posto nella classifica di Greenpeace Francia, perché il 10 per cento
del tonno che finisce nelle loro scatolette è pescato a canna, peccato che di
questi prodotti sostenibili non se ne trovi neanche uno in Italia. Carrefour si
è impegnata a rinnovare la propria politica di acquisti nei prossimi mesi:
speriamo che adotti precisi criteri di sostenibilità, e che valgano per tutti i
mercati in cui è presente.
“I nostri
oceani sono in crisi, e la maggior parte delle risorse di tonno oggetto di una
pesca eccessiva e indiscriminata. Aziende leader del mercato mondiale, come
MWB, Bolton, Carrefour o Auchan hanno la responsabilità di esserlo anche nel
garantire la sostenibilità dei loro prodotti. Solo se riusciremo a cambiare la
domanda che viene da Paesi forti consumatori di tonno, come la Francia e
l’Italia, potremmo generare un vero cambiamento nelle flotte che operano in
mare. Senza tonno non c’è futuro, n’è per i nostri oceani né per queste
aziende”, conclude Monti.
Greenpeace
Italia
ANGELO GACCIONE
.JPG) |
| Angelo Gaccione |
LA PRATICA MERITORIA DEL DONO
Come quasi tutti
i più significativi e monumentali edifici storici di Bergamo, anche il
magnifico convento di San Francesco, si trova in quello che davvero
rappresenta, per la quantità e la qualità dei manufatti architettonici, un
incredibile e ricchissimo museo all’aperto: Città Alta. Vi viene incontro
percorrendo piazza Mercato del Fieno. Entrando l’effetto è spettacolare, almeno
per me, che sono da sempre perdutamente innamorato dell’armonia dei chiostri
medievali e del sereno silenzio che evocano e custodiscono. Per la loro
geometria perfetta, le file di colonne, i capitelli fantasiosi, gli archi, il
pozzo per l’acqua piovana, gli aromi delle piante officinali quasi sempre
abbondanti, e per quel riquadro di cielo che li sovrasta. Due grandi chiostri
-addirittura- vi accolgono in San Francesco: uno detto delle arche (ve ne sono
diciannove e servivano per accogliervi le spoglie mortali dei membri di
famiglie facoltose della città); un secondo detto del pozzo, per una ragione
che non è difficile indovinare, e che guarda verso il profilo delle Orobie. San
Francesco è, da qualche tempo, un ex monastero, perché vi ha sede il Museo
Storico della città. Come tutti i musei accoglie, preserva e mostra. Quella
dell’accoglienza è una pratica meritoria: evita la dispersione di beni privati
-spesso in pericolo se gli eredi sono diversi-, offre un luogo di custodia a
tali beni, li cataloga, li mette a disposizione degli studiosi e della
collettività. Doppiamente meritoria è la pratica generosa e consapevole della
donazione: del donatore disinteressato, di chi dona senza nulla chiedere in
cambio, senza risarcimento, mosso solo dal desiderio della condivisione, di
giovare alla propria città e alla sua crescita civile, all’arricchimento del
patrimonio pubblico, al piacere che la fruizione del suo dono elargirà ai suoi
compatrioti, alla civiltà umana nel suo insieme, e a lui stesso, appagato dalla
gioia profonda della propria munificenza.
 |
| Bergamo. Chiostro di San Francesco |
Trovo che vi sia
qualcosa di sublimemente nobile nel donare. È un gesto che fa di un uomo un
vero uomo, lo umanizza alla massima potenza. Egli non si spoglia con quel gesto,
al contrario si arricchisce, perché ciò che egli ha donato (beni materiali e
beni spirituali) ritorna in cultura, in civiltà, in umanizzazione, perché la
loro diffusione, la diffusione cioè di conoscenze che la sua donazione produce,
allargandosi dal singolo uomo alla collettività, è foriera di notevoli
progressi e arricchimenti. Ogni arricchimento immateriale, cioè intellettuale,
ha una ricaduta concreta, oggettiva, ed innesca un circolo virtuoso di cui
beneficerà la civiltà nel suo complesso. Dunque anche il donatore e i suoi
diretti discendenti.
Alle
donazioni, il Museo Storico di Bergamo ha dedicato uno spazio e lo ha chiamato
“Chambre des dons” (Sala dei doni).
Non capisco francamente perché ricorrere al francese, dal momento che il
termine dono deriva dal latino donum, e con il suo suono pieno,
rotondo, la lingua italiana lo rende mille volte meglio. A parte ciò, mi pare un’intuizione
felicissima: in quella Sala le donazioni ricevute vengono mensilmente esposte,
storicamente contestualizzate e si dà ragione della loro provenienza e delle
motivazioni del donatore. Ogni appassionato ne potrà fruire nel corso del tempo
e la donazione rimarrà un corpo vivo in grado di parlare ai posteri.
 |
| Carlo Rovelli |
PERCHÉ SONO ATEO
Dio è amore. Io credo all'amore e lo cerco. L'amore che dà senso alla nostra vita. L’amore che trascina il mondo. Senza bisogno di aggiungerci Dio. Dio è comunione. Io cerco la comunione con i miei simili, perché è l'acqua che disseta la vita e ci porta a casa. Ma c'è comunione anche fra chi non conosce Dio.
Dio è giustizia. Io voglio stare dalla parte della giustizia, del perseguitato, voglio oppormi all'ingiustizia ogni volta che la vedo, sempre e comunque. E, come molti che credono profondamente alla giustizia, non ho bisogno di aggiungerci Dio.
Dio è mistero. Io vedo il mistero, lo percepisco nella
disciplina che studio, in tutto quello che imparo, di cui vedo i limiti ogni
momento. Sento lo sconfinato misero che è l'Universo. Ma vedo il Mistero, non vedo nessun Dio.
Dio è
preghiera. Io ho bisogno di chiudere i
miei occhi, entrare dentro di me. Cercare il silenzio. Esprimere il canto del
mio cuore. La mia tristezza, la mia gratitudine. La mia sete, la mia
solitudine. Faccio tutto questo, ma non
capisco cosa tutto questo c'entri con un Dio.
Dio è il creatore
del mondo. Io non lo so chi ha creato il
mondo. Ma pensare che lo abbia creato
Dio non mi aiuta capirlo neppure di una virgola. Chi ha creato Dio? Se Dio non è mai stato creato, o si è creato
da solo, o ha creato il tempo, perché il mondo senza Dio non avrebbe potuto
fare a stessa cosa? Io so che ci sono
molte cose che non so. So che ci sono infinite cose che non so. Perché non accettare
la mia ignoranza, invece di raccontarmi favole per difendermi dalla paura del
non sapere?
Dio è
indicibile. Se è così, perché vi
affannate a volerlo dire?
 |
| Carlo Rovelli |
Vivere come Dio
esistesse conviene, diceva Pascal. Può
darsi, ma io ai calcoli di convenienza preferisco l'onestà. Conviene anche vivere come se la morte non
venisse. Ma preferisco guardare in faccia il mio destino, la morte che
viene. Non raccontarmi favole consolatorie
sulla vita dopo la morte.
Amo
le favole. Mi piace raccontarle e ascoltarle. Ma mi piace anche sorridere e
riconoscere le favole come favole.
Dio ha ispirato
produzioni meravigliose, Bach, Dante, Piero della Francesca, Michelangelo, e
forse anche Newton. Io amo Bach, Dante,
Piero della Francesca, Michelangelo, e Newton.
Amo anche Lucrezio, i poeti cinesi, i poeti Zen, e Majakovskij, e
Brecht, che vivevano senza Dio. Dovrei
forse mettermi ad adorare Zeus e Atena perché mi commuove Omero? Devo aderire alla schiavitù solo perché Saffo
e Alceo la sentivano legittima, e permetteva loro di scrivere versi immortali?
Gli esseri umani producono meraviglie, ispirate dai loro pensieri e dalla loro
visione del mondo, ma non per questo voglio aderire alla visione del mondo di
coloro che hanno prodotto capolavori.
Noi
uomini abbiamo bisogno di riti, per riconoscerci, per ritrovarci, come gruppi e
come singoli, per segnare il tempo regolare del mondo e gli eventi importanti
della vita. Celebriamo i nostri riti, piangiamo insieme il dolore dei nostri
morti. Festeggiamo insieme la gioia dei nostri sposalizi. Perché abbiamo
bisogno di un dio per questo? Ho assistito a funerali di atei più intensi e
veri, e a matrimoni di atei più emozionanti e sentiti, che non quelli in chiese
fredde e rimbombanti.
 |
| Carlo Rovelli a destra, al centro della foto Carlo Rubbia |
Dio è la garanzia
su cui si fondano i valori antichi. E i valori fondano la nostra vita sociale.
Ma i valori antichi comprendevano la sottomissione della donna, la legittimità
della schiavitù, la sacralità dei regnanti, l'intolleranza verso gli ebrei.
Tutti valori difesi a spada tratta da coloro che difendevano Dio. Io voglio avere valori. Valori forti. Valori
che guidano la mia vita. Ma i valori che voglio sono quelli che sanno cambiare,
non quelli dei miei antenati, che avevano schiavi, sottomettevano le donne e si
prostravano davanti al re e al feudatario.
I valori che vanno difesi non sono i valori antichi. Sono i valori che costruiamo insieme, che
guidano la nostra vita: giustizia, eguaglianza, amore, bellezza. E soprattutto verità. L'amore per la verità. Che è quello che ci
frena dal lasciarci andare alle favole facili e consolatorie.
La
civiltà umana è cresciuta intorno all'idea degli dèi, molti dèi, o un solo
Dio. Gli dèi sono stati il centro del
pensare umano per secoli. È bello studiare come questo sia avvenuto, come la
religione abbia partecipato al farsi dell'umanità. Poi l'umanità cambia. Lentamente, ma cambia. Piano piano siamo guariti da molte illusioni
e superstizioni. Chi crede in Dio oggi sorride delle credenze religiose
sciocche dei suoi antenati. Non vede che
molti sorridono nello stesso modo delle sue?
Dio è l'assoluto. Dio è quell'assoluto che è assoluta certezza
verso cui il nostro cuore sente di anelare.
Dio è il punto fermo
a cui ancorare il tutto. Ma è il punto
fermo attorno a cui esiste il mondo, oppure un'illusione che ci costruiamo
perché siamo spaventati dalla provvisorietà di quanto c'è attorno a noi? Dal nostro non sapere trovare un’àncora? Quell'àncora a cui ancorare le nostre certezze
non c’è. Inventarne una e darle un nome
non mi piace. Un palo colorato con teste di animali nel centro del villaggio, o
un Dio trascendente da adorare nel profondo del nostro cuore: in ogni caso è
una scappatoia che ci costruiamo, spaventati dal nostro non sapere e dal
vuoto. La sete non prova che c’è acqua
accanto noi.
 |
| Carlo Rovelli |
Rispetto
chi crede in Dio. Non sono io scagliare pietre contro chi vede il mondo diverso
da come lo vedono i miei occhi. E neppure chi preferisce raccontarsi favole
piuttosto che accettare l'incomprensibilità del mondo. Ma preferisco accettare la mia ignoranza,
invece che credere alle favole che ci hanno trasmesso i nostri padri, che non
sapevano più di noi. Sapevano poco: sapevano perfino meno di noi. Accettare l'ignoranza e il mistero intorno a
noi, invece di riempirlo di favole, mi sembra la strada più vera, più bella, ma
soprattutto la strada più onesta.
ROBERTO CICALA
Se “le fiabe sono vere”: ricordo di Roberto Denti
«Le fiabe
sono vere»: sembra ieri che Roberto Denti rilegge al telefono queste parole
proponendo il titolo di un libro che vorrebbe prima o poi scrivere. Le cita dall’introduzione
alle Fiabe italiane di Italo Calvino
perché crede proprio alla verità delle fiabe, che «prese tutte insieme, nelle
loro sempre ripetuta e sempre varia casistica di vicende umane, sono una
spiegazione generale della vita» (il libro è uscito poi nel primo anniversario
della scomparsa del primo libraio italiano per ragazzi, ndr).
Con
lui parlare di libri vecchi e nuovi è sempre l’occasione per meditare sulle
uscite editoriali e sulla cronaca dei giornali, spesso partendo dalle parole
vecchie e nuove incontrate in quelle stesse pagine. «Dentimarci,
sgoff, bussolano» sono per esempio tre termini che lui ricorda perché, pur
strani, gli dimostrano il potere delle parole nella vita: si tratta del suo
cognome storpiato per sfottò alle elementari, dei calzoni alla zuava in dialetto
cremonese che la nonna gli imponeva e del dolce locale comprato coi soldi
rubati ma alla fine facendosi scoprire. Sono tre parole che rinviano agli anni
in cui un bambino occhialuto che non va d' accordo con la pronuncia della
"r" scopre il fascino delle storie cui resta legato fino all’età
adulta, da partigiano, da giornalista e poi da libraio e autore di molti libri.
Da piccolo tra le fiabe preferisce Il
gatto con gli stivali e come compagno d'avventure Sandokan e si
sbizzarrisce con la fantasia tanto da sognare la fuga: la tenta davvero quand’è
ragazzo arrivando in treno a Genova per lavorare come mozzo in una nave (non di
pirati): ma due giorni dopo viene ripescato dalla polizia, con un rientro a
casa sconsolato: «Tutto era uguale a prima. Una cosa soltanto mi colpì subito:
nello scaffale della libreria erano scomparsi tutti i libri di Salgari!» Eppure
quei libri gli cambiano la vita in chiave positiva: così il Robertino
«occhialina, quattr'occhi in vetrina», che tra i banchi di scuola i compagni canzonano,
anche ultraottantenne continua a divertirsi moltissimo con le parole e la
letteratura.
 |
| Roberto Denti |
Conoscendo bene l'arte dei cantastorie, Denti parla sempre con stile
colloquiale a grandi e piccoli nell’idea che la cultura dev’essere utile, alla
portata di tutti, proprio come avviene con le fiabe. Gliel’ha insegnato un amico
degli anni giornalistici giovanili a Milano, Gianni Rodari, secondo cui il
verbo “leggere” non va mai declinato all’imperativo (concetto poi ripreso da
Daniel Pennac) perché «l’amore per la lettura non è una tecnica, è qualcosa di
più interiore legato alla vita». Nell’attenzione sociale e nell’interesse per
le ricadute sull’attualità sta l’eredità e l’importanza della sua riflessione
sul genere della «fabula»: ne indaga le origini storiche come «strada
sotterranea e segreta che aiuta a superare le drammatiche difficoltà
quotidiane». Così ci aiuta a ricordare che «le fiabe sono vere» e per questo la
sua voce sarà sempre con noi, come quella cantilena dei Tatari della Siberia da
lui scelta a esergo del libro-testamento e che non riusciamo a ripetere senza
una vena di commozione, come quando ce l’ha letta la prima volta al telefono: «Tre
mele caddero dal cielo dorato: / una per chi la favola ha domandato / una per
chi la favola ha narrato/una per chi la favola ha ascoltato». Grazie, Roberto,
insegnaci ancora a leggere…

VINCENZO GUARRACINO
 |
| Vincenzo Guarracino |
IL TEMPO DEL NORD
RILEGGENDO IL DISCORSO LEOPARDIANO “SOPRA I COSTUMI DEGL’ITALIANI”
Gli Italiani, qualunque sia la classe di appartenenza, alle “classi superiori” non meno che al “popolaccio”, sono oggi i più cinici del mondo: "ridono della vita: ne ridono assai più, e con più verità e persuasione intima di disprezzo e freddezza che non fa niun’altra nazione".
Privi di amor proprio e di orgoglio nazionale, "passano il loro tempo a deridersi scambievolmente, a pungersi fino al sangue", presi a combattersi l’un l’altro, in una sorta di bellum omnium contra omnes: questo perché ognuno, trincerato nel suo individualismo, per non essere travolto e oppresso, deve imparare a difendersi e combattere.
Cinismo, disprezzo, indifferenza, superficialità, inettitudine, dissimulazione: qualità, queste ed altre, da “paese senza”, non di un popolo che voglia essere “nazione” o “patria”, conseguenze della mancanza di una "società stretta", di “un commercio più intimo degl’individui fra loro” e della carenza di ogni spinta ideale e di un’etica civile capace di legare l’individuo alla collettività, sottraendolo al rischio della “misantropia” e alla coltivazione del suo “pestifero” particulare di guicciardiniana memoria.
È Leopardi a dire questo ed è bene non sottovalutarlo: tanto più sapendo che proprio nel ’24, l’anno del Discorso sopra i costumi degl’Italiani (“acutissimo, tumultuoso e spesso paradossale”, l’ha definito Walter Binni), da cui il giudizio è estrapolato, è immerso, da “Eremita degli Appennini”, tra Operette morali e Zibaldone, nel perseguimento di una sua essenziale battaglia di verità, condotta per via fantastica e insieme riflessiva; e che il deserto e la “ruina immensa” del mondo circostante, la vita come desolante “serraglio di disperati” (come lo definirà nel Frammento sul suicidio, 1832), si applica eroicamente ad esplorarli ed esorcizzarli attraverso una scrittura, di volta in volta analitica ed appassionata, gelida e tagliente ma anche calda ed effusiva, incurante di abbellimenti e “cerimonie”, per corrispondere solo ai moti del “sentimento”.
Una battaglia di “verità”, un impegno di “civiltà”, per un “risorgimento” dalla “barbarie”, per contrastare “ragione geometrica”, “cinismo”, “strage delle illusioni”, con le armi di una corrosiva lucidità: davvero un “angelo” dalla spada sguainata, il Leopardi del Discorso, “chiuso nella sua corazza” di intelligenza, come lo vedrà Walter Benjamin in una celebre pagina sui Pensieri.
Attraverso una diagnosi impietosa, condotta con "la libertà e sincerità con cui ne potrebbe scrivere uno straniero", “senz’animosità” e al tempo stesso appassionata: costruttivo, insomma, sorretto dall’ansia di “ravvivare” quell’essenziale “amore verso la patria”, da cui hanno principio “probità e nobiltà” di un popolo degno di questo nome, come dichiara nella Prefazione alle Dieci Canzoni dello stesso anno: una cosa nuova e imprevedibile rispetto a ciò che emergeva da tanti testi in prosa e in versi degli anni precedenti, governati da uno sdegno tra patetico e velleitario dinanzi al “secol di fango” e alla “mediocrità” dei contemporanei, a testimonianza della mobilità dell’orizzonte teorico e morale, tutto in progress, “al presente”, dello scrittore.
Lucido e impietoso, disincantato, il ritratto che ne emerge degli Italiani, nel progressivo crepuscolo di ogni illusione e grandezza, con sullo sfondo le “altre nazioni” europee con “più vita” e con “più società” rispetto all’Italia, istituendo con esse una sorta di confronto-scontro antropologico.
Lucidamente polemico, ma non da non lasciare intravedere dietro la diagnosi dura e spassionata, assieme a una nostalgia di verginità, un lievito diverso, una sollecitudine drammaticamente moderna per la “patria infelice”, proprio mentre si sofferma sgomento di fronte alla “strage delle illusioni”, destinata a riecheggiare lividamente nel “silenzio nudo” del coevo Cantico del gallo silvestre, metafora assoluta dell’”arcano mirabile e spaventoso” dell’esistenza ma anche emblema del deserto morale e culturale dell’Italia.
Un deserto senza consolazione, un “secol morto”, un “secol di fango” oppresso da una greve “nebbia di tedio”, da inguaribile “mediocrità” (Ad Angelo Mai, 1820), davvero: di questa Italia forse davvero è meglio “ridersi” come fanno gl’Italiani, senza bisogno di addentrarsi oltre nell’esegesi leopardiana.
A meno di non soffermarsi su un punto, conclusivo ma non marginale, del Discorso.
Mi riferisco al passaggio dove l’anomalia dell’Italia rispetto ad altri paesi, quelli virtuosi della “rinata civiltà” (Inghilterra e Germania), viene segnalata in termini che rivelano una loro intrigante attualità.
Oggi, dice, “sembra che il tempo del settentrione sia venuto”: come sottrarsi a una sensazione nuova di fronte a questo fantasma della “modernità”, che da qui aleggia e si protende sulla storia, disegnando una sorta di diagramma dell’ineluttabile marcia della civiltà dal Meridione ai paesi del nord dell’Europa, come in una sorta di materialismo dialettico, in nome della “superiorità della loro immaginazione?”
C’è un che di oggettivo e insieme di profetico in questa affermazione. Il rilievo assegnato a un Nord “civile” che sopravanza gli altri paesi, con l’Italia confinata nel confronto in condizioni di oggettiva inferiorità civile non meno che culturale, è l’elevazione del tema della “modernità” a dato necessario oltre ogni negatività.
È in questo che risiede la vera novità, la parte teoricamente più originale del Discorso e l’attualità di questo Leopardi: nella scommessa sulla “modernità”, un fatto che ha i tratti della necessità di una nuova eticità, di una nuova “scienza dell’uomo”, intesa come nuovo modo di porsi di fronte alla vita con la consapevolezza della piccolezza e finitudine umana e insieme l’esigenza di un modo diverso di stare insieme con gli altri esseri, che sembra essere prerogativa dei popoli giovani del Nord che posseggono quanto è necessario per inaugurare una “rigenerazione” civile e morale (“le virtù, le illusioni, l’entusiasmo, in somma la natura”, Zib.115).
Oltre “la strage delle illusioni”, oltre il riso illividito di Bruto (un “ridere” per esorcizzare rovine e l’“infinita vanità del tutto”), Leopardi si protende, già “erta la fronte” e “renitente al fato”, nel presagio di nuove consapevolezze ed urgenze sentimentali ed etiche. FILIPPO GALLIPOLI
 |
| Filippo Gallipoli |
STANZE PERDUTE STANZE INACCESSIBILI
Ci sono stanze
nelle quali avete abitato, sostato, vissuto -in un tempo indefinibile- e che
inevitabilmente, avete perduto. Con esse avete perduto città, amori, legami,
sensazioni. Quelle stanze sono ora un ricordo lontano, polvere, silenzio e
buio.
Potete
visitarle solo in sogno.
Se
fosse possibile tornare in quei luoghi non li riconoscereste perché non vi
appartengono più. Quelle stanze sono di altri
-estranee- .
 |
| Filippo Gallipoli "Stanze perdute, stanze inaccessibili (acrilico) |
Non
erano anguste, ma ampie e vuote con pochi essenziali mobili. Eppure le avete
amate, riempite del vostro amore, della vostra disperazione, del vostro
sentire, delle vostre speranze e illusioni. Non
tornereste mai più in quelle stanze e, del resto, nessuno vorrebbe condividerle
con voi. Sono ormai penosamente mutate. Il tempo le ha rese perdute e
inaccessibili.
Raggomitolato
in qualche angolo buio di quelle stanze -o della vostra memoria?-
In
momenti di raro e assoluto silenzio, si può ancora avvertire come un lieve
ansimare.
Quelle
stanze, che sapevano ascoltare, hanno racchiuso in esse il vostro respiro -per
sempre-.
(Viterbo 30
giugno 2004)
***
 |
| Filippo Gallipoli |
PIERO LOTITO
Spaccò la pietra e trovò un pesce
fossile. Il pesce fu come attraversato da una scarica elettrica, e cominciò a
gonfiarsi e a muovere gli occhi e la coda. Poi fece un salto e rotolò per terra.
E là rimase, stupefatto e dunque nuovamente fossile. L’uomo gettò la pietra e
batté le mani per scuotere la polvere. Poi cercò una sigaretta e accese. Fissò
il pesce, finito fra altre pietre, forse materne anch’esse, e si mise a
pensare.
Passò
in alto, molto in alto, un aereo supersonico. Come i ragni e le lumache, così l’apparecchio
si tirava dietro una sottilissima bava che subito tagliò in due il fondale
azzurro.
Il
cercatore di pesci fossili aveva una strana storia. Metà uomo e metà pesce egli
stesso, riusciva a nascondere la sua seconda qualità portando larghi abiti e
mai scoprendosi in pubblico. Come tegole ben disposte, squame iridescenti gli
ricoprivano il corpo. Una pinna, pieghevole come un ventaglio, gli segnava il
dorso, dalla nuca ai glutei. Per questo egli fuggiva le spiagge e il mare, e
ogni volta che una donna gli passava la mano sopra la spalla, la respingeva e
fuggiva. Uomini così si nascondono anche nei sotterranei della metropolitana e
nei cinema all’ultimo spettacolo, quando è facile che qualche torace venga scoperto
perché le squame prendano aria.
Allora,
quel giorno. E quel pesce.
Perché
era di colpo ritornato alla morte? Il cercatore gettò il mozzicone e camminò
attorno al fossile. Pensò che mai sarebbe riuscito a risolvere il problema
della propria duplice qualità. Quale parte di sé sarebbe tornata a nascere? E
quale sarebbe di nuovo morta?
Una
lucertola con la coda mozzata, luminescente e nervosa, gli passò tra i piedi.
Egli alzò lo sguardo e vide nuvole bianchissime che calavano a farsi pungere da
sventolanti eucalipti.
 |
| Piero Lotito |
Raccolse
il pesce, lungamente lo soppesò, e poi fece tre giri su se stesso, come usano i
discoboli. Il fossile fu gettato in aria con la violenza dei missili. Salì
dritto e infine, quasi fermandosi, cominciò a cadere. Lo afferrò al volo un
cormorano, scagliato in caccia da un soprassalto di vita. Ma subito il fossile -troppo duro, pensiamo- fu lasciato
cadere. Ora fragilissimo, brillando al sole, piombò fra gli eucalipti e si
frantumò al suolo. Fu come la rovina di un cristallo.
Il
cercatore di pesci fossili puntò il luogo dell’impatto e vide aprirsi una
nuvola di luccicanti, infinitesimi frammenti. Per lo stupore, rifece col
fischio il sibilo di quel proietto e poi si strappò le vesti, scoprendo le
squame. Pochi momenti così, immobile, e si allungò per terra a cogliere
anch’egli qualcosa del sole.
Lo
colpirono raggi intermittenti e rossastri. Poi, qualcuno accese un arco voltaico
tra cielo e terra. E in un lampo -una luce di inimmaginabile candore- la
mutazione avvenne. La sabbia assalì il corpo, e quell’uomo finalmente apparve quel
che era: un cercatore di pesci fossili ormai fossile.
GIOVANNA ROSADINI
 |
| Giovanna Rosadini |
Inedito
Let me be faithful to the central meanings:
I.
Saremo sempre profili in controluce
incisi sulla linea
d’orizzonte, sospesi
al blu fondo e
salino che regna d’estate
nel tempo senza tempo di ogni infanzia
II.
Saremo sempre quell’eco di passi
nella nebbia che stinge le calli,
Venezia culla d’acqua
in cui nuotiamo in attesa
del mondo che verrà,
pesci pilota che smossi
si cercano e si sono trovati
III.
Saremo sempre in quel tondo di luna
magrittiana appeso sopra i tetti di Milano,
a respirare l’aria leggera della sera mentre
fa scuro, e l’ultimo cielo si colora di presagi
IV.
Saremo sempre l'intuizione
dentro lo sguardo colto
al primo incontro, aver visto
nell'altro il fermo immagine
che il tempo non intacca,
la forma di un'infanzia
che dura e non si stacca

ELIO VELTRI
 |
| Elio Veltri |
L'EVASIONE FISCALE IMPERVERSA MA RENZI
NON VEDE, NON SENTE E NON PARLA
Nel suo
capolavoro “Dei delitti e delle pene”,
il libro che più di qualunque altro ha influenzato la cultura civile e
giuridica del l700 e dei secoli successivi in Europa e nel resto del mondo,
Cesare Beccaria scrive che “l'unica e vera misura dei delitti è il danno fatto
alla nazione”. Il più grande danno che alcuni milioni di cittadini fanno a
questo nostro paese è l'evasione fiscale: 200 miliardi di euro sottratti alle casse
dello Stato, che è a un tempo un furto e una rapina. Essa va di pari passo con
la corruzione diffusa e la criminalità organizzata e ne costituisce l'altra
faccia della medaglia. Dopo due secoli e mezzo, Papa Francesco, che per
personalità, missione, cultura non potrebbe essere più distante dal Gran
Lombardo, di fronte a 500 parlamentari e uomini di governo, ha affermato:
“Io perdono i peccatori. I corrotti no”. E quindi, gli
evasori e i collusi con le mafie, No. Neanche se fanno la comunione tutti i giorni.
La guardia di finanza calcola che
l'evasione da esportazione illecita di capitali equivale al 29% del totale
dell'evasione del paese. Quindi, ogni anno da 60 a 70 miliardi di euro
sottratti allo Stato, volano verso la Svizzera, il Lussemburgo, paradiso fiscale governato per venti anni dal
neo-presidente della Commissione Europea, e verso altri paradisi fiscali.
L'Europa con ossessione quotidiana reclama dai paesi membri riforme di
struttura, ma non fa quelle necessarie per affrontare il problema dell'enorme
differenza dei sistemi fiscali, dell'evasione e dell'esportazione illegale di
capitali, risolvibile solo con la omogenizzazione dei sistemi fiscali dei paesi
membri e la lotta senza quartiere ai paradisi fiscali, fino all'adozione di
embarghi finanziari e alla chiusura di quelli che sono collocati sul suolo
europeo. Il governo non se ne occupa e tace e così fanno in Parlamento
maggioranza e opposizione. Tutti zitti perché gli evasori votano, sono circa 15
milioni e nessuno vuole rinunciare ai loro voti. Ma qui stiamo parlando dei
grandi evasori annidati nell'economia sommersa e criminale, pari a 600 miliardi
di PIL, che non sono certo milioni e trafficano indisturbati. Lo Stato riesce a
snidarli con difficoltà, ma anche quando ci riesce, non è capace o non vuole
farsi pagare. Qualche dato fa capire meglio la situazione. Il governo Letta,
rispondendo a due “question time”,
aveva informato il Parlamento che dal 2000 al 2012 su 807 miliardi di
tasse accertate e messe a ruolo, lo
Stato aveva incassato 69 miliardi pari a 9 euro su 100. Oltre 100 miliardi non
erano esigibili per fallimenti vari e considerati altri impedimenti lo Stato
rimaneva creditore di 540 miliardi di euro. Ma ministri, burocrati e Agenzia
delle entrate hanno lasciato capire che quei soldi lo Stato non li incasserà
mai. Questo perché, normalmente, a fine contenzioso incassa il 3-5% di quanto
dovrebbe. In qualsiasi paese europeo e negli Stati Uniti un governo che si
comportasse allo stesso modo dovrebbe dimettersi. In Italia non succede nulla
perché non si riesce nemmeno a parlarne seriamente. Se si esclude Report di
Milena Gabanelli, la televisione ignora il problema. Eppure i debitori con
debiti maggiori di 500 mila euro valgono il 40% delle riscossioni complessive.
Quindi non stiamo parlando del bar sotto casa e nemmeno di imprese familiari.
Altro dato: chi deve al fisco più di 50 mila euro rappresenta circa il 3% delle
rateizzazioni ma il 53% degli importi da incassare mentre i piccoli debiti fino
a 5000 euro rappresentano l'11,3% dei debiti complessivi delle rateizzazioni in corso, pari a 25,5
miliardi. I dati confermano che facendo
pagare le tasse ai grandi e medi evasori si possono trovare i soldi da investire
in scuola, ricerca, innovazione e servizi pubblici essenziali.
Una politica
che ricava le risorse per mandare avanti il paese quasi esclusivamente dai
redditi fissi sovverte anche i pilastri della democrazia liberale e la sua
regola centenaria: “No representation
without taxation”. Invece,
soprattutto i grandi evasori sono rappresentati e come!
Ma anche quelle
dell'etica pubblica e della decenza, quando include nel PIL i proventi del
traffico di droga, della prostituzione della tratta degli esseri umani, del contrabbando.
Questa è anche una vergogna europea. Il che non dovrebbe consolarci.
RISIKO 1435
Questo è un
gioco, e come tutti i giochi, prende qualcosa dal reale e lo adatta imponendo
alcune regole. Il gioco proposto è di tipo mentale. Una via di mezzo tra un calembour e un Risiko spazio temporale.
Dispieghiamo la mappa. Gravitiamo intorno al 1435 secolo
più, secolo meno. L'ultima crociata, l'ottava o la nona, secondo lo storico che
le conta, si è conclusa da poco con un nulla di fatto per i cristianissimi sovrani
e l'agognata Gerusalemme è rimasta in mani infedeli.
In questo Risiko alcuni eventi sono collocati in Boemia e
Moravia. Qui gli ussiti sono divisi in utraquisti e taboriti e si massacrano nella
battaglia di Lipany. In gioco questioni fondamentali come la somministrazione
dell'eucarestia sotto le due specie farinacea e vinicola.
Nell'Europa occidentale, qualche anno prima a Rouen la
pulzella Jehanne eretica per gli inglesi e santa per gli altri, viene
arrostita. Per cent'anni tra tregue ed armistizi in questa area del nostro Risiko si tagliano teste e si sbudellano
inglesi, bretoni, portoghesi e navarresi da una parte e francesi, castigliani,
scozzesi, genovesi, boemi, dall'altra.
Cento anni dopo, Lutero, disquisendo sulla Grazia disgiunta
dalle Opere e inveendo contro la simonia dà la stura ai movimenti scismatici
così che tutti, papisti in testa, coopereranno per i secoli a venire a
rifornire i cimiteri di tutta Europa mantenendo, in modo discutibile,
l'incremento demografico. E in questo bailamme di confessioni, gli ebrei
sefarditi o aschenaziti che siano, continueranno ad essere relegati nei ghetti
e additati al pubblico ludibrio come il popolo deicida.
Le conseguenze, anche di rivincita, sono ben note.
Nel 1492 poi, la mappa del nostro Risiko si amplia ma le
streghe continueranno ad essere bruciate ad ogni latitudine e indios e indiani
decimati a sud come a nord. Certo, le ideologie religiose si mescolano e si
confondono con altri interessi, come sempre, come ora.
Ma torniamo al punto di partenza, il 1435.
Il 1435 è l'attuale anno secondo il calendario mussulmano.
Sunniti, sciiti, yazidi, jihadisti, mosadisti e via
elencando, nel nostro gioco sono gli attuali calvinisti, anglicani, ugonotti,
ortodossi, evangelici, luterani, dolciniani. Anche questo elenco è lungo.
In qualche modo l'occidente-occidente nei seicento anni che
lo separano dal 1435 è riuscito solo da pochissimo (potremmo indicare il 1945
come esile e discutibile spartiacque) a trovare forme di convivenza e di
tolleranza religiosa, ma non razziale e politica. Nel calendario della storia,
solo da ieri mattina l'occidente e la cristianità hanno iniziato a invocare la
pace e a non benedire bandiere e cannoni. L'occidente si accontenta di
costruirli e venderli o a partecipare agli utili.
Bernardo di
Chiaravalle aveva giustificato il malicidio: i crociati non uccidevano uomini e
donne, ma il male che era in loro. Oggi, ai contemporanei “bernardi” ideologi
che si chiamano Bush, Khomeini,
Ahmadinejād, Bin
Laden ai quali si aggiungono pensatori
(?!) nostrani, si sono affiancati gli anonimi “bernardi” dell' economia (le Spa
originariamente si chiamavano società anonime) giustificando le migliaia di
operatori del mercato delle armi con la
tesi che loro responsabilità è unicamente quella di costruire buone merci.
Devono essere efficaci, funzionali, di basso costo e soprattutto devono
incrementare il pil e le esportazioni.
Nel gioco del Risiko vince chi raggiunge per primo il
proprio obiettivo, ostacolando ed eliminando gli avversari nel raggiungere il
proprio. Ed è a questo ciò a cui stiamo assistendo, consapevoli solo del fatto
che la carta dei veri obiettivi dei duellanti sarà mostrata solo alla fine del
gioco.
Il colonialismo in
tutte le sue sfaccettature in cui è evoluto e si manifesta oggi, ha solo
seminato e semina venti che si trasformano inevitabilmente in tempesta.
FRANCO TOSCANI
 |
| Franco Toscani |
Il socialismo etico-libertario di Stefano Merli.
Una ricerca appassionata e instancabile.
Tutta la ricerca
storica e teorico-politica di Stefano Merli (1925-1994) ci sembra percorsa da
cima a fondo da un filo conduttore, quello rosso del socialismo etico-libertario.
Nonostante la sua esplicita, orgogliosa militanza e appartenenza al socialismo
e alla sua storia, egli non fu mai uno storico di partito dogmatico e
ideologico, sia perché il lavoro di storico era per lui al servizio innanzi
tutto della verità sia per il privilegiamento
accordato per gran parte della sua vita alla dimensione strutturale,
economico-sociale (si pensi soltanto alle caratteristiche del suo capolavoro
pubblicato in due volumi presso La Nuova Italia di Firenze nel 1972-1973 Proletariato
di fabbrica e capitalismo industriale. Il caso italiano: 1880-1900),
rispetto a quella più strettamente politica e attenta alla forma-partito, alla
quale comunque egli prestò grande
attenzione sempre in stretta relazione
alla dimensione sociale e di classe.
Figlio del mondo
contadino e operaio della campagna piacentina, in cui affondavano profondamente
le mai rinnegate sue radici familiari, Merli non ha mai tradito queste origini,
che ha anzi ereditato e assorbito fruttuosamente nel suo peculiare stile di
vita e di lavoro, nella sobrietà e coerenza dei costumi di vita, nella ostinata
fedeltà al socialismo, nella stessa
pratica teorica.
Accademico fra i più antiaccademici, naturalmente anticonformista,
Merli fu docente universitario a Siena, Venezia e Milano, alla sua morte donò
ai piacentini, per la precisione all' "Istituto storico della resistenza e
dell'età contemporanea" di Piacenza migliaia di preziosi volumi, tuttora
in possesso dell'istituto e consultabili da parte della cittadinanza.
La sua straordinaria attenzione alla soggettività concreta, in
carne e ossa dei lavoratori, alle reali condizioni di vita e di lavoro delle
classi subalterne, ai temi dello sfruttamento e dell’alienazione nasceva
proprio dalla stessa personale esperienza di Merli nel mondo contadino e
operaio della sua infanzia e gioventù. Quello era il suo mondo, l’aria che
respirava nei suoi anni giovanili.
Scrive Maria Grazia Meriggi in riferimento al già citato Proletariato di fabbrica e capitalismo
industriale: “Il lavoro di Merli brulica di operaie tessili, cappellaie,
guantai, edili avventizi, coloni delle cascine che si spingevano fin nei pressi
del centro di Milano, di trecciaiole, di artigiani impoveriti (...). Nel suo
lavoro, che non è né storia sociale né storia politica soltanto, ma storia di
una esperienza di crescita sociale nel suo farsi , intessuto di
soggettività politica e anche straordinario repertorio di fonti, il tracciato
delle nuove organizzazioni si intreccia alla descrizione delle condizioni del
nuovo proletariato: organizzazione e tecniche di lavoro,orari, salari, razioni
alimentari e condizioni igieniche, rapporti gerarchici, vicinanza paterna e
durezza autoritaria, violenza su donne e bambini che continuava la disciplina
parafamiliare della bottega artigiana su nuove basi”.
La ricerca di Merli è stata caratterizzata per tutta la vita da
una lunga fedeltà alla passione per il movimento operaio delle origini che
aveva sollecitato alla ricerca anche Gianni Bosio tra gli anni ‘50 e ‘60.
 |
| Stefano Merli |
Lo sguardo storico di
Merli non era però soltanto retrospettivo; il suo ritorno indietro, alle
origini del movimento operaio voleva essere ed era al tempo stesso un balzo in
avanti, un protendersi verso un nuovo inizio, verso l’avvenire della sinistra e
del socialismo.
Col Nietzsche - un autore,
per la verità, a lui non caro e non congeniale per tanti aspetti e motivi comprensibili - della seconda delle Considerazioni
inattuali (intitolata Sull’utilità e il danno della storia per la vita,
1874), Merli avrebbe potuto convenire sul fatto che “noi abbiamo bisogno della
storia, ma ne abbiamo bisogno in modo diverso da come ne ha bisogno l’ozioso
raffinato nel giardino del sapere”.
Ne abbiamo bisogno per le esigenze della nostra vita e della
nostra azione nel mondo, “a favore di un tempo venturo”. Il senso autentico del
passato storico consiste per Nietzsche in un robusto nutrimento per il presente
e per l’avvenire, per l’invenzione della realtà storica.
Se si fosse confrontato con questo saggio del pensatore tedesco,
Merli sarebbe stato concorde in
particolare con la critica nietzscheana della “storia antiquaria”, capace solo
di conservare e non di generare vita. Lo studio della storia
passata, l’autentica cultura storica che non è “innata canizie” conduce infatti a produrre nuova storia, a inventare
il presente e il futuro.
Così in Merli è sempre stata salda la convinzione che la storia
del movimento operaio va riletta radicalmente ai fini di una nuova ripartenza
della sinistra; oggi, scrive nel 1992 su "Il Ponte", “i profeti
disarmati si prendono le loro soddisfazioni e i vinti di ieri (fossero dentro o
fuori il moderno principe) riemergono dall’oblio e dal disprezzo come i profeti
del domani” .
Una sorta di testamento spirituale di Merli è affidato così, ci
sembra, ad uno scritto preparato per il convegno Perché vissero, perché
vivono. Giacomo Matteotti, Bruno Buozzi, Eugenio Colorni, tenuto a Roma il
15-16 giugno 1994 (dunque, poche settimane prima della sua morte, avvenuta il
18 agosto), il cui esordio è già particolarmente perentorio e significativo:
“Matteotti, Buozzi, Colorni. Perché vissero, perché vivono. E’ presto detto.
Per affermare un’idea di socialismo”. Qui Merli rivaluta il riformismo inteso alla
maniera di Matteotti, Buozzi e Colorni e ribadisce che il socialismo libertario
non prevede solo il consenso, ma anche e soprattutto la partecipazione attiva e
concreta delle masse al potere.
Due sono le principali direzioni polemiche che guidano questo
scritto, breve ma assai importante, di Merli. Da un lato, nel nome dell’anticomunismo socialista che recupera la
corrente antigiacobina, autogestionaria e libertaria del socialismo italiano,
la polemica è indirizzata (come di consueto nell’ ultima produzione del nostro
autore) contro il comunismo statolatra e il suo sistema totalitario, il
velleitarismo-nullismo massimalista, il regime del Partito-Stato che riduce a
tragica caricatura la democrazia consiliare, l’autogoverno popolare e la parola
d’ordine del potere ai Soviet (a cui pure si richiama), il modello di direzione
dall’alto, autoritario-giacobino della conquista violenta del potere, destinato
a sostituire una dittatura con un’altra, non meno orrenda e oppressiva (anche
se mutata di segno) e a trasformare i lavoratori, i cittadini, la società -non
più soggetti e protagonisti del socialismo- nel predicato di un partito
rivoluzionario deificato e onnipotente.
Da un altro lato, Merli polemizza - e pure questa ci sembra un’indicazione
assai valida per noi, per il nostro
tempo in cui il termine “riformismo’ è sbandierato pressoché in tutte le salse
e da tutte le parti, da destra a sinistra, molto spesso in termini insulsi e
ben poco credibili - contro il riformismo della “politica politicante”, del
piccolo cabotaggio, il “socialismo del
sottogoverno”, l’usura dello statalismo e del trasformismo socialdemocratico,
il ritorno alle tendenze individualistiche, lo smarrimento di un’autentica,
seria via riformatrice.
Il senso di queste considerazioni è rivolto -con ostinazione e
cocciutaggine- a una radicale e
spietata autocritica del socialismo e
della sua azione politica. Per una ripartenza reale, per affermare, appunto,
una nuova idea e pratica di socialismo, attenta alla questione ambientale e
all’abitare ecologico, ad esempio.
Che cosa ci lasciano
in eredità, fra l’altro, la vita e l’opera di Stefano Merli? Pensando non solo
alla sua produzione scritta, ma anche alla sua forte e tenace personalità, alla
sua energia libera e creativa, alla sua brillantezza e vitalità di uomo e di militante, alla
sua generosità, alla genuina passione
per lo studio e per la politica intesa nel senso più alto e nobile, originario
e greco della parola, il messaggio che ci viene è inequivocabile, è un invito
alla resistenza e alla libertà creativa, a un rinnovato tentativo di invenzione
storica nella direzione del socialismo libertario, della democrazia radicale,
della partecipazione popolare e del
controllo dal basso del potere.
Può darsi che tutto ciò -nell’epoca del trionfo della tecnica e
dell’economia, del sistema delle merci e del capitale, del denaro e del
mercato, in cui nuove, spaventose forme di alienazione e di barbarie si
delineano- sia un’utopia, ma ci pare pur sempre un’utopia concreta, generosa e
fruttuosa.
Ora, a vent'anni dalla sua morte, resta il rimpianto per la vita di Stefano Merli troppo presto conclusa,
per il suo lavoro incompiuto, per la nostra amicizia troppo presto interrotta,
per ciò che non ci siamo detti e che non ci diremo mai più, per un dialogo
fertile e fruttuoso brutalmente troncato, ma resta pure la consapevolezza del
valore della nostra amicizia, dei suoi frutti e stimoli sempre vivi, della
ricchezza e fertilità dei suoi scritti e del nostro rapporto personale, della
sua figura vitale, del suo invito alla ricerca e al lavoro rigorosi, delle sue
idee appassionate.
Uno dei miei maestri, il filosofo Enzo Paci, amava dire che
“occorre fare della nostra vita la nostra passione”. Stefano Merli vi è
pienamente riuscito e non cessiamo per questo motivo di ringraziarlo.
GIUSEPPE
PUMA
 |
| Giuseppe Puma |
Khalid è vivo
Sono
solo pieno di dolori,
di
questo io mi lamento.
Il
respiro è normale
seguendo
l’imposizione dei bronchi.
Passeggio,
di sabato, lungo il Naviglio Grande a Corsico,
dove
insistono nei due lati
poche
bancarelle di cianfrusaglie,
mentre
eleganti canoe lo percorrono veloci.
Khalid
è vivo. E’ da anni,
oramai,
che è vivo.
Fuggito
nudo dal Magreb
nelle
grinfie dei trafficanti,
che
precedono vittorie o disfatte,
è
stato raccolto senza resistenza,
come una bottiglia vuota,
sul
greto di una spiaggia siciliana.
Pochi,
vecchi, usati e multiformi oggetti
coprono
un leso telo arabescato a terra steso:
è
la bottega ambulante di Khalid.
Guardo
il suo sguardo compassionato
di
uomo finalmente libero.
Guardo
con tenerezza le sue fattezze olivastre.
Lo
giustifico, anche senza alibi,
perché
non c’è più spazio
per
chi sentenzia punture di presunzione.
Compro
per due euro
una
minuscola scultura di marmo
e
vado.
Pochi
metri e mi giro,
noto
che mi guarda, mi sorride
nell’incrociare
i nostri intimi occhi.
Sono
pieno di dolori,
ma
respiro normalmente.
Diventerò
un
involto essiccato si ossa
o
una curva e riprovevole
appassita
foglia di carne
o
uno stoppino che si logora
deponendo
luce fioca e memoria.
Ma
Khalid è vivo.

MICHELE
SANGINETO
 |
| Michele Sangineto al lavoro |
Dalle mani il
suono
Sono nato ad
Albidona, un paesello dell’alto Ionio fondato dall’indovino Calcante e da Agamennone
mentre fuggivano dalla guerra di Troia; sono l’ultimo di tre figli, cresciuto
in una famiglia nel culto della dignità, della ricerca di un miglioramento
sociale, ma educato anche alla curiosità e alla socialità. Da giovinotto mi sono
trasferito in Brianza dove ho lavorato un anno come operaio. Rientrato al mio
paese, data l’insistenza di mio padre, factotum del paesello, e di mia madre,
donna energica e laboriosa, ho conseguito il diploma di Maestro d’arte. Nel
1973 vengo incaricato come docente di arte applicata all’Istituto d’Arte di
Monza, una scuola molto vivace.
Da
un paesello sono stato catapultato in una grande città e all’inizio fu
difficile: spesso incontravo una sorta di preoccupazione e di diffidenza nei
miei confronti, in quanto emigrato meridionale. Facevo fatica persino a trovar
casa. Ciononostante ho subito cercato di stare il più possibile in mezzo alla
gente e poco alla volta mi sono integrato e ho trovato qui la mia strada e, per
così dire, la mia seconda patria. La verità è che mi sento in debito con Monza.
Questa città mi ha dato tutto.
E’
così che nel partecipare a tutte le manifestazioni politiche, sociali,
artistiche, mi sono trovato in un vortice meraviglioso, quello della musica e
degli strumenti musicali. Un giorno un ragazzo mi chiese aiuto per riparare uno
strumento africano. Nel metter mano a quell’oggetto d’arte, in cui forma,
materiali e sonorità erano un’unica ricerca di armonia, mi sono incuriosito e
ho cominciato ad appassionarmi a questo mondo. Così ho iniziato la mia sfida a
costruire strumenti musicali a corda, quindi l’arpa, strumento affascinante e
complicato, allora poco conosciuto. Mosso dalla passione ho iniziato a costruire
senza alcuna indicazione dal punto di vista scrittografico o verbale. Non c’è nulla
che possa sostituire la pratica e l’intuizione, le sole cose che fanno capire
fino in fondo cosa si sta per fare. I segreti sono semplici: conoscere la
tecnologia del legno, saper leggere i disegni, saper incollare a perfezione,
saper levigare e tante piccole cose che si acquisiscono col fare. Sembra banale
ma è la chiave di tutto. Occorre capire che si è di fronte a dei pezzi di legno
che hanno il loro carattere, il loro modo di essere sia dal punto di vista
disegnativo che cromatico. In quel preciso istante si rompe quella armonia
naturale per ricrearne un’altra, per un oggetto nuovo che abbia un giusto
compromesso tra la leggerezza, la resistenza e l’aspetto sonoro. Sorgono grandi
conflitti tra il dire e il fare, sono gesti che richiedono sofferenza, fatica e
tempo.
 |
| Michele Sangineto con uno dei suoi strumenti |
Nonostante
l’età non più giovanissima, è comunque sempre rimasto vivo un desiderio e una curiosità
infantile di scoprire nuove cose e di sperimentare nuove esperienze, ma tutto
ancora come un gioco. In me alberga un eterno fanciullo.
Sono
molto soddisfatto dei miei strumenti musicali e soprattutto dell’arpa, uno
strumento a cui mi sono particolarmente dedicato apportando delle innovazioni.
Diversi musicisti a livello internazionale suonano le mie arpe; fra i tanti,
Alan Stivell le usa per le sue numerose incisioni.
Ho
partecipato a festival di musiche popolari a livello nazionale ed europeo (Festival
Interceltico di Lorient, Castello di Saint Chartier, Palazzo del Governo di Bruges,
Carrousel del Louvre di Parigi, Castello di Budapest, Royal College of Music di
Londra...).
Dal
1988 al 1991 ho organizzato a Monza quattro edizioni di “Suoni di antichi
strumenti”, un Festival di musica etnica. In quelle occasioni ho avuto modo di
invitare e conoscere i più grandi esperti di musica classica e antica: da
Nicanor Zabaleta ad Alan Stivell.
 |
| A sin. Renato Seregni, a des. Michele Sangineto |
Mio
padre suonava la chitarra, ma io non volli imparare. Il desiderio di suonare
l’ho avuto più avanti negli anni quando ho costruito il primo salterio, uno
strumento antico a corde suonato con l’archetto. Mi sembrava necessario poter
dimostrare che avevo fatto un buon lavoro. Nel 2000 ho costituito con la mia
famiglia l’Ensemble Sangineto utilizzando arpe e salteri da me costruiti con un
repertorio di musica popolare e antica. Ultimamente mi sono interessato alla
costruzione degli strumenti musicali impressi nell’arte pittorica di maestri
del Rinascimento come Gaudenzio Ferrari, Piero di Cosimo, Bernardino Luini, Giorgione,
Filippino Lippi e Leonardo da Vinci, e intendo divulgare queste mie
acquisizioni tramite conferenze nelle scuole e nelle biblioteche.
C’è
chi mi ha detto: “Vai per il mondo, o antico vichingo dal cuore di fanciullo,
forgiando il legno, raccontando il mormorio delle foreste e le ancestrali favole.”
E
poi ancora: “Prendi la cetra, fa’ il giro della città, canta con arte,
moltiplica le canzoni, affinché si ricordino di te”, ma io vorrei volare come
le farfalle, illuminarmi come le lucciole e suonare come Apollo citaredo.
DANTE MAFFIA
 |
| Dante Maffìa |
IL MENO CHE POSSA
FARE
Il meno che
possa fare un non milanese che capita a Milano in una giornata di pioggia, con
il traffico intasato, con i taxi introvabili, è prendere a calci i muri dei
palazzi o andare sul Duomo e buttarsi giù, così avrà un po’ d’attenzione.
Chi arriva a Milano è come se cadesse all’improvviso in
una poltiglia bollente in cui tutto si neutralizza. Il calore umano non fa bene
ai rapporti, anzi è un deterrente e bisogna cancellarlo. Le persone serie sono
quelle che sanno fare gli affari senza complicarsi la vita con calore e
affettuosità. Roba che inquina, e crea perplessità.
Eppure a Leonida non mancano gli amici. Ha avuto con
molti una lunga dimestichezza di viaggi e di vacanze, ma quando li incontra qui
gli sembrano marionette, anzi manichini che recitano una parte. Anche quelli
originari del Regno delle Due Sicilie.
Oh, è brutto scendere alla Stazione di Milano e trovarsi
subito nell’impero dell’estraneità, dell’indifferenza, dell’efficientismo che
non tiene conto delle esigenze di un povero cristo impacciato e smarrito,
perché no, anche a causa del clima, della nebbia, dell’aria nodosa e amarognola
che si respira.
Ha lasciato al bagagliaio della Stazione la valigia, ha
comprato un brutto cappello e ora va in giro vagabondando. Sembra un barbone
autentico, nessuno lo riconosce.
Questa sera dormirà sui cartoni nella rientranza d’un
portone, assaporerà la pienezza della libertà.
A San Babila, a Montenapoleone sono esposte le sue
creazioni nelle vetrine. Ha visto molta gente soffermarsi e commentare
sorridendo. Piacciono, i suoi vestiti. Chissà quanta gente sarebbe felice di
stringergli la mano.
Ha bisogno di stare solo con se stesso.
E se capitasse anch’egli in Sant’Ambrogio?
“È lontano, eh, a piedi ci metterà tanto”.
Va nella direzione indicatagli, si ferma a un bar per
bere un cappuccino, riprende ad andare.
Eccolo arrivato. Entra. Quasi non ricorda come si fa il
segno di croce, non gli viene in mente nessuna preghiera imparata da bambino..
Sant’Ambrogio è una chiesa che dà smarrimento. Che cosa
va cercando? C’è una forte umidità, fa freddo. Ha bisogno delle sue comodità.
Entra in un albergo, si fa riconoscere e prega di mandare
un fattorino alla stazione per la valigia. Non ha resistito. Farà il barbone
un’altra volta.
Dopo la doccia scende al ristorante, fuma quattro
sigarette e poi sale in camera a dormire. Forse ha la febbre e gli fa male
anche la gola.
È quasi un anno ormai che vive in questo albergo. Le sue
rendite glielo permettono. A Roma è tornato poche volte per sistemare gli
affari urgenti.
Non legge i giornali, non va a cinema o a teatro.
Passeggia per le strade e osserva la vita della città. Non avrebbe mai creduto
che anche Milano ha l’anima. Un’anima che s’è imbruttita ed è diventata
fuligginosa, ma sempre anima è. E scopre perfino scorci molto belli, dove meno
se l’aspetta: un palazzo, una strada, un monumento, un’atmosfera particolare.
Nella sua suite può andarlo a trovare chiunque. Alla
reception non fanno problemi, grazie alle sue laute mance, neppure a figuri
ambigui che invita occasionalmente.
Il suo corpo va riempendosi di macchie. Mister Aids è
entrato nel suo sangue ed è diventato il suo padrone.
È tentato di tornare a Roma e ricoverarsi al Policlinico
dove conosce alcuni medici, ma ha capito che non servirebbe a niente. E poi,
meglio morire a Milano, il suo grigiore è come la marcia funebre che lo
accompagna alla tomba. Si sente più a suo agio qui dopo la malattia. Non riesce
ad annullarsi, a uscire di scena in silenzio. Dovrebbe avere il coraggio di
cancellarsi. Il suo l’ha avuto e se Mister Aids è arrivato è perché lui non è
stato capace di rispettare nessuna regola. Ingordo fino alla morte, e
irresponsabile.
Ha fatto togliere la piccola pendola dal soggiorno della
suite. Il tempo non ci deve essere. Porta a spasso la sua agonia e il buffo è
che non è disperato né preoccupato degli altri che possano essere contagiati da
lui. Usa chi capita, senza precauzioni, e non gl’interessa che Lella e Zucchero
abbiano deciso di diventare suorine della carità, né vuole suicidarsi come quei
due stronzi di Marco e di Romolo.
Fra poco sarà primavera anche a Milano.
Leonida arriva, a volte, fino al Naviglio. Conta le
lattine vuote di birra e di coca-cola che galleggiano. Ecco i nuovi cigni si
dice. Conta e riconta per ore quante bottiglie di plastica gli transitano
davanti…
Di Roma gli manca il suono delle campane e l’odore di
fritto delle rosticcerie.
Alla reception hanno cominciato ad avere qualche
sospetto, teme che lo manderanno via al più presto, nonostante le sue mance
sperticate.
Morirà quando morirà, ma prima vorrebbe tornare in
Sant’Ambrogio, a risentire il gelo e l’umidità dell’ambiente. Crede sia
l’anticamera della morte.
Da qualche giorno sente le forze mancargli, ma esce
ugualmente per le sue passeggiate. A Piazza San Fedele l’altra sera ha visto un
figuro che con un giravite accecava dei gatti. L’ha aggredito e gli ha chiesto
per quale motivo si comportava in quella maniera.
“I gatti mi hanno dato l’aids”, ha risposto.
Leonida si è fatta una risata e gli ha raccontato delle
sue disavventure.
Sono entrati in un bar e ci sono scolati una bottiglia di
liquore a testa. L’ubriachezza gli ha dato un barlume di vita vera. Si sono
addormentati uno sull’altro vicino a un cassonetto della spazzatura. All’alba
li ha svegliati la pioggia battente e ognuno ha preso la sua strada senza
neanche salutarsi.
Leonida si sveglia poco prima dell’arrivo in stazione.
Non aveva mai fatto un sogno così atroce, così strano. Gli restano addosso dei
brividi di paura per quei particolari aberranti sulla malattia. E poi, ma che
cavolo, vedersi nelle vesti di un gay!

LUIGI MARSIGLIA
 |
| Luigi Marsiglia |
Il Grande Inquisitore e "L'entrata di Cristo a
Bruxelles"
La scelta nichilista
Il termine "nichilismo" viene delineato da
Ivàn Turgenev nel romanzo Padri e figli
del 1862. Nel decimo capitolo, l'attempato e democratico Nikolàj Kirsanov, soprannominato
dai nobili del distretto il rosso, definisce il giovane Bazarov: quel
signor nichilista.
"In primo luogo noi non predichiamo nulla... - accenna
quasi di sfuggita Bazarov - e abbiamo deciso di non occuparci di nulla... E
questo si chiama nichilismo..."
"Il contagio è già diffuso - replica il placido e
allarmato Pavel, fratello di Nikolàj - mi hanno riferito che i nostri pittori a
Roma non mettono piede in Vaticano e tengono Raffaello quasi in conto di un
imbecille, perché è un'autorità..."
"Secondo me - è la convinzione di Bazarov -
nemmeno Raffaello vale più di un soldo; e nemmeno loro (i succitati pittori
russi) sono migliori di lui!"
Un dialogo infarcito di francesismi da Kirsanov, come
d'abitudine per appartenenti all'aristocrazia di medio alto o basso livello,
che si svolge alla vigilia della riforma dello zar Alessandro II Romanov, riforma
che prevede l'abolizione, almeno sulla carta, della servitù della gleba, del
latifondo agrario, dei rapporti sociali di stampo medioevale e di gran parte
del retaggio feudale. Il confronto più aspro è proprio tra l'impettito Nikolàj,
che si ispira a quel gruppo di nobili liberali e idealisti alla Puskin che avevano dato vita alla
congiura Decabrista del '25 contro Nicola I, conosciuto come Nicola Bastone, e
il nichilista prima maniera Bazarov. Tra vecchio e nuovo.
L'ismo si
richiama al latino indeclinabile nihil o nil, traducibile con
niente o nulla; lo stesso Turgenev narra che il giorno degli incendi appiccati
a Pietroburgo, la folla accorreva ruggendo: "Avete visto cosa fanno i
vostri nichilisti!"… Questo per dire che il termine attecchì subito, trovando
terreno favorevole in Russia, dove fu adottato per identificare un esponente
rivoluzionario radicale e intollerante, dotato di cultura e fanatismo
sufficienti a calpestare qualsiasi principio, o prensìp, per citare alla
lettera Pavel Kirsanov, persino l'autorevolezza di Raffaello.
Fin qui la nascita del nichilismo; ma il neologismo
incalzato dalla crisi storica e dai crucci della quotidianità si evolve, si
smussa e si allarga assumendo connotazioni, varianti e portata diverse a
seconda degli affluenti da esso derivati: dieci anni dopo il racconto di
Turgenev, nel 1871/72 Dostoevskij pubblica I
demoni in cui il termine nichilismo, ampliato a dismisura, genera l'abisso,
le tenebre fitte e senza fondo incarnate da Nikolàj Stavrògin.
Mentre il grande peccatore Raskòlnikov, in Delitto e castigo, si lascia sedurre dal
superomismo nietzschiano e l'idiota Mysckin rappresenta l'uomo buono anche in senso cristiano, il
principe Stavrògin è il nulla assoluto, un nulla ricoperto di altro nulla.
Soltanto l'antiascetico e santo alla rovescia - secondo la scala della fede
espressa da Stavrògin al vescovo Tichon, per cui il vero ateo è sul penultimo
gradino in alto sotto il vero santo - soltanto Ivàn Karamazov si avvicinerà a
tratti alla voragine che occupa l'animo del principe.
Il protagonista de I
demoni è proprio Stavrògin; in tono minore, da comprimario, si muove e si
agita sulla scena Pëtr Verchovenskij, il nichilista che ricalca la figura tratta
dalla realtà del terrorista anarchico Sergej Necaev, estremista intransigente, cofondatore della società
segreta Volontà del popolo. Mentre Bazarov di Padri e figli (all'epoca della pubblicazione Necaev aveva circa 15 anni) era deciso
a porsi anche contro la volontà del popolo pur di far prevalere la razza eletta
degli uomini nuovi, ecco apparire la demagogia, l'ideologia critica che si
ammanta di populismo a buon mercato e pretende di agire secondo gli interessi e
con l'approvazione del popolo. Necaev
scrisse insieme a Michàjl Bakunin, il quale ne prenderà presto le distanze, il
famigerato Catechismo del rivoluzionario,
il vangelo della generazione votata a cambiare il volto della storia. Un
micidiale bluff: le cinquine, le cellule ramificate dei cospiratori, una rete
di falangi sotterranee che, agguerrite e pronte a dar fuoco al paese, attendono
il segnale convenuto, esistono esclusivamente nell'immaginario di Necaev, così come in quello letterario
di Verchovenskij. Il fenomeno si ridimensiona, sgonfiandosi del tutto; Necaev viene arrestato con l'accusa di
avere eliminato un giovane affiliato, potenziale spia, che si era ribellato
all'organizzazione.
"Verchovenskij, è la prima volta che vi ascolto e
vi ascolto con stupore - affermò il principe [Stavrògin] - dunque voi non siete
affatto socialista, ma una specie di... ambizioso politico?"
"Un mascalzone, un mascalzone. Vi preoccupa
sapere chi io sia? Vi dirò subito chi sono e qual è la mia meta... Noi
proclameremo la distruzione... - esclamò l'altro - ecco, comincerà la
rivolta!... La grande Russia si oscurerà, piangerà la terra sui suoi vecchi
dei... E allora, a questo punto, noi tireremo fuori... Chi?"
"Chi?"
"Lo zarevic
Ivàn."
"Chi, chi?"
"Lo zarevic
Ivàn, voi, voi!"
Per un momento Stavrògin rimase soprappensiero.
"Un impostore? - Chiese d'un tratto. - Ah, ecco il vostro piano!"
E' la visione malata, al limite del ridicolo, di
Verchovenskij/Necaev. L'incendio
è nelle menti, non sui tetti delle case. E in mezzo alle fiamme, in mezzo a
questa spirale di nebbia e fumo, esiste una zona arida, deserta, avara di
pensieri, gesti e speranze, un vuoto al di là di qualsiasi debolezza e
incrinatura, di ogni previsione, delusione, polemica o conformismo: è
Stavrògin, il quale se crede non crede di credere, e se non crede, non crede
di non credere. Altri personaggi de I
demoni ruotano intorno a questo colossale nulla: la dichiarazione di non
fede di Kirillov prima di spararsi un colpo di pistola alla tempia; il sorriso
sfacciato e maligno di Liputin che osserva l'incendio appiccato dai congiurati,
ciò che avrebbe dovuto essere o diventare l'apocalisse finale; la stessa
Varvàra Petròvna Stavrògina, madre di Nikolàj, o il sorpassato Stepàn
Verchovenskij, padre di Pëtr.
Il nichilismo teorizzato da Bazarov non è dunque
quello professato dai personaggi di Dostoevskij e, nello specifico, da
Stavrògin; nel primo è una scelta razionale e attiva, negli altri un
accanimento doloso, un vortice passivo. Là prevale l'abnegazione, il
tumulto dei comizi, la conferma politica nella rivoluzione e nel cambiamento violento
dello stato delle cose; qua la negazione della vita e l'indifferenza verso la
morte: una specie di necrofilo, per riportare l'aggettivo coniato negli
anni della guerra civile dallo spagnolo de Unamuno. Là predominano i
sobillatori e la triade hegeliana senza soluzione di continuità: tesi,
antitesi, sintesi - in sé, per sé, altro da sé; qua
Stavrògin e il nichilismo dell'anima.
"Sono lo spirito che nega continuamente: ed è
ragione; però che quanto sussiste è degno che sia subissato: e sarebbe stato pur
meglio che niuna cosa fosse mai uscita ad esistenza" così
Mefistofele, l'insidioso demone della vanità, provoca Faust.
Nikolàj Stavrògin giungerà a "uccidere Dio"
nell'atto feroce della violenza alla bambina Matrësa che si suiciderà; e il principe, sostanziale nulla fatto
di altro nulla, finirà con l'impiccarsi a causa di quel rimorso. Il tutto
descritto nel capitolo Da Tichon,
confessione mai inserita nel corpus del romanzo. Lo stesso delirio
pedofilo, lo stesso incubo di candore infranto e infanzia oltraggiata, sognato
da Svidrigàjlov, altro suicida, in Delitto
e castigo.
Ivàn Karamazov svela al probo fratello minore Aljosa la parabola inversa de Il Grande Inquisitore. In sintesi: Gesù
ritorna sulla terra per salvare gli uomini dal male e da se stessi, e fa il suo
ingresso trionfale a Siviglia; risuscita una bambina appena morta tra il
tripudio della folla plaudente; il cardinale, Grande Inquisitore, comanda ai
suoi scherani di arrestarlo."Perché sei venuto a disturbarci... -lamenta
l'alto prelato-. Tutto ciò che di nuovo Tu ci rivelassi attenterebbe alla
libertà della fede umana..."
"Egli - l'Inquisitore, secondo Ivàn Karamazov -
fa un merito a sé e ai suoi di avere infine soppresso la libertà (impersonata
dal Nazareno) e di averlo fatto per rendere felici gli uomini... L'uomo fu
creato ribelle; possono forse dei ribelli essere felici?... Il segreto dell'esistenza
non sta nel vivere, ma in ciò per cui si vive..."
"Domani stesso io Ti condannerò e Ti farò ardere
sul rogo come il peggiore degli eretici" è la lucida conclusione
dell'Inquisitore, che aspetta una risposta dal Cristo tornato sulla terra.
Questi si avvicina e lo bacia sulla guancia vizza, al che il cardinale
prorompe: "Vattene e non venire più, mai più!" E lo lascia andare per
le vie oscure della città.
Le tracce dell'entrata di Cristo a Siviglia, si
ritrovano nel dipinto di James Ensor realizzato nel 1888. Cambia la città: qui
è Bruxelles, ma la tela richiama indirettamente le allucinazioni, i
vaneggiamenti mistici e la disamina da parata di Karamazov - il romanzo è del
1880. Una massa di scheletri e maschere ghignanti, saluta nel quadro l'arrivo
del Messia in groppa a un asino; l'atmosfera borghese e inquieta della città
belga, col suo primo cittadino in monocolo e in trepidante attesa sul palco,
denota l'intento satirico delle pose carnascialesche di Ensor: le maschere
orgiastiche sono l'anima vera di una città spoglia di maschera, una volta che
sono stati deposti il perbenismo, il corruccio e l'ipocrisia di facciata dei buoni
commercianti di Bruxelles: Bruxelles come modello, come parametro concreto di
un mondo che danza allegramente intorno al feticcio del denaro. Il popolo è
nudo; sulla strada campeggia uno striscione scarlatto abbastanza sudicio che,
con tono da burla studentesca, inneggia: vive la sociale. L'aggregazione
visionaria dell'insieme ribalta la logica temporale della realtà; i tempi
levitano e la moralità accigliata del primo cittadino ristagna in
quell'infettante euforia: Ensor si rivolge all'effetto grottesco e al tema
instabile della fantasmagoria in maschera; il norvegese Edvard Munch, in questa
distorsione fantastica dell'immagine, approda invece all'effetto contrario,
psichedelico e schizoide, dell'alterazione figurale in senso opposto: la
fissità dilatata delle pupille e degli sguardi deviati, la mostruosità
sofferente del reale. Esseri tubercolotici o epilettici che avanzano sui
marciapiedi febbricitanti delle città.
L'entrata di Cristo a Bruxelles somiglia dunque a
quella di Siviglia.
Il capovolgimento, il contrappasso letterario nei
fratelli Karamazov risulta totale; un presunto parricida, Dmìtrij, sia
innocente che colpevole per il fatto di aver desiderato la morte del padre a
causa di Grùscegnka; Ivàn, che brama credere ma non crede; lo sparuto Aljosa dalla grande anima in
formazione, sballottato lungo le vie tentatrici del mondo; e Smerdjàkov, figlio
illegittimo, servo plagiato dai dubbi di Ivàn e assassino del vecchio
Karamazov. Quando morirà lo stàrets Zòsima (maestro spirituale di Aljosa, considerato santo al pari del
vescovo Tichon, il confessore di Stavrògin), quando morirà Zòsima l'odor
cadaverico inonderà la stanzetta del monastero: un indice questo di non
santità, di scandalosa corruzione della carne - per tre giorni consecutivi
dalla salma illibata di Ildegarda di Bingen, ricordano le cronache medioevali,
emanò un intenso profumo di rose e gelsomini…
In Dostoevskij l'ateismo è la ricerca fragile,
tortuosa e frenetica dell'irraggiungibile paradiso in terra, così come
l'inumana cattiveria presenta allo stato larvale una nascente e assoluta bontà:
la riconquistata purezza del peccatore.
ALBERTO FIGLIOLIA
 |
| Alberto Figliolia |
CINQUE POESIE
Perché hanno ucciso la
maestra anarchica?
Perché hanno ucciso
la maestra anarchica?
Perché il toboga scivolava
sulla sabbia?
Perché l'alba ha perduto
il silenzio?
Perché il sogno non ha più l'eco
della risacca?
Perché i ricordi fuggono
dal recinto?
Perché il ritorno fa più paura
dell'andare?
Perché un cane sazio mangia
un piccione morto?
Voci attraverso i muri.
Un litigio di amanti.
Il viaggio che non sai.
Un paese fantasma.
Le infinite generazioni.
La politica del dolore.
Le parole dei saggi.
Quali i sintomi della vita?
Può la curva del mare guarire
dal male?
Può un uomo essere bambino?
Strazia e consola il pensiero.
Cammino su un viale bordato
di palme e nuvole.
Che il vento suoni le corde
dell'amore...
la maestra anarchica?
Perché il toboga scivolava
sulla sabbia?
Perché l'alba ha perduto
il silenzio?
Perché il sogno non ha più l'eco
della risacca?
Perché i ricordi fuggono
dal recinto?
Perché il ritorno fa più paura
dell'andare?
Perché un cane sazio mangia
un piccione morto?
Voci attraverso i muri.
Un litigio di amanti.
Il viaggio che non sai.
Un paese fantasma.
Le infinite generazioni.
La politica del dolore.
Le parole dei saggi.
Quali i sintomi della vita?
Può la curva del mare guarire
dal male?
Può un uomo essere bambino?
Strazia e consola il pensiero.
Cammino su un viale bordato
di palme e nuvole.
Che il vento suoni le corde
dell'amore...
(Marina di Vasto, mattino, sabato 6.IX.2014)
***
***
Il bounty killer bruciava con il sigaro acceso la manica
destra della giacca blu.
La sua precisione era chirurgica, frastagliata la coscienza.
Finito il lavoro, mangiò la cenere residua.
Aveva un buon sapore quel grigio con brace.
L'ustione al palato gli procurò gran piacere.
Si preparava al nuovo viaggio.
Lanciò un'occhiata all'indiano legato e steso nella polvere.
L'appuntito palo di legno che
inchiodava l'uomo dalla pelle come cuoio all'arida terra era ancora ben saldo.
L'indiano non si muoveva; forse si fingeva morto.
Il cacciatore di uomini non se ne curò.
Il bounty killer, la barba rada e
sofferente e gli scontati occhi di ghiaccio, sciolse il cavallo dal manto
pezzato, guardò la povera stamberga di legno, le assi sporche, il misero
improbabile orto.
Sorrise e si allontanò.
Smettemmo di osservare lo schermo.
In luogo dei fotogrammi
scorrevano ora le immagini di una conduttrice del telegiornale. Soltanto le
immagini: un sincopato loop senza voce.
Dentro la sala chi tossiva, chi
recitava un mantra, chi invocava disperato il padre, chi gracchiava, chi
ripeteva incantato parole di seduzione senza soluzione.
Mi chiedesti di uscire, uscimmo e resistesti quando ti tirai
la mano per rientrare. Forse avevi ragione tu.
Fu così che optai per l'espiazione.
Fu così che optai per l'espiazione.
In una taverna del porto della Città d'Oro mi condannai a
lavare i piatti di ogni lebbroso.
Ma non c'era Vangelo né coerenza nelle mie azioni.
Presi i bicchieri sbagliati dove
non era il sangue della redenzione, ma il delirio dell'abbandono, l'alcool
della rabbia distruttiva, lo sgancio atomico.
Lo sguardo dell'uomo con le corna istoriate e la guizzante
lingua di fuoco mi gelò.
Poco più in là rimbombava l'eco di una poesia.
Mi sedetti e paziente, per millenni, ascoltai.
***
La sala era grande...
La sala era grande
forse addirittura smisurata
eravamo seduti a ferro di cavallo
e le distanze aumentavano
crescevano sempre crescevano
sempre
in mezzo qualcuno pose
(non vedemmo mani né corpo)
in mezzo qualcuno pose
un cigno malato
un cigno bianco dal becco nero
un cigno all'ultimo canto
e il cigno cantò
mentre noi tutti (liberi o
prigioni) copiavamo e imitavamo la sua fine
così la metamorfosi si compì
l'uccello mutò in maiale
e il maiale figliò
e il maialino neonato corse sotto
le forche caudine
grufolava si rotolava
e felice si restringeva
si restrinse a tal punto che
poteva esser tenuto
sul palmo della mano
e il maialino a pancia in su fece
le fusa
e tutta l'armonia fu restituita
al mondo
***
L'eco
di un martello all'alba
come pianto di prefiche ignote
la soave nausea del dormiveglia
come pianto di prefiche ignote
la soave nausea del dormiveglia
in un
sogno a puntate e più dimensioni
infine un coro di uccelli a destarmi
apro la finestra per farmi invadere dall'aria
ma il cielo è solo un'ipotesi dorata
è solo per screenare il carcinoma
infine un coro di uccelli a destarmi
apro la finestra per farmi invadere dall'aria
ma il cielo è solo un'ipotesi dorata
è solo per screenare il carcinoma
ripeteva
nel sonno un medico dal camice rosa
(la musa del silenzio gli si opponeva invano)
ora che il vento è gelido
ora che le nubi si squarciano
ora che gli eroi son morti
vedo i tentacoli della luce
(la musa del silenzio gli si opponeva invano)
ora che il vento è gelido
ora che le nubi si squarciano
ora che gli eroi son morti
vedo i tentacoli della luce
avvolgere intrappolare soffocare
nella sala il lieve gracchio
nella sala il lieve gracchio
della
televisione lasciata accesa
fuori, il rumore di fondo della tangenziale
richiudo la finestra, torno a letto
nel vuoto pneumatico del dormiveglia
al sogno a più puntate e dimensioni
ora che il vento è gelido
ora che le nubi si squarciano
ora che gli eroi son morti...
fuori, il rumore di fondo della tangenziale
richiudo la finestra, torno a letto
nel vuoto pneumatico del dormiveglia
al sogno a più puntate e dimensioni
ora che il vento è gelido
ora che le nubi si squarciano
ora che gli eroi son morti...
Il mio lavoro...
Il mio lavoro è la mia bara.
Ore di polvere, bocca di zero,
abisso, rullo,
faldoni a navigare l'ottuso mare
della coscienza.
Tuba una tortora nel ricordo.
Un motore s'avvia lontano.
L'azzurro del cielo è lamento, un
improvviso incupirsi.
L'infinito brusio della gente
e l'ascia del bisogno che spacca
la mente.
Vedo l'ombra della betulla
stormire silenziosa sul muro ocra di fronte.
Il guasto arcobaleno delle
presenze-assenze.
Fisso lo schermo del PC e
m'immagino sulla Luna senza scafandro,
seduto a una scrivania di
polvere...
me
pensante all'eternità
e mi sconsola la mia, la nostra,
finitezza.
Quando usciremo a riveder le
stelle?
 |
| Clirim Muca |
Gli ulivi di San
Vito dei Normanni
(dedicato a Lorenzo Caiolo)
Antichi guerrieri sono
questi inermi ulivi
fermi nell'atto della fuga
o dell'ultimo assalto.
Le loro uniformi a brandelli,
e nei corpi squarci dai dardi
di un destino beffardo,
dai fulmini di un cielo
talora tempestoso.
A ogni chioma d'argento
un elmo di luce
dona il generoso mattino.
Curioso il vento s'intrufola
tra i rami a tastare ferite,
a caricarsi di glorie,
svegliandoli dai sogni
e nel sogno cercan riparo.
Morire è nascere altrove.
L'anima leggera in balia dei venti:
un granello di sabbia
un frumento ringrinzito
un ossicino d'ulivo...
In quest'angolo di Puglia commosso
ho abbracciato tronchi d'ulivo,
come fossero miei antenati.
Il capo ho poggiato su petti e grembi
ruvidi, screpolati, familiari.
MARIO RONDI
 |
| Mario Rondi |
La Cubista
La signora
Liberata faceva la cubista in una discoteca di provincia: ballava per liberarsi
dalle angosce che ogni notte la tormentavano con perfidi ricordi di amori
svaniti nel nulla.
Nel rumore assordante della
musica, sulla sua pedana di cristallo, cancellava l’onda dell’ansia che sempre
la tormentava: avrebbe voluto stare nel silenzio più assoluto, davanti a un
camino che mandava scintille, ma per sopravvivere si era adattata a quel
lavoro.
I giovani frequentatori del
locale andavano in estasi quando la vedevano in azione: si muoveva sui tacchi a
spillo come una delicata pantera, orchestrando con sapienza i suoi passi
felpati, per mettere in mostra le forme slanciate con vaghi sorrisini.
In realtà lei viveva di
teneri pensieri, di trepide aspirazioni: di giorno stava per ore alla finestra
a contemplare il volo dei passeri, ad ammirare l’andirivieni delle formiche in
una fessura del muro.
Di notte danzava estasiata
sotto il frastuono delle casse acustiche a tutto volume: con le languide mosse
del corpo slanciato la sua mente fuggiva lontano, in un mondo incorrotto, dove
tutto era incanto e leggerezza.
Il suo pensiero era rivolto a
cancellare l’onta di un passato non proprio esaltante: con caparbietà si era
avviato in un cammino di redenzione, per togliersi di dosso le incrostazioni di
una vita insignificante.
Era diventava una convinta
vegetariana, per eliminare le contaminazioni della carne: si nutriva di erbe
selvatiche raccolte nei boschi, di germogli e infiorescenze che conosceva alla
perfezione, nella convinzione che solo con l’assoluto rispetto della natura
avrebbe ricuperato la purezza perduta.
Nel ballo notturno consumava
con movimenti flessuosi i grassi superflui: era un esercizio interiore di
autocontrollo che placava le ansie e allontanava qualsiasi proposito di
vendetta contro chi aveva approfittato della sua ingenuità.
Il vortice del suo corpo
straripante mandava in visibilio i giovani nottambuli che la sognavano tra le
loro braccia: erano disposti a tutto per sfiorare un lembo del suo vestito
svolazzante, per sentire da vicino il profumo inebriante della sua carne
sussultante.
Lei manteneva le distanze con
un sguardo fulminante che bloccava sul nascere le pretese di una facile
conquista: nella frenetica danza cercava l’estasi del distacco, la sublimazione
delle proprie miserie, per allontanarsi da quel senso di colpa che la
tormentava.
Quando scorse sulla pista di
ballo il signor Innocente, che se ne stava in disparte senza accennare al
minimo passo di danza, si accorse di essersi imbattuta in un perdente come lei:
teneva gli occhi bassi, evitando di guardarla, un poco infastidito dal rumore
eccessivo della musica.
Sembrava essere capitato per
caso, forse trascinato da amici che presto lo aveva abbandonato per gettarsi
nella calca: tamburellava le mani su un tavolino per darsi una certa
importanza, ma si capiva che si trovava a disagio, con l’occhio che vagava
smarrito nella sala in cerca di aiuto.
Per attirare la sua
attenzione lei faceva la spavalda, ancheggiando voluttuosa sul cubo di
cristallo e mettendo in mostra le linee mozzafiato del suo corpo, costipato in
bustini e giarrettiere sfavillanti: lui sembrava non vederla, travolto da
un’onda di tristezza che lo trascinava in un gorgo asfissiante.
Non aveva però fatto i conto
con la sua caparbietà: saltellava sulla pedana come un uccellino che vuole
spiccare il volo, si girava su un fianco, scoprendo uno spacco laterale, si
piegava in avanti come a offrire la maestosità del petto, ruotava la testa
ricciolina per mandare un saluto capriccioso, ma lui sembrava indifferente a
tanta frenesia.
Teneva gli occhi bassi,
tormentato da oscuri pensieri, incapace di compiere il più piccolo movimento:
quando la scorse che caracollava sulla sfera di cristallo, per prima cosa gli
sembrò eccessiva per tutto quel fru fru di piume e lustrini che agitava nel suo
numero d’attrazione.
Non cercava un corpo così
ridondante, ma ad un’occhiata trasversale intuì una strana irrequietezza: per
un gioco del destino, in quegli occhi scintillanti gli sembrò di cogliere una
richiesta d’aiuto.
Lei a un certo punto sembrò
ritirarsi, come pentita per l’eccesso del suo assalto, rivolgendo la sua
attenzione ad altri esagitati avventori: orchestrava con puntiglio la messa in
scena delle sue conquiste, che avrebbero ottenuto qualche piccolo regalo, da
aggiungere alla sua scarsa retribuzione.
Innocente aveva intuito,
sotto lo sguardo sfrontato, la disarmante tenerezza della signora Liberata: non
lo colpivano le mosse felpate di esperta ammaliatrice con cui teneva in scacco
i corteggiatori, ma l’onda della dolcezza che filtrava a tratti dai suoi
movimenti.
Lei recitava la sua parte
alla perfezione, slanciando in avanti le gambe a scoprire pizzi ricamati,
ruotando il busto per lasciare intravedere l’onda dei seni sussultanti e il
pubblico strillava estasiato dalle sue mosse accalappianti, dai movimenti
flessuosi che spingevano al visibilio.
Con che maestria celava il
tormento segreto che nascondeva in fondo al cuore! Nel ballo vorticante sul suo
cubo tutte le preoccupazioni erano cancellate, tutte le incertezze sembravano
per sempre bandite!
Innocente aspettando la
conclusione della numero, coltivando la sua atavica rassegnazione: qualcosa
però era successo segretamente dentro di lui che per la prima volta si sentiva
risvegliato dall’apatia.
Lei da lontano lo teneva
d’occhio, stupita della strana indifferenza ai suoi studiati adescamenti, ma
intuiva un desiderio di fuga che era molto simile al suo nei momenti di
sconforto: quando si fu sbarazzata della gazzarra degli esagitati avventori, si
diresse verso di lui che rimaneva in disparte.
Alle sue mosse provocanti,
con languidi piegamenti sui fianchi e sorrisi sfrontati, lui rispondeva con la
più assoluta indifferenza, come se volesse cancellare il ricordo di antichi
abbracci: nell’eccesso di lusinghe, col sussultare delle piume del succinto
vestito, intuiva però una strana incertezza.
Quando distrattamente
sorrise, lei però presto fuggì, lasciandosi dietro una scia di profumo: si era
accorta che il suo pensiero era andato in una direzione pericolosa e ne fu
terrorizzata.
L’improvvisa fuga aveva però
risvegliato in lui un antico ricordo e per un attimo si stupì che nel corso del
tempo alcuni misteri si potessero ripetere: non la rincorse, ma rimase immobile
al suo posto, con un bicchiere in mano per cancellare ogni ipotetica
coincidenza.
Più tardi lei tornò,
ritrovandolo immerso nelle sue meditazioni: ne provò un’istintiva pietà, ma ad
un’occhiate trasversale intuì la sua immensa tenerezza.
Ancheggiava spavalda sulla
pedana, ma intanto capiva che erano tutti e due nella stessa condizione:
pervasi da un desiderio di essere altrove.
Chissà perché a un certo
punto cominciò a ridere, come se si rendesse conto che la situazione era
comica, nell’impossibilità di uscire dalla farsa che li circondava: allora
anche lui, distolto dai suoi tristi pensieri, si mise a ridere sommessamente
per confermare la miseria che li circondava.
Quel riso insensato che
usciva dalle loro bocche li accomunava nel segreto desiderio di fuga:
arrivarono presto altri avventori particolarmente su di giri che infilavano
banconote negli slip della ballerina per ottenere mosse elettrizzanti.
Lei assecondava premurosa
tutte le richieste più strampalate per mandarli in visibilio, lanciando
occhiate languide che di molto li gratificavano nella baraonda generale.
Il giorno dopo Innocente
decise di farle un regalo particolare: dove lavorava preparavano quello che lui
chiamava il pane degli angeli, destinato per lo più agli istituti religiosi che
poi lo distribuivano nelle parrocchie.
In realtà erano le parti
delle particole che venivano scartate perché non risultavano perfette, come
pure i frammenti avanzati dai tagli: lui le mise in un pacco, vistosamente
decorato di nastrini per regali e le portò a lei.
Si affrettò a dire che le
particole non erano state consacrate, per non fare la parte del blasfemo e
ridendo aggiunse che si potevano usare per la colazione, se si volevano evitare
pesi sullo stomaco.
Fu per lei un regalo
meraviglioso: rappresentava perfettamente la sua speranza di redenzione.
Così al mattino si nutriva di
particole, sentendosi subito purificata delle proprie colpe: un’onda di
leggerezza invadeva il suo cuore, sospingendola lontano, in un mondo di candore
e tenerezza.
Adesso in certi momenti della
giornata, quando guardava dalla finestra il paesaggio imbronciato, avvertiva un
tremito interiore, come se qualcuno da lontano la chiamasse, le lanciasse un
segreto messaggio.
Di notte sul suo cubo mandava
scintille elettrizzanti che incantavano gli avventori: i suo corpo si esibiva
in spericolate acrobazie, come se accrescesse lo slancio per misteriosi
sortilegi.
Innocente la sbirciava da
lontano: lei si sentiva come protetta dal suo sguardo leggero e si cimentava
nelle mosse più audaci che mandavano in visibilio il pubblico che non lesinava
sulle mance.
In certi momenti però, quando
l’entusiasmo era alle stelle, lei avvertiva uno strano richiamo che giungeva da
un punto misterioso della sala: era come se una forza misteriosa, che si
nascondeva da qualche parte, volesse comunicarle qualcosa.
Adesso si cibava solo di
particole sconsacrate perché intuiva che le donavano uno slancio vitale del
tutto particolare: le ansie come per incanto si annullavano e si sentiva spinta
verso un’atmosfera rarefatta, dove forse qualcuno misteriosamente la chiamava.
In certi momenti della
giornata avvertiva una specie di fruscio nell’aria e sentiva che succedeva
qualcosa, come se qualcuno si stesse avvicinando, ma non riusciva mai a vedere
niente, perché forse i suoi occhi non erano ancora pronti per una rivelazione.
A volte credeva che fossero
delle allucinazioni, dovute all’eccessiva concentrazione nel ballo o al volume
troppo alto della musica o forse per l’ansia causata da un lavoro che non
amava.
Una notte, quando si
contorceva nel suo cubo per sconcertare i sempre più esigenti spettatori, a un
certo punto nel frastuono della musica le sembrò di udire una voce che la
chiamava: era stato un richiamo soffuso, ma al tempo stesso imperioso e lei ne
rimase sconvolta.
Non vedeva nessuno attorno a
sé, se non i soliti esagitati avventori, ma quel soffio misterioso non poteva
essere confuso col vociare degli scalmanati: giungeva da un’altra parte, da un
mondo inaccessibile che misteriosamente voleva comunicare con lei, forse
metterla in guardia per una minaccia incombente.
Innocente aveva intuito nei
suoi occhi una strana irrequietezza, ma non riusciva a comprenderne il
significato, quando tutti la guardavano entusiasti per le sue acrobazie sul
cubo: segretamente gli spettatori sognavano di affondare le mani in quel corpo
sussultante che sembrava vibrare.
C’era però qualcosa che
preoccupava Liberata nel suo massimo di splendore: era quel segnale misterioso
che le giungeva da lontano, come da un mondo segreto che lo affascinava, ma che
al tempo stesso temeva per le imprevedibile conseguenze.
Continuava a sbirciare in
ogni angolo della sala, nella speranza di intravedere qualcuno, ma nessuno si
faceva vivo, mentre nella sua mente cresceva un misterioso tumulto.
Alla fine, quando si stava
piegando su un fianco per mettere in mostra la linea slanciata del suo corpo
proteso all’abbraccio, le sembrò di scorgere qualcosa di indistinto che sbucava
dal buio: rimase senza fiato, paralizzata dall’emozione quando capì che era un
angelo che veniva in suo soccorso.
Con gesti risoluti sembrava
volerla invitarla a seguirla verso una direzione misteriosa: era sul punto di
spiccare il volo e trascinarla con sé oltre le luci intermittenti della pedana,
al di là del cubo di cristallo che conteneva tutta la sua vita, per librarsi
nell’immenso che si intravedeva oltre le finestre spalancate…


.jpg)


















