LIBRI
IL RITORNO COME FALLIMENTO
di Angelo Gaccione
Appunti personali a proposito di un saggio di Fulvio
Papi
 |
| La copertina del libro |
Accanto alla sua attività di filosofo, Fulvio Papi
coltiva da tempo una altrettanta forte passione per la letteratura. Broch,
Roth, Thomas Mann, Svevo, una accanita rilettura di Musil, e di recente i saggi
su Marguerite Yourcenar, Samuel Richardson, Henry Fielding e Cesare Pavese,
compresi nel volumetto dal titolo “Come
specchi del tempo*”. Di ciascuno di questi autori Papi indaga delle opere
specifiche e ne problematizza alcuni
aspetti. Tutti molto interessanti, ma che attengono, a mio modo di vedere, molto
di più al lavoro letterario degli scrittori, che a quello dei semplici lettori
o della critica. Potrei citare ad esempio l’attenzione che lui rivolge all’happy ending di un’opera, o alla
conoscenza oggettiva “delle
condizioni storiche” colte in tutti i suoi risvolti (politici, sociali,
psicologici, militari, religiosi, ecc.) ineludibili nella costruzione di una
figura storica, anche se poi il narratore, per esigenze proprie del suo fare
artistico, non può rinunciare alla sua soggettività “irriducibile” come la
chiama Papi. E finisce per contaminare l’oggettività storica, con l’invenzione
creativa propria della sua soggettività. Temi questi, assieme agli altri
presenti nei vari saggi, di notevole interesse per chi pratica l’arte della
scrittura, utili ad illuminare qualche crinale scosceso del proprio percorso. Il
tema del ritorno, (νόστος), presente nel
romanzo di Pavese (La luna e i falò)
preso in esame da Papi, e che egli giustamente individua come storia di
fallimento, mi conferma quello che ho sempre pensato: l’emigrazione fa dello
scrittore, di un certo tipo di scrittore, uno sradicato. Egli non mette radici
da nessuna parte e il ritorno non può che deluderlo: il tempo muta
inesorabilmente le persone e le cose, e seppure il suo luogo non è stato del
tutto devastato, tuttavia “il desiderio del ritorno non può suturare l’abisso
del tempo” perché “lo stesso spazio è mutato con il tempo”. Ho potuto
verificare tutto questo su me stesso, ritornando dopo un significativo periodo
di assenza nella mia terra di origine. Ho provato come un senso di vertigine,
come se improvvisamente fossimo diventati estranei, io a lei, lei a me. La
bellezza struggente dei suoi colori strideva col vuoto che il tempo aveva
scavato in me; quel che si perde non si recupera più, come ciò che si cancella
di fisico, fosse pure un albero, uno slargo che la nostra memoria aveva
trattenuto. C’è un terremoto interiore che produce le stesse rovine del
terremoto fisico che abbatte case e cancella luoghi, e rende meno stabile
l’equilibrio psichico. Forse è per questo che i poeti che partono o si
inaridiscono, o cadono vittima di quella “malattia
dei ricordi” (espressione molto cara anche a Papi) da cui finiscono per
restare imprigionati.
Se “I ritorni non sono che inganni del cuore”, come si legge in un famoso romanzo di Piero Chiara*, e se come per Anguilla, il protagonista del romanzo di Pavese di cui conosciamo solo questo soprannome, non c’è possibilità di ricongiungersi, dopo essere andato in giro per il mondo, che cosa rimane se non il peso di una memoria che ci tiene a galla per non sprofondare del tutto? “Capii che quelle stelle non erano le mie” dice Anguilla tornando, ma il ritorno è un fallimento. È stato così per lungo tempo anche per me: nessun cielo mi apparteneva e le stelle mi apparivano ovunque meno lucenti. Poi ho smesso di guardare il cielo.
Se “I ritorni non sono che inganni del cuore”, come si legge in un famoso romanzo di Piero Chiara*, e se come per Anguilla, il protagonista del romanzo di Pavese di cui conosciamo solo questo soprannome, non c’è possibilità di ricongiungersi, dopo essere andato in giro per il mondo, che cosa rimane se non il peso di una memoria che ci tiene a galla per non sprofondare del tutto? “Capii che quelle stelle non erano le mie” dice Anguilla tornando, ma il ritorno è un fallimento. È stato così per lungo tempo anche per me: nessun cielo mi apparteneva e le stelle mi apparivano ovunque meno lucenti. Poi ho smesso di guardare il cielo.
Note
*Una spina nel cuore, Arnaldo Mondadori Editore.
*Fulvio Papi
Come specchi del tempo
Yourcenar, Richardson, Fielding, Pavese
Ibis edizioni 2016, pagg. 96 € 8,00.
LIBRI
NON È
UN PAESE PER ONESTI
di Angelo Gaccione
 |
| Elio Veltri nel suo studio |
Biografia, diario, libro di memorie,
saggio, messa a punto di una stagione storico-politica irripetibile? Questo
nuovo libro di Elio Veltri è molte cose assieme perché è un libro multiforme in
cui più generi e formule vi fanno irruzione, compreso un certo gusto per la
narrazione e la letteratura. Qua e là affiorano descrizioni di visioni, scorci,
profumi, sapori, umori, nostalgie, personaggi, che hanno a che fare con la
poesia, e poetica è la lingua dialettale che fa capolino qua e là. Non è un paese per onesti, sottotitolo: Storia e storie di socialisti perbene, è
un libro denso e pieno di fatti, ricco com’è di eventi e personaggi pubblici
molti dei quali consegnati alla storia del secolo scorso. Perché attraversa un
arco temporale di tutto rispetto, e perché la temperie dentro cui fatti e
personaggi si situano, è stata una delle più esaltanti, drammatiche, scandalose
e infine deludenti della storia politica italiana. Dal punto di vista in cui si
situa Veltri e a consuntivo finale, può con fierezza dare conto di aver bene
operato. Ma ha potuto ben operare non solo perché l’insegnamento del rigoroso
ed onestissimo padre Agamennone (azionista prima e socialista per tutta la vita
poi) è stato eticamente impeccabile, ma perché egli stesso ha concepito la
propria esistenza e il proprio ruolo sociale come parte integrante di quelle
idee e di quell’insegnamento ricevuti. Di quell’insegnamento verificato nel
concreto della quotidianità minuta fatta di dedizione agli altri e di
solidarietà, che da quel sentire e da quelle idee discendono e sono nutrite. Dedizione
agli altri e alla propria comunità che finisce per divenire essenza umana prima
che istanza politica. Su queste basi Veltri ha potuto ricostruire e forgiare il
proprio io che è divenuto un abito consustanziale al suo sentire interiore e al
suo stesso operare sociale.
 |
| Elio Veltri |
La deriva di
personaggi insospettabili, anche di indubbio valore intellettuale, nella
conduzione della Cosa Pubblica, è dovuta al venir meno di questa tensione,
dell’allentarsi di questi capisaldi. I soli che, restando a presidio del
proprio operare e del proprio agire, ne possono preservare integra la moralità
e la missione. Attraversare indenne da scandali un’intera vita pubblica, in un
Paese che ha edificato su scandali e corruzione il suo DNA, può apparirci
miracoloso. Si tenga conto che quando entra nel Partito Socialista Italiano nel
1957, Veltri non ha ancora vent’anni. Sindaco di Pavia lo diventa a 38, ma
prima, già nel 1964, era stato eletto Consigliere comunale di quella stessa
città e di anni ne aveva appena 26. E poi ci saranno gli anni da Consigliere
regionale e quelli da parlamentare nazionale. Ripeto: attraversare a testa alta
un excursus così lungo, circondato poi da un clima che vedrà una parte del PSI
(il più antico e glorioso partito progressista italiano) immerso in quella
cloaca maleodorante fatta di scandali e ruberie (quella da noi battezzata come
la componente socialosca); che rema
contro il tuo stesso programma, ostile alle tue stesse battaglie amministrative
per la difesa degli interessi collettivi contro i particolarismi di pochi; per
la salvaguardia del bene pubblico, di una qualità di vita migliore per tutti e
con una attenzione vigile verso i più deboli, vuol dire avere introiettato in
ogni fibra e in ogni idea il concetto che Licurgo, nel suo intransigente pamphlet
Contro Leocrate, vuole imprimere
nella coscienza dei suoi concittadini: “L’amministrazione
di una città consiste nella custodia
che ciascuno ne fa per la sua parte”. In questa cura consiste la nobiltà che un uomo pubblico può
rivendicare a risarcimento, e di cui può andare fiero alla fine della sua
missione. È questo onore
che lo riscatta e lo rende prezioso agli occhi della città e dei suoi stessi
avversari, se ha ben operato. Veltri questo onore lo ha avuto e i suoi
concittadini lo ricordano con rispetto. Di quanti oggi possiamo dirlo?
 |
| Elio Veltri |
Chi si
immergerà nella lettura di queste oltre 300 pagine, potrà vedere l’impegno
quotidiano, le battaglie dell’Amministrazione per la custodia della città e dei
suoi beni, per impedirne il sacco, lo stravolgimento, la cancellazione delle
memorie che l’arte e la storia le hanno consegnato. I confronti pubblici, il
coinvolgimento dei cittadini, gli scontri, fino a fare assurgere la materia del
contendere, a bene prezioso che travalica gli stessi ambiti locali e nazionali
per farsi bene prezioso, paradigma, modello a cui guardare. Ma non c’è in
questa visione comunitaria e sociale, solo il terreno e il cemento; lo spazio
urbano ed extraurbano da tutelare da una miope riduzione a pura merce e a
profitti: c’è la scuola e ci sono i servizi, c’è il disagio e c’è la salute,
c’è la qualità della vita e c’è la cultura. Si può resistere a tutte le
intemperie e a tutti i rovesci alla sola condizione che chi Amministra non
rivendichi nulla per sé, allora si diventa indistruttibili; dicendo le verità
più scomode e non perdendo mai il contatto con gli uomini concreti e i loro
bisogni. Finiranno sempre, quest’ultimi, per distinguere ciò che è sporco e ciò
che sporco non è; ciò che utile a tutti da ciò che lo è solo per pochi. È stata qui la forza dell’uomo
pubblico Elio Veltri e del suo successo, ed è per ciò che la lettura di questa
straordinaria esperienza andrebbe resa obbligatoria a quanti, soprattutto di
questi tempi, si trovano da neofiti ad amministrare la Cosa Pubblica a vari
livelli.
 |
| Veltri con il libro in mano |
Il titolo
del libro è sconsolatamente tragico nella sua verità, e tuttavia non possiamo
gettare la spugna. Come ci ammonisce Hannah Arendt un uomo rinserrato nel privato
è morto per lo spazio pubblico e dunque non è di alcuna utilità al suo tempo,
ai suoi simili e alla città. Un esempio luminoso per questa speranza può
venirci dalle bellissime commoventi pagine che l’autore ha dedicato al padre
scomparso. La sua vita pur costellata da mille difficoltà e ostacoli, in tempi
oltremodo difficili, in una terra dura e scandalosamente bella, non è mai scesa
a patti con la propria coscienza. Non se n’è giammai dovuto vergognare. Anche i
momenti più bui non ne hanno potuto piegare lo spirito. Sono pagine, queste,
piene di abnegazione, di un uomo e di un professionista che ha lasciato un
ricordo indelebile di sé ad altri uomini e ad altre donne che continuano a
ricordarlo con struggente affetto e devota riconoscenza. Agamennone ci ha
insegnato col suo magistero che una vita
operosa, dignitosa, onesta e morale
(sono parole sue), non è mai sprecata, per quanto numerosi e protervi siano i
suoi nemici. Troverà sempre il suo trionfo perché una vita così caparbiamente
riaffermerà il suo valore.
Il libro di
Veltri è godibile perché vive di tanti momenti anche privati. Racconta dei suoi
affetti più cari e della donna che ha condiviso per questo lungo tempo, la sua
passione pubblica. Questa donna è Tilde, sposa e madre da oltre mezzo secolo,
conosciuta a Longobardi ancora adolescente. Si può dire che in loro si sono
fusi passioni e destino, e forse è questo che rende possibile e straordinarie
certe vite.
Elio Veltri
Non è un paese per onesti.
Storia e storie di socialisti perbene
Falsopiano Edizioni 2016
Pagg. 314 € 18,00
***
LIBRI
GLI “IMPROVVISI” DI VASSALLI
di Roberto Cicala
 |
| Sebastiano Vassalli a sinistra con Roberto Cicala |
Serve ancora un
bastian contrario come lui
Pubblichiamo la
trascrizione dell’intervento di Roberto Cicala alla presentazione del volume
postumo di Sebastiano Vassalli Improvvisi. 1998-2015 (curato da Cicala con prefazione di Paolo di Stefano, edito dalla
Fondazione Corriere della Sera-Rizzoli Rcs Libri) avvenuta il 21 settembre 2016
nella sede del quotidiano di Milano con Massimo Gramellini, Aldo Grasso e
Antonio Troiano.
 |
| Vassalli nel suo studio |
In uno dei suoi Improvvisi Sebastiano Vassalli ha scritto: «Resteranno in
circolazione pochi oppositori: tra loro, i bastiancontrari come chi scrive». Oggi
sentiamo con commozione la mancanza di un «bastian contrario» come lui; e non
soltanto sulla colonne del “Corriere della sera”, cioè nel diario in pubblico che
teneva contro la banalità: è un diario che, grazie alla raccolta degli Improvvisi voluta dalla Fondazione
Corriere della Sera, possiamo collocare accanto al palchetto che raccoglie i
maggiori romanzi di questo «viaggiatore nel tempo», come si era definito
scrivendo che la letteratura, come la poesia, è «vita che rimane impigliata in
una trama di parole».
Anche le sue parole più giornalistiche non valgono un giorno
solo, come il quotidiano, ma sono una riflessione sempre viva e attuale. Il “Corriere
della sera”, nei giorni dell’annuncio della sua candidatura al premio Nobel, la
primavera prima della scomparsa nell’estate 2015, gli aveva proposto di
raccogliere i suoi corsivi, brevi e spesso fulminanti, ironici, scomodi. Mi
aveva chiesto di curare la raccolta e all’inizio avevo pensato di raggrupparli
per temi (politica, poeti, guerra…) ma poi aveva preferito seguire l’ordine
cronologico di uscita. E ora, a rileggerli tutti insieme, gli devo dare
ragione. Ancora una volta. Quei frammenti, quei tasselli, che sembravano
occasionali, sono diventati un affresco, un mosaico unico dell’Italia di oggi,
di noi stessi.
Improvvisi è un titolo
che è un omaggio a Giorgio Manganelli, scrittore che gli aveva presentato il
suo primo libro, di poesia sperimentale, nel 1968. E aveva scelto il titolo con
Paolo Di Stefano, responsabile delle pagine culturali in via Solferino, tra
altre ipotesi, come Prediche inutili
oppure Cause perse. Era il 1998. Da
quell’anno ha scritto fino all’ultimo (a parte una parentesi su “La Stampa”) mandando
i fax al “Corriere” e battendoli sempre su due delle sue quattro macchine per
scrivere, con titoli che spesso la redazione cambiava: Per esempio il suo
titolo Vichingo o terùn diventa Quello della Sindone non è il mio Gesù.
Oppure: Cinema e biancheria intima diventa
Accadde una notte che la canottiera… Da
Il Viagra dell’ego proposto da lui si
passa a Siamo tutti poeti dato dal giornale.
Titoli che fanno venire voglia di leggere. E non manca un titolo sui selfie: Selfie delle mie brame… Fino all’ultimo articolo
sulla mafia e Bernardo Provenzano.
 |
| Vassalli tra i suoi campi |
Chissà che cosa avrebbe scritto di Nizza, Erdogan, della
moda del Pokemon Go, della guerra tra le fiere del libro. Ma in queste pagine i
veri protagonisti sono sempre i libri, definiti da lui «una merce povera e
avida di infinito». Tra gli scrittori citati ci sono Calvino, Leopardi, il suo
Campana, Saviano e Camilleri, che di recente gli ha tributato una bella
citazione. In occasione del traguardo dei 100 libri e dei 91 anni,
all’inventore di Montalbano è stata rivolta questa domanda: «Qual è il complimento che in assoluto, lungo
tutti i suoi cento libri, le ha fatto più piacere e di chi?» Camilleri
ha risposto: «quando Sebastiano Vassalli scrisse che non c’era bisogno di
costruire un ponte sullo Stretto perché io ne stavo costruendo uno di carta, e
che funzionava piuttosto bene». È un Improvviso
contenuto nel libro e vi scrive: «Camilleri, primo tra gli scrittori nati
sull’isola, ci racconta storie della sua terra come storie normali. La Sicilia
del commissario Montalbano è un luogo pittoresco, dialettale e complicato
quanto basta: ma è anche un luogo comprensibile, sia pure con qualche sforzo,
dai non siciliani. Questo fatto assolutamente nuovo è, secondo me, il
principale ingrediente del suo straordinario successo. Con Camilleri, che Dio
lo benedica, cade l’antico pregiudizio (presente ancora in Tomasi di Lampedusa
e in Sciascia) per cui al fondo delle storie siciliane ci sarebbe qualcosa che
non può essere raccontato ma soltanto intuito, e soltanto dai siciliani. Viva
il ponte di Messina Andrea Camilleri».
Le persone citate sono molte, da Dario Fo a Beppe Grillo,
talvolta satireggiando, come quando immagina un «governo dei comici: Fo presidente, Grillo primo ministro, Crozza agli
Interni e Benigni agli Esteri, Pozzetto alle Finanze tanto per non sbagliare)…»,
commentando: «Forse è l’unica via per tirarci fuori, ridendo, dal ridicolo.
Petrolini, Totò e naturalmente anche Flaiano sarebbero d’accordo». Molti altri personaggi frequentano le
pagine degli Improvvisi: da Celentano
a Vittorio Sgarbi, da Berlusconi al sindaco di Varallo Buonanno, tragicamente
scomparso di recente, senza dimenticare Veltroni o anche Scilipoti, quando
Vassalli scrive: «Duole dirlo ma, tra i
politici italiani di oggi, l’unico avviato a diventare immortale non è Silvio
Berlusconi né Matteo Renzi. È Domenico Scilipoti, ex Italia dei valori, ex
Responsabile e ora chissà. I giornali parlano di “scilipotume” e
“scilipotismo”; Renzi respinge l’accusa “di cercare nuovi Scilipoti” e Gentiloni
quella di “pensare a maggioranze scilipotiche”; la Germania viene definita “il
paese senza Scilipoten”; eccetera. Sa di avere un piede nell’immortalità e ne
parla senza falsa modestia. Ancora un paio di giravolte e c’è dentro tutto».
 |
| Vassalli nel suo salotto |
L’attenzione alle parole è poi dimostrata dall’opera da lui più
citata negli Improvvisi, che è, curiosamente,
il Vocabolario Zingarelli; ma cita anche Il Grande Fratello, i Righeira, Indietro tutta di Renzo Arbore, proprio
perché vuole raccontare l’Italia vera e quotidiana. Ad esempio leggiamo: «L’estate sta finendo, come diceva una
canzone-tormentone degli anni Ottanta, e può essere di qualche utilità
riflettere su questa stagione, tra le peggiori della nostra memoria. Aerei
dispersi e aerei abbattuti «per sbaglio»; popoli che vengono sterminati e
popoli che fuggono; guerre che nascono dall’odio e producono altro odio. Non
c’erano mai state, in anni recenti, tanta violenza e tanta disperazione a
premere sui confini dell’Europa e sui nostri confini. Sotto un involucro più o
meno consistente di civiltà, l’animale uomo è sempre lo stesso. Chi ha
scommesso sulla sua bontà, come Rousseau, o sulla sua ragionevolezza, come gli
utopisti dell’Ottocento, ha sempre perso. La mia personale speranza sul futuro
non riguarda le donne e gli uomini in quanto individui, ma riguarda i popoli in
quanto entità collettive. Il rifiuto della violenza deve venire da loro. La
speranza è che questa estate terribile ci abbia avvicinati a quel limite anche
in altre parti del mondo».
Sono parole purtroppo attuali. Le riflessioni sull’odio
(definito «un continente ancora in gran parte inesplorato. […] la nuova
frontiera del realismo») dimostrano la lucidità della mente e del cuore di
Sebastiano Vassalli, che, discutendo sullo scrittore Ignazio Silone, scrive che qualcuno lo definiva un
infame ma (aggiunge) «io non ci credo, e credo che per difendere la sua memoria
non ci sia bisogno di prove. Bastano i suoi libri».
Ecco: abbiamo bisogno di ricordare il «bastian
contrario» Sebastiano Vassalli con i suoi libri e soprattutto con uno nuovo. Da
leggere. È davvero la maniera migliore di ricordarlo.
Sebastiano Vassalli
Improvvisi
Fondazione Corriere della Sera 2016
Pagg. 425 € 14,00
 |
| La copertina del libro |
LIBRI
LE
ELEGIE ROMANE DI DANTE MAFFIA
di Anila Dahriu
 |
| Dante Maffìa |
È il libro di un
pazzo, per più d’una ragione. Del resto Aldo Palazzeschi l’aveva capito più di
quaranta anni fa e nello scrivere la prefazione al primo libro di Dante Maffia,
Il leone non mangia l’erba, non ha
esitato ad affiancarlo a Dino Campana.
Dicevo
pazzo per più d’una ragione, la prima delle quali è l’invenzione della lotta
tra angeli e chimere, i primi armati di spade acuminate e i secondi soltanto di
sogni. Per dimostrare che cosa? Che i sogni sono destinati comunque a perdere,
anche quando hanno a che fare con gli angeli? La seconda ragione è la
puntigliosità con cui Dio viene redarguito e posto sotto accusa perché è
innamorato della donna del poeta. Si paventa un’altra sconfitta del sogno e
questa volta del sogno dell’amore. La terza è porre Matera al centro
dell’Universo facendola diventare sede del Paradiso. La quarta è l’accensione
di mille fuochi poetici che tra loro s’incrociano dando inizio a una bagarre di
perdite infinite. La quinta è il linguaggio raffinato e troppo denso che
destabilizza e mette angoscia. E potrei continuare. Ogni verso sembra contenere
una quantità infinita di sbocci e di spunti che ne creano a loro volta altri,
quasi che le realtà e le emozioni fossero delle matriosche illimitate.
Eppure
non c’è nessun barocchismo, nessuna dilatazione di significato, perché Maffia
resta rigoroso e non divaga, semmai entra ed esce dagli assunti e proprio per
permettere al lettore di orientarsi.
 |
| Dante Maffìa |
Opera che, se si
ha la pazienza di addentrarcisi, cattura e fa sentire il fiato caldo della
parola poetica scandita con perizia e convinzione. Maffia giunge a una
scrittura come questa delle elegie dopo lunghe esperienze e maneggia quindi il
verso come un prestigiatore però attento a non calcare troppo sugli aloni degli
effetti. Un rischio calcolato che gli permette di entrare nei luoghi segreti
della psiche umana quando si trova a lottare con cose più grandi di lui. Ci
sarebbe voluto poco e invece che chiamare direttamente Dio in causa avrebbe
potuto servirsi della mitologia che gli avrebbe permesso addirittura di
azzerare i significati per poi ripristinarli fuori da ogni tentazione. No,
preferisce che la finzione resti fuori, che tutto si svolga nella pregnanza di
eventi visibili e verificabili. Così l’amore diventa patrimonio di tutti,
diventa certificazione del vivere.
Del
resto, dopo i suoi due ultimi poemi, Io,
poema totale della dissolvenza e Il
poeta e la farfalla, il primo uno sbalorditivo excursus su tutto ciò che
riguarda l’uomo, compresa la morte e la dissolvenza, e il secondo un canto
ininterrotto d’amore dall’innamoramento all’addio, che cosa ci si poteva
aspettare da un poeta che non ha soste, che combatte di continuo come un
cavaliere errante per cercare di scoprire che cosa avviene fuori dal realtà e
dalla logica? Queste elegie, che si snodano con una complessità priva di
angoscia, priva di paura, carica di incertezze e quindi ricca di possibilità.
 |
| Dante Maffìa |
E sono queste
possibilità di viaggio offerte al lettore che fanno delle Elegie materane un sussultare di eventi tutti racchiusi nelle mura
materane per significare che città e donna sono un’unica cosa e che città,
donna e Dio hanno lo stesso principio di vita e la medesima situazione da
svolgere. Direi che la posizione di Maffia riguardo a Dio è qualcosa di inedito
nel panorama della poesia e anche della teologia. Egli non è fuori dai
parametri della Chiesa Cattolica, ma vuole imprimere loro una visione diversa,
in cui conta il senso dell’umano innanzi tutto, e poi la salvezza dell’anima.
Come
a dire che il corpo sia più importante? No, come a dire che il corpo può farsi
anima e la terra diventare il luogo dove Dio sta insieme con gli uomini e non
nella radura di luce dove si è confinato.
Discutibile
quanto si vuole ma poesia fitta di rinvii, di richiami, di allusioni, di
scoscendimenti e di voli; poesia ricca di verità che non sa rinunciare alla
carne e alla passione e di dibatte in controversie indefinibili che
rivoluzionano il senso della venuta di Cristo sulla terra. Maffia lo vuole
perennemente qui, tra noi, in modo che debba sentire fisicamente il male che
gli angeli hanno fatto e fanno alle chimere.
Poesia
alta, comunque, che ci fa toccare con mano il male e il bene, senza nessun
manicheismo, con sfumature che graffiano e fanno perfino sanguinare.
Dante Maffìa
Elegie materane
Lepisma
Edizioni, 2016
Pagg. 120 € 12,99
 |
| La copertina del libro |
LIBRI
Notturno Canaglia a
Milano
di Cataldo Russo
Notturno Canaglia a Milano
è un romanzo sociale che ha anche tutte le potenzialità e gli ingredienti per
essere un ottimo thriller o giallo, il genere che va di moda oggi e che trova
gli editori più disponibili alla pubblicazione. L’autore avrebbe potuto
risolvere la trama in diversi modi, ha scelto di risolverla raccontando
l’esistenza, i sentimenti e l’agire dei protagonisti in rapporto ai cambiamenti
sociali e politici che hanno luogo non solo in Italia e a Milano alla fine
degli anni ’90, ma in Europa.
Appare
evidente che i fatti trattati da Calabrìa non possono essere disgiunti da ciò
che è accaduto in Europa dopo la caduta del muro di Berlino, che ha scandito la
fine dell’Impero Sovietico nella cui orbita la Moldavia, la patria di Alicia, e
la Romania gravitavano.
Dal
punto di vista dell’intensità narrativa, questo libro rimane sospeso fra il
lungo racconto e il romanzo, ma questo non è per niente un demerito. Anche “Il Vecchio e il mare” di Hemingway più che un romanzo è un lungo racconto dove la
tensione narrativa è sempre alta e inchioda il lettore alla pagina. Il fatto che la trama si dipani in un numero
di pagine piuttosto contenuto fa sì che siano ridotti al minimo i pericoli di
fasi di stanchezza narrativa, di digressioni inutili, di ridondanze
linguistiche e ripetitività che avrebbero potuto comprometterne il ritmo
narrativo martellante che caratterizza ogni pagina di questo libro.
Poche,
quindi, le pause, quelle pause che sono più frequenti nel romanzo lungo, dovute
alla necessità di legare insieme i vari episodi e i vari accadimenti.
Concordo
con il prof. Strano circa l’abilità dello scrittore nel sapere usare i vari
registri linguistici, passando con una certa naturalezza, a secondo delle situazioni
e delle caratteristiche morali dei vari personaggi dal tono drammatico a quello
discorsivo, dal tono serio a quello delle minacce e dei ricatti.
I
rimandi alle citazioni dotte e agli aforismi, che compaiono in questo libro e
così cari a Oscar Wilde de “Il ritratto
di Dorian Gray”, non rasentano mai la pura civetteria letteraria. Infatti,
essi non sono mai giustapposti o stridenti con la narrazione, citati tanto per
citare qualcosa, ma in sintonia con il clima del romanzo.
Calabria
ci narra una storia dei nostri tempi, aprendo uno squarcio sui retroscena di
un’emigrazione, quella dei paesi dell’est che ha avuto lati drammatici, che
magari oggi appare lontana, ma su cui ha prosperato senza distinzione
territoriale la delinquenza e lo sfruttamento.
Nel
romanzo ci sono tutti gli ingredienti cari a Dickens per commuovere il lettore:
lo sfruttamento della prostituzione, lo sfruttamento dell’emigrazione, lo
sfruttamento del lavoro, ma c’è anche la delinquenza di oggi: il traffico di
droga, la mafia dell’est europeo e la mafia e la ’ndrangheta italiana. C’è
anche il problema dei minori che si trovano a essere orfani e che, come accadde
al povero Oliver del capolavoro dickensiano, possono andare incontro a diversi
destini. Ogni tanto l’autore sembra tentato dalla voglia di dare il proprio
giudizio morale sui personaggi e i fatti, ma riesce ad evitare questa trappola
perché lascia comunque che a parlare siano gli avvenimenti e non il narratore.
L’autore
pur padroneggiando i fatti, le ambientazioni, le storie e i personaggi, lascia
che la storia si dipani attraverso l’agire e la condotta dei personaggi e non
con l’ausilio delle digressioni sociali o il moralismo.
Il
mondo che mette in scena Calabrìa è il mondo dello sfruttamento, dei dannati,
di coloro che la storia ha privato del diritto di potersi autodeterminarsi. È
il mondo dove conta l’arricchimento facile e dove la vita sembra non avere
alcun valore perché tutto è sacrificato al dio denaro. Per strane coincidenze o alchimie gli
sfruttati di questo romanzo si trovano a incontrare i loro sfruttatori e le
vittime ad andare incontro ai loro carnefici. Il suicidio di Alice, non è un
atto di vigliaccheria, ma una ribellione estrema a una situazione dalla quale
sembra non esserci una via d’uscita.
Questo
romanzo che si lascia leggere di getto ha anche un andamento cinematografico e
il passaggio da una situazione all’altra ha quasi la rapidità della dissolvenza
cinematografica.
La
Milano che emerge da questo romanzo non è quella della malavita quasi
folcloristica di Porta Romana o delle bande della zona di Ortica, tanto meno
quella descritta da Carlo Castellaneta o altri autori milanesi, ma quella
segnata dagli anni ’70 del secolo appena trascorso in avanti da criminali
incalliti come i Vallanzasca, i Francis Turatello, dalle varie famiglie ’ndranghetiste
e dai tanti clan delinquenziali dell’Albania o della Romania.
I
personaggi, tutti ben disegnati, sono coerenti nel loro agire con le loro
caratteristiche morali e umane.
Alessandro
Calabrìa
Notturno
canaglia a Milano
Ed.
Nuove Scritture, 2016
Pagg.
80 € 10,00
LIBRI
Lettere a Don
di Claudia Azzola
 |
| La copertina del libro |
Le tredici lettere
di Mary- Lou a Don Burness che l’autrice scrive al marito lontano, in viaggio, si
riferiscono a due successivi viaggi di lui in Europa, nel dicembre 1970-
gennaio 1971, e in maggio-giugno 1972,
in era pre-web, quando nello spazio ontologico e simbolico c’erano gli
epistolari e i carteggi. Non leggiamo le risposte del destinatario. Abbiamo
quindi un epistolario composto da lettere di una donna a un uomo che esprimono la natura di un amore, nel riconoscimento
e nel volere il bene dell’altro (come leggiamo
nell’introduzione di A. G.), e in filigrana si delineano due individualità, una “in assenza”, quella di Don. Mary-Lou riconosce
l’esigenza del viaggio in solitario (altri viaggi importanti li hanno compiuti
insieme: il “nostro albergo”, ecc.), necessità vitale del poeta, dell’artista,
del viaggio silenzioso che nutre l’immaginario, fatto di illuminazioni, di
apparizioni mentali, di esperienze che si esprimono solo in arte. Viaggio
silenzioso in cui il “camminatore” si porta anche le tristezze, e si parla
anche di depressione… da gestirsi da solo.
Ho apprezzato il grido che
Mary-Lou si lascia sfuggire nella lettera del 29 dicembre, martedì, 1970, “Non
andare via nuovamente - odio tutto questo….-
che si acquieta nell’accettazione della diversità e del diritto dell’altro. Si sente
che ha fatto pressione su di sé, e in un’altra lettera scrive: “È una buona
cosa che io non abbia il passaporto. (!)” e come in soliloquio, altrove scrive:
“Si può regolare la solitudine, quando si tratta di una condizione temporanea”.
Mary-Lou resta a casa (sta “fuori”
un giro), nella vasta e profonda provincia americana, nel New Hampshire, e si dedica
ai fatti quotidiani, alla lettura (è una grande lettrice, di Proust, di V.
Woolf, Doris Lessing, Wilfred Owen…), autori
che compiono una Odissea personale, come il giovane tycoon, protagonista del romanzo Cosmopolis di Don Delillo, del 2003, chiuso nella sua Limousine, bloccato
nel traffico in tilt di una New York dove in una giornata hanno luogo la visita
del Presidente, il funerale di una rockstar, e una violenta protesta antiglobal, in Times Square, metafora
della débacle del sogno americano
dell’efficientismo e dell’ottimismo.
Il simbolico non è negato,
nelle lettere di Mary-Lou, Odissea personale e Voyage autour de ma chambre, lo spazio piccolo ma immenso
all’interno della mente, nella esatta valutazione di sé, dove tenere a bada
l’incertezza, la debolezza, la realtà frattale dell’oggi. Dettaglio e
particolare (Omar Calabrese).
 |
| Un momento della presentazione del libro a "ChiAmaMilano" il 22 novembre scorso |
Non cronaca, ma narrazione a
tocchi, a pennellate, che delineano un
ambiente, e dialogo sintonizzato con il destinatario del cuore e con se stessa (innerlook e outlook), nella fluttuazione del pensiero, nell’evocazione della
realtà materiale, della politica sullo sfondo ma non tanto. Pragmatismo
americano e “ostinazione” (cito dall’introduzione di A. G.) comprendono la
passione amorosa schiacciante e gentile,
fiducia nella comunità a due che vede anche l’inquietudine, l’integrità di
ognuno che non deve essere infranta, la libertà di spirito e di scelte, a patto
che non decada mai la condivisione.
Ci sono le amicizie della vita,
una partita a bridge, una cena cordiale, l’uscita per un teatro, la presenza
della mamma, e c’è la neve da spalare, c’è la cura del giardino e degli animali,
Gerhard e Gertrude, i cani, e i gatti, che
percepiamo attenti, curiosi, invadenti, giocherelloni, come le persone. Mary-Lou
è il perno della vita in comune e della storia d’amore, mentre il “cavaliere
errante” compie la sua avventura europea. La visione del mondo è tutta in
soggettiva, sul vasto mondo. Mary-Lou non è povera di mondo. Tutto ciò che
tocca diventa una piccola magia, un portento da condividere con Don che è
lontano. Mentre Don compie la sua avventura, lei compie i doveri quotidiani,
nello spazio quotidiano.
Mary-
Lou Burness
Lettere
a Don
Ed. Nuove Scritture 2016
Pagg. 48 € 10,00
PER MARISA FERRARIO DENNA
di Vincenzo
Guarracino
 |
| Marisa Ferrario Denna |
La morte della poetessa
Marisa Ferrario Denna, avvenuta l’11 dicembre u.s., impone una riflessione
sulla sua vita di scrittrice e animatrice culturale ed editoriale. Un
riflessione che appare tanto più urgente e necessaria soprattutto alla luce
delle sue opere e della sua passione letteraria, svoltasi in una feconda marginalità
creativa ed operativa. Fedele a un’idea di poesia coerente con le ragioni
dell’io sulla scena della contemporaneità ma attenta anche a responsabilità
formali ereditate e radicate nella tradizione, come poetessa ha teso a dar voce
nei suoi testi (editi con diversi editori, da Scheiwiller a Book Editore, a Amadeus, a Lietocolle) alla sua sensibilità di
donna e come responsabile di una
raffinata collana di poesia, edita dalle edizioni Nomos di Busto Arsizio, ha
fatto emergere un gruppo notevole di
poeti contemporanei (Alida Airaghi, Silvio Raffo, Gilberto Finzi, Silvio Ramat,
Ottavio Rossani, tra i tanti), scelti con l’unico criterio della validità dei
testi, al di là di generazioni e tendenze.
Per parlare comunque di lei e della sua
opera, si può cominciare dall’epilogo, dai versi di un testo dal titolo
emblematico, Ordine, contenuto nell’ultima
raccolta di poesie Ritratti in
controcanto, edito proprio da
Nomos (2012), un libro in un certo modo emblematico e riassuntivo di una
poetica e di una vita.
In Ordine,
a partire da un dettaglio di un quadro di un pittore paesaggista del ‘600, Hoogstraten,
si constata l’”inutile fatica / di
volersi – dal disordine – salvare”, cui attraverso la scrittura, attraverso una
pratica e una disciplina rigorose e appassionate, si è tentato di dare un senso
approdando alla consapevolezza dell’inanità dell’assunto: come dire che
l’”ordine”, che la scrittura assiomaticamente si prefigge, per salvare se non
dalla casualità e dall’ingiustizia della vita, almeno dalla sua “malizia”,
resta un miraggio che sposta i suoi confini sempre più avanti cedendo il passo alla
vera essenza creatrice del mondo, al Disordine (ricordo un suo mirabile elogio
tessuto da Goffredo Parise e comparso sul “Corriere della sera”, nel gennaio
del ’76, alla vigilia della morte, intitolato “La vita è disordine”). Ma,
questo è il messaggio del libro, la vita val la pena di impegnarla nello
sforzo: ognuno deve compiere la sua parte, a seconda del talento, prima di
“andarsene”, con semplicità (“E andarsene sarà, semplicemente, / lasciare le
ciabatte sulla soglia, / varcare a piedi nudi un’altra stanza, / lasciare nel
disordine le cose, / che – mute – resteranno per ridire / l’ordine vuoto
dell’inconsistenza”).
 |
| La poetessa durante un incontro |
È una condizione e un’attitudine nei
confronti della vita, quella che l’autrice mette dunque in scena: se non ci si
può salvare dal “disordine”, ebbene lo si accetti come un valore con cui
confrontarsi, un’esperienza in grado di dare un senso alla vita, giusto come
dice il testo d’apertura, dove l’eponima “matita” diventa l’emblema di un modo
di concepire la scrittura come investimento, felice e doloroso al tempo stesso,
delle risorse migliori dell’io, in un corpo a corpo senza reti con l’oggetto
del desiderio.
Ho voluto descrivere questa sorta di
cortocircuito, perché mi pare che contenga una chiave di lettura abbastanza
precisa e chiara dell’operazione effettuata in questo libro dai risvolti molto
particolari, nel quale si intrecciano a più livelli elementi di grande
interesse, che possono dare una idea abbastanza fedele del “progetto”
perseguito per tutta la vita dall’autrice. A livello concettuale, innanzi
tutto, è significativo come tutto sembri situarsi in un ambito, concreto e
metaforico, quello della casa, al cui “ordine” il mondo femminile sembra
assiomaticamente votato (o condannato). A livello formale, poi, c’è una “concinnitas”, una discrezione e
un’educazione espressiva, che si traducono in una scrittura limpida, rispettosa
e “didascalica” ma anche densa in giusta misura, con un’attenzione all’Altro,
al Lettore, a riprova di un bisogno, tutt’altro che acre o risentito, di
parlare e di giovare, di “rifar la gente”, come diceva il Giusti. Un rispetto
che si traduce a livello metrico nel ricupero di strutture consolidate dalla
tradizione (sonetti, quartine, rime), e a livello retorico in un raffinato
dispiegarsi di figure (di pensiero, di elocuzione, di costruzione).
Ma che cosa contiene
esattamente questo Ritratti in
controcanto? È una galleria di
ritratti in versi di donne scrittrici o pittrici, interpellate ‘in controcanto’
ciascuna in due poesie: nella prima l’autrice si accolla il compito di guida
alla scoperta ed evidenziazione delle loro peculiarità espressive ed
esistenziali, nella seconda invece su ognuna distilla, come in un aforistico
dono di parole, un commento riflessivo-filosofico.
 |
| Un primo piano della poetessa |
Una struttura
originale, dunque, in un libro originale: giocato tra presente e passato, tra
storia e mito, si fa apprezzare, oltre che per il suo “ordine”, per l’impianto
geometrico rigorosamente perseguito, che in certo senso riflette il bisogno “di volersi – dal disordine – salvare” attraverso l’ordine
dell’arte, attraverso l’omaggio alla bellezza, per il suo pulsante contenuto. Le sessanta donne, tra
storia e mito, donne che lo abitano – donne che spesso hanno pagato
personalmente le loro scelte -, come sulla scena di un teatro, vengono evocate,
in un dialogo serrato e appassionante, con l’autrice stessa che non si sottrae
a mettersi in gioco come un personaggio pronto a stare in scena (della pagina,
della vita) con la serena coscienza del proprio ruolo, come rivelano gli
estremi dolenti versi del testo di chiusura (“E andarsene sarà, semplicemente,
/ lasciare le ciabatte sulla soglia, / varcare a piedi nudi un’altra stanza, /
lasciare nel disordine le cose, / che – mute – resteranno per ridire / l’ordine
vuoto dell’inconsistenza”).
Ecco, è proprio a quest’“ordine vuoto
dell’inconsistenza” che il libro intende dare una risposta: una risposta di
parole, sì, ma grondanti di vita, di sentimenti, di volontà di affermarsi da
parte di donne che hanno conquistato la loro verità attraverso l’arte e la
sofferenza. “Sorgo e tramonto; e in questo divenire / vado tracciando il
cerchio della vita”, rivendica per sé orgogliosamente Elena: questo solo conta
per la mitica eroina, la vita. È la sintesi migliore del libro, come nota la
prefatrice Alida Airaghi. Come dire che l’“ordine”, ancorché ostacolato nella
vita, trionfa nel segno di un’ansia di libertà, di luce, nella “verità”
dell’arte.
LIBRI
LA RAGIONE CON FREUD, DOPO FREUD
Ordine contrordine disordine
di Roberto Zanni
 |
| La copertina del libro di Maria Delia Contri |
All’“opposizione” rispetto a una “maggioranza compatta” Freud raccoglie il testimone della fiducia illuministica nella ragione come facoltà di pensare, come facoltà positiva di legge, dell’agire e del rapporti, a condizione che la si riconosca come superiorem non recognoscens, come entità autonoma da qualsivoglia principio di causalità o di comando.
Col suo libro Ordine, contrordine, disordine. La ragione
dopo Freud, Maria D. Contri lavora alla riscoperta di Freud, oltre Freud.
“Il sonno della ragione genera
mostri”, diceva nel ’700 Francisco Goya. Non è la ragione in quanto tale - dice
Freud - a essere distruttiva, ma la ragione in quanto concepisce, masochisticamente,
come soluzione, la propria autodistruzione.
La ragione, il pensiero, può
infatti produrre l’idea “viziosa”, difettosa, l’errore, della propria origine
nell’obbedienza, nella sottomissione a un Altro totalmente Altro, a quell’Altro
che Freud chiama Super-Io. Ne consegue il disordine anarcoide, e patologico, in
cui ci si logora senza pace nel tentativo di un’obbedienza logicamente
impossibile, di una ribellione impotente, della costruzione di un rapporto, di
una legalità altrettanto impossibili. E il masochismo si rovescia poi nel
sadismo di una volontà di potenza che di fatto è pre-potenza, la pre-potenza
dell’impotente.
Freud lo si può leggere, o
rileggere, così: con l’onestà, la competenza e il piglio di Maria D. Contri,
nel suo “Ordine, contrordine, disordine”, pubblicato da Sic Edizioni: “La voce
dell’intelletto è fioca, ma non ha pace finché non ottiene udienza - scrive
Freud, nel 1927, in L’avvenire di un’illusione
-. Questo è uno dei pochi punti che consentono un certo ottimismo per il futuro
dell’umanità [...] il primato dell’intelletto va collocato senz’altro in un
futuro molto, molto lontano, ma probabilmente non infinitamente lontano”.
Maria D. Contri, psicoanalista
che ha contribuito a fondare la “Scuola Freudiana”, finalmente rifondata in
“Società Amici del pensiero”, ce lo fa incontrare come un amico del pensiero,
frequentato da molto tempo, e di cui continua il lavoro. Con Freud, dopo Freud,
appunto.
Il testo si apre come un ventaglio di temi centrati
sulla questione del pensiero come facoltà legislante, questione antica, o
meglio “moderna”, ma di una modernità che resta prigioniera di un antico errore.
Ricordiamo come Theodor Adorno, in Minima
moralia affermi che per quel “vecchio cinico” di Freud “la ragione è una
semplice sovrastruttura”.
Tanta incomprensione, o
riduzione, della novità freudiana, propria anzitutto dei filosofi, copre la resistenza a non voler cedere
sulla metafisica. I filosofi, in fondo, temono di perderla se passassero
all’idea di un essere posto in essere,
da un pensiero legislatore. I filosofi sono nostalgici della teoria di un
essere che precede il pensiero e lo imprigiona.
“Credo che nel leggere Freud -
scrive Maria D. Contri - si sarebbe avvantaggiati dal pensare che ciò che egli
chiama ‘Super-Io’ alla fin fine altro non sia che la buona vecchia metafisica
di cui già David Hume, nel settecento, parlava come di ‘malattia’ del pensiero”.
Si tratta di elaborare una
“nuova dogmatica del pensiero”, sulla scorta dei principi che reggono il lavoro
del pensiero elaborati da Freud, e sul modello di quella “dogmatica giuridica”
che ricostruisce i principi con cui il Diritto statuale lavora, di un’attività
intellettuale laica e libera da quelle scorie religiose che, come polvere
d’oro, qua e là baluginano anche sulle metafisiche più spregiudicate.
Metafisiche che non osano accedere all’idea delle condizioni di possibilità
dell’autonomia del pensiero. Nell’alternativa tra religione e pensiero occorre
collocarsi senza riserve dalla parte del pensiero, ma questa decisione ha delle
conseguenze, la prima delle quali si può dirla con le parole di Heine, spesso
citato da Freud: “Il Cielo abbandoniamolo agli angeli e ai passeri”.
Una seconda conseguenza è tutta politica: il pieno
riconoscimento del pensiero individuale come “primo diritto”, a pieno titolo,
impone un ripensamento del legame sociale e dei suoi fondamenti, e dei suoi
rapporti con un diritto statuale, come “secondo diritto”, non conflittuale,
anarcoide, ma di collaborazione.
Se c’è un pensiero forte, di
cui siamo debitori a Freud, è proprio questo: la prudente fiducia nella
possibilità di un nuovo ordine di rapporti in cui la civiltà non chieda
all’individuo un costo libidico troppo alto, un “autosacrificio dell’io” fonte
di odio e di guerra civile. Principio di piacere e principio di realtà, nella
costruzione freudiana, non sono due principi in opposizione. La meta non deve
essere un compromesso al ribasso tra i due principi, deve essere una
collaborazione in vista della possibilità della soddisfazione individuale, nel
corpo e senza rinunce. Esclusa quindi la via della “sublimazione”, della
rinuncia.
Maria D. Contri dedica a
questi temi pagine nuove e illuminanti, contrappuntate da continui riferimenti
ai canoni filosofici e letterari, a ciò che freudianamente chiamiamo “cultura”,
riattivando temi rimasti irrisolti, aprendo strade inedite. Penso ai titoli di
alcuni paragrafi: Barocco for ever, Quel
maiale di Parsifal, ...e a chi non ha sarà tolto, Quel perfetto altruista di
Narciso, Le interiora dell’uomo interiore, Finché amore non ci separi, Dal
vizio della superbia al vizio dell’umiltà, per citarne alcuni.
Maria
Delia Contri
Ordine,
contrordine disordine
La
ragione dopo Freud
Sic Edizioni 2016
Pagine 294 € 23,00
LIBRI
NOTTURNO
CANAGLIA A MILANO
di Angelo Gaccione
Esordire letterariamente
in età non giovanissima ha l’indubbio vantaggio di mettersi al riparo dalle
ingenuità e di esibire, con sciolta disinvoltura, tutto quanto si è acquisito
in termini di esperienza e di cultura. È quanto accade all’autore di questo
romanzo, Alessandro Calabrìa, che ha appena dato alle stampe “Notturno canaglia a Milano” per i tipi
delle Edizioni Nuove Scritture.
Ambientato
nella Milano dei giorni nostri, “Notturno
canaglia a Milano” racconta una vicenda di malavita che ha i suoi fulcri
principali di azione fra il Palazzo di Giustizia e il carcere di San Vittore. I
protagonisti sono diversi, come avviene sempre in un romanzo, e diversi sono i
fatti che lo scrittore ci racconta. Il sipario si apre sul reclusorio di piazza
Filangieri dov’è detenuto Walter Alessi, un avvocato amante delle citazioni
colte e abile conoscitore del potere suasivo della parola. Siamo alla vigilia
di Natale, e come gli anni precedenti si tiene un concerto per i detenuti; a
introdurre la manifestazione musicale è l’avvocato Alessi che, ricorrendo alle
sue risorse di comunicatore commuoverà i presenti,
-fra
essi il magistrato Ester Grandini- raccontando la vicenda della sfortunata
Alicia Mocanu. Alicia era una giovane detenuta moldava accusata di spaccio di
droga, bravissima pianista, l’anno prima era stata lei a tenere il concerto in
quel salone, si era poi tolto la vita
combattuta com’era fra le minacce dei magistrati che l’accusavano di spaccio e
quelle del suo aguzzino, il serbo-croato Grigor Radu, che l’aveva costretta a
prostituirsi, e che la ricattava minacciando di uccidere sua figlia Ilenia.
Saranno proprio le appassionate parole dell’avvocato Alessi a spingere il
magistrato Grandini a farsi strumento di giustizia, perché quel suicidio non
resti impunito. Ma come la realtà spesso ci mostra, qualche volta la
giustizia è costretta ad arrendersi davanti alla tracotanza dei criminali, alla
loro omertà, non potendo uscire dai limiti che la legge assegna al suo
procedere, ed è costretta a gettare la spugna.
I confronti fra lo spacciatore e sfruttatore di carne umana Radu, strafottente e sicuro di sé, e la dottoressa Grandini, si risolvono sempre a vantaggio del primo. Dunque il crimine la farà franca?
I confronti fra lo spacciatore e sfruttatore di carne umana Radu, strafottente e sicuro di sé, e la dottoressa Grandini, si risolvono sempre a vantaggio del primo. Dunque il crimine la farà franca?
Alessi
non è solo un avvocato intelligente, le vicende che lo hanno portato in carcere
ne hanno maturato la personalità e accentuato la sua sensibilità verso i più
deboli. Il carcere si sa, è a suo modo un mondo a parte ma anche molto
sfaccettato, e lui sa coglierne a volo ogni risvolto. Che il serbo-croato possa
farsi beffe della giustizia egli non può accettarlo; la morte tragica di Alicia
lo ha molto turbato, e deve essere vendicata. L’occasione ghiotta gliela
fornirà il boss don Tanuccio, anch’egli detenuto a San Vittore, e che come
tutti i boss che non hanno nulla da perdere e sperano in qualche guadagno che
ne alleggerisca il peso della condanna. Come Grigor Radu pagherà i suoi
misfatti non ve lo racconterò per non togliervi il piacere del risarcimento,
dal momento che la lettura del romanzo vi farà propendere dalla parte della
sfortunata ragazza e della sua giovane e delicata figlia. Vi dirò però che alla
fine Walter Alessi uscirà da carcere e, con il magistrato, verso cui nutre una
forte attrazione -e che non nasconde-, si metterà sulle tracce della figlia di
Alicia e la rintracceranno. Il magistrato, un po’ per un personale senso di
colpa, un po’ perché senza figli e notevolmente attratta dalla delicata
sensibilità della ragazza, finirà per adottarla. Sullo sfondo, ma questo lo
scrittore ce lo fa solo vagamente intuire, resta l’incertezza di una possibile
storia d’amore fra i due adulti.
Calabrìa
ha costruito il suo romanzo con lineare fluidità. Ha usato un normale fatto di
cronaca (uno dei tanti che i giornali ci servono a iosa) per operare una
riflessione morale precisa e senza ambiguità. Dalle sue pagine si possono
cogliere i vari stati d’animo e le psicologie degli attori in campo,
soprattutto quelli della dottoressa Grandini e quelli dell’avvocato Alessi; quest’ultimo
intraprende un personale percorso che lo porterà verso il riscatto completo di
uomo. Ricco di citazioni dotte, da Leopardi a Marx, da Goethe a Oscar Wilde, da
Huizinga a Tacito, il romanzo di Calabrìa resta godibilissimo e questo sfoggio
di cultura lo impreziosisce.
 |
| La copertina del libro |
Alessandro Calabrìa
Notturno canaglia a
Milano
Ed.
Nuove Scritture 2016
Pagg.
80 € 10,00
***
LIBRI
VENTO DI TERRA
di
Nelida Milani Kruljac
Una nota della
scrittrice Nelida M. Kruliac sul nuovo libro
del nostro collaboratore Christian
Eccher.
Alcuni saggi compresi nel volume sono apparsi sulle pagine di “Odissea”
 |
| Christian Eccher |
Vento di terra di
Christian Eccher è un libro-reportage. È un diario conciso
e accattivante di viaggi compiuti percorrendo in solitaria le strade
dell’Asia centrale e del Caucaso, cioè delle repubbliche dell’ex Impero
Sovietico, del Kirghizistan, del Kazakistan, della Georgia, cercando sempre di
arrivare fin dove consentivano il tempo, le forze e le possibilità. E ci sono
anche Ekaterinburg, Mosca ed il Cremlino isolati e chiusi nelle tante paure, e
c’è pure la Transiberiana con tutte le immagini e i sogni che la parola evoca. Dalla
Russia alla Cina in treno, oltre novemila chilometri fino a Vladivostok: un
viaggio che ha bisogno di tempo e predisposizione mentale agli incontri. Che a
volte sono barlumi di nuove speranze e il più
delle volte sono storie di disincanto e di caduta delle illusioni utopistiche.
Il libro di Christian Eccher, docente di
lingua italiana alla Facoltà di Filosofia di Novi Sad e da lunghi anni
collaboratore esterno per l’inserto Cultura
del quotidiano istriano “La Voce del Popolo”, è uscito prima di tutto in lingua
serba a Novi Sad nel 2015 col titolo Vetar
sa kopna nella collana Lettera per i tipi dell’Editrice Mediterran
publishing, con l’illuminante prefazione di Mirko Sebić. Si tratta di veri reportage perché sono fatti buttandosi
in strada. E poi non sono solo reportage ma anche un insieme di pensieri, di
riflessioni e appunti emersi -soprattutto nella seconda parte del libro- dalla
frequentazione del Tanztheater di Pina Bausch e della compagnia della
Societas Raffaello Sanzio di Romeo e Claudia Castellucci. Non per niente il
sottotitolo dell’opera polifonica, ripubblicata in italiano dalla Sapienza di Roma
ad uso degli studenti di Scienze del Turismo e Mobilità umana è Miniature geopoetiche. Si tratta dunque
di un doppio viaggio, uno reale e l’altro culturale e artistico.
 |
| Christian Eccher (al centro della foto) durante un incontro culturale |
Sono reportage narrativi, un ibrido fra saggio e
narrazione, nati in uno spazio oggi poliarchico ad un quarto di secolo dalla caduta del muro di
Berlino e di tutta un’epoca
scandita da falce e martello, scritti soprattutto su questioni dei margini, dei
confini sorti fra ex consorelle socialiste, fra oriente e occidente, fra
ideologia e Storia, fra comunismo e capitalismo, fra liberalizzazione e
globalizzazione, fra stanzialità ed emigrazione, fra cristianesimo e islam.
Forse ancora “terre di nessuno” ma intenzionate ad uscirne, perché la Storia
insegna che se ne esce sempre quando si passa da un equilibrio ad un altro,
magari a costo di conflitti e guerre utili a stabilire nuove egemonie e nuovi
assetti, un nuovo sistema, dove “tutto si tiene” di nuovo. Perché tutto deve
continuare.
Forte di una scrittura precisa ed evocativa, libera da
qualsiasi esotismo e capace di raccontare la bellezza senza arretrare di fronte
alle brutture e alle contraddizioni del mondo, le cronache di Eccher scoprono e
registrano realtà sommerse, luoghi sconosciuti e abbandonati ai margini della
storia, una galleria di popoli e di individui, una serie tetti
di amianto, di marshrutke, di città leggendarie, di vestigia del passato e di
segnali del nuovo che avanza. Proprio
come nella musica di Mahler che accompagna sempre Christian nei suoi viaggi,
troppo moderna per i tradizionalisti e troppo radicata nel passato per gli
innovatori.
 |
| Christian Eccher con Claudio Ugussi |
Arrivando nelle ex
repubbliche socialiste si avverte, quasi sempre, una strana situazione: i
regimi che sono caduti hanno lasciato dietro di loro, non solo “il sol
dell’avvenir” ma -dopo un breve periodo di euforia- una desolazione profonda,
tristezza e vuoto morale. Tutti gli antichi nodi sono venuti al pettine in
questo crocevia di popoli e di culture: la sovietizzazione forzata che ha
prodotto il meticciato e la crisi identitaria che a sua volta ha prodotto il fondamentalismo
islamico volto a ricomporre, unitamente al nazionalismo, i resti identitari dei
popoli attraverso gli attriti tra alcune popolazioni; i vertici pronti a
rinnegare il proprio passato comunista e a cavalcare l’onda nazionalista; il
disastro ecologico e il degrado diffuso del paesaggio, la bruttezza estetica
degli edifici, l’architettura alienante, le difficoltà insorte in seguito
all’interdipendenza economica tra le varie repubbliche che ora si guardano in
cagnesco per inimicizia radicale e atavica; le mafie che infilano il
neoliberismo e il capitalismo ruggente e globale nel vuoto legislativo e
alimentano il mercato nero; le attese sfiancanti per ogni azione quotidiana che
richiede l’intervento di una qualche istituzione; la difficoltà di comunicazione
e di movimento all’interno delle repubbliche, la necessità di visti dalle
condizioni proibitive per poter lavorare a pochi chilometri da casa dove si era
sempre liberamente lavorato. Un viaggio tra le
contraddizioni della globalizzazione neoliberista gestita dalla “demokratura”,
arricchito di aneddoti, impressioni a caldo, racconti autobiografici dai quali
emerge molta più verità che dal copione parziale dei media e dagli itinerari
turistici obbligati. Per i lettori europei un mezzo per conoscere
e per conoscersi, per vivere relazioni ed esperienze non consuete… Per noi
istriani, anche troppo consuete.
 |
| Christian Eccher |
So che Christian si porta sempre dietro, o meglio
“dentro”, Pina Bausch (alla quale ha dedicato il libro) e Romeo Castellucci. Ma
mi sfuggiva il nesso, mi arrovellavo e non riuscivo a capire perché uno nato in
Svizzera come Eccher, e perciò razionale, ordinato, puntuale come un orologio, avesse accostato nel
volume le vicende di quelle terre
lontane al Teatro, a quel “gioco” strano che ci accompagna dall’Atene di
Pericle in poi. Mi ci arrovello: penso
di sapere e non so, cerco di capire e non capisco. Poi butto giù
un’ipotesi di pensiero. La relazione tra la prima e la seconda parte del libro
potrebbe risiedere nel valore morale. Intendiamoci: morale non nel senso di cattolico
e tantomeno di bigotto. Semmai di religioso. Semmai una morale che affonda
nelle contraddizioni della natura umana. Nelle lande dell’Asia centrale
spazzate dal gelido vento di terra o nelle società europee informatizzate e ospedalizzate,
il dramma dell’umanità ruota ancora e sempre attorno agli stessi temi: il
bisogno di amore, la paura dell’abbandono, la necessità gioiosa di procreare,
ma mai rassicurati da un modello da perseguire o da canoni definiti e garantiti
a priori, ma sempre tra fragilità e forza, tra particolare e universale, tra
complessità e semplicità, tra caos e armonia.
È possibile far meglio in tempi di radicale mutamento?
Mutamento significa che la mente muta. È possibile uscirne meglio? Bisogna
tentare di farlo, tentare di affrontare la sfida della trasformazione, che è
sfida culturale, filosofica, politica, di pensiero. Quella già affrontata dai
grandi artisti del nostro tempo che -non tutti- sono avanti dieci chilometri
rispetto a noi, dal Tanztheater di Wuppertal e dalla Societas Raffaello Sanzio,
da tutti quelli che contrastano le ipocrisie e i finti moralismi e si liberano
degli abiti che li coprono e -liberandosene- liberano la sofferenza di un vita,
di una persona, di un popolo. E con nuovi linguaggi ci fanno intuire qualcosa
di universale che esiste in tutti gli esseri umani da sempre.
 |
| La copertina del libro |
Christian Eccher
Vento di terra
Sapienza Università Editrice 2016
Pagg.132 € 16,00
***
LIBRI
LETTERE A DON
di Laura Cantelmo
 |
| Mary-Lou Burness |
Solitamente
la lettera d’amore, un topos
romantico, è un genere facilmente destinato a scivolare nella retorica, spesso
è ridondante, in sintonia con l’impeto della passione. Oggi, è stato giustamente rilevato nella presentazione,
il genere potrebbe ritenersi obsoleto, superato da un altro genere dall’effetto
più fulminante, ma linguisticamente sciatto e destinato all’estinzione, insieme
al mezzo che ne consente la trasmissione.
Nell’accostarmi a queste
lettere scritte da Mary-Lou Burness, consegnatemi da Gaccione provai una spontanea
riserva, nonostante Angelo me ne parlasse escludendo qualsiasi ombra di
retorica. Lui poteva affermarlo con sicurezza, avendo avuto il privilegio di
conoscere i due amanti e certamente le sue osservazioni mi hanno aiutata a
cogliere la freschezza di una prosa semplice, eppure emotivamente intensa e
insieme a provare nostalgia per quella forma letteraria intima e insostituibile
che è la lettera.
Posso dire che l’immagine
che mi si presentò alla lettura mi condusse presto a smentire i pregiudizi. Le
lettere non sono affiancate dalle risposte di Don, eppure pare risuonare la
voce di Don, talmente vivida è la prosa di chi scrive.
Innanzitutto dalle parole
di Mary-Lou traspare la fisionomia dei due artisti, imponendo la loro
singolarità di persone colte, creative, appassionate. Come donna, fui colpita
dal ruolo “pedagogico” di lei, che si presentava come persona curiosa,
anticonformista, profondamente immersa nella storia d’amore con Donald Burness,
molto più giovane di lei e indubbiamente inesperto agli inizi della loro storia.
Un ruolo che tuttavia non vede alcuna posizione di subalternità, bensì, secondo la più moderna pedagogia, potremmo
dire, un reciproco stimolo, una ricerca comune. Il terreno che Mary-Lou trovò
nella relazione con Don fu estremamente ricco e fertile, tanto da far maturare
una intesa profonda, totale, rara fino alla fine dei suoi giorni, quando ormai
invalida e fragile continuò a manifestare in ogni forma il suo amore. La differenza anagrafica non
pare emergere mai da queste deliziose lettere inviate da una donna innamorata
all’uomo con il quale vive una magica sintonia intellettuale ed emotiva.
 |
| La copertina del libro |
Nessuna nota
sdolcinata, nessun cedimento al sentimentalismo. Le lettere di Mary-Lou semplicemente annotano il quotidiano. Se
vogliamo, la banalità del quotidiano, di cui si alimenta la vita di ciascuno di
noi: gli animali di casa come persone di famiglia, la neve da spalare, la televisione
che presenta i candidati alle elezioni, i piccoli fastidi con i vicini di casa,
le partite a bridge. Potrebbero sembrare lettere di una comune casalinga, se improvvisamente non si illuminassero di una fugace
annotazione sulle letture, sulla musica ascoltata, sulla meraviglia ispirata
dalle tappe del viaggio del suo “Duck”, come talvolta viene teneramente
chiamato Donald.
L’amore, le allusioni
intime, sono accuratamente evitati, eppure restano il sottofondo pulsante, il
non detto, di una relazione profonda, assoluta, un tesoro da preservare
gelosamente che si svela quasi solo nel
commiato: “ti amo”, “mi manchi”, “ti adoro”,
elevando la vita che scorre a esperienza unica, eccezionale, come
eccezionale è il sentimento appassionato che li lega. La singolarità della
coppia balza in primo piano nel constatare che Don è spesso in viaggio per
l’Europa, mentre lei a casa lavora e custodisce con naturalezza la
quotidianità. Segno di una libertà di movimento concessa a lui, quasi - si
direbbe - volta a colmare il vuoto esperienziale del giovane Don, a sedarne la
sete di conoscenza. In questo Mary-Lou
espleta un ruolo “pedagogico” e al contempo si arricchisce assorbendo
dai racconti, dalle cartoline di lui, la bellezza di un viaggio che assume il
sapore di un grand tour di
settecentesca memoria.
L’unica lettera
indirizzata a Mary-Lou da Don è l’estremo saluto di un amante alla sua amata. Scritta
con profonda commozione negli ultimi istanti di vita di lei e letta poi davanti
alla sua salma, è l’addio a una donna straordinaria per intelligenza, senso di
libertà e amore della vita, che ha arricchito l’esistenza di entrambi in una totale condivisione di
emozioni e di passione. Ed è anche una lezione sull’amore, che non è
in alcun modo scalfito dalle devastazioni del Tempo: “L’amore non muta quando trova mutamento! L’amore non è affamato di
Tempo. I grandi poeti questo lo sanno.”
Mary-Lou Burness
Lettere a Don
Edizioni Nuove scritture, 2016
Pagg. 64 € 10,00LIBRI
IL CONGRESSO FILOSOFICO DEL 1926
E LA VIOLENZA DEL REGIME FASCISTA
di Fulvio Papi
Già nella prima edizione dell’opera di Eugenio
Garin (anni Cinquanta) sulle “Cronache della filosofia italiana” si faceva
ampia menzione del congresso filosofico, organizzato a Milano da Piero
Martinetti, e chiuso d’autorità dai fascisti. È una delle vergogne del regime,
non delle più gravi, se si pensa ai morti dell’ascesa fascista e alle migliaia
e miglia caduti sui vari fronti di guerra, ma idealmente era un provvedimento
che mostrava alla cultura italiana quali fossero le condizioni di sudditanza
alla dittatura di ogni forma di pensiero. A questo convegno Martinetti, così
lontano da ogni forma storicismo, invitò Benedetto Croce che accettò, e svolse
una lunga relazione sulla filosofia italiana dell’età barocca. Croce nel 1926,
dopo il varo del manifesto degli intellettuali antifascisti, era diventato un
simbolo della libertà filosofica nei confronti della vulgata fascista che
derivava dall’antico sodale Giovanni Gentile. Cinque anni dopo il filosofo
dell’atto, sollecitò Mussolini a stabilire che i professori dell’Università
dovessero giurare fedeltà al regime se volevano mantenere la cattedra. Fu la
vendetta di Gentile nei confronti di firmatari del manifesto antifascista,
richiesta al capo del governo il quale nel ’29, con i patti lateranensi, si era
rifiutato di rendere obbligatoria nell’Università l’educazione religiosa. Solo,
ormai è nozione comune, dodici accademici si rifiutarono, tra i quali il solo
filosofo Piero Martinetti con una lettera in cui negava ogni possibilità di
fare violenza alla propria coscienza che era la condizione fondamentale perché
il pensare filosofico avesse l’unica vera testimonianza, nella coerenza della
propria identità personale. Ho riassunto molto velocemente la cornice
dell’imponente studio avviato da Fabio Minazzi (cui deve andare il
riconoscimento di qualsiasi studioso della filosofia italiana) intorno al
famoso congresso del 1926. La novità assoluta che troviamo è nel reperimento di
tutte le relazioni che non confluirono negli “atti” ma furono disperse in varie
forme di comunicazione. Minazzi, con fervore morale e sapienza storica, ha
raccolto gli “atti” del tristemente celebre congresso, oltre tutta la
documentazione relativa alla sua preparazione da parte di un Martinetti, a
dispetto dei tempi, rigoroso interprete della libertà di pensiero.
Il lungo saggio di Minazzi che, facendo centro sulla
figura di Martinetti, è un documento storico di fondamentale utilità per
entrare nella temperie filosofica e politica del momento in cui il fascismo
diventava a tutti gli effetti un regime di polizia. Non va sottovalutato
nemmeno il bel saggio di Rossana Veneziano che riassume i testi dei vari
autori. A semplificare si può dire che Varisco faceva centro sullo stato come
garante dell’eticità di ogni persona. Al suo opposto De Sarlo, in aperto
antifascismo, sosteneva la libertà individuale come fondamento della “dignitas
hominis. Martinetti concedeva, secondo la sua etica filosofica, la libertà di pensiero
di ognuno, quale che fosse la sua tesi dominante. Fu un filosofo di rara
mediocrità ma di ostinata fede fascista, come Carlini, che provocò l’incidente
che Martinetti credette di risolvere con il suo tatto, ma che fu invece il
pretesto per l’autorità fascista di chiudere il congresso. Fu Luigi
Mangiagalli, podestà (illegittimo) di Milano e senatore del Regno ad assumere
questa decisione che, condivisa dalle altre gerarchie statali o partitiche,
mostrò come il regime considerava incompatibile con la propria identità, una
libera espressione del pensiero.
Ricordavo il merito di Minazzi di aver raccolto le
relazioni al convegno che ognuno oggi può leggere e interpretare secondo la
congiuntura etica e teorica del momento. Un contributo prezioso. Una più che
ragguardevole rassegna della stampa dell’epoca consente al lettore di risentire
gli echi più immediati all’evento filosofico. La mia lettura (che ovviamente
non è la sola) consente di raggruppare i contributi della stampa secondo tre
ordini. I fogli fascisti o fascistizzanti mostrano disprezzo e arroganza
aggressiva nei confronti di ogni forma di “pensiero” di natura filosofica.
Altri giornali davano resoconti relativamente obiettivi senza sottolineare le
tensioni etiche che si potevano percepire. Interessanti i giornali della
sinistra. L’Unità recita la lezione
sulla vera libertà che è quella economica senza la quale ogni altra libertà è
secondaria. Il solito Marx in pillole. L’Avanti!
Mostra comprensione filosofica intorno ai temi del congresso e una sua
opportuna sensibilità sulla libertà di pensiero. Quale in epoca staliniana fu
l’esito politico della concezione della libertà espressa nel 1926, è ormai una
conoscenza comune. Come lo è anche il sacrificio per la libertà di molti
giovani e meno giovani che guardavano alla sinistra comunista. Come si può
vedere, quel drammatico congresso filosofico del 1926 mostra echi molto più
lunghi e sensibili, che era bene ordinare nelle loro origini, ringraziando per
il loro lavoro tutti i curatori.
 |
| La copertina del libro |
A cura di Fabio Minazzi
con la collaborazione di Rossana Veneziano
I filosofi antifascisti. Gli interventi del congresso
milanese
della SFI sospeso dai fascisti nel 1926.
Mimesis Edizioni 2016
Pagg. 598 € 38,00
La resistibile invasione degli entomati
di Claudio Zanini
 |
| La copertina del libro |
Nel recedente romanzo
di Mariano Bargellini, La setta degli
uccelli, il narratore è prossimo ad avere un rapporto amoroso con due
fanciulle che, al culmine della seduzione, si trasformano, lasciandolo a bocca
asciutta. L’una, la merla rubacuori, gli lascia un simulacro
di ceramica vetrosa di cui deve scomodamente accontentarsi; l’altra vede
svolazzare via tra la nebbia, nelle fattezze d’una cincia dal ciuffo biondo.
Qui, in Giocare a
mangiarsi, “fantasia erotica d’un pazzo”, il fabulatore sembra prendersi la
rivincita, mutandosi in minuscola cavalletta che, posata sulla spalla nuda
della compiacente Olimpia, moglie di un editore, cresce a dismisura e, potenza
dell’Eros!, s’ingrandisce a scala umana, mentre i suoi organi s’industriano in
un paradossale atto sessuale. Paradossale, non solo perché consumato da un
insetto e da una donna, ma anche perché l’ortottero è femmina, e il suo
ovopositore funziona impropriamente ma, in modo efficacissimo, quale inesausto
stantuffante organo maschile.
Il narratore, evidente paradossologo, vittima, in
precedenza, dell’altrui metamorfosi, qui la scopre agire su di sé guardandosi
allo specchio (33), dove vede riflessa l’immagine d’una pensierosa maschera di
giada verde pisello, vale a dire la testa dell’ortottero fino a quell’istante
virtuale, computerizzato, suo avatar digitale
nel videogioco in voga, Giocare a
mangiarsi. Schizzata nel mondo dal monitor del suo PC, la cavalletta prende
il suo posto e, assalita da impulsi del tutto umani, si proietta in molteplici
luoghi e vicende.
Il racconto, svolto nella densa e multiforme scrittura del
Bargellini, innervato da una costante verve comica; e, scandito da una voce
narrante e monologante - aulica e plebea, ricca di termini desueti e ricercati,
spesso ironica, beffarda, poetica, disincantata, paradossale ma di logica
affilata -, rivela la bizzarra e progressiva invasione degli insetti, una
metamorfosi planetaria, fagocitante il mondo reale. Mutazione prefigurata nelle
“plastificazioni” operate dal bisturi dei cosiddetti “image makers” - proclamanti che l’uomo è tecnologicamente
superato - e di cui il narratore vede un esempio nella “ragazza cicala”,
sinuosa cubista in un talk show (36).
La stessa Olimpia,
che, a sua volta, si trasforma in insetto, un ceràmbice con le manine a pinza,
teorizza l’avvento della magnifica e progressiva trasfigurazione universale dell’umano - oramai inadeguato - in insetto: macchina perfetta ed efficiente, quantunque
il narratore la metta in guardia da tal esito: un uomo automatizzato e
funzionale a “un sistema di follia, d’iniquità, d’insignificanza”. L’insetto è
l’immagine dell’automa, dei ròbot dal “funzionamento esatto infallibile spietato”,
quali noi diventeremo (107).
Tali convinzioni, non impediscono la totale e definitiva
trasformazione del fabulatore in cavalletta; il quale, tuttavia, sembra tutt’altro
che dispiaciuto del suo sembiante d’insetto; anzi, da “cavalletta narcisista”
qual è, pare molto apprezzare i suoi occhi d’ebanite e la lucida mascheratura
di giada verde taglia XL; la sua efficienza sessuale, meccanicamente perfetta,
messa alla prova con Olimpia; e la vittoriosa voracità nei confronti dei
rivali. In aggiunta a queste qualità, a differenza degli umani, negli insetti
non vigono ipocrisia né menzogna.
Nel bestiario di questo Theatrum Insectorum compaiono
altre e diverse figure “mostruose”. Oltre alla seduttiva Olimpia, della quale
già abbiamo detto, c’è il marito editore: uomo indegno e contemporaneamente mosca
colta e virtuosa, suo avatar nel
videogioco di Giocare a mangiarsi. Ipocritamente,
l’editore piange la moria degli autori di best-seller, sorta di scarabei
stercorari ferocemente rivali. Questi producono palle di sterco per lettori di
palato grosso: vale a dire, volumi con la mummia dell’autore cellophanata in
copertina”. L’editore, che “stampa i libri che non gli piacciono, non quelli
che gli piacciono”, consiglia, dunque, al nostro narratore di “ridurre in poltiglia
l’italiano” per renderlo più digeribile; di adottare uno “(…) stile da copy;
frasette brevi, vuote, frivole, un’aggettivazione rassicurante, la più triviale
e dozzinale, meccanica e stancata dall’uso, da dépliant turistico. (…) Anzi,
stile da baccalà, così stirato, secco, essiccato”(124).
Impietosa e sarcastica è la critica del presente mondo letterario
in cui si persegue una devastante metamorfosi del linguaggio. Con lo stesso
umore corrosivo si sbeffeggia il pervasivo sistema della pubblicità, dove
spiccano le maschere grottesche (miserabili pulci) dell’art Adonis e della copy
Troncia, (vespasiano da concerto, vaso di tutte le deiezioni e trionfatrice di
una gara di peti); e del loro gatto pittore, di cui i due firmano i guazzabugli
colorati venduti a caro prezzo.
Il videogioco Giocare a mangiarsi, nel romanzo di
Bargellini, non solo è nefasto gioco, ma, in trasparenza, figura della realtà;
una realtà mascherata in cui ciascuno assume un sembiante artificiale dal quale
è vissuto senza ipocrita finzione; mentre il testo è favola vera, che, parlando del mondo virtuale, spiega quello reale,
dove la voracità è unica regola. Un bel paradosso, dove è lecito sostenere che
la letteratura (la più onirica e fantastica, per citare lo stesso Bargellini),
rivela la realtà nelle sue verità profonde; qui il virtuale, cioè il
videogioco, mette a nudo il mero stato delle cose di una realtà ferocissima. Il
mangiarsi del gioco virtuale, la voracità, non è solo una metafora: di fatto
si divora o si è divorati. Anche il carnevale (la mascherata totale) è stato,
in tempi lontani, un brutale rivelatore, come lo è spesso la follia. E questa
fabula non è forse un folle carnevale, “fantasia erotica d’un pazzo”?
Il mondo virtuale e quello reale, come già detto, si
sovrappongono sconfinando l’uno nell’altro con effetti di straniante e, a
tratti, angoscioso, disorientamento. Le categorie fondamentali della realtà sono stravolte; mentre
tempo e spazio subiscono dilatazioni e contrazioni, come le corna d’una lumaca (162),
anche
le identità individuali sono ridotte, appiattite alla dimensione degli entomati.
Come sostiene Olimpia, siamo inadeguati, inefficienti, il
nostro universo umano ci permette scelte limitate e sofferte; tuttavia,
l’illusoria libertà dell’universo virtuale del fatale videogioco, cosa ci
offre? Essa elimina la storia, il vissuto, la sofferenza; al loro posto suscita
uno spazio illusorio
costituito dall’accumulo indifferenziato di dati, richiami, immagini, testi; un
vuoto abisso illimitato in cui si precipita nell’ossessivo digitare un termine
dopo l’altro, in un rimando senza fine.
La rete “(…) è uno sconfinato
ipertesto… esclusivo, autoreferenziale e invincibile… un non luogo e un non
tempo, che vive in un eterno presente” (ne parla Giuseppe O.
Longo in Prove di città desolata).
Ci soccorrono, inattese e come antidoto a tale immenso artificio,
nel capitolo VIII, due sorprendenti ed enigmatiche scene agresti, estranee al
videogioco, in cui il contesto è del tutto nuovo.
Nella prima, un gregge inquieto e incustodito, quasi
ammaliato da un seduttivo pifferaio, sale l’erta spoglia d’una montagna verso
una casupola nera, (figura, nei Tarocchi, d’un cambiamento disastroso), oscuro
e minaccioso esito dell’ascesa. Questa, mi pare visione onirica; tant’è che il
narratore la ricorda il mattino dopo - a colazione, in un ostello alpino -, assistendo
alla prima di diverse metamorfosi: una coppia di fidanzati si trasforma in due
grandi farfalle; quindi la Famiglia Turistica (pronta per un telequiz), diventa
una squadriglia aerea di grossi mosconi.
Nella seconda scena, come per riprendere fiato dopo
raffica di mutamenti, Bargellini (211) descrive l’immagine sublime d’un mirabile arcobaleno, che mi piace citare:
“Si dispiegava, zendale di Iride, giù dai balconi delle
montagne e sopra le pendici selvose, l’arcobaleno posato sulla terra. A una
prima occhiata, quasi torrente ghiacciato d’acqua alpestre fumida verde, d’una
viridità smeraldina; ma poi variata, a ben guardare, da una vena di zaffiro,
distante, quella colata sbieca di luce verde; e più distante ancora, lungo il
bordo esterno, da una venatura arancio. A risalirlo con lo sguardo fin sotto al
velario delle nubi, di una nuvolaglia vespertina apertasi, strappata come in un
affresco trionfale; ed aggrumatasi di rosa.(…) D’un subito precipite con
un’arcata ad angolo acuto radendo le cime sprofondava al di là del crinale. (…)
Mimava dei cartigli bioccoluti il sole, senz’alcun motto, bianchi nell’azzurro…
”.
In questi due scenari alpini, inaspettatamente, la scrittura cambia
registro. Nel primo, si fa meno spezzata e sincopata, ricomponendosi in
un’apparente quiete da cui traluce, tuttavia, un’ansia inspiegata; nel secondo s’illumina
in un’abbagliante sequenza barocca.
Tali sequenze, lo ripeto, a mio parere estranee al contesto della
narrazione, acquisiscono proprio a causa di tale “essere altrove” – forse,
azzardo, uno psicanalista direbbe, in una profondità inconscia primordiale -,
una segreta presenza perturbante che colora di significato l’intero testo (smussa
le asperità delle vicende narrate, ne vanifica le necessità, apre spiragli sotterranei,
ecc.)
In questi paesaggi alpini si respira un’aria pura,
rarefatta, di cristallina trasparenza. È uno scenario, questo, opposto a quello
artificiale e supertecnologico dove si affannano insetti e umani nel tremendo
gioco. Incomparabilmente bello, dunque, si mostrerà il mondo, radioso affresco tiepolesco
o dipinto da Turner -sparito ogni umano sembiante - al trionfo della minuscola
genia degli insetti, sia naturali, sia virtuali? si chiede il fabulatore. Subito
dopo, un’altra grottesca metamorfosi: quella d’una lettrice in coccinella
pustoluta; quindi, in diretta TV, il presentatore di uno show diviene un onisco
appallottolato e rotolante. E via di questo passo, pervicacemente, verso la
catastrofe.
Certo, in conclusione pare che l’autore ponga alla
sgomenta attenzione del lettore, soprattutto l’inderogabile progressione della nostra
metamorfosi in insetti, e, parimenti, il sovrapporsi fagocitante della rete
virtuale all’umana realtà, insieme al declino d’ogni punto di riferimento
spazio/temporale. Tutto sarebbe dunque perduto!
Tuttavia, il nodo cruciale delle questioni messe in
campo, consiste, a parer mio, sia nell’irruzione appena citata dell’intermezzo
alpino a scuotere l’alchimia del testo; sia - e Bargellini qui sorprende,
rovesciando la situazione con un coup de théâtre -, nel fatto che, addirittura, sia la
cavalletta la narratrice; lei insetto - alter ego del narratore -, a
scrivere, in una “performance inaudita”, il romanzo Giocare a mangiarsi, favola
vera, evocando le vicende del misero affabulatore che in lei s’era
sdoppiato, per poi, nel finale, sparire nel nulla. Un testo scritto
dall’ortottero ma, si badi bene, non con la lingua
sciatta e vuota auspicata dall’editore/mosca e dai copy, ma attraverso lo splendore e l’irriducibile, “perversa
e scandalosa” (Barthes) complessità d’un linguaggio ancora profondamente umano;
“una fortezza di parole”, così Salardi, che ci difende dalla sua rovina. Lui,
dunque, l’insetto! scrive delle metamorfosi (ovviamente), ma anche del tremore
del gregge e del sublime variare cromatico dell’arcobaleno. Quindi, non tutto è perduto; e, se ne La setta degli uccelli, erano “le nostre
anime aeree e segrete (le umbracule)”, qui, a salvarci, forse è questa intima essenza
del linguaggio. E
questo, noi lettori, fa ben sperare nelle sorti della letteratura.
Mariano
Bargellini
La
setta degli uccelli
Effigie Ed. 2016
Pagg. 259 € 15.00
***
LIBRI
SCENARI DI LIBERTÀ
di Angelo Gaccione
 |
| Greta Salvi |
Minuzioso e ben documentato, questo volume di Greta
Salvi: “Scenari di libertà”
sottotitolo: “Teatro e teatralità a
Milano durante il Triennio Cisalpino 1776-1779”
prende in esame, come si evince dal titolo stesso, un periodo storico
importante, pur nella sua brevità, non solo per la messa in prova delle idee
degli illuministi lombardi (i fratelli Verri, il Beccaria, i letterati e gli
intellettuali riuniti nell’Accademia dei Pugni, attorno alle pagine del giornale
“Il Caffè”: Alfonso Longo, Luigi Lambertenghi, Giambattista Biffi, Paolo Frisi,
Gianrinaldo Carli e tanti altri), tutti formatisi sulle idee dei philosophes francesi, (o nei salotti di
aristocratiche come Maria Vittoria Serbelloni e di Clelia del Grillo Borromeo),
ma della tenuta stessa di quella libertà tanto agognata dai milanesi e che il
giovane generale Bonaparte e le sue truppe lasciavano sperare. Il tema di fondo
resta il teatro naturalmente: il teatro messo in scena, soprattutto “Alla
Scala” e “Alla Cannobbiana” (quest’ultimo ubicato nell’area del Bottonuto, tra l’attuale
via Paolo da Cannobbio e la via Larga, e che dopo alterne vicissitudini,
compreso un incendio, sarà ricostruito nel 1943 e prenderà il nome di “Teatro
Lirico”), i cui testi e i relativi autori, le compagnie, gli impresari,
dovranno ben presto vedersela con le istituzioni e con le direttive francesi e
del Dicastero. Le speranze e gli entusiasmi repubblicani suscitati da Napoleone
e dalle sue armate si affievoliranno presto nei patrioti, e il trattato
Campoformio vi metterà il sigillo tombale. Eppure, come ci mostra la Salvi nel
suo saggio, i milanesi li avevano con benevolenza accolti, soldati e generale,
e anche la produzione teatrale, quella rigidamente propagandistica, seppure con
tutta la necessaria retorica dei tempi, del contesto e degli ideali cui si
ispira, non sarà così marginale e contenutisticamente insignificante per
celebrarne i fasti, tutt’altro. Tuttavia, come sempre avviene, fra potere
istituzionalizzato (che si definisca rivoluzionario poco importa) e creatività
artistica ed intellettuale, l’attrito è destinato a riproporsi subito. Sicché
il teatro subisce controlli e censure a più livelli, sia quello apertamente
schierato (il patriottico), sia quello di argomento più disimpegnato e di intrattenimento.
Le direttive governative e la continua mediazione tengono aperto un conflitto
che non vedrà vincitori. Sicché l’acceso dibattito che aveva investito il
progetto di un teatro patriottico corroborato di sublimi ideali, e che si era
dipanato per l’intero triennio della Cisalpina, sarà costretto a fare i conti
con la realtà effettiva dello specifico teatrale, i costi, la qualità, il
pubblico e gli aspetti organizzativi e gestionali che esso comporta.
I testi e gli autori rappresentati e che la
Salvi ci segnala, appartengono al repertorio “repubblicano” e anti-tirannico,
siano essi attinti alla tradizione classica, al mito e alla Roma di Bruto,
siano più coevi o approntati da quegli intellettuali “militanti” (dal cosentino
Francesco Saverio Salfi, per esempio, vera star delle scene), e sempre con
quell’intento educativo di stampo illuminista, con quel furore estremista e
libertario che riscontriamo in Alfieri, non a caso continuamente rappresentato
dai dilettanti della Compagnia del Teatro Patriottico. E tuttavia dalla ricerca
emerge che questo teatro non ebbe, a conti fatti, un ruolo così predominante
nel triennio preso in esame, rispetto a quello di intrattenimento e più
popolare, e non solidificò. Anche perché le ambiguità dei francesi si
riveleranno ben presto per quello che sono: opportunismo politico da utilizzare
per le proprie mire nazionali, per le ambizioni di un generale che si farà
presto nuovo Cesare e dittatore, e devono dunque servire alla sua offensiva
diplomatica da spendere con gli austriaci e sulla scena dell’assetto europeo.
Si arriverà al punto che il pubblico fischierà le opere di contenuto
patriottico-filofrancese, ora che quelli che si erano presentati come
liberatori verranno percepiti come occupanti. La stessa teatralità che avrà
luogo per le strade, nei parchi o al Lazzaretto, le feste pubbliche, le
ricorrenze, i tributi d’onore agli eroi e ai caduti, gli anniversari legati
alla caduta della monarchia francese o alle vittorie, con le fastose
scenografie, gli addobbi, le luci, le salve dei cannoni, le sfilate, le
bandiere e i vari aspetti simbolici (gli alberi della libertà in primis), si
erano un po’ alla volta trasformate in cerimonie calate dall’alto, relegando
gli strati popolari al semplice ruolo di comparse, o addirittura escludendoli,
a volte brutalmente, dallo spazio della “rappresentazione scenica” dell’evento,
a tutto vantaggio dei ceti più in vista e delle autorità.
Il
quadro storico di riferimento che apre il volume, il ruolo che il teatro avrà nel
rapporto con le due massime istituzioni: La chiesa e la Repubblica; la riproposta
delle edizioni a stampa dei testi fino all’inserto iconografico che chiude il
libro, ci consegnano una ricerca preziosa che Greta Salvi ha costruito con
passione e che sarà utilissima non solo per gli appassionati di teatro, ma
anche per i cultori di storia milanese e non solo.
 |
| La copertina del libro |
Greta Salvi
Scenari di libertà
Fabrizio Serra Editore 2015
Pagg. 240 € 48,00
LIBRI
Gabriele
Scaramuzza conversa con Chiara Pasetti,
in
occasione della pubblicazione del suo libro su
Camille Claudel
 |
| Chiara Pasetti |
Scaramuzza. Il suo libro è
molto bello, ben articolato, e ha sostanza; si legge come un romanzo. Non
guastano poi le emozionanti fotografie che ha introdotto. Vale la pena dunque
soffermarcisi un po’. Lo faccio ponendole alcune domande, utili ad approfondire
qualche punto e a invitare alle lettura. Innanzitutto il titolo pone una domanda: Mademoiselle Camille Claudel è ovvio; ma quell’ “e Moi “ che lei aggiunge, a chi si riferisce ? che implicazioni
ha?
Pasetti. Ho
riflettuto a lungo sul possibile titolo di questo lavoro; Mademoiselle Camille Claudel è in effetti il titolo del saggio di
Mathias Morhardt che ho tradotto interamente (finora non era mai comparso in
traduzione italiana), e ho notato che anche gli altri critici, scrittori,
giornalisti dell’epoca si riferivano sempre a Camille in questo modo. Ho deciso
poi di aggiungere “e Moi” per diversi motivi. Innanzitutto perché MOI è il
titolo del testo teatrale contenuto nel libro, il quale nasce dalla risposta di
Camille Claudel alla domanda «qual è il tuo artista preferito?»: lei, nel 1888,
risponde «Moi-même»! In secondo luogo perché dietro a quel “Moi” si cela anche
Flaubert, il mio maestro spirituale e fonte di ispirazione perenne. È noto che
Flaubert, alla domanda «chi è, insomma, questa Madame Bovary?», abbia risposto «Madame
Bovary c’est moi!». In realtà questa frase è riportata da uno dei suoi primi
biografi, ma non è mai stata scritta da Flaubert… Possiamo dire che ormai ci
piace pensare che lo abbia detto realmente! Infine, legare i due titoli con una
congiunzione mi sembrava un modo per creare fin dall’inizio un dialogo tra me e
lei, una sorta di legame tra la parte saggistica, vorrei dire “seria”, del
testo, e la parte più creativa, quella relativa al monologo Moi.
S. Il suo libro è apparso
presso nella collana Nous, da lei diretta. Può dirci qualcosa circa il progetto
della collana e la collocazione in essa del suo saggio? Quali altri scritti
seguiranno?
P. Sono
profondamente grata all’editore Nino Aragno per avermi proposto la direzione di
questa collana, di cui il testo su Camille Claudel è la prima pubblicazione. Ho
scelto di chiamare la collana “nous” proprio in relazione al Moi di cui
parlavamo prima… da un pronome soggettivo a uno plurale, “accogliente”, che
comprende in fondo anche me stessa in questo “noi”. Era un sogno per me
dirigere una collana tutta mia! In questo “nous” del titolo sono compresi tutti
e soprattutto tutte le autrici e gli autori che da tempo studio e medito di
pubblicare, e che posso racchiudere nell’esergo di Nietzsche che ho scelto: «noi
incomprensibili». Si tratta di testi in gran parte ancora inediti o quasi, che
ho intenzione di pubblicare per ridare voce a figure in gran parte femminili
poco conosciute, poco indagate e studiate in ambito italiano, oppure a grandi
autori (Flaubert per esempio) di cui pubblicherò però non i testi più noti
bensì quelli ancora inediti e dimenticati. La prossima pubblicazione riguarda
la giornalista e scrittrice Caroline Rémy, detta Séverine, i cui articoli sono
ancora quasi tutti inediti in Italia. Uscirà a breve per la traduzione di
Ilaria Moretti, con una mia nota introduttiva. Seguiranno sicuramente i
racconti giovanili di Flaubert, e tante altre donne che la storia (e la
critica) ha spesso trascurato. È un progetto a cui tengo moltissimo e che spero
di riuscire a portare avanti con impegno e con la passione di sempre.
S. Per quali vie
è giunta a occuparsi con tanta passione e tanta acribia di Camille
Claudel?
P. Nel 2013, per caso, ho scoperto che ad Avignone si teneva una mostra
di sculture di Camille Claudel, all’interno dell’ospedale psichiatrico di
Montfavet dove Camille è stata internata dal 1914 al 1943, anno in cui è morta.
Ho visto la mostra e ho finalmente potuto rendermi conto del valore di questa
grandissima artista. Da quel momento ho letto tutto ciò che è stato scritto su
di lei, e più leggevo, studiavo, guardavo i film che le sono stati dedicati
(penso al film del 1988 con Isabelle Adjiani e Gérard Depardieu, ma anche al
recente film del 2013 con Isabelle Binoche) più cresceva in me la
consapevolezza che ci fosse ancora molto da dire su Camille, specialmente in
Italia, dove a parte una attenta, rigorosa e appassionata biografia scritta da
Anna Maria Panzera (Camille Claudel,
ed. l’Asino d’oro), uscita sempre quest’anno, gli studi sono ancora relativamente
pochi, e molto specifici. Da studiosa di estetica mi sono interessata
moltissimo alle sue opere, così nuove e vorrei dire di rottura per quegli anni,
e da donna non ho potuto rimanere indifferente alla drammatica vicenda
dell’internamento in manicomio, che ha messo la parola “fine” sulla sua arte.
 |
| Camille Claudel giovane e anziana |
S. Per esprimersi
ha usato vuoi la via del teatro vuoi quella del saggio. Entrambe molto ben
riuscite. Non a caso il suo volume contiene in conclusione anche il testo
teatrale. Ma come mai questi due approcci diversi? Quali sono le affinità e le
differenze tra le due vie?
P. Come spiego nell’introduzione, a un certo punto mi sono resa conto
che la via del saggio, che pure mi è congeniale, non mi bastava più. Da tre
anni “vivevo” insieme a questo personaggio, come direbbe Flaubert mi ero
“trasportata” in lei, e ho sentito il bisogno, accanto alla forma del saggio,
di dare voce a quella parte di me che si era identificata in lei, che ne
“sentiva” pensieri, emozioni, rabbia, sofferenza, delusione, ecc. Il lavoro
teatrale è nato nel 2013 come lettura, il testo era quasi interamente tratto
dalla corrispondenza di Camille Claudel. Ma anche quella forma non mi
convinceva appieno; così, mi sono messa a scrivere… Ho immaginato di essere
lei, in atelier, agli inizi del Novecento, quando ormai la sua relazione con
Rodin era conclusa e il mondo dell’arte, che all’inizio l’aveva osannata, la
stava lentamente abbandonando, ho immaginato le sue difficoltà di riuscire a
vivere della propria vocazione, la scultura, di riuscire a vendere le sue sculture.
E ho immaginato cosa potesse provare quando improvvisamente la madre e il
fratello hanno deciso di rinchiuderla in un asilo per alienati mentali. Le
parole sono venute fuori da sole, è stato quasi un flusso di coscienza… Del
resto non è la prima volta che scelgo di scrivere un testo teatrale accanto ad
altri di natura più saggistica, lo scorso anno ho realizzato la drammaturgia
della Tentazione di sant’Antonio di
Flaubert e sto scrivendo un nuovo spettacolo teatrale. Credo che, quando si ama
scrivere, e si conosce a fondo un argomento e un personaggio, a un certo punto
venga naturale posare la penna “accademica” e prendere quella creativa, intima,
personale. O almeno a me è capitato così… Dopo una prima versione teatrale che
non mi aveva per nulla convinto, ho sottoposto il testo al regista e attore
genovese Alberto Giusta, al quale è piaciuto molto il personaggio e anche la
storia. Il regista ha quindi individuato nella persona dell’attrice Lisa
Galantini, che è davvero di una bravura strepitosa, l’interprete migliore per
il ruolo di Camille Claudel. Abbiamo debuttato il 30 settembre a Genova, e
speriamo che questo monologo, a cui abbiamo lavorato tutti con tanta dedizione,
possa essere conosciuto nei teatri italiani. Credo che aiuti il pubblico a
scoprire questa meravigliosa figura di donna e di artista e che sia, anche se
postuma, una forma di risarcimento, dovuto, per tutto ciò che ha subito…
 |
| Rodin "Maschera di Camille" |
S. Come vede i
rapporti tra il celebre Paul e la sorella Camille? E l’atteggiamento
(sconcertante per me) di Paul Claudel?
P. Il rapporto, strettissimo, tra i due, è in effetti particolarmente
interessante. Paul, nel suo testo Ma sœur
Camille che ho tradotto nel libro, parla di un «ascendente spesso crudele»
che lei «esercitò sui miei giovani anni». Sappiamo che lui deve le sue prime
letture (Rimbaud soprattutto) a lei, e si trovano echi della poetica e
dell’estetica di Camille nei testi di Paul. Certamente lui era una personalità
molto più debole, deve aver sofferto molto il confronto con questa «donna di
genio», che oltre tutto era molto bella (posso immaginare che la sua bellezza
prorompente, per un fratello, sia stato fonte di grande gelosia). Inoltre la
strada che a un certo punto lui sceglie di intraprendere, la carriera
diplomatica, non contemplava scandali, dunque il fatto di avere una sorella
così eccentrica, che a un certo punto diventa “l’amante” di Rodin, che aveva
ben ventiquattro anni più di lei, deve averlo molto irritato nonché deluso… La
madre è sicuramente la principale responsabile della decisione
dell’internamento, ma Paul ne è comunque complice. E come Lei, Professore,
sottolinea, l’atteggiamento di Paul dal momento dell’internamento in poi resta
sconcertante, quasi incomprensibile. Andò a trovare la sorella poco più di una
dozzina di volte in trent’anni, e non fece nulla per riportarla a casa o per
trovarle una sistemazione più confortevole e rispettosa della sua persona e
dell’artista che è stata. Credo che sia morto pieno di rimorsi e di rimpianti,
e il testo che ha scritto nel 1951, dunque diversi anni dopo la morte di
Camille, lo dimostra… Nonostante questo, Paul non ha ai miei occhi nessuna
giustificazione. Ha voluto abbandonarla, questo è quanto, io la vedo così…
 |
| A destra lo scultore Rodin |
S. Cosa le ha
dettato l’articolazione interna del libro? I titoli dei capitoli sono in
francese, concetti e nomi. Nel primo capitolo a prima vista mi attraggono i
paragrafi sulla bellezza e sulla verità. Vuol parlare dei rapporti nel suo
contesto tra questi due temi decisivi ?
P. Ho scritto la mia introduzione, e anche la conclusione, praticamente
di getto. Una volta concluse, rileggendo il tutto ho individuato dei temi e dei
concetti forti, e ho pensato di indicarli, anche per dare più ritmo alla
narrazione, e di indicarli in francese. I paragrafi cui Lei allude, sulla
bellezza e sulla verità, in effetti sono strettamente legati, e da studiosa di
Flaubert non posso non citare il suo pensiero, che naturalmente riprende
Platone: «il Bello è lo splendore del Vero». Dietro questi due nomi, La Beauté e Le Vrai, si nascondono naturalmente tante altre riflessioni, non
soltanto filosofiche. La Beauté
inoltre è il titolo di una splendida poesia di Baudelaire, che infatti ho
inserito nel libro, i cui versi iniziali recitano: Sono bella, o mortali, come un sogno di pietra… e la poesia si
chiude sugli occhi dalla luce immortale,
che inevitabilmente mi hanno fatto pensare allo sguardo di Camille. Rodin
trarrà da questi versi il titolo di una sua scultura. I rimandi insomma sono
molteplici. Quanto al paragrafo sul vero, c’è anche l’intento svelato dalla
frase iniziale del paragrafo, di Flaubert, di dire “la verità”, o ciò che più
vi si avvicina, sugli ultimi anni della vita di Camille Claudel. Il ruolo di
Flaubert nel libro è forte e credo evidente, anche nei titoli dei paragrafi (La Bêtise sopra a tutti, che mi ha
consentito inoltre di chiudere, o meglio di non chiudere…, sulla sua celebre
massima: «la stupidità consiste nel voler concludere»).
 |
| Opera di C. C. |
S. Infine: un paragrafo
è intitolato “K. e K.”; perché questi due K
a chi si
riferiscono?
P. Questo paragrafo è una sorta di divertissement,
un dialogo immaginario fra due personaggi, che non svelo per non togliere la
sorpresa al lettore! Anche questo nasce dal desiderio di una scrittura più
intima, dove poter usare delle parole e delle immagini che la forma e la
struttura del saggio non consentono. Posso solo dirLe che le iniziali puntate
si riferiscono a due soprannomi reali dei protagonisti del dialogo. È chiaro,
inoltre, che dietro a questa “K.” c’è anche Kafka, e mi sia consentito
confessarLe, Professore, che devo a Lei la passione per questo autore, che Lei
mi ha fatto conoscere e amare attraverso i testi, importanti e bellissimi, che ha
scritto su di lui. Uno dei primi esami di Estetica che sostenni, proprio con
Lei, molti anni fa, era dedicato a Kafka, e a lungo Lei si soffermò sui nomi e
sul significato di questi nomi dei personaggi di Kafka della trilogia dei
romanzi: Karl per L’America, Joseph K. per Il Processo, e
semplicemente K. per Il Castello…
Reminiscenze kafkiane, dunque, affiancate e nutrite da altri studi, altri
autori, altre K…!
 |
| Copertina del libro |
Chiara Pasetti
Mademoiselle Camille Claudel et Moi
Nino Aragno Ed. Torino 2016
Pagg. 250, € 20,00
Mademoiselle Camille Claudel et Moi
Nino Aragno Ed. Torino 2016
Pagg. 250, € 20,00
LIBRI
LE
MENTI PRIGIONIERE
Letteratura
e dissenso nella Russia Sovietica
di Angelo
Gaccione
 |
| Franco Celenza |
"Le menti
prigioniere” è il bellissimo titolo che Franco Celenza ha dato al suo nuovo
recente saggio pubblicato da Morellini. Dopo le sue scorribande dentro l’universo
teatrale (Celenza è anche un valente studioso, oltre che appassionato, di
teatro), con questo libro ritorna al tema del totalitarismo al quale ha
dedicato più di un saggio. Introdotto da una corposa e ben articolata disamina
di Cesare Milanese (che a sua volta solleva diverse questioni che meriterebbero
di essere dibattute), il lavoro di Celenza prende in esame il rapporto tra
potere e letteratura nella Russia sovietica, per giungere ad un a verità
apodittica: la libertà creativa-espressiva è inconciliabile col totalitarismo.
Fra queste due istanze non può esserci dunque che conflitto e scontro, poiché
la libertà è sempre irriducibile, e troverà le sue forme e le sue vie per
manifestarsi. La “diatriba”, come la
definisce Milanese, fra potere coercitivo e “potere” della parola letteraria, “proprio perché la letteratura è diatriba” (sono ancora parole di Milanese), “non può non essere che permanente”.
Questa diatriba può aver fine ad una sola condizione: che la letteratura si
faccia serva. Ma a questo punto decreterebbe la propria morte, perché verrebbe
meno alla sua stessa essenza, alla sua stessa ragione, a quella visione
eretica, ribelle, scettica, che alla letteratura assegnava il dissidente
Evgenij Zamiatin, e che aveva difeso con tutte le sue forze fino al sacrificio
finale. Il vasto panorama di letterati ed intellettuali che ci presenta Franco
Celenza, dalla morte di Lenin al passaggio del potere nelle mani di Stalin
prima e via via fino a Gorbaciov (artefice di una serie di riforme e di
allentamento della politica repressiva ), appartiene a questa visione eretica e
ribelle. Il pugno di ferro nei confronti di questi dissidenti sarà spietato e
si protrarrà fino a quasi gli anni Novanta. Ricordiamo qui, en passant, che il drammaturgo
cecoslovacco Vaclav Havel viene condannato a più di quattro anni di carcere
alla fine del 1979, lo scrittore russo Solgenitsin potrà tornare in patria (da
cui era stato espulso) solo ai primi degli anni Novanta, e che in quegli stessi
anni libri importanti di tanti di loro, non erano ancora pubblicati nei paesi
di origine. Lo stesso scienziato Sacharov esiliato a Gorkij, poté rientrare a
Mosca solo nel 1986, riabilitato da Gorbaciov. Se il totalitarismo è
inconciliabile con la libertà tout-court, figuriamoci se oppressione e servitù
ideologica non lo diventino in maniera tragicamente rovinosa nell’impatto con
la creatività della ricerca, della visionarietà estetica e del pensiero, che
dalla libertà assoluta traggono nutrimento, e di questa libertà hanno bisogno
per germogliare.
Quel che è accaduto in Russia sotto il regime sovietico oggi
lo conosciamo in abbondanza. In realtà sapevamo tutto dall’inizio: lo sapevamo
da quello che era accaduto a Nestor Makhno e ai rivoluzionari ucraini (vedi “La rivoluzione russa in Ucraina”), lo sapevamo
dal massacro di Kronstadt e dagli scritti di Volin (vedi “La rivoluzione sconosciuta. 1917-1921”). Incarcerato durante la
rivoluzione del 1905 dallo zar, Volin lo sarà un paio di volte nel 1920 dai
bolscevichi; Trotskij lo aveva addirittura condannato a morte, proprio lui che era
stato il fondatore del primo soviet di San Pietroburgo. Scarcerato su pressione
dei delegati sindacali europei, Volin fu fra i primi, assieme alla componente
anarchica, anarco-sindacalista e libertaria, a denunciare in Russia e fuori la
degenerazione della rivoluzione, subito dopo la presa del potere dei
bolscevichi. Lo sapevamo dall’esproprio da parte dei bolscevichi
dell’autogoverno dei soviet; tutto il
potere ai soviet si trasformò subito
in tutto il potere ai dirigenti del
partito, a quelli del partito unico, a quello bolscevico. Da come fu
strutturato l’apparato militare, fotocopia in tutto e per tutto di quello
zarista, così come la burocrazia soffocante, e così via. La deriva giacobina e
autoritaria impressa da Lenin e Trotskij, il partito che si fa Stato, e dunque
ordine maniacale, terrore per ogni idea divergente e dunque da annientare, da
tutto questo germoglia l’autocrazia criminale e personale di Stalin, come aveva
lucidamente intuito il rivoluzionario Volin che scrive: “Stalin non è caduto dalla luna. Stalin e lo stalinismo non sono altro
che la logica conseguenza di un'evoluzione preliminare e preparatoria, lo
stesso risultato di un terribile errore, un'involuzione negativa della
Rivoluzione. Sono stati Lenin e Trotsky - vale a dire, il loro sistema - che
hanno preparato il terreno che ha generato Stalin. Avviso a tutti coloro che
hanno sostenuto Lenin, Trotsky e altri, e adesso inveiscono contro Stalin: oggi
raccolgono quel che hanno seminato!”.
 |
| Franco Celenza nel suo studio mentre legge |
La critica libertaria alla
degenerazione bolscevica della rivoluzione avviene subito, ed è una critica che
nasce dai suoi stessi protagonisti, delusi della piega che gli eventi hanno
preso. Non sono “né agenti nemici”, né nostalgici dello zarismo: sono
rivoluzionari della prima ora, uomini radicati fra le masse e dentro le idee di
quel cambiamento. Uomini lucidi che avevano capito per tempo quello che oggi
noi sappiamo e che sia Milanese, nel suo saggio introduttivo al libro, sia
l’autore, confermano con decisione: la assoluta continuità
storica-ideologica-operativa che da Lenin e Trotskij porta a Stalin. L’universo
concentrazionario, i gulag, gli ospedali psichiatrici, il lavoro forzato,
l’assoluta intolleranza verso idee diverse, trovano origine in quel seme
primigenio. Cadranno tutti i migliori sotto il terrore staliniano, centinaia di
migliaia di comunisti che erano stati il perno e l’anima della rivoluzione; ne
farà le spese anche Trotskij, il massacratore di Kronstadt, e, ironia della
storia, il libertario Volin sarà fra quelli che si batteranno perché la
Francia, dove il bolscevico era riparato, per sfuggire al patibolo di Stalin,
non lo espella. Se la rivoluzione si fa regime, se non è tollerato alcun
pensiero divergente all’interno di un’ortodossia di cui il partito e il suo
capo si ritengono depositari, e i militanti stessi, i comunisti, vengono
incarcerati o assassinati, men che meno il regime può concedere che a “deviare”
siano gli artisti e gli intellettuali. Anzi, il regime e il suo autocrate,
fissano i contorni e le basi di questa “devianza”, di questa “degenerazione”.
La beffa è che un regime che incarna al sommo grado devianza e degenerazione ai
danni di un intero popolo, si arroga il diritto di definire “arte degenerata” e
parola e letteratura “deviata”, quella di un pugno di scrittori il cui peso
specifico sui destini di altri uomini è quasi nullo, e che se ne ha uno è solo
di tipo spirituale e morale. Contro i dogmi di un regime così spietatamente
paranoico, si troveranno a collidere, per un lasso di tempo interminabile,
alcuni dei maggiori scrittori russi. Celenza nelle sue pagine li enumera in
dettaglio e ne segue il destino: espulsi dalle associazioni letterarie,
denigrati, perseguiti, incarcerati, eliminati, costretti al suicidio, alla fuga
all’estero, al silenzio, all’autocensura
o ridotti ad autoprodurre clandestinamente i loro scritti e diffonderli nella
forma del samizdat, per sfuggire alla rete di spie che pullulano in ogni dove.
Figure del calibro di Pasternak, Babel’, Bachtin, Bulgakov, Grossman, Mandel’štam,
Sinjavskij, Solgenitsin, Zinov’ev, tanto per citarne alcune, vessate in ogni
modo, solo perché non in linea con il realismo socialista, perché non
sufficientemente entusiaste del regime e dei suoi apparati, perché hanno osato
dubitare dell’uomo nuovo, o
conservato nelle loro opere e nei
loro pensieri l’indipendenza dello spirito. Composto da otto agili capitoli, il
lavoro di Celenza prende in esame un ventaglio variegato di temi tutti focali,
e parte da lontano per mostrare come si arriva alla letteratura di partito, ai
processi farsa dei dissidenti, all’universo concentrazionario, al crollo del
mito rivoluzionario, al non-conformismo intellettuale e all’opposizione al
regime come malattia mentale. Un intervento di Carlo Alfieri sulla diaspora dei
letterati russi dispersi in ogni dove, compone il capitolo nono, e si chiude
con un’appendice in ordine alfabetico dei personaggi della cultura e del potere
sovietico, con un glossario di supporto molto utile per una maggiore
intelligibilità delle sigle citate nel testo e un’ottima bibliografia di
supporto. Questo libro di Celenza potrebbe apparire fuori luogo in anni
definiti “post-ideologici” (anche su questa definizione ci sarebbe da
discutere, e molto), ma io che lo ritengo un libro necessario, spero invece che
le scuole lo utilizzino come merita, perché le nuove generazioni sappiano cos’è
accaduto alla libertà di espressione (e le scuole, lo studio, la ricerca, il
confronto intellettuale, si fondano su questa libertà), e cosa potrebbe in
futuro accaderle, se non ne prendiamo coscienza. Vorrei chiudere questa nota
con un appunto polemico: il comportamento dei comunisti italiani rispetto a
quello che avveniva in Russia e alle “purghe” staliniane, è stato improntato al
silenzio e all’omertà. Questa “prudenza”, per non danneggiare l’immagine del
paese “fratello” durante gli anni della “guerra fredda”, è proseguito
intollerabilmente nei decenni successivi. L’invasione dei carri armati
sovietici dell’ex Cecoslovacchia, a cui il Pci darà il suo benestare ideologico,
è parte di quel disonore. Apprenderemo poi che il Pci era sul libro paga dei
gerontocrati di Mosca.
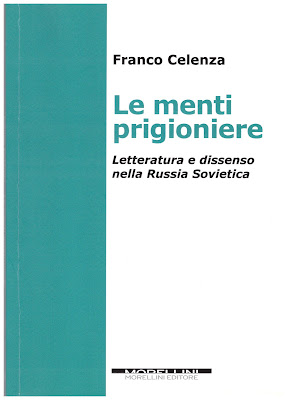 |
| La copertina del libro |
[Franco Celenza
Le menti prigioniere
Letteratura e dissenso nella Russia Sovietica
Morellini Editore, 2016
Pagg. 130 € 14,00]
***
LIBRI
LO
SPREGIO
di Angelo
Gaccione
 |
| Alessandro Zaccuri |
Alessandro
Zaccuri non è solo quell’ottimo e acuto critico letterario che conosciamo (per
me uno dei migliori sulla piazza), è anche un valente narratore, come mostrano
i suoi romanzi: da “Il signor figlio”
a “Infinita notte” a “Dopo il miracolo”, fino a questo fresco
di stampa dal titolo “Lo spregio”
(Ed. Marsilio, pagg. 120 € 16,00), finito di scrivere nel novembre del 2013.
In
un celebre pamphlet letterario di un po’ di anni fa, lo scrittore americano Tom
Wolfe lamentava il fatto che gli scrittori hanno rinunciato a raccontare la
realtà, lasciandola pressoché interamente nelle mani dei giornalisti, così come
la cronaca, che è materia viva, magmatica, pulsante, e che ai narratori si
offre come pozzo senza fondo. Il danno per Wolfe è duplice: perderne
l’interpretazione più profonda e smarrire la conoscenza del proprio tempo.
Perché è solo il buon narratore in grado di riscattare la materia “vile” della
cronaca e a conferirgli il giusto tocco, l’anima che vi soggiace, e farne
qualcosa di intemporale, di paradigmatico, di universale.
Purtroppo
anche da noi la stragrande maggioranza dei narratori ha rinunciato alla realtà
e alla cronaca del proprio tempo, condannandosi in parte alla sterilità, in
parte all’inconsapevolezza. Senza consapevolezza sociale, cioè etica, la
traiettoria dello sguardo dello scrittore risulta obliqua, rispetto alla
verità, è quel che è più grave, viene perduta quella che io chiamo la ragione morale della letteratura.
Non
è così in Zaccuri e non lo è per questo suo nuovo romanzo. Qui di realtà e di
cronaca ce n’è in abbondanza ed egli la maneggia e la domina con un rigore
etico da autore “classico”, come sarebbe piaciuto a Wolfe.
“Lo spregio” ci mette sotto gli occhi uno
squarcio degli anni Novanta (i meno giovani ricorderanno la corruzione diffusa,
la criminalità mafiosa pervasiva declinata nelle varie forme e sigle, la
saldatura innaturale fra delinquenti di varia natura e servitori delle
istituzioni, gli arricchimenti rapidi e il malaffare, le clientele partitiche,
la Milano da bere e tanto altro
ancora), e come scenario una striscia di territorio che corre a ridosso del
confine svizzero. Trafficanti, spalloni, prostitute e uomini dello stato sono
in combutta: merci e mercimonio la fanno da padrone: il denaro, l’apparenza, il
potere, sono i segni distintivi dell’epoca. La Trattoria dell’Angelo gestita
dal Moro (al secolo Franco Morelli) e da suo figlio Angelo (un trovatello
figlio di nessuno, forse frutto di quei rapporti promiscui che il Moro
controlla e copre nei suoi ambienti, e che egli adotta come proprio), è il
fulcro di questi traffici loschi.
Quando
Angelo ne verrà a conoscenza, l’età dell’innocenza sarà morta per sempre in
lui: entrerà in conflitto col padre, con la scuola, con l’ambiente, e si
trasformerà in teppista, in temerario ricattatore e trafficante a sua volta,
sulle orme paterne e soci.
Fino
ad un altro incontro fatale, quello con Salvo, figlio di Don Ciccio, patriarca
di una famiglia mafiosa che la giustizia ha spedito in questo estremo lembo di
terra del Nord, dalla lontana Calabria, e col quale forma un inossidabile binomio.
Con
l’ingresso sulla scena di Don Ciccio e della sua tribù (Salvo, Mimmo, e così
via), il romanzo vira verso un’indagine intorno a quella che possiamo definire
“mentalità mafiosa”. Mentalità che dagli anni Novanta del secolo scorso ad
oggi, non è assolutamente cambiata, nei riti e nelle credenze. Si è modificata
la logica imprenditoriale e finanziaria, sono caduti alcuni tabù considerati
inviolabili e sono comparsi i figli con laurea in tasca. Sono scomparsi la
coppola storta e le canne mozze, ed è finita la subalternità
verso il potere politico e le sue rappresentanze. E tuttavia è rimasto integro
il rapporto (tutto esteriore e superficiale) con il sacro e le sue
rappresentazioni. Salvo, il giovane rampollo del capo bastone Don Ciccio, veste
all’ultimo grido, gira per locali alla moda, indossa tutti i feticci della
modernità più spinta, gira in Cherokee, ma conserva come un vecchio patriarca
di San Luca, di Ciminà, di Africo Nuovo di quasi un secolo prima, nel
portafogli, l’immagine di san Michele Arcangelo, l’angelo guerriero armato di
spada e protettore degli uomini di fegato, degli “uomini d’onore” mafiosi. Su
quell’angelo e su quella devozione, Salvo tiene all’amico Angelo (accolto nella
sua famiglia come un congiunto) un contorto sermone che l’amico non capisce. La
loro mentalità, da questo punto di vista, è agli antipodi. Angelo resta pur
sempre un uomo del Nord, teppista, ma uomo del Nord. Intorno agli angeli verte
molto questo interessantissimo romanzo di Zaccuri, che padroneggia la materia
da par suo, e che ha avuto delle intuizioni geniali facendo lavorare al meglio
la sua fantasia di scrittore.
L’avere
introdotto Salvo ad intrufolarsi in maniera fraudolenta nella villa di Livio
Mambrotti per carpirne la fiducia e farsi consegnare la statua di uno splendido
angelo, opera dello scultore locale Jacopo Guiderzoni, che la adorna, è stato
un vero colpo di teatro. Il giovane la vuole per sé, perché risplenda davanti
alla casa della sua famiglia, carica di tutti i significati con cui la
mentalità mafiosa l’ha rivestita. Così avverrà, ma un altro angelo, un angelo
dalle fogge piuttosto strane, un angelo che sembra evocare la lotta fra
l’arcangelo Michele e Lucifero, farà la sua comparsa davanti alla casa di
Angelo figlio del Moro. Il marchingegno scultoreo che l’amico si è procurato dal
Tirabassi, -un imprenditore in rovina con i beni sotto pignoramento- (Don
Ciccio e la sua cosca a quella rovina avevano contribuito attivamente per
impossessarsi dei beni a prezzi stracciati), forse per emulare Salvo e darsi
importanza, forse per un semplice atto di spavalderia: “L’insegna dice: Taverna dell’Angelo, e un angelo ci
vuole” dirà al padre, gli sarà fatale. Salvo e Don Ciccio considerano quel
gesto come uno spregio arrecato a loro e al loro sentire; uno spregio che può
essere lavato solo col sangue, secondo la pratica e la mentalità mafiosa. Così
avverrà: l’arcangelo mafioso avrà ragione dell’angelo che aveva osato sfidarlo.
Il sangue e la morte metteranno il sigillo sul giovane e sulla sua scultura. Il
Moro se ne andrà pochi giorni dopo il figlio, quella morte aveva solo accelerato
il male che da tempo lo insidiava.
Sorretto
con una scrittura scorrevole e coinvolgente, non priva di sprazzi di raffinata
letterarietà, la lettura di questo romanzo di Zaccuri scivola con lo stesso godimento
con cui è stato concepito.
 |
| La copertina del libro |
Alessandro
Zaccuri
Lo spregio
Marsilio
Ed. 2016
Pagg.
120 € 16,00
***
L'incontro
prudente, poesia e filosofia
di
Fulvio Papi
Soltanto il poeta si
assume la responsabilità dell’io, soltanto lui parla a nome di se stesso,
soltanto lui ha il diritto di farlo. La poesia s’imbastardisce quando diviene
permeabile alla profezia o alla dottrina […]. Il trionfo della non autenticità
si attua nell’attività filosofica, questo compiacimento nel “sì”, e
nell’attività profetica (religiosa, morale o politica), questa apoteosi del “noi”.
La definizione è la menzogna dello spirito astratto.
[Emil Cioran - Sommario di decomposizione, 1949]
Non
esiste alcun rapporto univoco tra la poesia e la filosofia, come non esiste
alcun rapporto univoco tra la pittura e la dimensione figurativa, tra la musica
e la sonorità, tra l'architettura (religiosa e non) e l'idea di spazio. Anche
se ogni tradizione poetica, ogni epoca pittorica, ogni composizione musicale
come ogni manufatto architettonico sottintende un tessuto filosofico più o meno
rilevante e, soprattutto, è possibile farne oggetto di una meditazione
filosofica. Per quanto riguarda la poesia, al di là del genere o della poetica,
nella nostra tradizione più recente mi sentirei di dire che vivo ogni poesia
come “un mondo” e ogni filosofia come un effetto di un “corpo” del filosofo,
come autobiografia interpretata e risolta nell'ordine del pensiero. In una
visione di questo tipo le relazioni tra poesia e filosofia possono essere le
più differenti: armonia, prestito, occasione, declinazione, risonanza,
complicità come anche rifiuto. Se dovessi rimanere in questa prospettiva dovrei
solo cimentarmi in un commento del Mariner di Coleridge (a valle di Schelling), la Libertà di Paul Éluard (col retaggio dell'esperienza
surrealista), qualsiasi poesia di Ingeborg Bachmann, amatissima (con alle
spalle i grandi viennesi e, soprattutto, Roth).
Ma la
filosofia generalizza, infatti usa concetti che “comprendono” o “circoscrivono”
e, come minimo, si dovrebbe domandare “che cosa” circoscrivono e quale tecnica
o opportunità concettuale adoperano per ottenere questo risultato. Esistono molte
forme di verità, ma in questo compito raggiungono un effetto di verità. Come
nessuno può pensare di interpretare un romanzo ritenendo che esso sia il
modello formale del romanzi: si può naturalmente mostrare quale sia la sua
struttura formale che esiste nelle favole o nei libri gialli, ma non certamente
nella Recherche di Proust o nel Doctor Faustus di Mann.
Prenderò il
mio “inizio” (che a rovescio può anche essere una fine) dalle preziose osservazioni
di Baudelaire sulla moda. La moda poetica, come quella sociale, è sempre un
processo di mutamento, di trasformazione, di nuova identità, di certezza nella
propria apparizione e, di più, di necessità implicita nel suo genere. La poesia
è tutt'altro che ripetizione di norme compositive che riguardino il suo oggetto
e la sua traduzione scritturale. Non può che rinascere come rottura radicale
con tutti i canoni della vita borghese, della sua funzione normativa, dei
costumi pubblici, delle consuetudini pacificate, delle esclusioni radicali, dei
sentimenti occlusi, dei comportamenti sociali codificati, delle regole diffuse.
La poesia trova un mondo sul quale la forza del lessico borghese, i suoi pudori
come le sue violenze, aveva fatto valere il suo potere: essa è nella scoperta
soggettiva di un altro mondo che ha, nella famosa linea Poe - Baudelaire,
l'affermazione che la poesia non ha altro scopo che se stessa, è poesia per la
poesia. Un “romanticismo” che esce dall'ascolto sentimentale dell’“io” per
diventare una soggettività poetica vitale, paga del suo modo d'essere e di
sentire, necessaria al suo scopo artistico, aperto alla scoperta di nuove
occasioni poetiche e alla loro costruzione secondo una finalità chiusa in se
stessa, compimento di un'opera che è la riscoperta del fare poetico. È un’aura
che giungerà sino al giovane Mallarmé che - com’è noto - è stato uno
straordinario traduttore delle poesie di Poe. Il giovane Mallarmé è nel clima
dell'idea di poesia di Baudelaire, ma il fare poesia si colloca su un piano
completamente diverso. La poesia acquista una sua autonomia agendo direttamente
sul linguaggio, la sua natura poetica abbandona ogni modalità comunicativa,
trova una pluralità di relazioni che derivano dai significanti stessi con
effetti che sono estranei alla dimensione simbolica e possono piuttosto essere
paragonati ad una scrittura musicale.
La poesia
nasce da una idea normativa di poeticità che avrà la sua risonanza e la sua
teorizzazione avanguardista in relazione alla concezione anti-platonica e anti-saussuriana
del linguaggio teorizzata dal primo Derrida. Ora questo processo intorno al
pensare la formalità linguistica del poetico fu un processo che caratterizzò
una parte rilevante nella poesia del Novecento, basta ricordare poetiche come
il futurismo (ben più ricco quello russo rispetto a quello poco più che
pubblicitario italiano) o il surrealismo francese, che spezzava ancora una
volta le forme comunicative dominanti corrispondenti al dominio economico della
forma capitalistica della produzione. In Italia - come tutti sanno - fu l’ermetismo
poetico che garantiva alla dimensione poetica la sua irriducibilità ad altre
finalità che non fossero la realizzazione di se stessa. La ripresa filosofica
della celebre concezione di Baumgarten sulla poesia come forma di conoscenza
intuitiva poteva offrire una pluralità di interpretazioni; in Italia fu l’estetica
di Croce che vi si ispirò più direttamente, ma in ogni caso forniva una
interpretazione filosofica che poteva assumere due aspetti opposti: l'uno lo
spazio per una autonomia poetica; l'altro la dimensione normativo-interpretativa
della poesia. Il panorama che ho così brevemente tracciato mostra la ripetizione
di una caratteristica intellettuale, più o meno rilevante, secondo cui ogni
esperienza poetica ha un suo correlato “teorico”, più o meno rigoroso, al quale
fa riferimento un importante tentativo filosofico di affrontare il problema
dell'arte e della poesia dal punto di vista di una universalità filosofica.
A questo
punto è necessario ricordare l'importante saggio di Heidegger del 1935, L’origine dell’opera d'arte, con alcune
rapide premesse che sono probabilmente indispensabili per concordare con la mia
interpretazione. Heidegger, ora ne siamo certi, era iscritto e militante del
partito nazista. Tuttavia né Essere e Tempo
né il famoso discorso a proposito del Rettorato del 1933 sono scritti di cultura
politica direttamente nazista; semmai le pagine finali del capolavoro di
Heidegger, e, molto più direttamente, il citato discorso appartengono a un’aura
intellettuale entro la quale si può inscrivere il nazismo come senso
storicamente politico dell'identità di un popolo. È una distinzione che, senza
minimamente entrare nelle dispute sul rapporto del filosofo tedesco con il
nazismo, è necessario fare per distinguere quello che è un lessico operativo e
identitario dell’azione politica del partito (a cui personalmente il filosofo
poteva aderire) e il lessico filosofico di cui si vale in un crescendo
inventivo dal “discorso” all’Origine
dell'opera d'arte, lessico che appartiene alla forma del pensiero
filosofico che Heidegger mette in relazione con la storia della filosofia e con
la cultura filosofica contemporanea. Questo non vuole affatto negare, come
dicevo, che questo modo di pensare filosofico non appartenga a un ethos che, in una determinata
congiuntura politica, diventa un’aura intellettuale favorevole al precipizio
nazista. Sappiamo tutti che Lukács ha esagerato fuor di
misura quando, nella Distruzione della
ragione, ha veduto nella cultura tedesca di un secolo la preparazione delle
condizioni intellettuali del nazismo, come se Dilthey e Klages fossero simili,
e tuttavia è abbastanza facile riconoscere che vi sono filosofie o letterature
che creano un ambiente favorevole alla diffusione di una ideologia totalitaria
(come quella criminale nazista) e altre che nella loro apartheid accademica non hanno gli stessi effetti. Per non citare
il caso di un fascista come Pound, le cui poesie sarebbe difficile omologare ai
libri di “mistica fascista”.
Fatte queste
distinzioni - che non cambiano i giudizi morali, ma impediscono interpretazioni
troppo preconcette - torniamo al nostro tema. A qualcuno non mancherà di creare
scandalo questa affermazione, ma a me pare che vi sia una linea filosofica che
connette il famoso discorso del Rettorato, due anni avanti, con il saggio non
meno famoso sull’Origine dell'opera
d'arte, anche se si tiene presente la differente destinazione dei due
scritti - l'uno propositivo di un fare, l'altro impegnato in un capire
teoricamente - diversità perfettamente visibile proprio nella differenza tra i
lessici dei due scritti: l'uno filosoficamente comunicativo, l'altro così
rigorosamente teorico da richiedere invenzioni lessicali che riescano meglio a cogliere
l'essenza del problema. L'uno segna dunque una linea d'azione spirituale per l’Università
centrato sulla identità storico-politica (il “destino”) di un popolo; l'altro
saggio vede egualmente nel fare poetico il riconoscimento, il farsi popolo di
un popolo, la determinazione spirituale della sua storicità. Un proposito
filosofico che non ha niente a che vedere con una “estetica” che assume le
opere d'arte come oggetto di categorizzazioni che vengono dall'esterno e
adoperano strutture intellettuali che per agire presuppongono una oggettività,
comunque definita. Tuttavia gli autori e le opere che Heidegger ha scelto per “mostrare”
la sua concezione del poetico nella realtà della poesia mi paiono poco
pertinenti, come già molto tempo fa aveva sostenuto il giovane Cacciari. In
generale nel testo heideggeriano, dove linguaggio è proporzionato al perseguire
il disegno filosofico, mi pare si possano trovare argomenti per comprendere, in
una metafisica storicità, l'origine spirituale di popoli che in quella forma
poetica hanno la loro stessa enciclopedia. A livello della poesia lirica
contemporanea l'effetto filosofico heideggeriano invece diviene una poetica
dominante: il rapporto terra-mondo diviene una modalità che costituisce
l'orizzonte ontologico di ogni fattura poetica che desidera una propria fedeltà
alla essenza della poesia. A mio modo di vedere, questa riduzione del pensiero
filosofico a poetica, la verità dell'essere, traccia una linea omogenea tale da
divenire uno stile diffuso e condiviso che, oggettivato, si dà anch'esso per
essere compreso nella sua verità. E quindi riapre il problema del rapporto tra
poesia e filosofia, anche se potremmo dire che, contrariamente a una lunga e
forte tradizione, qui è la poesia che interroga la filosofia e richiede una
posizione teorica che possa entrare in una relazione positiva con la sua
molteplice realtà.
Come ogni
sintesi filosofica che sveli l'essenza di un fare (la poesia, il pensiero, il
lavoro, l'amore), pure nascendo da condizioni molto differenti, annulla il
molteplice e la sua specifica ragione d'essere, essa condiziona la lettura dei
testi poetici secondo un'unica prospettiva e, infine, nella pratica poetica
concreta finisce col costituire una poetica che ha la stessa funzione di
uniformità di ogni altra poetica. È una prospettiva che nel nostro universo
poetico è molto degnamente rappresentata, per esempio in una rivista importante
come «Anterem», ma allo stesso modo in cui negli anni passati fu interpretata
la poetica dell'avanguardia di Sanguineti o Porta, o come da una ventina d'anni
agisce una poetica per “il combattimento per il bello” in conflitto con
l'ambiente sociale dominato dal calcolo capitalistico e dalla sua
dis-educazione alla sensibilità e all'etica antropologica, in competizione con
la tecnologia che trasforma ogni relazione moderna condizionata da “amorosi
sensi”. La bellezza, in questa prospettiva, non è la rinascita di Canova o delle Grazie di
Foscolo, ma desidera essere una relazione poetica del soggetto umano con il
mondo, secondo quelli che, un tempo, si sarebbero chiamati i “valori dello
spirito”. Va da sé che questa schematizzazione non comprende affatto il lavoro
poetico di ogni autore il quale nel suo fare poesia può risentire di
suggestioni poetiche diverse che solo il critico attento può forse
rintracciare. Non credo possa stupire che nel mio discorso sia apparsa la
parola “poetica”. Nella filosofia italiana essa ha una linea relativamente retta
che va dall’estetica di Banfi alla teoria critica di Anceschi. Era certamente
una poetica militante quella che Anceschi ospitò per anni nella sua rivista «Il
Verri», senza minimamente credere che essa fosse una “filosofia della poesia”
piuttosto che una emergenza poetica che “sul campo” voleva giocare la sua forza
ideale e il suo tentativo egemone, espressione importante di quella che nella
prosa dello stesso Anceschi era una stagione letteraria da comprendere con uno stile
interpretativo di natura “fenomenologica”. Dove il termine è privo dell'insieme
teoretico originario, per indicare sostanzialmente l'attenzione alla vita della
poesia come congiuntura culturale, o come moda necessaria, per riprendere
proprio qui Baudelaire.
È abbastanza
ovvio l'uso della categoria “poetica” in un tempo storico che, perduta la sostanzialità
dell'arte (bella e romantica), ha cercato di trovare altri fondamenti per
riflettere se stessa in una prospettiva di diritto intellettuale. Senza fare
elenchi che tutti conoscono sono poetiche il realismo di Zola e l’opposto
significato della letteratura come appare nell'ultimo libro della Recherche proustiana, è una poetica la “secessione”
di Klimt e Schiele in Austria, il futurismo con i suoi deliri anti-romantici e
anti-classici e i miti della velocità, dell'improvvisazione dell'impaginazione
e, infine, della guerra. Qui questa lezione di concretezza ci sarà utile per
trovare il rapporto tra poesia e filosofia dal “basso”, cioè da quello che
accade, piuttosto che da un vertice che, come ogni altezza, trasforma un mondo
in un colpo d'occhio panoramico che eleva l'anima ma nasconde i sentieri da cui
passa la vita.
Nella nostra
epoca coesistono una poesia alta e una poesia bassa. Quest'ultima è molto
diffusa nella sua traduzione musicale e costituisce quasi un sottofondo
quotidiano dell'esperienza sociale, ma soprattutto è l'occasione di grandiosi
concerti cui partecipa principalmente una grande quantità di giovani. Si tratta
di una poesia che narra, esplora, rende palesi sentimenti ed emozioni che
percorrono la vita dei giovani e quelle manifestazioni sono l'occasione per
l'esplosione collettiva di questi sentimenti che pure percorrono la loro vita
senza poter prendere figura linguistica o progetto d'azione. Questa poesia è un
riconoscimento di sé e di un proprio mondo possibile con una circostanza
negativa. Essa non costituisce temporalmente una continuità educativa, un
permanente riconoscimento di sé, essa svanisce nella sua eco e diviene una
forma di acculturamento d'occasione e sempre d'occasione di reciproco
riferimento. Parole e musica sono strettamente uniti e le parole, senza poter
essere ripetute secondo un ritmo musicale, rischierebbero di essere letture
deboli e fragili, incapaci di incendiare seppure per breve tempo l'animo dei
partecipanti. È la forma contemporanea della poesia popolare che, se facciamo
un passo indietro - mi riferisco sempre alla situazione italiana -, è quella
delle romanze e dei libretti d'opera. Le romanze costituiscono la possibile poetizzazione
dell’esistenza in una pluralità di dimensioni oggettive, i libretti d’opera (la
cui storia è più complicata di quanto non si creda comunemente) contengono
commenti, massime di saggezza, espressioni d'opportunità che costituiscono un tesoro
lessicale di un grande pubblico. Il quale d'altra parte non leggeva le poesie
di Corazzini, di Gozzano, di Fogazzaro e d'altri poeti dell'epoca.
Una
filosofia che non frequenta quel tessuto lessicale che per convenzione viene
considerato la forma preminente di pensiero, un gioco linguistico
d'aristocratica selettività laddove tutti gli animali diventano fosforescenti,
non ha che una possibilità, che è quella molto comune rispetto a una infinità
di fenomeni: il cercare di comprendere, considerare la poesia come un oggetto
intellettuale il cui senso può essere compreso a fondo solo attraverso un'opera
di decriptazione. E qui noi ci troviamo di fronte a due temi: da una parte una
poesia, le poesie; dall'altra parte gli strumenti, non pochi, per la sua
comprensione, che poi coincide con la sua valorizzazione. Consideriamo la
poesia una figurazione verbale. Per accedervi abbiamo strumenti che provengono
dalle congiunture biografiche, dalle relazioni che esse hanno con il repertorio
culturale, il quale ovviamente ha una pluralità di direzioni, dalle nozioni
tecniche che sono implicite in questo genere di manufatto e che appartengono a
una o a più istituzioni poetiche: l'interpretazione nella finalità dei versi, l'immaginaria
destinazione dell'autore, la risorsa di un inconscio che trova la sua via
espressiva. Non per ogni oggetto poetico sarà necessario usare assieme tutti
questi strumenti, di volta in volta potrà aver luogo una opportuna selezione
operativa. Si dovrà dare luogo a una selezione positiva tra i due estremi del
testo e dell'opera che sono stati in collisione per anni, quando la critica
strutturalista mise in crisi quello che essa chiamava critica impressionistica.
La loro coesistenza dà luogo ad una forma di ermeneutica che si è attrezzata
per questo fine. In questa filosofica dimensione del comprendere agisce
naturalmente un elemento fondamentale, la pratica della lettura della poesia,
la frequentazione delle sequenze poetiche, una abitudine all'intellegibilità.
Che altro è lo stile filosofico se non la finalità intellegibile?
È
inevitabile non dimenticare la figura dell'autore, un poeta è uno che sa fare
poesia. Ma il saper fare è a sua volta un apprendimento, la realizzazione di una
esperienza. Ed è questa parola che richiede una particolare attenzione. Qual è
l'esperienza di un poeta? Anzi, si dovrebbe dire che ogni poeta ha una
esperienza che diviene costruzione di poesia. Era molto facile un tempo mettere
in relazione diretta esperienza e costruzione con la parola sintetica “espressione”.
D'altra parte noi che consideriamo la poesia come un'opera dobbiamo in qualche
modo tenere conto di una soggettività, quella che ha un nome, una visibilità se
vivente, una storia se è di un tempo passato. Molto semplicemente, l'autore non
è una funzione dell'apparato testuale come si può dire di un testo scientifico
compiuto; altrimenti, anche in questo caso, ogni analisi della scoperta
richiede un'operatività soggettiva nel campo dello scoprire, e non è nemmeno una
soggettività sintetizzata e quindi trovata nella forma della sua espressione.
Partiamo dall'opera per trovare l'autore. L'opera è costituita dall'intreccio
di un insieme di elementi che provengono da un rapporto linguistico che mostra
già una sua problematicità messa in atto dalla finalità poetica, dalla
collocazione sociale in cui accade la poesia come relazione tra il fare e il
fruire, dalla tradizione che agisce sempre con varie reattività nel fare
poetico, con lo scopo che l'autore immagina di realizzare. È sempre un
equilibrio tra questi elementi che costruisce un'opera poetica e l'autore
compone in una scelta possibile tra i possibili equilibri tra questi fattori, anche
se in molte opere l'autore appare tramite il privilegiarsi di uno o dell'altro
di questi elementi. Tuttavia non esiste alcun sapere astratto di un “filosofo”
che possa selezionare l'equilibrio concludendo con un giudizio: la poesia non
può che nascere dal sapere selettivo di una poeticità.
Sarebbe nondimeno
superficiale rimanere in questa prospettiva, e qui occorre presentare una
veloce analisi di un tema fondamentale. La filosofia sono i filosofi, e i
filosofi sono i ‘corpi’ dei filosofi, dove non bisogna limitarsi a pensare alla
opposizione tra Körper e Leib, fondamentale ma tuttavia con il
rischio della genericità. Il Leib va
inteso come un processo unico di “formazione” che può avvenire attraverso
percorsi molto differenti che non si trasformeranno mai nella linea retta di
una soluzione filosofica. Quest'ultima è un risultato rilevante che per essere
esercitato deve passare attraverso forme radicali di criticità che ne
impediscono cadute dogmatiche, illusioni sentimentali, toni orfici, attrezzi di
preventivo giudizio intellettuale. La filosofia è un punto di sviluppo delle
potenzialità affermative della educazione di un corpo, ma non è la sua radicale
trasformazione. Il corpo del filosofo rimane dotato di una sensibilità, di una
disponibilità emotiva, di una coincidenza sentimentale, di una curiosità
educativa del suo stesso sentire. È una banalità idealista quella di pensare
che la lettura della poesia rievochi nel lettore il quadro intuitivo
dell'autore. Una lettura ha sempre una sua trasversalità che non è
necessariamente un fraintendimento, come Valéry
riteneva potesse essere sorto in questa circostanza.
La lettura e
la scelta della lettura, le ragioni delle preferenze (per esempio quali sono e
perché sono tali le poesie che Calvino riteneva dovessero essere memorizzate
come aiuto alla vita quotidiana), una trovata consonanza: tutte queste
esperienze hanno un senso filosofico nella relazione con la poesia, ma non
appartengono alla pratica del comprendere, piuttosto, e interamente, a una
opzione di “gusto”. Questa è una parola difficile che viene direttamente dalla
estetica del ‘700, da Hume come da Kant (per prendere i massimi). Noi diamo a
questa parola il significato che nella nostra strategia filosofica assume più
facilmente: è uno dei casi in cui la storia della filosofia è un immenso tesoro
disponibile per una riattivazione teoretica. Il gusto è dunque quella
attitudine che ci fa scegliere poesie o generi poetici che sono con-senzienti
con un “noi stessi” che probabilmente non è mai interamente rivelato, e che la
poesia può forse, nella pluralità degli elementi della suo eco, portare verso
una superficie. Sia il tema del comprendere che quello relativo al gusto
potrebbero dare luogo ad approfondimenti, ma essi segnano - per quanto mi
riguarda - il perimetro entro il quale ha senso porre il problema del rapporto
tra filosofia e poesia.
***
LIBRI
VERDI
RITROVATO
di Gabriele Scaramuzza
In una recente
conversazione (dal titolo “Insegno Verdi
per recuperarne l’essenza”), raccolta da Carla Moreni sul Domenicale di “Il
Sole – 24 Ore” del 31 luglio 2016, Riccardo Muti nota che pochi autori sono
bistrattati nelle esecuzioni come Verdi, e perciò proposti a una fruizione
malevola e distratta come lui, malgrado non manchino ricerche accurate sul suo
teatro, in grado si scrostarne ogni banalità e volgarità che non di rado gli si
imputano. Resta vero, come già ha sostenuto Bruno Barilli, che “Verdi è stato
il musicista più incompreso del mondo”.
L’ultimo,
e il più corposo lavoro in questo senso è quello di Paolo Gallarati,
indispensabile per penetrare comprensivamente nel mondo verdiano, e proprio
nelle opere di quella “trilogia popolare” che più si presta a fraintendimenti e
banalizzazioni.
Nella
sua Premessa appropriatamente scrive
Gallarati: “Di un riscatto culturale e morale il nostro paese ha quanto mai
bisogno: riflettere sull’attualità, il rigore, la logica costruttiva, la
potenza emotiva, i valori artistici e etici che caratterizzano le opere di
Verdi e rappresentano la nostra identità, ci può rifornire di energia
intellettuale e morale, preservandoci da esercizi inconcludenti di sterili
chiacchiere”.
Chiunque
ami Verdi, o comunque desideri penetrarne la sostanza (desiderio di cui non
molti purtroppo sono dotati), non può che essere grato toto corde all’impegno
di questo insigne musicologo, che raccoglie e porta avanti su larga scala non
solo i concreti risultati conseguiti da Massimo Mila, ma soprattutto ne eredita
il modo di essere, simpatetico finalmente, e teso a valorizzarlo, nei confronti
di Verdi.
Una
giustificazione del titolo la troviamo nelle ultime righe della Conclusione, riferentesi all’oggi: “Il
teatro di Verdi è trattato dagli editori con coscienza filologica, e dagli
interpreti con un’attenzione e con risultati forse mai così vicini a quello che
egli avrebbe desiderato. Dunque l’artista che, nel corso degli anni, fu, per
alcuni versi perduto, si può dire che sia stato, oggi, felicemente ritrovato”
(p. 527).
Non
sarà certo possibile inseguire in tutte le sue articolazioni il complesso e
intenso lavoro di Gallarati. Mi limiterò a metterne in luce qualche punto nella
mia ottica particolarmente significativo. Raccomando in primo luogo la lettura
della premessa, della prima parte e delle conclusioni, che contengono
riflessioni che vanno oltre la cosiddetta “trilogia popolare” e valgono per
tutto Verdi.
Dando
per scontato il profondo apprezzamento per le pagine su Rigoletto e su La Traviata
(cui tuttora vanno le mie più intime simpatie), mi soffermo per qualche tratto
a me particolarmente consono della parte dedicata a quel “racconto di racconti”
(così giustamente Gallarati lo connota a pag. 307) che è Il Trovatore.
Il
testo è “prettamente melodrammatico”(308), come per Mozart è un “campo di forze metriche, ritmiche,
prosodiche, fonetiche, retoriche, semantiche da utilizzare sfruttandone alcune
e ignorandone altre, stabilendo gerarchie, contrasti e collegamenti ora
prevedibili, ora del tutto inaspettati” (p. 535).
Da
sottolineare sono le tonalità metafisiche, valorizzate da De Chirico, presenti
in quest’opera (e non solo in questa, aggiungo): evidenti nelle “tonalità
assorte” di scene quali quella del Miserere,
“l’asciutta volumetria delle architetture sonore, come piazzate in uno spazio
senza tempo”, “situazioni sospese oltre l’apparenza, in una dimensione
meta-fisica, volta a cogliere la struttura profonda dell’esistenza” (396).
“Concezione del tempo metastorico in cui il passato diventa attuale e il futuro
è contenuto nel presente” (419) - che torna in la Vera storia di Berio-Calvino, notoriamente ispirata al Trovatore.
Accenno
solo all’attenzione di Gallarati alle scelte tonali, all’originalità e alla
varietà delle forme musicali non meno che letterarie, dei personaggi e delle
situazioni. Ai temi della notte che domina in cinque quadri su otto, del fuoco,
della morte e non ultimo del silenzio, che ancora il Miserere “riassume e porta a evidenza emblematica”.
Estremamente
significativo resta per me il problema della melodia: è uno dei mezzi
fondamentali di cui la musica dispone, e che Verdi (al contrario di Wagner)
valorizza al massimo, conoscendone bene la portata significativa. Non può esse
relegata tra i prodotti di scarto della musica, secondari, scadenti (reazionari
magari, sottovalutati). Gallarati ne rileva il “carattere propulsivo”; più in
generale per Verdi la stessa “adozione delle forme chiuse non rappresenta una
scelta convenzionale, ma una necessità imposta da un contenuto drammatico”
(295) peculiare.
Leggendo
mi sono soffermato con particolare attenzione (ed emozione, devo ammetterlo) sulle
pagine che concernono il primo quadro dell’ultimo atto, per me uno dei più
struggenti dell’opera. Parte da D’amor
sull’ali rosee, attraversa il Miserere
nel suo svolgersi drammatico, ben più che un mero tempo di mezzo, si conclude
con la splendida cabaletta (ai miei occhi la migliore di Verdi, a torto a volte
tralasciata) Tu vedrai che amore in terra.
Il
mio scopo è stato invitare alla lettura: il libro di Paolo Gallarati è
essenziale non solo e non tanto per chi ama Verdi, ma in particolare per chi
vorrebbe conoscerlo. Non sono pochi coloro che preferiscono la pigra via dei
pregiudizi e dei luoghi comuni anziché la via più difficile e onesta della
penetrazione conoscitiva di Verdi.
Va
sé poi che l’intero libro è a sua volta un invito all’ascolto e alla visione
delle opere verdiane: da qui si deve partire e qui si deve ritornare, e sempre
si devono aver presenti in una lettura che sappia capire.
Paolo Gallarati
Verdi ritrovato. Rigoletto, Il Trovatore, La traviata
Milano, il Saggiatore, 2016, pagg. 587 € 32,00
LIBRIPaolo Gallarati
Verdi ritrovato. Rigoletto, Il Trovatore, La traviata
Milano, il Saggiatore, 2016, pagg. 587 € 32,00
***
DI CHE GIARDINO SE
di Gabriele Scaramuzza
Viene
perfettamente incontro ai miei vissuti il recente libro illustrato di Duccio
Demetrio. Già il titolo, Di che giardino
sei? - a quale giardino appartieni o, forse meglio, quale giardino
appartiene al tuo vissuto - esprime la rilevanza di un simbolo che è
imprescindibile anche nella conoscenza e nella costruzione di me stesso.
Non tenterò alcun resoconto compiuto del testo di Demetrio, ma
solo notazioni a latere, che prendono l’avvio dalla mia esperienza del giardino,
e proprio dalla lettura di esso sono stati stimolati. La mia vita, come la vita
di ognuno, è popolata di giardini, frequentati o desiderati, presenti nel ricordo
o nell’immaginazione, o anche solo nei libri che abbiamo letto. Ai poli opposti
vorrei ricordare l’inquietante giardino della Nausea di Sarte, o i giardini della Recherche di Proust - autori entrambi ben presenti a Demetrio. E
ricorderei anche per parte mia il verde dei luoghi frequentati da Kafka, non
solo a Praga; e i giardini presenti nell’Infanzia
berlinese di Benjamin, che mi ricorda Rosalba Maletta: luoghi della sua éducation
sentimentale con Luise von Landau. La stesura di Berliner Kindheit curata da Adorno inizia proprio da Zoologischer
Garten!
Non tutti hanno avuto un giardino proprio. Ma sono accessibili a
tutti giardini pubblici - esistono a Milano con questo nome i giardini verso
Porta Venezia, dove un tempo c’era lo zoo; ma pubblico è il Parco, dal Castello
a Corso Sempione; pubblico è il prezioso Parco della Guastalla; per non dire
dei non pochi giardinetti, giardini o parchi creati in seguito a Milano e nei
dintorni. Ho raccontato di un “mio” giardino personale nelle memorie raccolte
in In fondo al giardino. Non ho ancora
parlato invece dello spazio che parchi e giardini pubblici si sono presi nella
mia esistenza milanese; dovrò farlo, di queste esistenza rappresentano simboli
ancora da indagare: luoghi di incontri casuali, scampoli memorabili di natura
(alberi, ma anche acque, rocce come brecce e puddinghe, i pesci rossi e le
tartarughe alla Guastalla); punti densi nella memoria come il Ponte delle
Sirenette al Parco; ma anche luoghi di appuntamento, di giochi, di acque correnti,
di animali, di feste. Il chiuso di un giardino fruibile nella privatezza della
proprio intimità è difficilmente disponibile alla maggioranza. Proprio questo
esercita un enorme, diverso fascino, ed è denso di risonanze per chi ha avuto
la fortuna di viverlo.
Non ho mai avuto giardini di proprietà della mia famiglia. Ma
giardini privati che ho frequentato con intensa partecipazione, tuttora densi
di suggestioni per me, vivi per il mio sempre nella memoria, ci sono stati. Il
mitico “giardino della nonna” della mia infanzia, da sfollato nel paese di
origine dei miei, era di origini nobili, ma venne poi coltivato a mezzadria
dalla famiglia di mio padre, e come tale fu a disposizione mia e di pochi altri
nei primi anni. Era recintato per due lati da un muro, per un lato lo limitava
il naviglio della Martesana, per il resto confinava con le case un tempo nobili
e poi affittate a sfollati e paesani; ora è uno spazio pubblico.
La intensa significatività dei giardini è messa in luce, oltre che
nei testi di Duccio Demetrio, negli scritti di Pia Pera (traduttrice dal russo
e dall’inglese, da poco morta del terribile sla) fino alle sue opere più belle:
La bellezza dell’asino, Virtù dell’orto, L’orto di un perdigiorno, Giardino
segreto, fino all’ultimo, Al giardino
ancora non l’ho detto. Alla sua scomparsa è stata ricordata da interventi
calzanti ed empatici di Nicola Gardini, Margherita Loy, Cesare De Michelis, nel
domenicale di “Il Sole – 24 Ore” del 31 luglio 2016. È anche lei che dovremo
ringraziare per l’aiuto che ci ha offerto nell’approfondimento di un luogo
mitico (giustamente Demetrio ricorre al termine mito nel suo libro), in cui si
condensano tra i simboli più pregnanti del nostro vivere.
Negli scritti autobiografici si scrive in prima persona, certo, ma
non è solo di sé che si parla. Scrivere è sempre un confronto con altri e altro,
tra cui fondamentale la natura. Una biografia che presuma di esaurire la verità
di una vita, che creda di essere esclusivamente scrittura di un io astratto,
tutto concentrato sulla propria privata interiorità, che parli solo di sé senza
lasciare che nulla di “esterno” vi si intrometta, è impossibile. Il giardino
rientra tra gli interlocutori chiave di quel dialogo che è ogni nostra
biografia, ci lascia figure, emozioni, ossessioni, memorie magari sparse
e lacunose, ma non per questo meno vere, indispensabili a orientarci nella
vita.
Il libro di Demetrio dice qualcosa di
rilevante già nel titolo e nel sottotitolo. Il primo si costruisce come
domanda, di per sé chiede di un’appartenenza, e di che genere sia. Ci interroga
sulla nostra identità, rappresa in un simbolo che resta fondamentale per
chiunque abbia potuto viverlo. Simbolo che indubbiamente è, come si dice nel
sottotitolo, una delle forme in cui si esprime la conoscenza di sé.
Ogni giardino si caratterizza in quanto delimitato, ha un argine –
un muro, un fiume, anche solo una siepe,
che lo separa dal resto. Ed è per lo più vissuto come un luogo protetto, ha
delle difese, permette di ritrovare una propria intimità, favorisce il
raccoglimento. Ma anche suggerisce il viversi come separati – orgogliosamente
magari, “aristocraticamente”.
Di che
giardino sei? ha un formato non usuale, è impaginato con gusto, ha figure
suggestive, immagini pertinenti. Nel tono generale è sempre assai accattivante
e condivisibile – oltre che benissimo scritto, come sempre Demetrio sa fare. Si
articola in tre parti fondamentali, fenomenologicamente assai ricche: del mondo
dei giardini individuazione le varie componenti, gli sfondi simbolici, i legami
con la memoria, l’ampia tipologia. Non è luogo qui di inseguirne le complesse
articolazioni, si deve solo esser grati a Duccio Demetrio per il dono che ci ha
fatto di uno strumento essenziale alla presa di coscienza di sé, del proprio
vivere, e delle sue finalità.
Duccio Demetrio
Di che giardino sei?
Conoscersi attraverso un simbolo,
Milano-Udine, Mimesis, 2016, pp. 178, € 18,00
***
LIBRI
L’APOSTOLO TRADITORE
di Giuseppe
Langella
 |
| Francesco Piscitello |
All’interno
del rigoglioso filone degli “apocrifi moderni”, ovvero delle riscritture
letterarie dei Vangeli fiorite nel corso del Novecento, a Giuda è stata riservata
un’attenzione speciale. Nessun’altra figura, tra quelle che entrano nell’orbita
della vita terrena di Gesù, ha fatto discutere tanto quanto quella
dell’apostolo traditore. Diversi autori, anzi, hanno ricostruito la tragica
vicenda della Passione proprio intorno all’enigma di questo discepolo che
consegna il Messia nelle mani del Sinedrio: si pensi soltanto all’Opera del tradimento (1975) di Mario
Brelich, alla Gloria (1978) di
Giuseppe Berto, a Trenta denari
(1986) di Ferruccio Ulivi, al Vangelo di
Giuda (1989) di Roberto Pazzi, alla Notte
del lupo (1998) di Sebastiano Vassalli. Sarà da notare, semmai, che solo
Vassalli ha ribadito l’antica condanna nei confronti di Giuda, vedendo in esso
un diavolo assassino, il medesimo ultimamente reincarnatosi in Ali Agca,
l’attentatore di papa Giovanni Paolo II. Tutti gli altri scrittori, al
contrario, nel solco del copione teatrale che chiudeva Il quinto evangelio (1975) di Mario Pomilio, hanno proposto, con
argomenti tutt’altro che deboli o pretestuosi, una sostanziale revisione della
sentenza, perorando l’assoluzione di Giuda, in qualche caso, addirittura,
riconoscendo a quest’uomo, che si è accollato la parte più infame e un destino
di maledizione perché si compisse la redenzione dei figli del peccato, una
statura eroica.
Alla
riabilitazione di Giuda contribuisce ora, con motivazioni originali e probanti,
l’opera teatrale di Francesco Piscitello L’apostolo
traditore, uscita di recente nelle Edizioni Nuove Scritture. La struttura è
quella classica di un dibattimento processuale, con Accusa, Difesa e Testimoni
chiamati a deporre davanti alla Corte, e arringhe finali a sostegno,
rispettivamente, della colpevolezza o dell’innocenza dell’imputato; alla
maniera, per intenderci, degli episodi della serie televisiva che prendeva il
titolo dall’avvocato Perry Mason. Una
particolarità registica di queste udienze ci suggerisce che a Piscitello non
interessa allestire una semplice rievocazione del tradimento di Giuda, né
soltanto far luce su un caso giudiziario controverso: il calcolato anacronismo
di portare in scena dei personaggi storici, come i quattro evangelisti, Pilato,
Caifa o Maria di Magdala, a fronte di giudici, avvocati e giuria popolare del
nostro tempo, dipende da un’intenzione attualizzante, dal proposito di
interrogare l’uomo contemporaneo attraverso lo schermo, lo specchio deformante,
di Giuda. In questo, Piscitello si allinea a una modalità drammaturgica
adottata, prima ancora che da Pomilio, da Diego Fabbri nel celebre Processo a Gesù (1956). Non per nulla,
nella pièce di Piscitello il sipario
cala appena la Difesa ha terminato la sua arringa, prima cioè che la sentenza
venga pronunciata, affinché la responsabilità di decretare l’assoluzione o la
condanna di Giuda resti totalmente affidata agli spettatori, coinvolti nel
processo in qualità di giurati e chiamati, quindi, a esprimere il verdetto.
Finale
aperto, dunque, perché a pronunciare l’ultima parola sia ciascuno di noi, anche
se la Difesa smonta abbastanza facilmente il teorema accusatorio, desunto da
una frase di Giovanni, di un Giuda che avrebbe venduto per denaro il suo
Maestro al Sinedrio, in quanto avido di ricchezze e ladro. Piscitello fornisce
invece una spiegazione del tradimento che merita di essere riferita, perché si
discosta notevolmente dalla linea difensiva tenuta in genere dagli apologeti
novecenteschi dell’Iscariota. Egli non si appella, infatti, alle circostanze
obbliganti che avrebbero privato Giuda del libero arbitrio, ovvero il “prestabilito
disegno” di Dio (At 2, 23) e la
possessione diabolica di cui aveva parlato Luca (22, 3). Al contrario ipotizza
un movente che salva, insieme, l’innocenza di Giuda e l’impregiudicata volontarietà
dei suoi atti. Ricorda, a questo riguardo, le attese messianiche del popolo
ebraico, condivise anche dai discepoli di Gesù: Giuda, convinto che il suo rabbi fosse il Messia, decide di
accelerare i tempi, inducendolo a uscire allo scoperto. Seguiamo il
ragionamento di Giuda secondo la ricostruzione fornita dalla Difesa: «Quale
occasione migliore di questa? È il tempo della Pasqua, quando si celebra la
liberazione dalla schiavitù d’Egitto: il momento giusto per effettuare la nuova
liberazione - dai romani, questa volta - in una significativa coincidenza. Sono
a Gerusalemme Erode, il tetrarca, e il Prefetto di Roma: il Regno si
paleserebbe anche sotto i loro occhi! Gerusalemme è piena di folla che gli è
già corsa incontro festante. […] Se il Maestro non ci pensa, ci penserò io a
spianargli il cammino: di fronte a un Sinedrio che lo accusa, che forse lo vuol
morto, Gesù non potrà che portare subito a compimento la sua opera, rivelando
coi fatti di essere, proprio lui, il Messia atteso». Dio si vale di questa
«intenzione buona, addirittura pia», per attuare un disegno completamente
diverso, quello della redenzione attraverso il sacrificio della croce. Quando
Giuda si accorge di aver commesso un «enorme, spaventoso, tragico errore», si
dispera e, sopraffatto dal rimorso e dallo sgomento, corre al Sinedrio per
restituire la somma pattuita, getta via le monete e va ad impiccarsi. Egli,
dunque, avrà pur peccato di ingenuità, avrà pur frainteso le parole del suo
Salvatore, ma è innocente. Perché, allora, a sorpresa, l’avvocato difensore,
chiudendo la sua arringa, chiede clamorosamente ai giudici di non assolverlo?
Lascio questa domanda in sospeso, per non svelare al lettore l’ultimo colpo di
scena, in cui l’autore lancia una forte provocazione morale.
C’è
da dire, piuttosto, che l’argomentazione serrata e dimostrativa, condotta a fil
di logica a partire dalle scarne fonti neotestamentarie, non è l’unico pregio
di questo lavoro teatrale. Piscitello ha saputo far parlare i testi,
trasformandoli in deposizioni assolutamente verosimili, in interrogatori
incalzanti e in vivaci confronti, che portano allo scoperto aporie, dubbi e
contraddizioni. Si avverte, poi, ma perfettamente metabolizzata, una solida
documentazione storica e una non comune maestria nella caratterizzazione
psicologica e culturale dei personaggi, segnatamente di Caifa e Pilato, che
sembrano rivivere già sulla pagina, col vigore stringente della loro mentalità
e delle loro ragioni; figuriamoci quale evidenza d’intonazione e postura acquisterebbero
su un palcoscenico, dove ci auguriamo di poterli presto applaudire.
 |
| La copertina del volume |
Francesco Piscitello
L’apostolo traditore. Processo a Giuda
Iscariota
Edizioni
Nuove Scritture, 2015
Pagg.
64 € 12,00I PRIMI POSTI
Un racconto di Mario Rondi
Amilcare
nel sogno aveva l’impressione di essere in ritardo e quindi si affrettava per
non venir superato dagli altri che già s’accalcavano: non voleva assolutamente
perdere l’occasione del concerto gratuito della famosa orchestra da camera, nel
centenario della morte del grande musicista. Voleva prenotare un posto in prima
fila, proprio davanti agli orchestranti, in modo da ammirarne i movimenti,
verificandoli in armonia con l’onda delle note: la gente cominciava già a
spingere perché le porte della biglietteria erano appena state aperte.
Gli premeva essere lì davanti
per ammirare l’espressione del flautista che, a un cenno del direttore, avrebbe
attaccato il celebre motivo che sempre gli riempiva il cuore, poi ci sarebbe
stato anche il tocco del violinista, quando il piano si sarebbe scatenato in
una sarabanda di effetti sonori.
Non voleva correre il
pericolo di trovarsi delle teste davanti, magari quella cotonata di un robusta
signora che gli toglieva tutta la visuale: voleva finire dentro la musica, come
un’appendice compartecipe, per cogliere i momenti struggenti e di abbandono, ma
anche eventuali piccoli difetti che al suo occhio attento non sarebbero
sfuggiti.
Ci aveva sempre tenuto a
stare davanti, ai primi posti, per controllare la situazione ed essere in
qualche modo protagonista degli spettacoli, per stare immerso in quello che
succedeva: così anche a teatro voleva avere un posto in platea, a ridosso degli
attori, in modo che non gli sfuggisse una parola, un piccolo sibilo, una
casuale esclamazione del protagonista che rendesse il momento unico nella
storia.
Non ammetteva che ci fosse
qualcuno davanti a lui a vedere quello che succedeva, era come se lo volessero
mettere in secondo ordine, una pedina anonima dell’evento: lui doveva sempre
stare al centro della scena, il protagonista indiscusso, come era sempre stato
nella sua vita molto chiacchierata.
Niente poteva sfuggirgli:
un’occhiata di sbieco, non perfettamente efficace, della protagonista della
sceneggiata, un rimbrotto non completamente a tono di un personaggio
collaterale, una strillata eccessiva di un usciere che stava abbandonando la scena,
il canto troppo farsesco di una comparsa che era stata inserita all’ultimo
momento.
Amilcare era subito pronto a
cogliere i primi difetti della rappresentazione, perché niente sfuggiva al suo
occhio attento a ogni particolare: l’essere dentro la scena con anima e corpo
lo autorizzava alle più feroci stroncature perché la sua posizione centrale
glielo permetteva, non sarebbe stato così se si fosse trovato davanti una fila
di teste con riccioli ribelli e un copricapo che impediva la visione.
Adesso aveva il suo biglietto
in tasca con scritto un numero centrale, proprio in faccia agli orchestranti:
da lì avrebbe controllato la situazione, pronto a far cenni di diniego se
coglieva qualcosa che non andava, ma anche a godersi in santa pace l’armonia di
quella musica paradisiaca che sarebbe sgorgata dagli strumenti, perfettamente
allineati nella sala del concerto. Ad un certo punto gli era però sembrato di
avvertire un leggero mal di testa, come un repentino scombussolamento del suo
cuore, ma era durato un secondo e adesso era pronto per disporre la mente
all’ascolto di quei suoni paradisiaci che avrebbero sospinto il suo pensiero
lontano: la gente già cominciava a entrare alla spicciolata e Amicare notò che
quel giorno c’erano tanti suoi conoscenti che gli si affrettavano stranamente
incontro per salutare.
Forse sapevano che lui, come
al solito, si era aggiudicato uno dei primi posti, per questo erano così
ossequienti, come ricordando dell’importanza che aveva per lui quel concerto in
ricordo del grande maestro, di cui era stato uno dei primi estimatori. Rispondeva
con calore al loro saluto, contento che pensassero a lui, sempre presente alle
occasioni mondane con il suo frac impeccabile, appena uscito dalla stireria:
ora stringeva una mano, orgoglioso della sua presenza tra tanti stimati
professori e dottori, quando gli sembrò di cogliere un velo di tristezza nello
sguardo della signorina Concetti.
Adesso si rendeva conto che
molti sembravano piegarsi di fronte a lui, con un senso di prostrazione che gli
pareva eccessivo: in fondo era un appassionato di musica, ma non credeva di
essere degno di tanta attenzione tutta d’un colpo, anche se aveva un bel posto
davanti al direttore d’orchestra. Poco alla volta si rese conto che quel saluto
aveva il tono del compianto, forse anche della commiserazione, della distaccata
compartecipazione a qualcosa di misterioso: tutti gli si facevano vicino, come
a incoraggiarlo, a ribadire la loro stima, con la segreta speranza che avrebbe
detto anche per loro una parola buona a chi di dovere al momento opportuno…
Allora, quando gli
orchestranti attaccarono una struggente marcia funebre, Amilcare si rese conto
che aveva conquistato i primi posti al cimitero e che dalla sua fotografia
sorrideva affabile come sempre.La città della Pace di Teodosio Campanelli
A
cura di Laura Margherita Volante
 |
| Teodosio Campanelli |
L.M.V.
Da
anni di guerre e crimini contro l'umanità è venuto il tempo di riconoscere che
la pace è un diritto umano fondamentale
della persona e dei popoli. La realizzazione della Città della Pace in che modo è percorribile per far sì che questo diritto diventi realtà?
T.C.
È
chiaro che parlare di Pace sa di utopico, ma come sono convinto che ogni uomo
ha il dovere di perseguire questo nobile concetto, quanto meno di provarci! Ed
è partendo da questa affermazione che nasce il progetto della Città della Pace,
parco tematico di sculture sull'idea della Pace. Facilmente realizzabile nella
sua struttura fisica esso rappresenta un nuovo passo verso la costruzione della
Pace e poiché si tratta di progetto di respiro internazionale esso come una
macchia d'olio si allargherà sempre più attraverso le coscienze delle persone
di tutto il mondo.
L.M.V.
" Bernard Lown, copresidente della Lega Internazionale
dei medici per la prevenzione della guerra nucleare (premio Nobel per la pace
1985) affermò:
“Per
giustificare e accettare la guerra e per convincerci, abbiamo creato una
psicologia che la dichiara inevitabile; ma è una razionalizzazione per
accettare la guerra come un sistema adatto a risolvere i conflitti umani ….Trattare
come inevitabile un qualunque comportamento mette in moto una profezia
autorealizzante….Noi viviamo in un'epoca, in cui accettare tutto ciò come
inevitabile, non è più possibile senza andare incontro alla prospettiva molto
concreta dell'estinzione della specie umana” .
Queste parole risuonarono come avvertimento e dopo trent’anni come accusa visto
lo scenario planetario. Possiamo ancora non perdere la speranza di sognare un
mondo migliore?
T.C.
La
speranza si sa è la zattera di salvezza di ogni uomo. A tal proposito ricordo
un cartello che vidi in un ostello in India, il quale recitava: "se
perdi soldi, non hai perso nulla, se perdi tempo, stai perdendo qualcosa, se
perdi la speranza hai perso tutto."
 |
| I have a dream |
L.M.V.
“Senza pace non c’è
progresso umano” (A.Einstein). Il progresso umano ha
subito un arresto epocale in un momento storico di sofisticate e avanzate
tecnologie, applicate nella Scienza e nella Medicina, ma a vantaggio dei
ricchi…Quale globalizzazione, dunque? Cosa pensi in proposito?
T.C.
La
frase di Einstein, seppur detta da un uomo di scienza, va comunque letta sotto
una luce di romanticismo pragmatico, nel senso che se l'uomo è in Pace il
progresso umano cresce in ampiezza ed esso va inteso come miglioramento
dell'uomo stesso.
L.M.V.
“Ugualianza
Giustizia Pace”, l’assioma. L’Arte può con la sua potenza creativa ancora avere
voce oppure non ha più interlocutori, visto il degrado in cui il paese Italia è
precipitato per un sistema corrotto e immorale?
T.C.
La
famosa frase La bellezza salverà il mondo
di Dostoevskij dovrebbe essere la base di partenza di artisti con elevata
sensibilità che vogliono migliorare il mondo.
 |
| Interior Beautiful |
L.M.V.
La
tua idea di realizzare un progetto per la Pace, che ha come fine il
coinvolgimento artistico e culturale di tutti i popoli e di tutte le culture,
rappresenta senza dubbio un esempio concreto verso la costruzione della Pace
fra tutte le genti della Terra. Vuoi spiegare come intendi procedere e quali
sono i capisaldi di tale progetto?
T.C. La realizzazione
di questo complesso monumentale che verrà inserito all’interno di un parco o in
altra zona verde, prevede una struttura a forma di “spirale” quale
simbolo cosmico della vita: galassie, dna, etc. La
struttura sarà costruita con pietre e monoliti, esattamente 192, ognuna
delle quali rappresenta una nazione del mondo. Le
pietre (nazioni) si troveranno tutte insieme raccolte in un augurante abbraccio
di Pace e Fratellanza, su un fazzoletto di terreno che simboleggia l’intera
Terra. Dopo la realizzazione del complesso monumentale, si bandirà un concorso
internazionale di scultura e con cadenza annuale, saranno ospitate n quel sito
dieci artiste, ognuna proveniente da una nazione diversa. Ogni
artista lavorerà una pietra scelta fra le 192 presenti e realizzerà
un’opera secondo il proprio stile e cultura con tema unico: “La Pace”. Il
concorso andrà avanti per anni fino a, quando l'ultima pietra del complesso
sarà stata scolpita. Il
suo completamento darà vita al più imponente museo all’aperto dedicato alla
Pace con opere realizzate in loco da artiste provenienti da ogni
parte del mondo.
 |
| Over 1 |
L.M.V.
Il
passaggio dalla cultura etnocentrica a quella universalista prevede, secondo
te, anche un percorso di educazione e di conoscenza, che ha come tema la Pace,
partendo già dalle scuole materne, dove c’è una forte presenza di bambini
stranieri?
T.C.
La scuola e l'educazione sono i pilastri fondamentali per la crescita di ogni
uomo. La globalizzazione e le migrazioni degli ultimi anni possono favorire
specie tra i più piccoli l'idea di fratellanza al di là delle culture e dei
colori della pelle.
L.M.V.
La
città della Pace è rappresentata da una spirale con 192 monoliti - tutti i
popoli della Terra - e il linguaggio espressivo artistico scelto è la scultura.
Perché? E perché rivolto alle artiste? Cosa ti ha spinto a tale scelta?
T.C.
Ho
pensato alla scultura come espressività plastica ma soprattutto per il fatto
che deve trovarsi all'esterno oltre alla durata quasi eterna della pietra.
Mentre secondo me la scelta femminile rappresenta la vera svolta del progetto,
in quanto penso che le donne abbiano uno slancio diverso alla vita oltre che un
senso spiccato per la Pace e la Fratellanza.
L.M.V.
Quali personalità della Cultura nazionale e internazionale vorresti
coinvolgere? Ritieni sia necessario un coordinamento? A che livello o a più
livelli, sia in orizzontale sia in verticale?
T.C. Sicuramente gli
enti più rappresentativi da coinvolgere sono le Nazioni Unite, l’Unesco e tutte le
organizzazioni internazionali che si
occupano della Pace e del suo sviluppo a tutti i livelli. Ora risulta chiaro
che la partenza del progetto inizia da un piccolo passo e da un gruppo di
persone che credono in esso seguendo un
programma portano l'idea al suo
compimento. Buona Pace a tutti.
LO SGUARDO INDAGATORE DI VINCENZO MARZOCCHINI
di Laura Margherita Volante
 |
| Vincenzo Marzocchini |
L.M.V. “Fotografi
nelle Marche dal dopoguerra a oggi”. Cosa ha motivato la scelta del luogo e del
periodo storico per la tua preziosa indagine storica e critica?
V.M. Nel panorama
editoriale della nostra regione relativo alla fotografia mancava un resoconto
del genere. E’ il primo lavoro storico che cerca di mettere ordine nei percorsi
susseguitesi nel tempo, dal secondo dopoguerra a oggi, dei tanti protagonisti della
fotografia con poetiche sia affini che lontanissime tra loro. Con il volume Ritratti al plurale edito lo scorso anno,
si è cercato di ricostruire la storia della Fotografia marchigiana fin dai suoi
primordi, soprattutto nel capoluogo anconetano. Qui si ripercorrono i fatti
salienti del rinnovamento e gli sviluppi successivi dal 1950 ai nostri giorni.
È un percorso costruito seguendo protagonisti d’obbligo, impostisi nella storia
della fotografia non solo nostrana, affiancati da tanti altri fotografi scelti
dall’autore, quindi opinabili, comunque fondamentali nella restituzione di un
panorama esauriente, significativo della variegata fotografia marchigiana
contemporanea. Ogni capitolo, ogni argomento trattato, è introdotto da una
sintetica storia mondiale sulla quale si innestano le poetiche dei fotografi
marchigiani.
L.M.V. Arte
come “Imitazione originalità
immaginazione invenzione”. Quale di questi ingredienti è più incisivo per creare
un’immagine artistica?
V.M. Tutte
le storie delle singole arti visive si dipanano secondo il principio vichiano
dei corsi e ricorsi storici. Tutto si
ripete ad un livello diverso: evoluto od involuto; ogni periodo o avvenimento
sociale contiene in sé i germi, analogie e similitudini, di quello precedente.
Applicato all'arte, tale enunciato ci porta sulla strada dell'imitazione basata su citazioni, ispirazioni varianti, spostamenti
minimi. Se rileggiamo attentamente la storia dell'arte risulterà evidente
come la prima forma di creatività sia stata l'anticonformismo sia estetico che
etico. La creatività esprime innanzitutto un atteggiamento mentale. Per
comprendere appieno gli sviluppi attuali della storia dell'arte e quindi della
fotografia - in relazione all'immaginazione e all'originalità, all’imitazione e invenzione, dobbiamo rivedere le teorie estetiche dell’arte a
cavallo tra Settecento e Ottocento di Burke,
Cozens, Reynolds, Ruskin (pittore, critico e collezionista di
dagherrotipi). Ma mentre quest'ultimo è stato importante semplicemente come
diffusore delle teorizzazioni precedenti in virtù della sua influenza sul mondo
artistico, perché in effetti non rielaborerà niente di nuovo trastullandosi tra
i vari poli artistici, fondamentali risulteranno le intuizioni dei primi tre.
Secondo il Burke, l'immaginazione si
limita a combinare e a rimanipolare il vecchio e il già noto… fa appello,
anziché all'esperienza, alla memoria e, anziché guardare verso il mondo
esterno, scava a fondo dentro a quello interno… L'uomo di genio…Secondo
Reynolds, non è colui che sa inventare ex
novo…bensì colui che sa rimaneggiare con estro e abilità le cose inventate da
altri pur senza precludersi, nello stesso tempo, soluzioni inedite derivategli
dalla osservazione diretta della natura … né la natura né l'arte vanno mai
'pedestremente imitate', e il vero artista non può fare a meno di inserire
continui scarti di 'novità' nel modello; novità che egli desume da una corretta
e approfondita conoscenza sia della natura che dell'arte…(Francesca Alinovi
e Claudio Marra, La fotografia. Illusione
o rivelazione?). Sin dalle origini della nuova arte schiere di fotografi si
sono confrontati sui medesimi soggetti: il tavolo da pranzo imbandito, le
calle, il nudo, così come è successo ai pittori per Madonna con bambino o con le ballerine o quant'altro. Ma Charles
Baudelaire ripreso da Nadar non è lo stesso immortalato da Carjat! Quello che
conta, dunque, è la componente soggettiva della visione, quel tanto o quel
quanto basta a caratterizzare ciò che Massimo Pulini descrive nel suo volume Il secondo sguardo. Per esempio, i punti
di vista, nel senso di angolo di ripresa e inquadratura, di Martin Parr e Wolfang Tillmans per descrivere la società del consumismo a volte
coincidono, ma l'ironia che ne deriva è diversa: controllata nel primo,
sarcastica nel secondo.
L.M.V. Fotografie
che sembrano pitture e pitture che sembrano fotografie come la finzione sembra
verità. Quale arte rappresenta meglio il vero oppure ognuna percorre una via
diversa per arrivare alla verità e quale?
V.M. Nessuna
espressione artistica detiene il primato del vero. Ogni arte è tale se tecnica
e idea convergono e rappresentano il pensiero dell’autore. Lo stupefacente
dell’arte è che in tali lavori oggettività e soggettività, visione reale e
mondo interiore coincidono e possiamo allora assecondare Baudelaire, almeno in
questo caso: Che cos'è l'arte pura
secondo la concezione moderna? È la creazione di una magia suggestiva che
accoglie insieme l'oggetto e il soggetto, il mondo esterno all'artista e
l'artista nella sua soggettività. Nel Postmodernismo, mutuando le
parole di Aaron Scharf, uno dei grandi storici dell'arte, possiamo sostenere
che nel XX secolo l'ingresso della
fotografia nel campo delle altre arti visive avvenne in un modo e in una misura
senza precedenti. …La tecnica della riproduzione fotografica si è talmente
allargata da divenire una caratteristica della pittura contemporanea. Tale
processo trova la sua metaforica decantazione, che può essere declinata verso
il sublime artistico o la vituperazione dell’arte perturbante, nell’inquietante
racconto di Michel Tournier I sudari di
Veronica. Il riferimento religioso contenuto nel titolo della mostra - che
è lo stesso del racconto - non è casuale: le immagini che la fotografa Veronica realizza sono ottenute
sottoponendo ad un vero e proprio spellicolamento
il corpo del suo modello amante Ettore
con una diabolica terapia prolungata nel tempo. Lo sottopone a particolari
diete alimentari ed esercizi fisici per trasformare il suo massiccio corpo
atletico affinché acquisti fotogenia. L’autrice sostiene: “Soltanto ora è diventato fotogenico. In che cosa consiste la fotogenia? È la facoltà di dare origine a
fotografie che vadano oltre l'oggetto
reale. In parole povere, l'uomo fotogenico fa stupire coloro che, conoscendolo
già, vedono le sue fotografie per la prima volta: sono più belle di lui,
sembrano svelare una bellezza che fino a quel momento era dissimulata. Ora,
quella bellezza, le fotografie non la svelano, la creano.” Ogni artista
esprime una rappresentazione personale, soggettiva del mondo che sulla tela o
sull’emulsione impregnata di alogenuri d’argento si trasformano in verità
parziali che si propongono però come universali.
L.M.V. Fotografie
in bianco e nero o a colori. Quale forma cromatica preferisci e perché?
V.M.
Ci sono stati grandi autori definiti maestri del bianconero come Weston, Adams,
White
- tanto per citarne alcuni -e grandi maestri del colore quali Haas,
Fontana, Madame Yevonde ecc…. Fotografi che hanno privilegiato il bianconero
per lavori personali e il colore per quelli professionali su commissione. Sono
due mezzi espressivi che vanno utilizzati in relazione ai progetti ideati e
alle proprie scelte estetiche. Ci sono stati nella storia della fotografia e
del fotogiornalismo in particolare dei periodi nei quali era d’obbligo il
bianconero, poi le riviste patinate negli anni sessanta e settanta
incominciarono a richiedere sempre più servizi a colori. Nel passaggio
intermedio grandi interpreti del mondo della moda, Newton per esempio,
riuscirono a produrre lavori eccelsi su entrambi i materiali sensibili alla
luce. Personalmente prediligo il bianconero perché lo sento più vicino al mio
fare fotografia, ma ho utilizzato emulsioni a colori per determinati lavori,
per esempio per documentare e ricreare in polaroid le produzioni e i momenti
creativi, in fieri, di alcuni pittori. C’è chi, come ad esempio Alex Webb,
inizia con il bn e poi si converte al colore.
Afferma nel volume Street
Photography e Immagine poetica: “Agli
inizi della mia carriera fotografica disprezzavo il colore, lo ritenevo volgare
e commerciale, lontano dal cuore e dall’anima della fotografia. Poi, verso la
metà degli anni ’70…ad Haiti e in Jamaica, e in seguito lungo il confine tra il
Messico e gli Stati Uniti, mi sono reso conto che alle mie foto mancava
qualcosa: la luce tagliente e i colori intensi di quei mondi…in cui il colore è
parte integrante della cultura…Ho capito che il colore va oltre il colore
stesso. Il colore è emozione.” Come il bianconero di Weston, Adams, Brassäi,
Sudek, Kertész…aggiungo di mio.
L.M.V. Si
dice che la bellezza è come il sole: “sei
bella/o come il sole” perché il sole dà luce, calore, e non si vede.
Nell’arte fotografica come si esplica tale azione?
V.M.
Il
termine fotografia è di origine greca, è composto da photos (luce) e graphein (scrivere).
Quindi, si esplica semplicemente nell’atto stesso del fotografare che
letteralmente significa scrivere con la
luce. Talbot, uno dei padri della fotografia e inventore del metodo
negativo/positivo, chiama le sue immagini derivanti dalla luce che si dipinge
da sola calotipie, cioè, sempre dal
greco, belle stampe. Il più o il meno
bello da aggiungere alla luce naturale è frutto delle scelte dell’artista coi
suoi punti di ripresa e con le mirate selezioni tonali in fase di stampa.
L.M.V. Luci
e ombre hanno un richiamo magicamente poetico. C’è una tecnica fotografica per
ottenere questo effetto?
V.M.
Il fotografo umanista francese Edouard Boubat appunta in un suo scritto: “Spesso mi domandano: Come hai cominciato? -
Mi piacerebbe rispondere: Con la luce.” Josef Sudek racconta: Da giovane ho conosciuto Ruzicka, un boemo
americano, e attraverso di lui la fotografia di Clarence H. White. A quel tempo
non sapevo ancora che tutto il mistero è nascosto nelle zone in ombra. Appena
arrivato dagli Stati Uniti, il dr. Ruzicka mi diceva spesso: esponi sulle
ombre, il resto verrà da sé - aveva ragione. Ma come padroneggiare la tecnica,
questo non lo sapevo ancora. L’impiego della luce e dei materiali
fotosensibili in base alle capacità tecniche e la cultura del fotografo (quelle qualità che Roland Barthes definisce
lo studium) danno origine agli stili che i critici chiamano le poetiche del fotografo. La luce è per il
fotografo quello che le parole sono per lo scrittore, i colori per i pittori, i
materiali quali il marmo, il legno, i metalli e la creta per lo scultore: un
mezzo privilegiato per esprimersi. Il fotografo avveduto, sapiente, colto, sa
sfruttare le qualità della luce racchiuse nell’intensità e nella quantità, nel
contrasto determinato dal tipo o forma di sorgente luminosa, nella direzione o
provenienza che influisce sulle ombre e la profondità; altresì, la differenza
della luce naturale nell’arco della giornata, di quella artificiale, perché
agiscono in modo diverso sui colori le cui sfaccettature suscitano sentimenti
differenziati. Ombra: significa nascondimento, mistero, ignoto, inconscio,
spazio chiuso, tenebre, male, femminile. Penombra: quiete, stasi, equilibrio,
ascolto, attesa. Luce: energia, dinamismo, rivelazione, conoscenza, sapere,
conscio, certezza, apertura, bene, maschile. Tanti autori
nella Storia della Fotografia hanno rimarcato nei titoli delle loro opere che
le scritture di luce sono figlie dell’ombra: Touhami Ennadre, Lumière noir; Olivier Christinat, Lumière cendrée; Bill Brandt, Shadow and light; Eugene Smith, Il senso dell’ombra; Vivian Maier, Out of the shadow; Augusto Allegri, Le ombre della memoria; Paulo Nozolino, Penumbra; Michele Battistelli, Ombre sulla Moldava, Sergio Scabar, Silenzio di luce; Evgen Bavčar, Nostalgia
della luce; Paolo Monti, Nei segreti
della luce tra le cose. Ancora: basti pensare alle opere di Mario
Giacomelli con quelle ombre dense, neri catramosi e bianchi abbacinanti. L’incanto della luce – tra l’altro – è un
titolo comune a dei lavori di Elio Ciol e Marialba Russo. Tutto ha
origine dall’ombra: l’universo trae origine dal buio. Fotografia, Pittura e Scultura condividono la comune origine che si
collega all’ombra, alla silhouette da cui provengono tutte le arti attraverso il
mito greco della giovane figlia dello scultore Dibutade o Dibutate di Corinto: dovendo l’innamorato partire per la guerra, la
giovane gli contorna l’ombra del viso proiettata sulla parete dalla luce di una
torcia. Suo padre, scultore, esegue un calco in gesso dal quale ricava una
scultura. Le poetiche dei singoli fotografi nascono dall’utilizzo della luce
diretta e riflessa, dalle sue interpretazioni e sperimentazioni sui materiali
fotosensibili disponibili sul mercato (oggi si deve dire anche e soprattutto a
seconda dei programmi tecnologici utilizzati inseriti nei computer delle
macchine). Questa penombra è lenta e non
fa male;/scorre per un mite pendio/e
somiglia all'eterno, scrive Jorge Luis Borges nella sua opera Elogio dell'ombra. La luce, da cui è scaturita
la vita, deriva dalle tenebre. L’evoluzione biologica ha selezionato gli
animali adattandone una parte alla notte e un'altra al dì. Da una silhouette,
dall’ombra (ci ricorda Plinio il Vecchio nella sua Historia Naturalis) hanno avuto origine la pittura e la scultura;
le ombre proiettate su di una parete, secondo il mito platonico della caverna,
hanno posto le basi per lo sviluppo dell'arte della conoscenza; le ombre
integrate e portate hanno contraddistinto le varie fasi e gli stili nella storia
della rappresentazione visiva tramite la pittura; dalla traccia delle ombre su
dei materiali fotosensibili è nata la fotografia. Sembra che sia stato il
pittore Claude Monet a suggerire l'uso in fotografia della presenza
dell'artista attraverso la registrazione della propria ombra (1905) con l’opera Nello stagno delle ninfee;
Alfred Stieglitz, qualche anno più tardi, sembra voglia imitarlo con Ombre sul lago. Ma bisognerà attendere
il tedesco Otto Umbehr (più noto come
Umbo), molto probabilmente influenzato
dalle opere di Marcel Duchamp (così come lo furono poco prima Man Ray e Moholy-Nagy con i rayogrammi e i fotogrammi) ad utilizzare in
fotografia nel 1930 l'ombra come traccia
per registrare una presenza inconfondibile: l'artista e il suo strumento. La stessa
situazione diventerà 40 anni dopo la soluzione (ancora per dimostrare una
presenza) scelta da Ugo Mulas. Quest'ultimo dedicherà una sua verifica a Lee
Friedlander che, come per un'ossessione, aveva consacrato tanti clic a registrare l'ombra (traccia) della
propria presenza (testimonianza di fotografo) all'interno del quadro
(fotogramma). Umbo è stato anche un pioniere nell'inserire l'ombra quale
soluzione estetica per catturare l'attenzione dell'osservatore e per
rappresentare metaforicamente attraverso forme astratte una realtà non sempre
intelligibile. Le ombre allora alluderanno alla presenza di un mistero (come
intitolerà alcune sue opere), di un enigma. Il fascino del mistero ammalierà Ralph Gibson, nei lavori del quale le
ombre registreranno il sentire interno, testimonieranno la presenza di sogni,
di tensioni, il pulsare di un enigmatico mondo interiore. È nella luce fumosa
dei bar, nella luce soffusa dei lampioni, in quella nebbiosa dei boulevards che
Brassaï penetra attraverso i segreti
di Parigi: “La notte suggerisce, non
mostra. La notte ci turba e ci sorprende per la sua stranezza, libera quelle
forze dentro di noi che di giorno sono dominate dalla ragione.” Egli entra
nelle pieghe della notte e disvela, mette a nudo il buio, rivela spaccati di
vita sociale, ci fa leggere la vita della città attraverso i suoi protagonisti
colti nelle attività notturne nel bene e nel male.
 |
| La copertina del volume |
L.M.V. Leopardi
in poesia e Fellini nella cinematografia affermarono che con l’immaginazione si
può tutto. Nel linguaggio fotografico è sufficiente avere immaginazione per
rappresentare quella soglia tra il sé e l’infinito, fra il tutto e l’assoluto?
V.M. Il
fotografo boemo Josef Sudek, noto come il Poeta
di Praga, diceva: “Ogni cosa che ci
sta intorno, morta o viva, agli occhi di un fotografo pazzo, misteriosamente,
assume mille variazioni: oggetti che sembrano morti prendono vita dalla luce,
dall’ambiente. Se un fotografo ha un briciolo di sensibilità e attenzione nella
sua testa, riesce forse a catturare qualcosa - e penso che la poesia sia in
questo.” L’immaginazione è determinante per creare
poesia, ma le esperienze di vita sono la linfa dell’immaginazione. Leopardi e Fellini
rappresentano, con parole che si trasformano in immagini il primo e attraverso
immagini e dialoghi che diventano poesia il secondo, i propri vissuti che
assurgono, mediante attraversamenti linguistici artistici, a messaggi universali.
L.M.V. La
fotografia, artisticamente intesa, è un lampo che non ha bisogno di parole. Ciò
mi ricorda gli inviati speciali, che ne fanno un uso artistico come denuncia di
atrocità tramite scene di vita umana, abbruttita dalla guerra, dalla fame,
dalla malattia, ecc…
V.M.
Nessun reporter si è mai considerato artista. Sono stati i musei e le gallerie
d’arte che l’hanno consacrata un’arte tra gli anni 1940 e 1960. Ansel Adams
nella paesaggistica, Eugene Smith nel sociale hanno passato notti intere a
rendere esteticamente più apprezzabili le loro immagini semplicemente per
mettere in evidenza il vero, sia che riguardasse il bello presente nel mondo sia
che sottolineasse i pessimi comportamenti umani. A entrambi interessava mettere
in evidenza la verità e il giusto. Se il mezzo tecnico era insufficiente a
registrarli (negativo) intervenivano manualmente in fase di stampa a modulare
luci e ombre, dettagli e scala tonale - ecco allora un eccellente esempio di
fusione tra oggettività e soggettività - per renderli in positivo. Il primo
contribuì a salvaguardare i parchi e a estenderne la cultura, il secondo
rischiò la vita e subì pesanti conseguenze fisiche per la difesa dell’ambiente
e dei diritti umani e sociali. Nel contemporaneo, a partire dalla fine degli
anni Settanta a oggi, le nuove forme di reportage chiudono il cerchio
storico nei rapporti tra pittura e fotografia iniziato, come ci ricorda Peter
Galassi, prima della fotografia, con
la mediazione della camera obscura a
cui hanno fatto ricorso famosi e meno noti pittori per la costruzione dello
spazio in prospettiva. Nel
contemporaneo molti fotografi di reportage votati all’arte, hanno posto alla
base della propria estetica riferimenti o citazionismi
pittorici. Una pratica dettata dall’esigenza del mercato dell’arte di
promuovere nuovi interessi attorno al reportage di guerra, in particolare,
soppiantato dai nuovi mezzi di comunicazione e che vede già nei primi anni ’80
impegnati su queste nuove tendenze fotografi come Susan Meiselas, Steve
McCurry. Stilemi che a partire dagli anni Novanta ad oggi si rafforzano nelle
opere di Sebastião Salgado, James Nachtwey, Georges Mérillon, Zaourar Hocine; a
seguire, Luc Delahaye, Carl De Keyzer, Éric Baudelaire con i quali la macchina
di piccolo formato lascia il posto al cavalletto o treppiede e all’apparecchio
di grande formato per una rappresentazione quanto più scenografica con precisi
pittori di riferimento anche nell’uso del colore. Se Mérillon e Hocine ci
rimandano alle tele caravaggesche, Delahaye, De Keyzer e Eric Baudelaire citano
epressamente le opere pittoriche con fotografie di grande formato e
composizioni storiche simili a un tableaux vivant e che rievocano i quadri di
David e Gericault.
L.M.V. La
fotografia può con il suo sguardo indagatore mettere in luce il rapporto fra il
reale e il sé interiore?
V.M.
È proprio perché la fotografia è uno strumento espressivo che permette di
indagare il mondo non in modo asettico che ciò può accadere. In questo consiste
un’opera d’arte e che fa la differenza con una foto semplicemente tecnicamente
perfetta. Arte visiva come dialogo dell’anima con le cose per dare un senso
all’esistenza. Questo percorso, all’insegna di una pratica fotografica
autoriale che fonde mondo reale e quello ideale inizia nell’Inghilterra della
metà dell’800, poco dopo la nascita della fotografia. Margaret Julia Cameron ne
fu una eccelsa protagonista e sostenitrice. La soggettività prende campo sempre
più alla fine dell’Ottocento e si consolida nella fotografia, considerata come
mezzo espressivo, con le avanguardie dada, futuriste, surrealiste. Quando
Umberto Eco afferma “L’opera d’arte è
sempre una confessione”, non fa altro che ribadire vecchi concetti che si
trascinano nell’arte dal mondo greco-romano, enfatizzati nella pittura a
partire dal Rinascimento attraverso le serie di autoritratti con specchio -a
dimostrazione dell’identità con l’opera d’arte- e del trasferimento sulla tela
delle idee, del pensiero dell’artista. Due secoli dopo, insiste su questo
principio l’inglese John Ruskin e Oscar Wilde agli albori del Novecento ne fa
una squisita incarnazione in Dorian Gray: -Ogni
ritratto dipinto con passione è il ritratto dell’artista, non del modello. Il
modello non è che il pretesto, l’occasione. Non è lui quello che viene rivelato
dal pittore, ma piuttosto il pittore che sulla tela rivela se stesso. La
ragione per cui non voglio esporre questo ritratto è che temo di avere palesato
in esso il segreto della mia anima. Dice Basil Hallward, uno dei
protagonisti. Luigi Ghirri, in Niente di
antico sotto il sole, riporta un brano di Borges nel quale si parla di “un pittore che volendo dipingere il mondo,
comincia a fare quadri con laghi, monti, barche, animali, volti, oggetti. Alla
fine della vita, mettendo insieme tutti questi quadri e disegni si accorge che
questo immenso mosaico costituiva il suo volto.”Ma su questo aspetto della rappresentazione del sé - autore - in
fotografia hanno scritto poesie Prévert, Wenders sottolineando come l’atto del
fotografare sia bidirezionale: davanti cattura l’oggetto e dietro il pensiero
del fotografo che diventa “inconsapevole,
involontario operatore del film della propria vita.”
***
LIBRI
IL GENIO FRAGILE
di Chiara Pasetti
 |
| Adriano Manesco nell'Aprile del 1973 |
In memoria del professor Adriano Manesco (1937-2014)
Adriano Manesco è stato un grande studioso, un professore universitario, e
un uomo curioso e irrequieto. Aveva studiato al Liceo Classico Salesiano
Sant’Ambrogio di Via Copernico a Milano; tra i vari compagni di classe, alcuni
diventati brillanti intellettuali, c’era anche Silvio Berlusconi. Si laureò in
filosofia all’Università Cattolica mentre, per mantenersi, collaborava al Giorno
con turni serali e notturni. Parallelamente alla sua attività di ricerca iniziò
a insegnare filosofia e storia, con impegno e passione, in diversi licei
classici di Milano e provincia (chi è stato un suo studente lo ricorda come «il
genio»); successivamente, distinguendosi per cultura, versatilità, profondità
di analisi, competenze maturate attraverso uno studio lungo e appassionato
della filosofia, dell’antropologia, della linguistica e della geografia, passò
al ruolo di ricercatore in Estetica all’Università Statale (dove conobbe
l’allora giovane studente Elio Franzini), e subito dopo in Geografia, poiché
amava molto oltre alla filosofia anche lo studio delle culture orientali. In
quegli anni si rivelò estremamente originale e acuto sul piano didattico oltre
che professionale e pubblicò, tra le altre cose, un volumetto su Dufrenne, un
saggio su Il problema dell’oggetto estetico (nel 1977) e infine le
pagine su La riflessione estetica nel mondo arabo-islamico e su La
riflessione estetica nel Positivismo nel Trattato di estetica di
Dufrenne e Formaggio del 1981. Nei primi anni ’80, malgrado gli importanti
traguardi raggiunti, la sua sete di conoscenza e l’insofferenza nei confronti
di alcune logiche accademiche che non riusciva a tollerare lo portarono a
lasciare l’Italia per l’Estremo Oriente. Lì studiò le lingue, insegnò italiano e
approdò infine a Bangkok come professore di Filosofia greca e araba presso la
Abac Assumption University. Nonostante la sistemazione fosse prestigiosa,
«nessun luogo poteva rimpiazzare un luogo originario perduto o mai esistito, ma
sempre ostinatamente cercato; sognava di trasferirsi in Giappone, per poter
vivere in un ambiente umano in cui sentirsi accolto e riconoscere come suo»
(Anna Ferruta). Rientrato a Milano, in pensione dagli anni ’90 visse sempre da
solo in un appartamento stipato di libri vicino alla stazione centrale; una
sorta di isolamento confortato però dalla compagnia di alcuni amici di sempre che
spesso incontrava, tra cui Gabriele Scaramuzza, con cui parlava dei rinnovati
interessi per Montaigne e Mann e a cui faceva leggere le recensioni che
scriveva, temendone il giudizio (che invece era sempre estremamente positivo).
Non perse mai, malgrado le difficoltà di vivere e, come scrive Scaramuzza, «di
costruirsi un argine duraturo ai suoi disagi», il suo «amore per la vita». Che
è stata barbaramente interrotta il 7 agosto 2014, all’età di settantasette anni.
Fatto a pezzi da due uomini che Manesco conosceva, «sistemato con cinica cura
in un trolley e gettato in un cassonetto della spazzatura» (così Renzo
Cecchinelli). I giornali parlano, tra le altre cose, di movente economico e di
ricatto, i due assassini avrebbero rubato la pensione del professore e alcuni
oggetti personali. Una fine indegna di qualunque essere umano, e specialmente
di una persona che nella sua vita aveva sempre cercato di trasmettere valori di
rispetto per la dignità umana e un appassionato interesse e impegno per la
crescita culturale e civile. I suoi amici, colleghi, ex studenti, collaboratori
(ed erano davvero tanti, malgrado ciò che è stato scritto nelle cronache) hanno
voluto rendere omaggio a quest’anima generosa, gentile, geniale, al loro «amico
fragile» (dalla splendida canzone di De André, ricordata nella testimonianza di
Elio Franzini, che definisce Adriano Manesco anche «un sognatore, un colto
viaggiatore, più curioso di tutti noi e così intelligente da non essere
spaventato dall’assurdo») nel volume Un amico fragile. Testimonianze
e ricordi per Adriano Manesco (Mimesis edizioni). Non una biografia, ma un
insieme di ricordi anche familiari, discreti, commossi, vibranti. Un modo per
non dimenticare la nobile e inquieta vita, e la terribile e raccapricciante
morte, del professor Adriano Manesco, che ha lasciato un segno profondo nella
mente e nel cuore di chi lo ha incontra
Un amico fragile.
Testimonianze e
ricordi per Adriano Manesco
a cura di Virgilio Melchiorre,
con la partecipazione di Sibilla Cuoghi,
Anna Ferruta, Elio Franzini, Gabriele Scaramuzza,
Ed. Mimesis, Milano-Udine, pagg. 13
***
DOG SERVICE
Un racconto di Alberto Mari
 |
| Nella foto: Alberto Mari |
Un posto in paradiso o all’inferno. Fedele o ingrato
non aveva importanza. Poteva godersi l’ampio panorama dalla terrazza. Al di
sopra dei vizi e delle virtù. Non faceva più parte di un branco ma di un
gruppo. Il fiuto era concentrato sul mercato. Era il suo party in una vita da
uomini e lui era la parte migliore.
Negli
occhi brillanti una foresta al neon. Le orecchie antenne a estrarre i rumori.
Occhi febbrili, occhi selettivi. Nelle pareti panoramiche della metropoli, le
atmosfere dello stilista, il disegno delle voci notturne, ricordo d’erbe
agitate.
La
scritta al contrario nel vetro smerigliato ceruleo dell’agenzia, sovrastata dal
marchio d’ispirazione araldica con la testa di un bracco famoso.
Occhi
vigili, occhi attenti. Al tintinnio del ghiaccio nel drink, l’udito scatta come
un grilletto.
Cani
famosi, cani di successo. L’odorato percepisce la sfumatura Chanel N.5, secoli
di carezze tentano il suo capo. Lei è visibilmente vicina degna dei più remoti
ululati, gli occhiali a righe bianche e rosse persi nelle piastrelle verde
lime.
Occhieggiano
le unghie rosso vivo nella scarpetta dorata. La telecamera inquadra l’ospite.
Un braccio l’avvolge: “Vieni, devo farti conoscere questo, farti conoscere
quello…”
“Ti
presento, ti presento… Mezzanotte.” Il sorriso si schiude all’arrivo del nome.
Arretra l’abito favoloso, volteggia con altri modelli. Indossatrici col cane
uniti nella camminata danzante. Dame e cavalieri sfumano nei volti, maschere in
carca delle parole giuste.
Infido
posa con la copia di Cenerentola. Sono entrati nella parte sfidando la musica.
Lui è un tipo affascinante ma pericoloso, la fredda lama in tasca, lo sguardo
acido delle buone maniere.
All’uscita
un mendicante deturpato gli chiede se è felice, mentre lui alza la mano verso
un taxi. Una volta abbaiavano. Adesso con la coda esprimono deferenza.
Perfettamente inseriti nel cast, temprati come marines, hanno sperimentato di
tutto. L’abbandono nell’autostrada. Una sana iniziazione. Vanno d’accordo su
tutto, tranne che nel calcio. Insieme fanno squadra ma nello spogliatoio solo
il nero li accomuna.
“L’azzurro
lascialo al cielo!” Grida uno. “Il rosso sta bene da solo”. Replica l’altro.
Ciascuno, anche nei guinzagli, ha i suoi colori da difendere.
Il
pennello del pittore si sfoga in sberleffi neri, rossi, e azzurri. Ignara
controfigura dell’arbitro pelato, come un buddista in posa sorridente. Un
ermafrodita gesticola come un direttore d’orchestra orgoglioso della sua opera.
Non importa a quale bandiera appartengono. Dog I sulla poltrona presidenziale
sprofonda ripensando ai bei tempi della schiavitù senza pensieri con il cibo
assicurato.
Intanto
il pittore è immerso in un mare di stoffe. “Oh, come starebbero bene sulle mie
tele!” E reggendo i vari lembi a turno precipita verso i quadri semoventi
sommersi nella sua Atlantide personale.
Un
guinzaglio in ecopelle viola, guarnito Swaroski, lo riporta a galla, ma intanto
i visitatori nei loro costumi estivi si tuffano nella mostra. Ogni tanto si
svegliava stanco e sudato con varie escoriazioni sul corpo. Era sfinito. Doveva
aver corso moltissimo.
“Dimostrati
degno della notte”. Il corpo sinuoso parlava controluce, immobile, in un lungo
istante, seguito da un volteggio, un alone di nebbia lucente.
“Autumn
winter” Applausi, mormorii, estasi, sfinimenti. Nel tessuto fremente del sonno
il disegno dei rami, il pallore della luna. Il terreno morbido, moquette,
prato, al ritmo ansante del respiro.
Uno
sconosciutolo guardava attraverso lo specchio con una luce giallognola negli occhi.
Nello
sguardo chiuso le mani tormentavano un bosco a capofitto, ripreso a gran
velocità.
In
lontananza s’udiva un sinistro ululato.
Il
sogno del mendicante era finito, il capo racchiuso nel braccio, nascondeva Il
sangue pulito del coltello.
Davanti
all’ingresso dell’agenzia c’è una dimostrazione di extracomunitari. I vari
cartelli inneggiano a una improbabile uguaglianza.
Sull’ascensore
gli sguardi divagano, rivolti a qualsiasi parte, cercando di uscire
dall’imbarazzo formale. Le teste chine inquadrano gambe femminili con calzature
di diversi tipi, marchi e colori, col tacco più o meno alto, due paia di scarpe
da uomo Geox, sotto calzoni color arancio e le zampe inquiete d’un cane.
Quest’ultimo è l’unico ad alzare la testa e a guardare in alto.***
LIBRI
IL PENSIERO “VIRULENTO” DI LIDIA SELLA
di
Angelo Gaccione |
| Lidia Sella |
Come ci ha ormai abituati da qualche tempo, anche
questo nuovo libro di Lidia Sella: “Strano
virus il pensiero” (La vita felice ed. pagg. 72 € 12,00), è costruito
mettendo assieme due formule: quella propria della poesia e quella che le è
altrettanto congeniale della forma breve, secca, lapidaria dell’aforisma. I temi
del libretto sono quelli più consoni alla sua visione e che l’autrice ha messo
al centro della sua speculazione e della sua poetica. Non ho usato a caso il
termine “speculazione”: chi conosce gli scritti e sa dei suoi interessi e delle
sue letture, non si stupirà affatto. Sella oscilla da sempre fra filosofia e
scienza (non è per caso che il suo libro porti due riflessioni, quella di Antonio
Prete e quella di Giulio Giorello) perché da queste due forme di sapere
ineludibili è attratta, per approdare attraverso esse, ad un’altra forma,
quella propria della poesia, per dare organicità alla sostanza dei suoi
pensieri e del suo sentire. Perché in fondo Sella resta un poeta, e la materia
di cui l’universo si compone, lo spazio-luce, l’energia, l’infinitamente
piccolo, il cervello rettile o la memoria ancestrale, possono trovare una via
di rappresentazione e “dicibilità” (mi scuso di questo brutto termine, ma
dovrebbe meglio rendere l’idea), solo con la parola organizzata, rigorosa,
della formula poetica o di quella altrettanto letteraria dell’aforisma. Perché
al fondo di tutto il suo speculare, del fuoco del pensiero (la brace, com’ella scrive) che non deve
mai estinguersi e perire, c’è e resta la nostra condizione umana di creature
fragili e destinate alla fine. C’è la nostra esaltazione e la nostra
limitatezza fisica e temporale, c’è la nostra genialità e la nostra ferocia, c’è il piacere fisico e c’è la decadenza della vecchiaia, c’è l’amore e c’è la
spietata aggressività, c’è la bellezza e il suo contrario. Insomma, c’è la vita
e la morte e dunque ogni creatura non può che interrogarsi sul proprio destino.
E a questa interrogazione che diviene fondamentalmente esistenziale, sono prima
di tutto i poeti, gli artisti, i drammaturghi, più che gli scienziati e i
filosofi, che in ogni tempo hanno saputo dare voce. Perché il loro modo, il
loro linguaggio ha saputo toccare, e meglio, le viscere e il cuore, prima della
ragione. E i teologi? Per Sella non c’è spazio in questo universo fatto di
quanti e di buchi neri, per dirne l’incommensurabile ed il mistero, per questo
bastano i poeti e i musicisti.
E tuttavia il bisogno di parlare con Dio è ineliminabile. Nella sezione intitolata “Religionespiritualità” c’è un distico che così recita: “Da bambini parlano coi pupazzi, da grandi con Dio: l’insopprimibile bisogno di un interlocutore immaginario”.
E tuttavia il bisogno di parlare con Dio è ineliminabile. Nella sezione intitolata “Religionespiritualità” c’è un distico che così recita: “Da bambini parlano coi pupazzi, da grandi con Dio: l’insopprimibile bisogno di un interlocutore immaginario”.
 |
| La copertina del libro |
L’attrazione
più forte di questo libro, il suo fascino, rimane, almeno per me, quello
racchiuso nella formula contratta dell’aforisma, del brandello, del distico o
addirittura del solo rigo. Sono efficacissimi e spesso molto poetici, e si
imprimono in maniera immediata nella mente del lettore per la loro forza e
verità. Spaziano negli ambiti più diversi e ce ne sono di ogni tipo, anche di
politici o che riguardano l’attualità più cogente. Vediamone alcuni: “Ormoni in calo, saggezza in aumento”; “Non omicidio ma suicidio, l’aborto”; “Chi mai vorrebbe partire per un viaggio senza ritorno? Eppure proprio
questo avverrà”; “L’angolo delle foto
di famiglia si trasforma presto in un raduno di morti”; “Hai perso qualcosa? Non angustiarti: un
giorno perderai tutto”; “Quando avrai
imparato tutto non ti servirà nulla”; “Rughe
sulla pelle del vecchio mare, le onde”; “Noi, vasi di tempo da cui
ogni tanto sboccia un fiore”. Di queste perle poetiche o sapienziali è
pieno il libro. Vediamo con quale impietosa efficacia è fissata la fine di un
innamoramento nel distico titolato “Paradosso”: “Dissolta la nebbia dell’innamoramento lui e lei non si riconoscono più”.
Non è da meno questo ispirato alla cronaca più ravvicinata: “Banchieri, politicanti, come investirete i
sorrisi rubati ai popoli europei?”,
o questo che si presenta come un perentorio grido di protesta: “Non mi importa che l’umanità sopravviva
quando il mio popolo non ci sarà più”. Troverete molto altro in questo
libro e vi assicuro che la sua lettura non vi deluderà.
***
LIBRI
BETOCCHI A COSENZA
di Angelo Gaccione
di Angelo Gaccione
 |
| Carlo Cipparrone |
“Orizzonti
Meridionali”, le sensibili e colte edizioni dell’editore cosentino Franco
Alimena, non potevano esordire meglio, inaugurando la Biblioteca di Capoverso con questo magnifico e
necessario libro del poeta Carlo Cipparrone. Si tratta di “Betocchi. Il vetturale di Cosenza e i poeti calabresi” (Edizioni
Orizzonti Meridionali Pagg. 136 € 12,00). Perché ho detto che si tratta di un
libro necessario? Intanto perché contiene dieci preziose lettere che il grande
poeta toscano (dico toscano anche se in realtà Betocchi era nato a Torino, ma
da cui ancora infante era stato portato dalla famiglia a Firenze, dove avverrà
la sua formazione di uomo di lettere e di poeta), scrive a Cipparrone dal 1°
dicembre 1957 al 20 settembre del 1963 e che con questo libro ci viene offerta
la possibilità di conoscere. Poi perché dà il segno di che pasta fosse (ahimè,
tempi ormai scomparsi!) la civiltà letteraria che informava gli ambienti
letterari di allora. Una roba impensabile paragonata all’oscena pratica di
questi anni. Ha ragione Cipparrone a sottolinearlo nella sua noticina
introduttiva alle lettere: “Non è più
pensabile, oggi, che un autore affermato dedichi parte del suo prezioso tempo e
della sua attenzione a giovani aspiranti poeti, quali eravamo io e Nerio…”.
Infine, perché Cipparrone ricostruisce minuziosamente il soggiorno di Carlo
Betocchi nella città di Cosenza, dove era giunto nell’autunno del 1957 per
tenere una conferenza letteraria all’Accademia Cosentina. Assieme al giovane
amico Nerio Nunziata (anch’egli con un destino di poeta), Cipparrone, allora
poco più che ventenne, guida Betocchi (che di anni ne aveva 58) nei luoghi
della città più suggestivi di storia e di memorie. Il poeta si lascia
volentieri guidare da questi due giovani ventenni, con amichevole disponibilità,
e conserverà ricordo e stima, dei “Cari e
bravi amici”, senza dimenticare l’ospitalità della famiglia Cipparrone, come
si può vedere dalle lettere. Alla città bruzia Betocchi dedicherà il testo
poetico “Il vetturale di Cosenza", e della città conserverà un buon ricordo: “Conservo di Cosenza un caro ricordo, e penso
a quante cose si potrebbero dire di quel centro della Calabria nel quale potei
trattenermi solo una sera…”. Cipparrone e Nunziata oltre che sensibili ed
accoglienti, erano stati tempestivi e puntuali, firmando a quattro mani un resoconto
dell’incontro col poeta, sul giornale “Cronaca di Calabria” del 25 Novembre di
quell’anno. Betocchi non solo apprezzò, ma non si lasciò sfuggire l’occasione:
prendendo spunti da quell’articolo, svolse una interessante riflessione
pubblica con uno scritto dal titolo “Quale cultura per il Sud?” che apparve sul quotidiano “Il Popolo” del 12
Dicembre 1957.
 |
| La copertina del libro |
La ricostruzione della giornata cosentina di Betocchi è
raccontata minuziosamente da Cipparrone; dagli spostamenti agli incontri, dalle
reazioni alle confidenze. Fra l’altro il poeta cosentino è la prima persona in
assoluto ad essere informata della nascita del testo poetico “Il vetturale”. Le
carrozze a cavallo che così poetiche avevano reso ai nostri occhi città come
Roma, Napoli, Cosenza, Firenze, avevano svegliato presto l’ospite con il loro
rumore; ma era stato un risveglio proficuo e di cui non si lamenterà. Ma c’è
altro in questo libro: Cipparrone ha ricostruito il rapporto che Betocchi ebbe,
oltre che con lui e Nunziata, con altri poeti calabresi, tra questi Calogero,
Ermelinda Oliva, Gilda Trisolini e Silvio Vetere. Sono sicuro che chi si interessa
di poeti e poesia, apprezzerà questo volume di Cipparrone, così come gli
estimatori di Betocchi e gli amanti come me di epistolari. A proposito voglio
segnalare alcune coincidenze: il libro di Carlo mi è arrivato proprio mentre
sto lavorando al riordino del mio vasto e pluriforme carteggio; i due poeti
portano lo stesso nome e hanno svolto la stessa professione di geometra. È
proprio vero che esiste un destino nelle cose.
Carlo Cipparrone
Betocchi. Il
vetturale di Cosenza e i poeti calabresi
Edizioni Orizzonti Meridionali
Biblioteca di Capoverso -2016
Pagg. 136 € 12,00
***
LIBRI
LA VIGNA DI NABOTH
di Angelo Gaccione
 |
| La copertina del libro |
La
storia è raccontata nella “Bibbia”
nel I Libro dei Re (21,23). A prima vista la proposta di Achab non sembra
fraudolenta: chiede a Naboth di Izreel la cessione della sua vigna in cambio di
un campo addirittura migliore, o dietro il pagamento di un giusto prezzo. È
vero, Achab non si aspettava un rifiuto così deciso: in fondo lui è il re di
Israele (vi immaginate il re di Israele che si abbassi a domandare una vigna al
suo vicino e che questi possa osare un rifiuto…). Ci rimane male: anzi è
angustiato, sdegnato, addirittura non prende sonno; la moglie Gezabele se ne
accorge e naturalmente vuole che il marito ritrovi la serenità. Donna pratica,
Gezabele organizza subito un complotto per mandare a morte il disubbidiente
Naboth ed entrare in possesso della sua vigna. Lo strumento del complotto è la
calunnia: su istigazione della donna del sovrano, trovare “due uomini iniqui”
che accusino pubblicamente Naboth di avere maledetto Dio e il Re, è un gioco da
ragazzi. Il poveretto verrà lapidato e la vigna, senza più ostacoli,
incamerata.
Ovviamente una tale
ingiusta e violenta usurpazione non potrà rimanere impunita: il Vecchio
Testamento è implacabile: il Signore manda Elia il Tisbita ad annunciare al re
la tremenda profezia: i cani sbraneranno sua moglie Gezabele e gravi sciagure
si abbatteranno sulla sua casa. Il lettore potrà leggere direttamente la
vicenda e seguirne gli inevitabili esiti. Ma perché Ambrogio da Treviri, il
sant’Ambrogio dei milanesi e patrono della città, che l’iconografia ci consegna
fiero e sdegnato su un bianco destriero mentre con il braccio alzato marcia
verso i suoi nemici per annientarli, assume la vicenda come un paradigma e la
svolge, nella sua riflessione, tornandovi di continuo ed avendola costantemente
presente?
Risponde a questi ed altri
quesiti, la lunga e bene argomentata introduzione di Maria Grazia Mara al libretto
di Ambrogio “La vigna di Naboth”
(Edizioni Dehoniane Bologna, pagg. 136 €
13,50), che del vescovo milanese ricostruisce non solo il pensiero teologico, ma
la datazione e la nascita del “Naboth”, il suo contenuto, e soprattutto il
clima storico-politico che lo giustificano e lo motivano. Alla luce delle
contingenze storico-politiche, la vicenda del re Achab e del vignaiolo Naboth assume,
in Ambrogio, un significato molto più concreto e contemporaneo di quanto si
possa immaginare. Scrive Maria Grazia Mara a questo proposito: “Almeno per
dieci anni, dal 386 al 396, Ambrogio manifesta un interesse ricorrente per la
storia di Achab e di Naboth. Ambrogio assume per sé o il ruolo di Naboth di
fronte a Valentiniano II e a Teodosio, che considera quindi i nuovi Achab, o il
ruolo di Elia di fronte ad Achab, o il ruolo di Elia di fronte a Jezabel”. Lo
scontro che oppone potere imperiale e potere spirituale, la delimitazione delle
reciproche sfere di influenza, le tensioni che vedono in conflitto ariani e
cattolici, sarebbero dunque alla base della riflessione ambrogina della vicenda
narrata nel I e II Libro dei Re. Naturalmente resta tutto il peso degli
insegnamenti etico-morali e dei comportamenti empi che la storia intende
stigmatizzare: l’ingordigia, la malvagità d’animo, la frode, la menzogna,
l’ingiustizia, l’attaccamento oltre misura ai beni effimeri della vita, e la
superiore punizione divina che arriva puntuale ed esemplare. Come resta,
fortissima, la difesa di Ambrogio dei poveri, il suo schierarsi dalla loro
parte contro i potenti; la polemica contro i ricchi, la ricchezza e l’avidità,
che egli svolge con tale virulenza di linguaggio, con così tagliente radicalità
critica, che non sarebbe dispiaciuta al suo conterraneo di Treviri: quel Karl
Marx autore de “Il capitale”, se ne
avesse potuto leggere lo scritto.
Ambrogio
La vigna di Naboth
a cura di Maria
Grazia Mara
Edizioni
Dehoniane Bologna 2015
Pagg. 136 € 13,50
***
LIBRI
PER LELIO BASSO
di Fulvio Papi
 |
| Lelio Basso |
Il libro di Alessandro Olivieri "Lelio Basso. Per la rivoluzione in Occidente"
riapre il discorso su una figura centrale della storia del socialismo italiano, e rende gli onori dovuti ad uno dei padri nobili della Costituente e dell'antifascismo, che noi non abbiamo dimenticato (A.G.)
La figura di Lelio Basso, dal punto di vista
politico e teorico, fu fondamentale per quei giovani, molto pochi, che
seguirono il PSI dopo la débâcle
elettorale del 18 aprile 1948. Lelio era stato
segretario del partito che aveva scelto la prospettiva frontista, alla
quale era contrario, ma fortemente voluta da Nenni che aveva la maggioranza
alla direzione, e, forse sperava di poter ripetere il successo che ebbe in
Francia il Fronte popolare negli anni Trenta. Il partito aveva un periodo di
vero sbandamento, soprattutto intellettuale, chiuso in un nuovo massimalismo e
alla sua opposizione vi era una ragione critica per il passato, ma
un’approssimazione politica e, soprattutto, una assenza di prospettive a
livello teorico. Lelio rappresentava l’intelligenza e la conoscenza storica e
filosofica intorno alla quale a noi pareva sarebbe stato possibile trovare il
senso della partecipazione alla vita del partito. Ricordo le riunioni che
tenevamo in federazione (via Valpetrosa 2) il venerdì sera quando Lelio, di
ritorno da Roma, parlava con noi, avrebbe detto Labriola, di “socialismo e di
filosofia”. Erano momenti di vera formazione politica, privi del tutto di quel
tono dottrinariamente autoritario degli ambienti comunisti che, del resto,
conoscevo dalle riunioni dei miei compagni comunisti all’Università. Quando, in
un periodo immediatamente successivo, Rodolfo Morandi diede al partito una
svolta organizzativa molto radicale cercando di costruire una organizzazione di
quadri del tutto dipendenti dal centro, Lelio fu messo alla porta in un modo
così radicale da essere gravemente offensivo non solo del suo valore
intellettuale e del suo contributo politico, ma, in qualche caso, della sua
persona. Il che non mi impediva, qualche volta, di andare a trovarlo a casa in
corso Venezia 6. Quel comportamento del partito mi parve allora
incomprensibile, non solo perché non sapevo valutare la distanza ideologica tra
il centralismo politico di Morandi (una specie di “stalinismo di riflesso”) e
la concezione di Lelio che aveva sempre sostenuto, studioso ed estimatore
dell’opera di Rosa Luxemburg, l’esigenza della crescita della prospettiva
socialista dall’espressione libera e consapevole delle masse popolari, ma anche
perché non mi rendevo conto del degrado del partito, per lo meno a livello
della sua organizzazione burocratica. Anche se nelle sezioni, compresa la mia
in centro, restavano ben evidenti i ritratti di Turati e di Matteotti. Quanto
questa linea politica corresse se stessa, ma, soprattutto, dopo il rapporto
Kruscev sui crimini di Stalin e, conseguentemente, sulla condizione sociale
dell’Unione Sovietica, pensai che Lelio fosse il vero vincitore dei travagli
interni al PSI. Ma le cose non andarono affatto così, poiché i poteri
consolidati nel partito non si potevano scalzare con la forza vincente delle
idee. Al congresso provinciale di Milano noi “bassiani”, tutti giovani
intellettuali, toccammo il desolato cinque per cento dei voti. Ma senza alcuna
delusione o scoramento perché, un poco ostinatamente , pensavamo di avere
ragione. Solo più tardi capii che l’effettualità delle cose mostrava che in
politica non c’era “ragione”, ma solo un gioco di forze, alle quali se non eri
adeguato, saresti comunque, prima o poi, finito in un angolo.
 |
| La copertina del libro |
Mi sono tornati
in mente i giorni di quell’antico tempo dei primi anni Cinquanta, ora che ho
appena terminato la lettura dell’ottimo libro di Alessio Olivieri “Lelio Basso. Per la rivoluzione in Occidente”
(Edizioni Punto Rosso, 2015, Pagg. 186 €
15,00). L’opera è molto rigorosa e tocca tutti gli aspetti della presenza di
Lelio nelle fasi della politica italiana dagli anni Venti, all’opposizione al
fascismo, alla Resistenza, alla Costituente, alle vicende socialiste, fino alle
sue ultime testimonianze in un quadro di giustizia internazionale. Credo faccia
bene l’autore a insistere sull’influenza positiva del celebre libro di Mondolfo
“Sulle orme di Marx” poiché il
filosofo prediligeva gli elementi umanistici nell’opera di Marx che valevano
come critica radicale alla società capitalistica, al di là di quelle che erano
le posizioni politiche riformiste dello stesso Mondolfo. Era una strada
differente, sia dal positivismo socialista maggioritario, sia dei fermenti
gentiliani e sorelliani che poi s’incontrarono con la dialettica,
sostanzialmente volontaristica, che derivava da Lenin. Per quanto riguarda
l’eredità di Marx, furono queste le radici a rendere molto importante
l’incontro con il pensiero di Rosa Luxenburg e quindi l’insieme
dell’orientamento di Basso per il quale un’esperienza socialista non può
nascere che da un cosciente movimento popolare desideroso di ottenere, con il
proprio impegno, una trasformazione sociale, (che in Italia doveva essere, dopo
il 1948, il compimento della costituzione repubblicana verso successive e
ulteriori conquiste sociali).
 |
| Lelio Basso con Pietro Nenni al XXXIII Congresso del Psi (Napoli 15 gennaio 1959) |
Ora non posso seguire ne suo svolgimento tutto il libro di
Olivieri, ma vorrei cercare una ragione vitale del pensiero di Lelio mettendo
sulla medesima rotta le parole rivoluzione e sconfitta, delle quali Lelio
parlava in una sua celebre intervista. La sconfitta personale che Lelio si
attribuiva era il fallimento della trasformazione della società verso una
prospettiva socialista. La via del suo marxismo, opposta sia alla versione
riformista, quella che privilegiava il pensiero economico di Marx, sia quella
rivoluzionaria che privilegiava invece la dialettica storica di classe
interpretata dalla “avanguardia” politica, era rimasta sterile. Le due
soluzioni antinomiche storicamente, nelle condizioni date obiettivamente erano
la “realizzazione” di interpretazioni del laboratorio di Marx, che non
rappresentavano la sua “verità”, ma piuttosto interpretazioni operative
possibili in contesti materiali dati obiettivamente. Il marxismo di Lelio,
nella sua forza e nella sua passione vitale, era piuttosto una variante
intellettuale dell’umanesimo europeo. Lelio stesso aveva detto che prediligeva
i famosi “manoscritti” parigini di Marx, del 1844. Il progetto di Lelio era,
nel profondo, la liberazione dell’uomo da una civiltà che ne distruggeva la
possibilità creativa, l’“essenza che costruisce se stessa”.
 |
| Lelio Basso al centro della foto, alla sua sinistra Togliatti, alla sua destra Luigi Longo e Alcide Malagugini al Congresso Nazionale del Pci (Milano, 5-10 gennaio 1948) |
E qui a mio modo di vedere non manca affatto la dimensione,
sotterranea, carsica, della salvezza di origine religiosa. Una simile
prospettiva ideale doveva avere necessariamente il suo correlato nella
considerazione del “popolo”. Il marxismo che era il linguaggio praticabile
nella contemporaneità , rappresentava la realtà storicamente ideale delle due
radici vitali che ho cercato di ritrovare. Così che la sconfitta di Lelio, è la
sconfitta di una civiltà etica, di una idealità europea praticabile oggi solo
moralmente (ma è pure una forza) poiché, a livello materiale ed egemone è
tutt’altra cultura vincente. Quanto a Marx ho cercato di mostrare, dopo una
pratica di decenni, che non il suo umanesimo “tedesco”, ma la sua analisi
londinese del capitale è la limpida visione genealogica, economica e sociale,
di quello che poi è accaduto come “nostra storia”.
ALBUM FOTOGRAFICO
 |
| Lelio Basso con Arafat (Kuwait settembre 1974) |
 |
| Un comizio di Lelio Basso a Scandiano (12 giugno 1949) |
 |
| Kruscev apre il Congresso Mondiale per il disarmo generale e la pace Mosca, 9-14 luglio 1962 (Palazzo dei Congressi del Kremlino) sul podium Lelio Basso mentre applaude |
 |
| Congresso Provinciale del PSIUP (Milano 1946) |
***
LIBRI
TOMBE DI UOMINI MOLTO ILLUSTRI
di Angelo Gaccione
 |
| Cees Nooteboom |
Dalla tomba di Calvino, a Castiglione
della Pescaia, circondata di piante e fiori, ho portato via un ramoscello di
lavanda; da quella di Kafka a Praga, ho portato via una pietra: altre ne ho
posato sopra come usano gli ebrei, anche se io ebreo non sono. Il ramoscello di
lavanda ha resistito un bel po’ di tempo, prima di diventare secco e disfarsi;
la pietra invece resiste imperterrita ed è in un piccolissimo cestino di vimini
in un cassetto di una delle librerie di quella che è ormai per tutti “la
Carboneria”, il locale dove si è accumulata una quantità esagerata di libri. Di
Kafka possiedo anche la stessa fotografia della tomba che compare in questo
libro di Nooteboom. Sul Cimitero Acattolico di Roma (detto anche degli inglesi
o degli stranieri), avevo scritto, a suo tempo, un vero e proprio articolo per
un giornale milanese, e oltre che davanti alle tombe di Shelley, Keats e Gadda,
avevo sostato, come aveva fatto Pasolini, davanti a quella di Gramsci.
 |
| C. Nooteboom |
Forse è una pulsione comune a lettori, scrittori,
appassionati di discipline fra le più varie (teatro, musica, arte, letteratura,
filosofia, ecc.) andare in cerca dei luoghi che sono appartenuti a quegli
uomini e quelle donne che con le loro opere, le loro parole, i loro versi, le
loro note, i loro concetti, le loro azioni, ci hanno toccato il cuore,
commossi, esaltati, resa più vigile la nostra intelligenza. Questo vale anche
per quei teorici e rivoluzionari che non erano solo uomini di penna, ma anche concreti
uomini d’azione. Chissà quanta gente ogni anno va a Londra per la tomba di
Marx, in Svizzera per quella di Bakunin, a Caprera per Garibaldi e a Genova per
Mazzini.
Luoghi di
nascita, case dove sono vissuti e morti, stanze dove hanno lavorato, e infine i
luoghi che ne hanno accolto le spoglie. Questo culto laico, forse un po’
feticista, comprende la venerazione di “reliquie” come per i martiri e i santi:
libri, penne, occhiali, pipe, lettere, macchine per scrivere, manoscritti, dattiloscritti
e tombe… E questo culto è praticato anche da quanti non credono ad alcuna
trascendenza, e negano che dopo questa vita ve ne sia un’altra.
 |
| C. Nooteboom |
Quella di noi uomini del XXI secolo non ha più nulla in
comune con la visione foscoliana che lo aveva spinto a scrivere “I sepolcri”. La nostra sensibilità si è
formata lontana da quell’aura romantica e patriottica dell’Ottocento. E
tuttavia, una parte minoritaria di noi, continua ad andare per cimiteri alla
ricerca di una tomba davanti a cui sostare, sebbene consapevoli che dentro non
è rimasta che polvere. Perché lo facciamo? La risposta più convincente ce la dà
Cees Nooteboom nelle pagine introduttive del suo prezioso e magnifico libro (Tumbas – Tombe di poeti e pensatori) accompagnate dalle fotografie realizzate
da Simone Sassen: “(…) si va a far visita a dei morti che si conoscono meglio
della maggior parte dei vivi”. Lui è andato dappertutto: dalle Americhe al
Giappone, dall’Africa all’Europa; si è messo sulle loro tracce ed è andato a
scovarli dov’erano o si nascondevano. Spesso vi è ritornato facendo nuove
scoperte, o notando ciò che in una precedente visita gli era sfuggito. È andato
a trovare morti che aveva conosciuto in vita e morti che non aveva mai
incontrato; morti del presente e morti di epoche incommensurabilmente remote,
ma tutti legati, nei modi più diversi, alla sua vita di lettore e di scrittore.
Ecco come ne scrive: “Ho fatto loro visita perché sono parte della mia vita,
perché la mia vita l’hanno accompagnata nei modi più diversi e in diversi
momenti”.
 |
| La copertina del libro |
Viste tutte assieme le foto in bianco e nero di
Simone Sassen, queste tombe compongono una specie di collina di Spoon River,
dove però gli “ospiti” sono tutti illustri e le loro voci non sono affatto
anonime. Si tratta fondamentalmente di poeti e scrittori (anche Nooteboom lo
è), anche se non manca qualche drammaturgo, filosofo o pittore. Le loro tombe
sono diversissime: da quelle più umili e dimesse, a quelle magniloquenti e
sfarzose, a marcare quasi una distinzione anche nel regno dei morti. Il regno
che tutti “livella”, come ha scritto il grande Totò nella sua omonima opera; il
luogo dove la polvere ritorna alla polvere, secondo le parole della “Bibbia”. Il destino dei morti non è
tutto uguale: ci sono morti che riposano nel Famedio (come il nostro Manzoni);
altri nel Pantheon (come il divino Raffaello); altri nella fossa comune (come
Mozart); altre spoglie sono andate addirittura disperse (come quelle del poeta
Giuseppe Parini). Ci sono tombe ben tenute e tombe in completa rovina; tombe accudite
e tombe desolate che mettono tristezza. Forse non bisognerebbe più seppellire
gli artisti nei cimiteri. Forse sarebbe meglio cremarli e custodirne le ceneri
nei luoghi a loro più consoni. I musicisti nei Conservatori (il nostro Verdi
riposa nella Casa dei Musicisti), i pittori nelle Accademie, i drammaturgi nei
Teatri, gli scrittori e i poeti nelle Biblioteche… In fondo sarebbero più a
loro agio e ci guarderebbero, come i ritratti e i busti della sala degli
Spiriti Magni della Biblioteca Ambrosiana, con i loro sguardi benevoli e
severi. Per dirci, come scrive Nooteboom, che le loro voci continuano a
parlarci ogni qual volta prendiamo in mano i loro libri; a leggere ciò che
hanno scritto; a citarne i versi o a discutere il loro pensiero. Perché sono talmente
vivi, che “Parlano anche ai non nati, a
chi non viveva ancora quando hanno scritto quel che hanno scritto”
(Nooteboom), e parleranno anche a quelli che verranno. Ma solo se ne avremo
cura, se sapremo custodire la loro opera. Senza dimenticare mai che la barbarie
è sempre dietro l’angolo e in agguato, e un libro è sempre troppo fragile.
Cees Nooteboom
Tumbas – Tombe di poeti e pensatori
Fotografie di
Simone Sassen
Iperborea, 2015
Pagg. 384 € 20,00
***
LIBRI
IL DOMINUS E ALTRI RACCONTI
di Angelo Gaccione
Chi si occupa del racconto o intende praticarlo
nella scrittura, deve sapere due cose fondamentali: come non deve scrivere e come
deve tenersi a bada per non debordare, dal momento che la quantità di pagine
che ha a disposizione, non è quella del romanzo. Michele Di Palma, che firma “Il dominus e altri racconti” (Tralerighe
ed. 2016, pagg. 112, € 12,50) lo ha imparato, e costruisce le sue narrazioni
attenendosi a questi punti fermi. Se posso permettermi un’irriverenza, dico che
a me “Il dominus”, il racconto che apre la raccolta, piace proprio perché è
rimasto un racconto e non si è dilatato nella misura del romanzo. Come ho più
volte avuto modo di segnalare, ogni racconto è una storia conchiusa, breve ma
conchiusa. È lo squarcio di vita di un personaggio colto in un momento
memorabile, fissato in un’istantanea, e come tale si incide in noi per
rimanervi. Perché quella memorabilità si fissi in noi e vi permanga, deve
essere isolata da un eccesso di eventi, di accadimenti, di contorno, che la
stempera o la confonde. Resta più impressa l’avventura di una magica notte
d’amore rubata, che la ripetizione stanca che si trascina nel tempo e che nulla
più concede all’incanto. E il racconto ben scritto è questo incanto che si
contrappone alla stanca banalità della ripetizione. Potremmo sintetizzare e
dire che il racconto è una notte d’amore; il romanzo un matrimonio con le sue
esaltazioni e le sue cadute. È per questa ragione che il racconto non tollera
cadute, sbavature, e deve mantenersi teso come una corda di violino. Se si
incrina, sia pure in un punto solo, non gli è concesso riscatto. Da parte sua Di
Palma ci sa fare e sa ben condurre il gioco. Ha una buona capacità di
osservazione: “(…) la ragazza ha un
incisivo superiore spaccato, una fenditura obliqua, che lo rende simile a una
piccola ghigliottina”, (“Punti neri, piccoli inestetismi” pagg. 48-50), ma
sa altrettanto bene restituire l’immagine: “La
piccola ghigliottina ha un bagliore minimo, riflette una scintilla di sole”.
“Contiguità” è il racconto che io giudico migliore in assoluto. Qui l’amarezza,
il dolore rattenuto, le parole smozzicate, il non detto, rendono l’atmosfera familiare
carica di umiliazione. Di Palma ha saputo affrontare il confronto fra le due
sorelle e il rapporto della padrona di casa col marito, con profonda
penetrazione psicologica. Sono convinto che questa prima prova editoriale sarà
foriera di positivi sviluppi, giacché l’autore ha buone carte da giocare; forse
gli occorrerà selezionare accuratamente la materia, ma il modo di condurla lo
padroneggia alla perfezione. Per uno come me che al racconto ha dedicato una
mezza vita, la decisione di Tralerighe di tornare a dare voce al racconto
italiano, è davvero una buona notizia. Siamo sempre in attesa che un editore si
assuma questo affascinante difficile compito.
***
LIBRI
LE FIGLIE DEL DIAVOLO
di Angelo Gaccione
Di tutt’altro genere il libro di Bruno Perini “Le figlie del diavolo” (Tralerighe ed.
2016, pagg. 272, € 14,50) pubblicato nella stessa Collana. Segnalato come
thriller per la serie di oscuri e inquietanti omicidi che racchiude, io lo
giudico un romanzo politico-finanziario, perché le trame, gli intrighi e i
crimini, nascono in quel mondo fatto di oscurità, di delirio per il denaro, per
il potere; di intrecci perversi fra ambienti militari dittatoriali e
sanguinari, e speculatori senza scrupoli. La materia qui ha una presenza
cumulativa ed il protagonista, il giornalista di cronaca giudiziaria Tiziano
Donini, un passato di donnaiolo, ma al contempo appassionato di Proust e di
letteratura, si troverà, suo malgrado, a seguire come un segugio in Europa e
fuori (compreso il Cile di Allende e della promettente esperienza del suo governo popular, stroncato dai golpisti di
Pinochet agli ordini della Cia americana), Rebecca Casati, sua seconda moglie,
che a seguito di una rottura unilaterale, comunicata al marito mediante una
telefonata mentre questi si trova a Roma presso la redazione del suo giornale,
abbandona la casa e parte per Venezia per…
Descrivervi la trama di un libro di tal fatta che vi tiene
sospesi fino alla fine perché il suo stesso narratore in prima persona, il
giornalista Donini, ignora la trama completa, ed è alla disperata ricerca delle
varie tessere per ricomporre un ordito che lo liberi da un tremendo sospetto,
sarebbe da parte mia una vigliaccata. Vi basti dire che lo seguirete volentieri
nel suo peregrinare e temerete anche voi per la sua vita, perché volete
giungere con lui alla risoluzione definitiva della faccenda. Perché ora che
avete appreso che ci sono di mezzo torturatori di destra, golpisti, criminali
che si sono rifatti i connotati, disegni di Michelangelo Merisi (il folle e
geniale Caravaggio), omicidi seriali, (per i lettori milanesi accenniamo, en passant, che la loro città è presente
attivamente nei luoghi e nelle atmosfere, dal momento che il protagonista vi
abita e vi è nato, e ha rischiato pure di morirvi, inseguito da un fuoristrada
dalla targa straniera, fin lungo le rive del Naviglio), borghesi senza
scrupoli, non vedete l’ora di saperli assicurati alla giustizia. Bruno Perini è
un virtuoso della penna e questa materia la padroneggia bene, è a suo agio; il
ritmo che imprime alla sua scrittura, la fluidità, la capacità di mescolare
cronaca, storia politica, citazioni di natura artistica, letteraria, luoghi e
loro mitologie, rendono il suo lungo racconto godibile e piacevole.
Paradossalmente, in questo romanzo affollato di personaggi, luoghi e
situazioni, la figura che emerge più vivida è Rebecca Casati, proprio quella
che lo stesso marito crede di conoscere poco, e di cui il lettore ignora quasi
tutto. Forse è vero, come sostenevano i pittori impressionisti, che lo sfumato,
l’allusione, la velatura, vale più di ciò che l’occhio vede nella sua nitida,
spalancata evidenza.
***
LIBRI
LAURA VOLANTE CONVERSA CON LORENZO SPURIO
In occasione dell’uscita della sua vasta
antologia sui poeti marchigiani
 |
| Lorenzo Spurio |
Da dove nasce l’idea di raccogliere in due volumi poesie
di poeti marchigiani, rispettivamente in lingua italiana e in dialetto?
L’idea
è nata alcuni anni fa quando, ricercando in biblioteca alcune informazioni su
un poeta fermano, mi sono imbattuto nell’Antologia
di poeti marchigiani curata dal poeta maceratese Guido Garufi pubblicata
dai tipi del Lavoro Editoriale di Ancona nel 1998. Oltre a trovare le
informazioni del poeta che andavo cercando, sono stato affascinato dal
caleidoscopio di esperienze poetiche che avevano contraddistinto la Regione e sono
stato incuriosito da numerosi poeti la cui attività culturale era in atto. Tra
di essi alcuni li avevo conosciuti di persona, altri li avevo sentiti nominare,
altri li avrei conosciuti in seguito ed altri ancora -come sempre accade- non
li avevo mai sentiti né li avrei ritrovati nei miei studi successivi.
L’antologia di Garufi mi ha in un certo senso dato l’input a questo mio grande lavoro, mi ha fatto, cioè, ragionare su
quanto siano importanti operazioni editoriali come queste se ben condotte e
iscritte all’interno di un determinato progetto culturale. Nello stesso periodo
in cui nasceva l’idea di portare avanti un lavoro in parte analogo in parte
innovativo a quello di Garufi (ultima raccolta antologica dei poeti marchigiani
seria e puntuale) avevo curato altre antologie poetiche, alcune frutto dei
concorsi letterari che mi avevano visto nella Giuria e di altre iniziative, forte
della convinzione che le opere collettanee, se ben organizzate attorno a una
data realtà, possono essere il genere letterario più interessante e in linea
con i tempi poiché permettono la fruizione di una conoscenza ampia e corale,
condivisa ed empatica grazie a una compartecipazione convinta degli autori e
una polifonia allargata di voci.
Quale è la motivazione che ti ha spinto a produrre
un volume che raccoglie poeti dialettali?
Se
ci pensiamo bene il dialetto è la naturale lingua madre di ciascuno di noi,
quella che i linguisti definiscono, appunto, L1. Il fatto che molte persone non
lo utilizzino non significa che non ne conoscano quello della loro rispettiva
area geografica o che non appartengano a una determinata isoglossa.
Semplicemente il fatto di non impiegare il dialetto nella lingua di tutti i
giorni è dovuto a due ragioni: la prima è che l’impiego del dialetto nella
nostra società non faciliterebbe tutti quegli scambi comunicativi tra persone
di luoghi e regioni diverse, ed il secondo è che l’impiego del dialetto espone
il parlante a un giudizio spesso di tipo negativo, pregiudiziale e viziato
perché il dialetto è visto come una lingua rozza, troppo colorita tanto da
apparire volgare e dunque mostrarsi indelicata e inappropriata in tutti gli usi
della lingua che oggi è dato alla lingua nazionale, standardizzata, sebbene
alla mercé di una serie di ingerenze dell’inglese. Chi studia la letteratura ed
osserva con interesse le variazioni che si producono a livello sociale in un
dato arco storico non può fare a meno di considerare anche quel mondo, non
standardizzato né ufficiale, rappresentato dalla società subalterna, dal mondo
di provincia, dai reconditi luoghi che non rispondono a una centralità e dunque
alla cultura popolare, alla dimensione demoetnoantropologica di un popolo.
Essendo il dialetto un sistema linguistico-comunicativo, cioè un codice
impiegato per veicolare concetti, allora la giusta attenzione va posta nei
confronti di tutti quegli esponenti, poeti di natura o vernacolieri, che
l’hanno impiegato nel comporre poesia. Non credo, infatti, nella subalternità
del dialetto rispetto alla lingua all’interno del discorso poetico. Questo
significherebbe non capire la grandezza di geni quali Pasolini, Franco Loi,
Franco Scataglini (incluso in antologia, per l’appunto), poeti che hanno
arricchito notevolmente le pagine della storia della letteratura italiana.
Lingua e dialetto in poesia possono essere impiegati in maniera uguale dal
poeta o chi se ne serve per raggiungere un proprio obiettivo ben tenendo
presente che il dialetto può prestarsi maggiormente alla trattazione di un
mondo andato, di ritualità della provincia o di scene di vita popolare nonché
più scanzonate e divertenti fermo restando, però, che il dialetto non è sempre
comico o frivolo ma può essere il codice di chi tratta, proprio come chi scrive
in lingua, di tematiche più alte e sofisticate, impegnative o che implichino,
ad esempio, un monito etico-civile.
Naturalmente hai dovuto fare una ricerca accurata e
ti chiedo in base a quali criteri hai operato una selezione sia per i poeti in
lingua che in dialetto?
Data
la vastità dell’opera si potrebbe pensare che i tanti poeti siano stati
inseriti o, come si dice in gergo antologizzati, sulla base di nessun parametro
selettivo. Non è così. Nella nota critica introduttiva al testo, infatti,
specifico quale è stato il procedimento adottato per l’individuazione delle
voci poetiche da tenere in considerazione per il mio lavoro. Rifuggendo in
maniera voluta un approccio ipersofisticato e dunque iperselettivo, volto
cioè a dar voce alle solite e poche espressioni
poetiche di cui in molti si sono già occupati, il mio desiderio è stato quello
di guardare con interesse al gruppo umano dei poeti della nostra Regione nella
loro interezza senza considerare un poeta maggiore all’altro per aver
pubblicato nel corso della sua attività più opere o vinto più premi. I due
parametri che ho osservato per l’inserzione dei poeti nel testo sono stati: 1) l’essere marchigiano (nativo della
nostra Regione o vivere qui da vari anni o, ancora, aver maturato nel corso del
tempo un particolare legame d’unione e d’amore con il nostro territorio) e 2) aver pubblicato nel corso della sua
attività almeno una silloge, un’opera organica. Questo -come chiarito nella
introduzione- non perché chi scrive poesia da decenni e non ha mai pubblicato
nulla non sia un poeta, semplicemente ho voluto inserire coloro la cui attività
poetica è riscontrabile, documentabile e consultabile attraverso materiale
bibliotecario, testi a stampa diffusi da case editrici, pubblicati da
tipografie o in proprio, volumi antologici e opere omnia commemorative di
autori deceduti di cui si è tributato il ricordo.
 |
| La copertina dell'antologia |
Questa Antologia in due volumi, ideata e curata da
te, presenta alcune note critiche personali di inquadramento letterario,
storico, territoriale e psicologico degli autori?
A
ciascun autore è stato dedicato lo stesso spazio con la pubblicazione di una
nota bio-bibliografica nella quale si dà nozioni in merito alla attività
letteraria degli stessi (pubblicazioni di testi di poesia, narrativa,
saggistica, collaborazioni a riviste, antologie, associazioni, premi vinti,
etc.) e di tre poesie da me scelte (nel caso del dialetto con relativa
traduzione in italiano). Ho reputato che non avrebbe avuto grande senso
inserire un mio commento critico su ogni autore basandomi sull’analisi delle
sole tre poesie scelte e selezionate perché sarebbe stato assai riduttivo e
semplicistico dare un commento su pochi testi senza tenere in conto l’intera
opera dell’autore, la complessità della sua figura, le tematiche ricorrenti, la
sensibilità, le preferenze stilistiche, etc. Ho voluto che la mia opera
parlasse direttamente al lettore mediante le tante voci dei poeti inseriti
senza un mio commento critico a corredo per ciascuna esperienza volto a
spiegare o approfondire alcuni aspetti delle loro opere. Non ho voluto creare
filtri tra i poeti e gli ipotizzabili lettori né dettare in qualche modo le
interpretazioni, sviscerare in maniera tecnica e forse asettica i linguaggi e
ispezionare i componimenti nella loro creatività e genuinità.
Il titolo dell’antologia “Convivio in versi-Mappatura democratica della
poesia marchigiana” induce alla
riflessione: perché Convivio? Cosa intendi per mappatura democratica?
Con
la parola “convivio” ho inteso riferirmi a una sorta di cenacolo allargato,
aperto a voci poetiche diverse per periodo storico, estrazione, mestiere e
quant’altro. Un momento di convivialità e dunque di partecipazione e
condivisione tra tutti coloro che non hanno mancato di dare la loro adesione
convinta a questo progetto editoriale. Convivio, dunque, nel senso di incontro
e dialogo tra i vari poeti, una sorta di incrocio di esperienze, una
stratificazione di percorsi poetici e letterari, dove è possibile indagare
l’autenticità di ciascuno pur riscontrando riflessi e rimandi ad epoche, fasi
letterarie, modelli di riferimento. Un simposio dove ciascuno ha il suo
legittimo turno alla parola, per dire la sua e manifestare la propria presenza.
Una contaminazione di forme, stili, codici espressivi che si imbeve in una
multiforme varietà di tematiche investigate. Tale “mappatura”, tale analisi
sistematica da caratterizzarsi quasi come un vero censimento poetico, è “democratica”
nel senso che, come si diceva in una precedente domanda, non sottende a una
selezione ipersofisticata frutto di un approccio in qualche modo
discriminatorio e viziato. L’idea di questo progetto è proprio quella di aver
voluto creare un simposio assai ampio perché variegato nelle forme e nei
contenuti, e, ancor più, nella diversa popolarità e successo dei vari poeti. A
ciascuno di essi è riservato lo stesso spazio in termini di liriche riportate
e, allegoricamente, il medesimo tempo di lettura in un ipotetico simposio concreto,
un assise di poeti oranti.
Tu non solo sei un giovane poeta con riconoscimenti
prestigiosi, ma anche affermato critico letterario, per cui domando se secondo
te la poesia ha ancora voce e rispondenza nello scenario culturale in cui
emergono ignoranza materialismo consumismo, corruzione ecc…
La
domanda è bella ed estesa, addirittura complicata per poter abbozzare in
maniera sintetica una risposta. Trovo che oggigiorno la poesia sia diventata il
mezzo di comunicazione, nell’arte letteraria, di un grande numero di persone,
acculturate o meno, che se ne servono con le più disparate intenzioni o
finalità. Chi la impiega per dar sfogo a un universo personale magari difficile
o particolarmente incline a una emozionalità da vivere nel privato, chi se ne
serve per imprimere momenti con la consapevolezza che col passare del tempo
potranno essere eternati. Chi, ancora, la adopera per farne il mezzo per
trasmettere un messaggio d’amore, sia esso diretto alla propria donna o intriso
di un profondo attaccamento alla Natura o a Dio. C’è un’altra ampia fetta della
poesia, quella che ricade all’interno di una categoria che potremmo definire
etico-civile, che si pone in maniera molto lucida i quesiti di natura
esistenziale quali problematiche o disagi che l’uomo vive in quanto parte di
una comunità. Poesie che denunciano uno stato di vergogna o danno sfogo
all’odio, che recriminano e misurano lo sdegno dinanzi a calamità o aberrazioni
dell’uomo. Trovo che in questa ultima compagine della poesia, nei casi in cui
venga fatta con cognizione di causa e l’impegno civile del poeta non si
esaurisca sulla carta, sia possibile vedere il vero senso della poesia nella
nostra società che, come giustamente osservi, è dominata dal malaffare e da un
sentimento d’odio. In via generale la poesia è un procedimento automatico che
partendo dall’inconscio permette di far risaltare la complessità umana, essa è
una rivelazione che investe prima il sé e poi un ipotetico destinatario. Come
osservava Mario Luzi in una intervista, però, il compito del poeta è anche
quello di “rivelare le cose che accadono”. Sia i sommovimenti emotivi, ciò che
impulsivamente accade nel nostro cerebro e nella sfera dei nostri sentimenti,
sia ciò che, spesso più rumorosamente, accade fuori di noi, nella società che
ci circonda. Al poeta della contemporaneità non è consentito -secondo il mio
punto di vista- cantare o struggersi per i propri drammi personali percependosi
come una monade, ma il pensiero della sua esistenza può avvenire solamente in
concomitanza a un interesse di carattere sociale. Il poeta, da cantore di un
umano sentire, pur con i soli mezzi della creatività e dell’evocazione, è in
grado (e deve esserlo) di fare della quotidianità concreta e del sentimento
sociale un punto di partenza. Se la poesia non serve a risolvere problemi o a
sanare conflitti, la parola -che è arma suprema dei deboli- è l’unico
ingrediente che possa avvicinare persone. Alla poesia deve esser riconosciuto
allora la potenzialità di far conoscere genti e, immancabilmente, comprendere
meglio se stessi.
***
LIBRI
TOMB’S TONE
di Michele Farina
 |
| La copertina del libro |
Non è scorretto parlare di “Tumbas. Tombe di poeti e
pensatori” di Cees Noteboom come di un libro di culto, nel senso più
sacrale del termine. Il volume dello scrittore olandese, uscito per Iperborea
lo scorso novembre e tradotto in italiano da Fulvio Ferrari, gode del fascino
irripetibile degli esemplari unici, perché di esemplari unici è composto.
Accompagnato dalle fotografie di Simone Sassen, il libro si presenta come la
raccolta dei pellegrinaggi di una vita compiuti dall’autore sulle tracce delle
tombe degli autori prediletti, le quali diventano luogo e occasione di parola e
riflessione. Se basta scorrere l’indice del volume per subire l’aura delle
personalità sepolte fra le pagine, è necessario immergersi nella lettura
(lineare o antologica non importa) per apprezzare la delicata personalità di
Noteboom. Egli è presenza continua e mai intrusiva, capace di amplificare un
dialogo ininterrotto e di farne partecipe il lettore, sapendo bene quando
intervenire e quando fare un passo indietro, lasciando parlare direttamente i
suoi autori. Orchestrare queste voci sarebbe impresa già ardua, ma farne
suonare i silenzi richiede una straordinaria sensibilità. La morte, o meglio
l’eternità, combina e ridisegna le mappe dei destini, creando accostamenti che
la vita mai avrebbe saputo divinare: Iosif Brodskij ed Ezra Pound sepolti
insieme a Venezia, Elias Canetti e James Joyce a Zurigo. Risulta peraltro
notevole la scelta di allegare al volume una selezione di testi poetici in
lingua originale, che ne enfatizzano l’istanza liturgica e celebrativa:
leggerli, magari ad alta voce, significa attivare circuiti che eludono confini
cronologici e geografici, creando una comunione permanente con quella
«gigantesca minoranza» costituita dai cultori della parola poetica. Gli autori
attraverso di noi diventano perpetui perché perpetuati, rendendo la poesia una
religione senza aldilà e con decine, centinaia di libri sacri. È l’ambiguità
intrinseca di queste corrispondenze la causa di atti paradossali quali
l’affidare lettere alla casella posta sulla tomba di Antonio Machado o
l’omaggiare sigarette e boccette di profumo al sepolcro di Charles Baudelaire.
L’immagine della bottiglia di assenzio accostata al nome di Julio Cortàzar
inciso sul marmo, che campeggia in copertina, si fa emblema di uno scambio che
le soglie biologiche non sanno interrompere: abbiamo ancora domande da porre a
questi morti, qualcosa da condividere. Le fotografie in bianco e nero escludono
ogni cosa che non sia sepolcro, non concedono allo sguardo nessun volto che non
sia scultura: una scelta di sobrietà cromatica che ben si intona con la
dimensione della pagina scritta, come se l’unica realtà possibile fosse quella
prodotta dai caratteri tipografici impressi sul foglio bianco. Semmai sta al
lettore colorare il proprio viaggio aiutandosi con l’eco della memoria dei
libri letti. Tumbas incanala
l’energia di tutta questa materia diventando esso stesso feticcio, un crocevia
di voci che abbatte le differenze tra tombstone
e milestone. Come in Le bave del diavolo di Cortàzar,
Noteboom gioca la sua partita con i poeti, utilizzando strumenti che sfuggono
alle pupille: «L’essenziale resta invisibile. Il segreto si nasconde nelle
lettere che nessuno leggerà. Una balena a New York, un cacciatore delle Alpi ad
Anversa, l’inferno a Ravenna, una chitarra azzurra ad Hartford, Connecticut, la
collina dell’infinito a Napoli: il lettore vede sulla tomba del suo poeta
quello che non vede nessun altro».
Cees Noteboom
Tumbas. Tombe di poeti
e pensatori
Iperborea,
2015
Pagg.
375 € 20,00
***
SPECIALE PASOLINI
In occasione della
presentazione del numero monografico della rivista “Capoverso” interamente
dedicato a Pier Paolo Pasolini il 26 gennaio 2016 alla Casa della Cultura di
Milano, Franco Dionesalvi, Fulvio Papi e Giovanni Bianchi hanno presentato tre
nuove riflessioni inedite, che “Odissea” offre in lettura ai suoi lettori nella
Rubrica “Officina”. Le foto, dello 'ALBUM' che
registrano l’evento, sono state scattate da Giuseppe Denti, Giovanni Bonomo,
Mario Buonofiglio. Quella in cui sono ritratti Fulvio Papi, Angelo Gaccione,
Renato Seregni, è stata scattata da
Alessandro Zaccuri.
 |
| 1 - La porta rossa della "Casa della Cultura |
INTERVENTO SU PASOLINI
di Franco Dionesalvi
 |
| 2 - Franco Dionesalvi |
Grazie per avermi invitato, sono lieto di essere qua a
parlare di Pierpaolo Pasolini, a partire dal numero speciale della rivista “Capoverso”
che gli abbiamo dedicato.
Sono
quarant’anni che abbiamo perso Pasolini. “Lascia un vuoto incolmabile”, si dice
abitualmente degli scomparsi, ed è una frase spesso un po’ bugiarda. Ma in
questo caso è vero: Pasolini non è stato sostituito da nessuno, probabilmente non
era possibile. Con lui se n’è andato un modo diverso di intendere e praticare
il ruolo dell’intellettuale: non un professionista dell’editoria o delle
lettere, ma un “sacerdote”, una persona che si vota all’elaborazione teorica,
alla percezione del “senso”, e a queste informa tutte le scelte della sua vita.
Inseguendo una idea di coerenza assoluta, e sposando quelle scelte costi quel
che costi, fino alle estreme conseguenze. Pagando, se necessario, anche con la
vita. Di gente così, in Italia, non ce n’è più stata. E ci mancano, infatti,
interpreti del nostro tempo capaci davvero di farci cogliere quel che lo
sguardo superficiale non vede, di aprirci gli occhi a una comprensione più profonda e più lucida
della realtà.
Inimitabile,
Pasolini.
Intanto
perché il suo anticonformismo, la sua singolarità spiazza e disorienta ancora
oggi, e dunque rende impossibile il pur praticato mestiere dell’imitatore. Poi
perché è difficile trovare persone, come lui, pronte a sacrificarsi, in un
tempo in cui tutto si misura in denaro e ogni azione è preceduta dal calcolo
degli interessi e delle convenienze. Così difficile imitarlo, e anche così
arduo capirlo, l’autore degli “Scritti
corsari”; al punto che lo si cita spesso a sproposito. Come quando si ricorda
la sua difesa del poliziotto, e non si capisce che dietro non c’era un richiamo
alla disciplina, ma l’invito a guardare con occhi liberi, senza preconcetti,
per cogliere la complessità del reale e non soltanto quello che la nostra
ideologia ci porta a vedere.
Pierpaolo
Pasolini denunciava la progressiva e ineluttabile perdita di quelle che
riconosceva come le caratteristiche più autentiche e impagabili della natura
umana. Diceva, più di quarant’anni fa, che l’ “edonismo consumista” ci aveva
catturato, tutti, e ci divorava dall’interno, facendoci perdere l’immediatezza,
la naturalezza, la poesia. E che il “nuovo fascismo”, il “potere senza volto”,
era peggiore dei precedenti, ed era quello della televisione,
dell’omologazione, del conformismo: subdolo e insinuante, impediva la
contrapposizione frontale e dunque era destinato ad annientarci senza mai
mostrarsi. Poi andava in cerca di quanto ancora restava dell’autenticità umana,
che inseguiva nei sud del mondo, nell’Italia meridionale prima, in Africa poi.
Ma sentiva la macchina del potere consumista, ineluttabile, arrivare,
trasformare tutto in merce. Intanto gli altri poeti, gli altri cineasti, gli
altri intellettuali discettavano e discettano di forme e di sfumature, di premi
e di cordate.
Persino
la sua morte, ancora per certi versi misteriosa e inestricabile, appare come
una ulteriore, disperata denuncia, come il sacrificio d’amore del più
tormentato e cupo fra i “santi”.
Quando
Pasolini morì, io avevo diciannove anni e da pochi mesi ero diventato direttore
di un Centro Servizi Culturali, a Cosenza. Feci un comunicato in cui esaltavo
la sua figura e il suo “insegnamento”. I responsabili di quella struttura mi
dissero che quel comunicato non poteva andare, perché Pasolini era un
corruttore di giovani. Per protesta mi dimisi. Di lavori ne avrei lasciato
diversi, poi, nel corso della mia vita. Ma quel mio piccolo omaggio indica che
un uomo così è entrato, intimamente, nella vita di tanti di noi.
Era
il 2 novembre quando, in uno spiazzo polveroso all’Idroscalo di Ostia,
trovarono ucciso Pierpaolo Pasolini. Il poeta della “disperata vitalità” venne
trovato morto proprio nella periferia suburbana in cui aveva ambientato i suoi
romanzi, “Ragazzi di vita”, “Una vita violenta”, “Petrolio”. E accadde nella notte fra la festa di
Ognissanti e la ricorrenza di tutti i morti, come in fondo era giusto perché
lungo quella linea di confine fra il bianco e il nero, fra il bene e il male,
fra il santo e il dannato egli aveva vissuto, consumato e immolato tutta la sua
esistenza.
Pasolini,
è risaputo, era omosessuale. Aveva sopportato questa sua condizione in un tempo
in cui non veniva affatto accettata, ma consegnata alla dimensione delle
tenebre e dell’inconfessabile. Peraltro la sua intensa, sebbene non dogmatica,
religiosità, e il suo forte senso morale, lo costringevano a misurarsi
incessantemente con la condizione della colpa, con l’auto-condanna della
purezza perduta. E aveva subìto i processi, per il suo “peccato”. Era stato
scacciato dal partito comunista. Era stato espulso dal corpo insegnante. Aveva
visto censurati e condannati i suoi film. Ciò nondimeno la sera Pasolini andava
a caccia dei suoi corpi di ragazzo e dei suoi impossibili amori, tiranneggiato
da un’idea forte e febbrile di bellezza che doveva incessantemente inseguire,
pur sapendo che per lui era inattingibile, che poteva solo scottarlo,
ricacciarlo indietro nello stesso istante in cui si illudeva di raggiungerla e
possederla. Questo gioco perverso lo induceva in quelle notti a scorrazzare per
le periferie della metropoli, lungo le borgate, fino in fondo alla strada, fino
alle baracche, fino al mare. Di più, davvero, non possiamo sapere. Una cortina
di mistero ha coperto e portato via per sempre uno dei pochi grandi artisti che
l’Italia abbia annoverato nel secondo Novecento. Alcuni hanno sostenuto che
dietro l’omicidio ci fosse un movente politico, che il contesto erotico
servisse solo a coprire la longa manus di un potere clerico-fascista. Altri
hanno posto l’accento sul senso simbolico di questo delitto, su come egli
l’avesse prefigurato e profetizzato; vi hanno letto insomma il compimento di
una vita che è tutta una poesia, straziante e crudele, anticonformista e vera.
A
questa vicenda abbiamo dedicato il numero dell’autunno 2015 di “Capoverso”.
Provando, con l’aiuto di numerosi contributi che spaziano in diversi campi e
diverse prospettive, a indagare ancora su quanto Pierpaolo Pasolini ha lasciato
di sé, del suo pensiero, della sua percezione dell’incanto della vita.
***
NOTE INTORNO A PASOLINI
di Fulvio Papi
 |
| 3 - "Capoverso" |
Non sono la
persona più adatta per parlare dell’opera di Pasolini. Non conosco che
pressappoco la sua opera cinematografica. Anche se sono certo che il cambio di
genere dalla letteratura al cinema ha certamente un senso importante. Le mie
letture sono lontane e non sono mai state degli studi. Dalle “Ceneri di
Gramsci” si possono leggere questi versi:
“Ma io, con il
cuore cosciente
di chi soltanto
nella storia ha vita,
potrò mai più con
pura passione operare,
se so che la nostra
storia è finita?”
Non sono versi di evidente interpretazione. Si dovrebbe
sostare sul senso di ogni parola. Tuttavia vediamo.
La nostra storia è il rapporto con
quello che a Pasolini appare il senso dell’opera di Gramsci. Gramsci è uno storicista
per cui la sola vita sensata è quella che prende la forma di storia. Il suo
storicismo viene dallo storicismo di Marx e quindi richiede l’uso di categorie
che appartengono al pensiero astratto come classe, lotta di classe,
partito-principe, intellettuale organico. Esse appartengono a Gramsci con
assoluta certezza etica. Ora è proprio con questo mondo intellettuale e
politico che Pasolini sa che la sua vicenda è “terminata”. La parola
“terminata” è autobiografica: indica la vicenda che ebbe inizio con
l’iscrizione al Pci e non tanto con la bigotta espulsione, quando con la verità
di se stesso che Pasolini porta in primo piano. Una verità che non è mai stata
la riduzione della vita a storia. No all’egemonia del pensiero teorico, ai
custodi di questa prassi intellettuale, alla partecipazione totale a questa
trasfigurazione del mondo. E qui occorre leggere “vita” e capire il suo senso.
Sono le poesie friulane che danno accesso al significato di vita, le famose
poesie elogiate da Contini come letteratura. Ma qui sono capite come segni di
una verità dell’esistenza.
Poiché non sono capace di fare meglio, leggo la prosa di
Carlo Cipparrone a pagina 40 di “Capoverso”. - Mistica e sensuale insieme, come generalmente è tutta la poesia
pasoliniana, quella dialettale è un inno alla purezza d’animo della società
contadina, alla sua cristiana religiosità, alla naturale bellezza del paesaggio
friulano, con i suoi innevati profili montani, le lussureggianti vallate echeggianti “il triste tremolare dei
grilli”, gli incontaminati corsi d’acqua,
le fontane di “rustico amore”, il
“canto delle campane”, i paesi dal
“colore smarrito”, siti ideali per una
vita semplice e tranquilla di gente umile e laboriosa. In questa naturale
cornice, surreale e quasi fiabesca, emergono dai versi di rara musicalità i
temi che saranno ricorrenti anche nella successiva poesia in lingua, quali la
figura dominante della madre, a cui l’autore era legato da un amore struggente, e il ricordo del fratello Guido,
ucciso in un conflitto intestino tra partigiani delle brigate “Osoppo” e
“Garibaldi”-
Questo insieme ambientale e morale è l’identità mitica
che il giovanissimo Pasolini costruisce di se stesso. La madre ha il ruolo
della sintesi affettiva. La morte del fratello è un segno della storia che comunque
vissuta, porta sempre con sé il segno della morte. Come ogni identità mitica
porta con sé la visione di una perdita, nella tradizione del paradiso perduto,
del tempo irreversibile. Se Pasolini dopo il ’49 non fosse stato un uomo forte,
alla ricerca di una realizzazione della propria energia vitale e intellettuale,
pur restando fedele al suo nucleo mitico, con una sua trasfigurazione, non
avremmo mai avuto il grande intellettuale che egli è. Segnato da una
irriducibile individualità che, anche a dispetto di ogni successo mondano,
resta una solitudine di sé con se stesso. Proviamo a rovesciare la scena:
Gramsci che vede Pasolini. Teniamo presente la storia degli intellettuali di
Gramsci. Pasolini sarebbe stato un caso marginale. Basta considerare la concezione
della lingua.
La dimensione mitemica originaria segna ovviamente la
strada del divenire di Pasolini autore (da augere, aumentare). Aumentare che
cosa? Il possibile senso del proprio tesoro mitemico. Per quel poco che so io,
tre mi paiono le sue trasfigurazioni:
1. una
concezione poetico-letteraria
2. una visione
socio-politica
3. una
concezione vitale e religiosa.
Per approfondire i tre temi ci vorrebbe un tempo che non
ho.
La poetica
letteraria si vede molto bene attraverso l’analisi di Saverio Bafaro di “Ragazzi di vita”. La vita dei ragazzi
(non adulti), la cintura delle borgate, il dialetto in forma realistica (tutto
il contrario di Gadda), la dimensione naturale, il senso di un’epoca che muore.
La visione
socio-politica è perfettamente visibile nel celebre scritto sugli scontri
di Villa Giulia tra universitari e polizia. E non è solo la questione di ricchi
e poveri. Ma più o meno sotterraneamente c’è la questione di una appropriazione
indebita di un lessico. Gli universitari usano un idioletto che appartiene alla
tradizione e alla vita della classe operaia e comunque alle sue
rappresentazioni storiche. Ne deriva una falsificazione storica, una
appropriazione giustificativa della propria realtà, modesta volontà di potenza
(anche comprensibile) intorno ai propri fini. Il tutto in un linguaggio che è
un falso storico. Si vede infatti come è andata a finire. I ricchi sono rimasti
ricchi e i poveri, poveri.
Infine il tema dell’aborto: Pasolini vi vedeva un trionfo
della individualità, del dominio intellettuale, individualistico, artificiale
del corpo, l’affermazione di un privilegio sociale in una vicenda naturale. Più
simile a un lusso che a un diritto civile.
A me non interessa discutere come verità le tre
prospettive. Mi è interessato di più cercare di mostrare come esse derivino
come trasformazioni intellettuali di una lontana identità mitica (un “segreto”
forse avrebbe detto Jung). Tutto questo è molto poco, ma spero un approccio non
futile.
(Casa della Cultura, Milano, 26 Gennaio 2016)
***
Rileggere
Pier Paolo Pasolini
di
Giovanni Bianchi
 |
| 4 - "Capoverso" alla "Casa della Cultura" |
Oltre il dilemma
Avevo letto le pagine, le pellicole e
l’esistenza stessa di Pier Paolo Pasolini come improntate all’autobiografismo
storico. Perché proprio il corpo a corpo con un’ostinata storicità mi era parsa
la cifra del grande scrittore. Ma come sempre muovendomi tra i Se e i Ma che lo
spirito del tempo sembra aborrire (e che invece considero segno di saggezza),
avevo successivamente revocato in dubbio quella definizione che mi era stata
suggerita dalla insistita frequentazione di Clemente Rebora, il grande milanese
che sta in cima alle mie preferenze nella poesia moderna. Insomma il dubbio era
che mi fossi lasciato andare a un effetto di trascinamento, come chi muove sul
desktop con il mouse un’icona verso l’altra. Le differenze tra i due erano
evidentemente palesi, proprio perché tutto metropolitano, nella prima
produzione poetica, è Rebora, mentre Pasolini è uomo delle periferie, quelle al
confine della patria con il territorio friulano, e poi le borgate romane,
popolate da gente assai poco o mal agghindata, risalita nella capitale dalle campagne
del Mezzogiorno.
Il
dubbio era dunque consistente, ma presto fugato, non tanto da una rivisitazione
delle liriche pasoliniane, ma da una rilettura delle Lettere Luterane. È quindi bastato il primo capitolo del testo
pubblicato nell’agosto 1991 da l’Unità-Einaudi a riconfermarmi nella scelta
dell’autobiografismo storico di PPP. La poliedricità di Pasolini si è cimentata
in tutte le forme possibili del linguaggio, ma questa versatilità onnivora non
ha disperso o diluito il senso delle parole forti che costituiscono insieme la
chiarezza e la costante provocazione del lessico pasoliniano.
Le Lettere luterane
Fin
dal titolo il primo capitolo della raccolta dice una presa di posizione
ostinatamente controcorrente: I giovani
infelici. Si potranno anche sospettare le pulsioni della particolare
sessualità di PPP; resta il fatto che la sua lettura del giovanilismo è da
subito chiara ed oppositoria. Pasolini non si concede nessun sociologismo, anzi
affonda esplicitamente la propria analisi nella classicità dei greci. Una
posizione che non solo lo mette fuori dal coro dei modernisti, ma lo espone
coscientemente allo “scandalo dei pedanti” e al loro strepitante ricatto. Chi
sono i giovani che Pasolini legge?
“Nei
casi né migliori né peggiori (sono milioni) essi non hanno espressione alcuna:
sono l’ambiguità fatta carne… Essi non hanno nessuna luce negli occhi: i
lineamenti sono lineamenti contraffatti
di automi, senza che niente di personale li caratterizzi da dentro. La
stereotipia li rende infidi. Il loro silenzio può precedere una trepida domanda
di aiuto (che aiuto?) o può precedere una coltellata. Essi non hanno più la
padronanza dei loro atti, si direbbe dei loro muscoli. Non sanno bene qual è la
distanza tra causa ed effetto. Sono regrediti -sotto l’aspetto esteriore di una
maggiore educazione scolastica e di una migliore condizione di vita- a una
rozzezza primitiva… hanno assimilato il degradante italiano medio… Non sanno
sorridere o ridere. Sanno solo ghignare o sghignazzare”.
C’è
quasi del Lombroso in questo ritratto… Non solo un andare in senso
ostinatamente contrario, che fu caratteristica di De André, ma anche una voglia
di provocare e non prendere requie. E che rimanda ad altre prese di posizione
pasoliniane contro questi giovani.
Dopo
gli scontri di Valle Giulia, quando prese le parti dei poliziotti contro i
figli di papà che li attaccavano dicendosi rivoluzionari. Dopo il rientro da
Praga. In effetti quel che Pasolini non sopporta nelle nuove generazioni è di
prendere falsamente a prestito il lessico degli altri, in particolare degli
operai, che cercavano un riscatto pensando che fosse la rivoluzione
sessantottina.
È
questa falsità che lo spinge a condannare e fustigare una generazione, non in
sé, ma perché è prodotta da quello che veniva chiamato “il Sistema” e che
rappresentava la sconfitta acquiescente della generazione dei padri.
Una malattia ricorrente
Pasolini
sa che il giovanilismo è una malattia ricorrente nella storia e nella politica
del Bel Paese. Funzionò anche ai primordi del fascismo, traendo in inganno lo
stesso Benedetto Croce, che vide le esercitazioni muscolari dei gestori del
manganello come una sorta di acne giovanile che lo scorrere degli anni e la
maturità avrebbero provveduto a temperare.
Non
andò così. Il giovanilismo mena fuori strada perché attribuisce a un desiderio e
a una baldanza soggettiva quel che è invece indotto da fuori, nelle coscienze e
nella vita quotidiana, dal sistema della produzione. Perché?
Pasolini
è esplicito anche questa volta nelle espressioni del suo autobiografismo
storico: “Oggi tutto è cambiato: quando parliamo di padri e di figli, se per
padri continuiamo sempre a intendere i padri borghesi, per figli intendiamo sia i figli borghesi che i figli proletari.
Il quadro apocalittico, che io ho abbozzato qui sopra, dei figli, comprende borghesia
e popolo. Le due storie si sono dunque unite: ed è la prima volta che ciò
succede nella storia dell’uomo. Tale unificazione è avvenuta sotto il segno e
per volontà della civiltà dei consumi: dello “sviluppo”. Non si può dire che
gli antifascisti in genere e in particolare i comunisti, si siano veramente
opposti a una simile unificazione, il cui carattere è totalitario -per la prima
volta veramente totalitario- anche se la sua repressività non è arcaicamente
poliziesca (e se mai ricorre a una falsa permissività). La colpa dei padri
dunque non è solo la violenza del potere, il fascismo. Ma essa è anche: primo,
la rimozione della coscienza, da parte di noi antifascisti, del vecchio
fascismo, l’esserci comodamente liberati della nostra profonda intimità…; secondo, e soprattutto,
l’accettazione -tanto più colpevole quanto più inconsapevole- della violenza
degradante e dei veri, immensi genocidi del nuovo fascismo”.
Il registro apocalittico
La
storia d’Italia di PPP non è dunque in vena di sconti ai progressisti, ed è
tutt’altro che lontana dall’uso esplicito di materiali apocalittici. Se oltre
al disincanto e alla disperazione un barlume di luce può apparire all’orizzonte
è certamente quello di una difficile speranza e non quello di un facile
ottimismo. L’ottimismo non è categoria storica, ma psicologica: più adatta alla
falsità delle pubblicità che al tormento di chi vuole costruire futuri.
È
sparito il popolo dei contadini ed è pure sparito quello degli operai proletari
e comunisti. Questa volta non è tanto Pasolini a fare l’affermazione, quanto il
filosofo fondatore dell’operaismo italiano: Mario Tronti ci ha ripetuto più
volte negli ultimi anni che se non ce l’hanno fatta loro -gli operai comunisti-
non c’è speranza che altri vi riescano.
Una
tragica elegia, che ripete letterariamente con Gogol che alla stazione di posta
della storia non ci sono cavalli sufficienti per la Rivoluzione. Non a caso
Pasolini militava insieme la letteratura e la politica, ed ha finito per
impersonare in un’epoca di transizione insieme confusa e convulsa (anche questo
è la transizione infinita) la figura
inedita e subito scomparsa dell’intellettuale “disorganico”. Anche per questo profetico e tragico friulano non
c’erano mai cavalli sufficienti alla stazione di posta.
Poesia civile
Di
questi eventi e di questi umori si nutre la sua poesia totalmente civile. Come
a dar conto dal suo versante al Gramsci -citato da Fulvio Papi- che ripete che
la sola vita sensata è quella che prende forma di storia. Un Pasolini non
addolcito dalla lontananza e sempre in grado di provocare perché insieme
rivoluzionario e antimoderno. E infatti quando deve scrivere la lunghissima
lirica in memoria delle vittime di Piazza Fontana prende a prestito i materiali
e la location dell’Apocalisse di
Giovanni: l’isola di Patmos; solo da lì è possibile guardare all’orrenda bomba
milanese dei neofascisti. Non a caso del suo antimoderno fa parte anche
l’imprinting religioso della fanciullezza. Che riesce a collocare, pur senza
nascondere l’ansia di una ricerca ulteriore, anche il Vangelo secondo Matteo nel novero dell’ostinazione civile di PPP.
Qualcosa che attiene insieme alla storia e al mistero che l’accompagna. Basta
confrontare le sequenze pasoliniane con il calligrafismo del Gesù di Zeffirelli.
La nuova provocazione
E
a questo punto non è possibile non vedere e non rilevare la nuova provocazione
di Pier Paolo Pasolini. Essa consiste nel risultare insieme oggi così distante
e, proprio per questo, così attuale. L’uso abituale di materiali apocalittici
può far pensare -lo si è già notato- a David Maria Turoldo, o anche e più a
Sergio Quinzio: un irregolare di genio dell’ermeneutica biblica che ha passato
la vita a interrogarsi sui ritardi e la non-venuta del Messia, fino ad
apparirmi, a dispetto di una cordiale e profonda amicizia, un poco menagramo.
Niente
comunque di più alieno e di più stellarmente lontano rispetto al lessico delle
attuali politiche della governabilità, che hanno esplicitamente sostituito alla
critica la mitologia debole delle fiabe. Per esse Pasolini e tutti i suoi
scritti in fascio, e più ancora le sue posizioni politiche, finiscono
inevitabilmente nella tipologia dei “gufi”.
Il
mito c’è anche -a piene mani- in Pasolini, ma non è certamente quello
dell’ottimismo fiabesco, della Wall Disney Corporation, di una generazione di middle class low esposta al rischio di
vivere attese di plastica e piccoloborghesi al posto del mito tragico e della
sua perdita che caratterizzano la letteratura pasoliniana.
Questo
è il fascino paradossale e la riscoperta inquietante che il leggere Pasolini
oggi comporta. Una distanza che lo rende, importunamente ma utilmente, attuale. Con l’abitudine a non fare
sconti a nessuno, tantomeno a se stesso. Con una cifra tragica che ho ignorato
fino alle confidenze di una trasmissione televisiva che ha dato conto dei
settantacinque anni di vita della Pro Civitate Christiana di Assisi.
È
risaputo che nelle stanze fatte costruire da don Giovanni Rossi Pier Paolo
Pasolini ha concepito l’idea del film sul Vangelo di Matteo. Si ritrovò infatti
da solo nella sua camera perché tutti gli altri si erano recati all’incontro
con papa Giovanni XXIII arrivato in treno in pellegrinaggio nella città del Poverello.
Dovendo passare il tempo, si rivolse all’unico libro presente: il Vangelo
appunto. Lo lesse d’un fiato attraversando i sinottici e decidendo di provare
l’impresa filmica. Al ritorno ne parlò con don Giovanni Rossi che gli propose
di confessarsi. Pasolini oppose un cortese diniego e il giorno successivo
scrisse al fondatore della Pro Civitate una lettera stupenda e chiarificatrice.
Il
problema di Dio lo assillava, ma era altresì convinto di non potere risolverlo.
E usa in proposito una metafora inquietante. Scriveva a don Giovanni Rossi: “Non
sono né a cavallo né a piedi; sono come chi è caduto da cavallo e gli è rimasto
il piede impigliato nella staffa. Così vengo trascinato e mi trovo nell’impossibilità
di togliermi da quella infelice posizione. Solo a Dio è concesso risolvere una
situazione tanto complicata.
Fino
alla fine PPP non cessa di stupire e inquietarci. Le sue pagine e i film
risultano quantomeno un antidoto contro l’assuefazione e la pavidità.
[Gennaio
2015]
ALBUM
Le foto alla Casa della Cultura
durante l'incontro per Pasolini - "Capoverso" il 26 Gennaio 2016
 |
| 2 - Il Tavolo dei relatori |
 |
| 3 -Il tavolo dei relatori |
 |
| 4 -Il tavolo dei relatori |
 |
| 5 - Il tavolo dei relatori |
 |
| 6 - Il tavolo dei relatori |
 |
| 7 -Il tavolo dei relatori |
 |
| 8 -Il tavolo dei relatori |
 |
| 9 - Il tavolo dei relatori |
 |
| 10 - Gaccione, Papi, Ferretti, Alimena |
 |
| 11- Il tavolo dei relatori |
 |
| 12 - Il tavolo dei relatori. Gaccione al microfono |
 |
| 13 - Scorcio sul pubblico e relatori |
 |
| 14 - Angelo Gaccione |
 |
| 15 - Da sin. Seregni, Papi, Gaccione |
 |
| 16 - Variante |
 |
| 17 - Gaccione, Papi, Ferretti, Alimena |
 |
| 18 - Gaccione, Papi, Ferretti, Alimena |
 |
| 19 - Alimena, Zaccuri, Dionesalvi, Bianchi |
 |
| 20 - Gaccione mostra "Capoverso" al suo fianco Papi, Ferretti, Alimena |
 |
| 21- Papi, Ferretti |
 |
| 22 - Maria Dilucia legge brani di "Patmos" |
 |
| 23 -Maria Dilucia |
 |
| 24 - Franco Dionesalvi |
 |
| 25 - Franco Dionesalvi e Alessandro Zaccuri |
 |
| 26 - Dionesalvi, Alimena, Zaccuri, |
 |
| 27 - Dionesalvi e Giovanni Bianchi |
 |
| 28 - Alimena, Zaccuri, Dionesalvi |
 |
| 29 - Alimena, Zaccuri |
 |
| 30 - Dilucia e alcuni relatori |
 |
| 31 - Margherita Caruso (la Madonna del film "Il Vangelo secondo Matteo" al tavolo: Gaccione, Papi, Ferretti |
 |
| 32 -Caruso e il tavolo dei relatori |
 |
| 33 - Dilucia. Al tavolo Gaccione e Papi |
 |
| 34 - M. Dilucia |
 |
| 35 - Gaccione con M. Dilucia |
LIBRI
NON LUOGO A PROCEDERE
Il nuovo libro di
Claudio Magris
di Fulvio Papi
 |
| Claudio Magris (Foto: Alberto Ramella) |
L’ultimo libro di Claudio Magris mostra che è
ancora possibile l’esistenza di una grande letteratura e quella che, in modi
differenti, si pone la domanda sul senso della sua presenza nel mondo. È una
domanda che, di principio, evade da qualsiasi proposito pragmatico che ha già e
sempre la sua giustificazione. La letteratura può essere lo specchio infranto,
la stonatura voluta, il graffio volontario. E se si replica che anche la letteratura
è una prassi, risponderò che accetto il gioco linguistico, solo se si ammette
che le prassi sono differenti, e che questa parola non può far rinascere
l’universale. Il titolo del romanzo “Non
luogo a procedere” fa comprendere subito che l’opera è l’ascolto del
fallimento che, per lo più, attende la giustizia per quanto riguarda i fatti
storici. Possiamo certamente cercare la giustizia, anche con coraggio, ma alla
fine siamo sempre nella corrente, come l’interprete nel caso del discorso. E di
solito si perde. Nella dimensione dell’evento storico, della sorte collettiva,
dei destini indivisi “tutta la storia umana è un raschiamento della coscienza e
soprattutto della coscienza di chi sparisce”, così dice l’Autore. È il guardare
dalla parte opposta rispetto al famoso detto dello storicismo hegeliano secondo
cui “la storia del mondo è il giudizio del mondo”. L’aristocratica severità
idealista ignora la morte plebea che attende ognuno, ed esalta la fierezza personale
che assume il ruolo affidato dall’universale con una fedeltà involontariamente
astuta, capace di volgere nel cammino della storia (via gloriae) i propri desideri e la domanda di felicità della
propria esistenza. Poiché ogni fiore germoglia in una terra che può essere solo
ragione. Di per sé dire queste cose nella forma dell’idea scheletrica (avrebbe
detto Canetti), non è proprio una novità. La scoperta, intesa anche come forma
della conoscenza, è tutta nella narrazione che sfugge alla naturale violenza
dell’astratto, per cercare di riprodurre la percezione sensibile, il dolore
della violenza sopportata, l’argomentazione del crimine, il dominio assassino
che avvengono in un luogo, a se stessi destinato dalla nascita, in quella luce
in quel colore. Sono queste le tempeste che nel nostro tempo cadono nel mare
immenso dell’oblio. Sventolano i vessilli di un potere vittorioso che non
pagherà mai le tristi ragioni della sua gloria. È la temporalità del presente,
l’intersoggettività passiva che ritesse sempre le fila che trova in un nuovo
tessuto e agisce, sul sentire di ognuno come una nube che eguaglia ogni fatto
secondo il suo colore prevalente, condiviso da maggioranze pigre, paghe del loro
equilibrio e anche della loro, pur modestissima partecipazione ai margini della
festa. È quell’orizzonte della vita che tende a restringersi, a divenire
prossimo, la doxa quotidiana viene scambiata per una pubblica verità, l’ “io”,
un povero io che nasce in queste circostanze, nel suo “in der Welt sein” si
feconda secondo le voci che vengono dal formicolio della vita comune. Questo è
il nostro fiore di loto, il gioco di potenti, ma oplà Wir leben. Questo non
accade solo oggi, ma sempre quando le anime sono formate dagli schizzi di fango
dei giardini nobili, e nell’epoca che ci tocca, dal puro scambio mercantile:
una specie di peccato d’origine e che si reitera come costante nel suo rapporto
con il tempo.
Ho cercato,
a mio modo, di evocare il senso delle pagine di Magris, un romanzo di natura
storico-antropologica, dando però un significato leggero a queste parole,
quanto, invece, si fa più forte nel discorso letterario, il contenuto
morale. Leggo che Magris si sente vicino a Tolstoj. Assomiglia a quanto ho
cercato di dire. Certamente di Tolstoj non ha il ritmo narrativo, e non è solo
una questione di contemporanea sapienza letteraria, ma di poter dire e dare
forma all’esperienza umana e alle sue mutevoli tracce. I personaggi centrali di
Magris hanno sempre un “da dove”, una archeologia simbolica che ha sempre
dovuto pagare altissimo il suo essere nel mondo: neri o ebrei. L’opera di
Magris è una costruzione che inserisce nell’unità del suo flusso di senso una
pluralità di sedimenti temporali che coesistono facilmente poiché sono capitoli
di una narrazione, in fondo, a tema. Racconti nel racconto, si può dire: ma la
loro necessità narrativa è tutta qui. Azzarderò qualcosa di più: questo
rapporto tra unità e differenza, tra tempo presente ed epoca lontana mi pare si
avverta anche nella scrittura. Quanto più l’oggetto si allontana in un tempo
che non dimentica mai le fantasmagorie naturali che accompagnano come sfondo ma
anche come risorsa di uno stanco “se stesso” come corpo nero o ebreo, la
scrittura diventa continua allusione poetica, fiorisce di metafora in metafora,
le parole possono apparire come lo scintillare delle cose evocate che complica
un poco la narrazione perché richiede una diversa empatia (esperienza che non
mi pare ci fosse né in “Danubio”, né
in “Microcosmi”).
La scena della scrittura cambia in modo
sensibile, quando i fatti narrati sono vicini alla memoria dello scrittore e
alla sua più diretta sensibilità morale e politica. Qui è quasi sempre la
referenza diretta a dominare la scrittura, come di chi chiami direttamente il
lettore a una conoscenza storica, alla frequentazione di una verità che
comunque lo deve riguardare. La referenza stabilisce, com’è ovvio, una più
diretta unità tra scrittore e lettore. La “fabula”, a patto di semplificare molto,
non è difficile da raccontare. Un personaggio (colto dallo scrittore nel mondo
reale) con una sua stravaganza ma sicura dignità, si mette in mente di
raccogliere per farne un museo ogni tipo di ordigno bellico della seconda
guerra mondiale, ma anche della prima, così come di altre civiltà o di altre
epoche: sottomarini della imperial-regia marina, un carro armato della armata
rossa, una mitraglietta francese del 1909, una daga delle legioni romane. Il
proposito è quello che un simile museo di strumenti di morte divenga un
incentivo di pace. Proprio per questa ragione la memoria della contemporaneità
è particolarmente importante poiché essa ha a che vedere con il nostro modo di
essere. Si tratta di riprodurre nei propri quaderni messaggi, grafici, nomi, disegni,
striature, simboli che sono leggibili in ciascuna delle 17 celle del campo di
sterminio della Risiera di San Sabba a Trieste, l’unico organizzato in Italia
dalla tecnologia criminale dei nazisti. Aggiungo: il campo di Fossoli dove
ebrei, partigiani, note figure antifasciste venivano concentrati per lo più per
l’invio in Germania o in Polonia, ma anche fucilati sul luogo, era noto a
tutti. Della Risiera di San Sabba a Trieste se ne cominciò a parlare negli anni
Sessanta. La reticenza a ricordare la strage è descritta molto bene da Primo
Levi. Ma il caso di Trieste richiede qualche spiegazione in più. In ogni caso
nei quaderni dell’ideatore del museo vi erano riprodotte tragiche testimonianze
che qualsiasi interprete capace avrebbe fatto parlare facilmente. Era la
possibilità di un rapporto tra verità e giustizia. I nazisti erano maestri
delle macchine dell’assassinio, ma i segni sui muri screpolati potevano
indicare il corteo di spie, delatori, complici, profittatori, affaristi che
prosperavano nei dintorni dello sterminio. Poteva essere il documento della
verità sulle indegne collusioni. Ma un incendio misterioso invase il magazzino
dei reperti bellici e probabilmente ridusse in cenere i preziosi quaderni e, se
non fu così, o non fu così per tutti, essi vennero sottratti, destinati a
scomparire, nel loro silenzio, negli archivi segreti dell’esercito inglese a
Londra. Il perché in questo caso è facilissimo, assomiglia alle vicende
dell’armadio dimenticato nel ministero della Difesa a Roma che conteneva la documentazione
completa delle stragi naziste in Italia. La guerra fredda, la naturale
connivenza dei potenti solidali nelle loro strategie, a Roma come a Trieste,
coprirono ogni segno della verità e la “storia” ignorò la giustizia e accettò
la coscienza che il comodo del momento suggeriva coltivando l’indifferenza. La mia narrazione, colpevole come ogni secondo testo di un primo fondamentale, ora
procede facendo centro su un altro personaggio, Luisa che dopo l’incendio ha il
compito di mettere insieme il museo secondo una sequenza di sale. Il nostro
essere al mondo è solo un gioco di dadi, ma nel caso di Luisa questo gioco ha
una profondità epocale e una qualità etica, una contro-storia, i fatti che per
lo più non hanno narrazione o ne hanno solo frammenti che non costituiscono
gradini della ascesa alla pubblica verità. Magris, raccontando l’intreccio
incerto dei racconti del soldato tedesco che non avrebbe sparato su inermi
polacchi, sa bene la potenza dei racconti e quale possa essere il caso della
prevalenza della “verità”. Certamente come dice Magris ogni “io” non può che
nascere nella relazione con un “tu” (e spesso questo “tu” è molto complicato e
anche sfuggente). Ma il “tu” di Luisa è tutto nella profondità
dell’ingiustizia, nella persecuzione di una lunga traccia temporale, la storia
degli ebrei nel mondo. Luisa è inconsciamente costretta a percepirsi come il
testimone vivente di una storia di violenze che hanno segnato la nostra storia
e ancora oggi ne portano i segni. Ma è una ragazza che ha elaborato in se
stessa l’Altro sociale che molto ti costruisce e non poco ti costringe ad
essere (Ricoeur ha scritto sul tema un vero librone). I suoi amori arrivano,
appassiscono, si arenano nella palude dell’esistenza comune. Ma sa
ricominciare, è un testimone che riesce a valicare le condizioni un poco
disperate della testimonianza. Non cade nell’inganno dell’amore che Magris
ricorda da un celebre verso per cui il primo bacio è solo l’iniziale rottura dell’incanto
amoroso. La ragazza non soffrirà di questo reperto romantico (petrarchesco
infine), accetta la discesa al solo possibile della banalità ripetitiva. Il suo
senso, la costruzione del suo “io” deve percorrere altri cammini che non sono
quelli della “illusione poeticante” dell’esistenza. È nel suo corpo nato da
madre ebrea e da nero americano che c’è già una forma dell’io, una condizione
di autoriconoscimento: lo svelano i colori differenti delle mani, più scure
all’esterno, più chiare all’interno. La madre di Luisa è Sara salvata dalla
persecuzione assassina dei nazisti perché nascosta dalla madre nell’accogliente
casa di Anna in un piccolo paese istriano. Trieste, l’Istria e la Dalmazia dopo
il settembre del 1943 sono diventati una provincia tedesca dove nazionalisti e
fascisti accettano di mantenere il loro rango privilegiato al servizio dei
nuovi signori. La “storia” può cambiare la scena, ma il ruolo dell’attore non
cambia poiché il privilegio e la persecuzione sono scritti nella sua identità
come la capacità di cambiare abito nel momento opportuno. La madre di Sara,
Deborah, finisce nel forno crematorio della Risiera, ma su di lei corre voce
che abbia dato notizia ai nazisti degli stessi ebrei che la ospitavano. Il
sospetto è infamante e la sua ombra scende su Sara cui tocca il destino di
sospettare di sé come figlia della spia. Ma il fatto, nell’interpretazione, è
controverso: Deborah ha parlato nell’illusione di salvare se stessa? Ha fatto i
nomi in un interrogatorio atroce dopo la cattura? I dubbi e le incertezze si
possono moltiplicare, ma questa voce, che come ogni voce o si spegne o, al
contrario, diviene un racconto della realtà, come tra i vecchi e i nuovi amici
di Trieste e così diviene il segno, la marcatura della vita di Sara in uno spazio
indecente del sopravvivere. Almeno sino al giorno in cui entra nella sua vita
il sergente Brooks, un nero americano di un reparto che dopo il maggio del ’45
occupa Trieste, diventata “stato libero” sotto l’amministrazione alleata. Brooks
viene dalla storia dei neri d’America, dalle navi negriere, dalla persecuzione,
dalla sorte dei neri nel continente della ricchezza e del potere dei bianchi.
Non è solo una rappresentazione del passato, è una violenza che si ripete nel
presente: la sorella di Brooks, arruolata nell’armata americana, viene uccisa a
calci da una banda razzista a Londra. Sara e Brooks portano nel loro corpo, nel
loro modo di essere nel mondo, di sentirlo, di percepirlo, di temerlo e di
desiderarlo, i segni delle loro dolorose discendenze. E così che il loro amore
è il fiore vitale della loro esistenza, la perfetta rispondenza emotiva dei
loro destini, una felicità che non sa di ripagare i segni delle persecuzioni che,
nel silenzio, rimangono nelle loro vite. Breve tuttavia la stagione di questo amore,
l’ultimo dono reciproco è la nascita di Luisa poiché Brooks muore in un banale
incidente ad Aviano. Senza un caso crudele la perfidia della storia avrebbe
potuto essere medicata? La vicenda privata avrebbe potuto sopravvivere come una
delle famose isole felici? Pagine che costringono il lettore a uscire dal suo
involontario guscio protettivo sono quelle che Magris dedica alla disgustosa
festa per il compleanno di Hitler, il 20 aprile 1945, che i gerarchi nazisti
organizzano nel castello di Miramare. Vi si ritrova come in uno specchio il
mondo che nella Risiera di San Sabba ha la sua realtà: comandanti tedeschi
dell’esercito e della polizia, amministratori fascisti, rottami del potere di
tutto il tempo dell’occupazione, personaggi che hanno intessuto con costoro i
loro affari, prossimi voltagabbana, interpreti della furbizia dell’io
sprofondato nella vergogna. Corrono discorsi insensati, comportamenti
disgustosi, eccessi sessuali in quella che dovrebbe essere, tra le splendide
sale di Miramare e il suo giardino, l’ultima festa, il lugubre necessario
commiato, la trasfigurazione lubrica della morte. Ma non sarà così poiché molti
si salveranno, alcuni persino con onore. Il tribunale della storia è senza
giustizia, il suo codice è scritto sulla sabbia, la sua aura morale,
l’indifferenza. Pochi giorni dopo con lo sfondamento delle linee tedesche la VIIIa
armata inglese, a est come a ovest, è nella valle del Po. Trieste insorge contro
i nazisti. Ma il IX corpus dei partigiani di Tito ha già raggiunto la città.
Sono giorni del tutto inimmaginabili altrove: ci sono gli insorti italiani del
CVL (azionisti e cattolici), i partigiani di Tito, i comunisti divisi tra
italiani e “compagni” iugoslavi, la guarnigione tedesca, soldati, SS, Kriegsmarine,
che resiste ancora, la guardia civica che si schiera da una parte o dall’altra.
Si spara ovunque, ma alla fine i partigiani di Tito prevarranno, disarmano gli
insorti italiani, sono padroni della città. Nei giorni dell’occupazione
uccisero e gettarono nelle foibe italiani di ogni appartenenza, in una furiosa
vendetta dei crimini commessi in Slovenia e Croazia dagli occupanti
italiani. È
così con l’opera di Magris siamo calati in una storia, oggi del tutto placata,
dove gli uomini (ricorda
l’Autore) sono sempre vittime, qualsiasi posto possono assumere. Il gioco è dei
“padroni del mondo”. A Trieste come altrove: il loro volto muta, ma il loro
potere, si diffonde con l’aria che respiriamo. So che del testo ho ignorato
analisi che andavano fatte. Una però non l’ho dimenticata. Mi sono segnato
tutte le frasi triestine che compaiono nell’opera, e credo di aver capito il
loro senso. L’autore (da augere:
colui che aumenta) è sempre un uomo con l’altra gente, guarda lo stesso mare,
sopporta la stessa bora, conosce le stesse strade, condivide il modo più
semplice per scambiare se stesso; così l’opera è un lavoro e un tempo, tra il
lavoro e il tempo degli altri. E questo, gli cade dalla penna, come lo sguardo
quotidiano nel mondo.
 |
| La copertina del libro |
Claudio Magris
Non luogo a
procedere
Ed. Garzanti 2015
Pagg. 368 € 20,00
***
IL TRAGICO VOLO
di Giulia Marchina
 |
| Giulia Marchina |
Vent’anni fa, l’ 11 Febbraio 1996
a Roma, in Via del Corallo n. 24
si toglieva la vita la poetessa
Amelia Rosselli.
Passò anche Amelia, volava come
una tunica.
G. Giudici
Questo 11 febbraio ricorre il
ventennale di un tragico volo, quello che la poetessa Amelia Rosselli spiccò
dalla finestra della sua cucina, a Roma, in via del Corallo.
Da sempre
conscia di essere appartenuta alle fila dei poeti della «ricerca»,1
quando venne a mancare in lei la sua stessa lingua, la scrittura, quel silenzio
la condusse al suicidio, fatalmente concorde nella data a quello perpetrato nel
1963 da Sylvia Plath, da lei amata e tradotta.
Per Amelia
vita e poesia furono voci inscindibili di uno stesso verbo, un verbo
plurilingue, o di una lingua insondabile e imprecisata: i suoi versi e i suoi
scritti giovanili, fortemente intessuti di prestiti dal francese e
dall’inglese, nonché dall’italiano popolare e da arcaismi della nostra tradizione
letteraria, costituiscono un prezioso e inusitato amalgama, formalmente e
semanticamente complesso e spesso, anche per i critici, indecifrabile. Ritengo
importante sottolineare che queste peculiarità linguistiche da me appena
accennate, nonché le concrezioni, i grumi traumatici che permeano il suo
discorso ad ogni livello, sono tutti caratteri riconducibili alla sua storia di
orfana (il padre Carlo Rosselli, fondatore di Giustizia e Libertà, fu assassinato a Parigi nel 1937), rifugiata e
peregrina in Europa e negli Usa. La sua non fu dunque una scrittura
«cosmopolita»,2 ma piuttosto il frutto cangiante
di un secolo terribile e di una sensibilità nuova:
Nata
a Parigi travagliata nell’epopea della nostra generazione
fallace. Giaciuta in America fra i ricchi campi dei possidenti
e dello Stato statale. Vissuta in Italia, paese barbaro.
Scappata dall’Inghilterra paese di sofisticati. Speranzosa
nell’Ovest ove niente per ora cresce. (3)
fallace. Giaciuta in America fra i ricchi campi dei possidenti
e dello Stato statale. Vissuta in Italia, paese barbaro.
Scappata dall’Inghilterra paese di sofisticati. Speranzosa
nell’Ovest ove niente per ora cresce. (3)
 |
| Amelia Rosselli mentre declama una poesia |
In Stranieri a se stessi, Julia Kristeva ha
lucidamente messo in relazione due termini che risultano, per così dire,
simbiotici: quello di étranger
(straniero/estraneo) e quello di étrange
(strano), giungendo con la sua riflessione a legittimare il carattere d’inquietante étrangeté proprio a molti
poeti e artisti che hanno vissuto la condizione dell’esilio e
dell’emarginazione.4 Amelia Rosselli fu per così
dire, un’eterna straniera, anche in patria. Rientrata in Italia fu refrattaria
a qualunque etichetta, in particolare a quella della Neoavanguardia, sentita da
lei come un vero e proprio peso, come scrisse ironicamente nel poemetto La Libellula (1958): «E io/ lo so ma
l’avanguardia è ancora cavalcioni su/ de le mie spalle e ride e sputa come una
vecchia/ fattucchiera».5
A differenza
di molti poeti del suo tempo, Amelia sentì il bisogno di imbrigliare la sua
materia in un metro unico e regolare, da lei definito e spiegato al pubblico
dei suoi lettori con grande chiarezza nel manifesto Spazi metrici (1962). E in questo darsi delle regole e rispettarle,
nell’attenzione al ritmo e alla musica, fu di uno sperimentalismo certo assai
più vicino a quello dei grandi poeti della classicità! Il ritmo seducente dei
suoi versi, la lingua che come un Proteo multiforme, si nutre di più lingue, le
parole, definite da Zanzotto veri e propri «mostriciattoli di luce»,6
invitano il lettore a intraprendere una quête,
a cercare di risolvere l’enigma della Sibilla.
 |
| Amelia Rosselli nella sua casa di Roma |
Tutto il mondo è
vedovo se è vero che tu cammini ancora
tutto il mondo è vedovo se è vero! Tutto il mondo
è vero se è vero che tu cammini ancora, tutto il
mondo è vedovo se tu non muori! Tutto il mondo
è mio se è vero che tu non sei vivo ma solo
una lanterna per i miei occhi obliqui. Cieca rimasi
dalla tua nascita e l'importanza del nuovo giorno
non è che notte per la tua distanza. Cieca sono
ché tu cammini ancora! cieca sono che tu cammini
e il mondo è vedovo e il mondo è cieco se tu cammini
ancora aggrappato ai miei occhi celestiali. (7)
è vero se è vero che tu cammini ancora, tutto il
mondo è vedovo se tu non muori! Tutto il mondo
è mio se è vero che tu non sei vivo ma solo
una lanterna per i miei occhi obliqui. Cieca rimasi
dalla tua nascita e l'importanza del nuovo giorno
non è che notte per la tua distanza. Cieca sono
ché tu cammini ancora! cieca sono che tu cammini
e il mondo è vedovo e il mondo è cieco se tu cammini
ancora aggrappato ai miei occhi celestiali. (7)
Note
1. A. Rosselli, Una scrittura plurale, a cura di F. Caputo,
Novara, Interlinea, 2004.
2. P. P. Pasolini, Notizia su Amelia Rosselli, in «Il
Menabò», n.6, 1963, pp. 66-69.
3. Variazioni Belliche in Rosselli, L’Opera poetica, a cura di S.
Giovannuzzi, Milano,
Mondadori,
2012, p. 46.
4. Ne L’idiota della famiglia Jean-Paul Sartre ripropone questo concetto il
termine
inglese ma
di origine francese «estrangement», con cui Lacan traduce la freudiana
unheimlichkeit.
5. La Libellula: Panegirico della libertà in Rosselli, L’Opera
poetica, a cura di S. Giovannuzzi, Milano, Mondadori, 2012, p. 196.
6. A. Zanzotto, Aure e disincanti nel mondo letterario,
Milano, Mondadori, 2001, p.128.
7. Variazioni belliche op. cit. p.179.
***
LIBRI
Ravasi
e il giubileo antisistema
di
Giovanni Bianchi
 |
| Gianfranco Ravasi |
Il bello dell’esegesi
Ci sono esegeti a miccia lunga. Principe
tra essi era il cardinale Martini, che non a caso nell’ultimo soggiorno di
studio a Gerusalemme dedicava il tempo ai testi che sarebbero serviti per le
traduzioni. Un impegno all’evidenza arido, ma tutto orientato a fare
risplendere la parola di Dio e in alcuni casi a farla “esplodere”. Sulla
medesima scia e con altrettanta competenza si muove da sempre il cardinale
Ravasi, già direttore a Milano della Biblioteca Ambrosiana, approdato in
Vaticano al Pontificio consiglio della cultura.
La
miccia lunga infatti consente di lavorare con acribia i testi, anche quelli che
nella Scrittura rivestono un carattere normativo e talvolta addirittura “fiscale”, perché alla
fine la parola di Dio, indagata, sprigioni tutte le sue punte potenzialità in
commenti che cantano.
Ultimo
frutto delle fatiche di Ravasi (ma non per molto, c’è da giurarlo) il testo Il significato del giubileo. L’anno Santo. Dalla
Bibbia ai nostri giorni, edito dalle Dehoniane di Bologna, 8 euro
l’abbordabilissimo prezzo di copertina. Altra caratteristica invidiabile di
Ravasi, va detto subito, è riuscire ogni volta ad annullare le distanze tra il
rigore dell’analisi ermeneutica e la fruibilità della divulgazione. Un pensiero
ed una scrittura cioè che attraversano i confini e le linee degli specialisti-
chiamiamoli per una volta i “pianisti” della Scrittura -per rivolgersi anche
agli orecchianti e perfino gli stonati.
È
questa capacità che riesce a far cantare i testi e a renderne nel contempo
palese la natura esplosiva. Prendiamo ad esempio la fine di p. 32 e l’inizio di
p. 33. Scrive Ravasi:
“In
Israele la terra non si vende mai; essa non è di proprietà neppure della tribù
o della famiglia. L’uomo ha soltanto l’usufrutto della terra, non il possesso.
La terra resta sempre di Dio. Siamo ben lontani dal concetto di proprietà
privata dell’Occidente o anche dal romano ius
utendi et abutendi di una realtà, fino a devastarla come accade in un certo
capitalismo occidentale, che ha ancora alla base questo concetto quasi assoluto
di proprietà privata, per fortuna temperato dalle legislazioni degli Stati”.
Non
c’è possibilità di fraintendere e neppure di svicolare. L’uomo della strada,
anche se di fretta, riesce a capire, così come non puoi fare a meno di pensare
che Amartya Sen, Stiglitz, Crugman e anche Thomas Piketty annuiscano
compiaciuti: ecco uno degli effetti della miccia lunga. E infatti Ravasi ha già
scritto a p. 27: “Il capitolo 25 del Levitico è una pagina di lettura non
facile, forse noiosa, complessa e arida, che contiene, come in un involucro,
tutta l’energia che è stata poi alla base del successivo Giubileo della
tradizione cristiana. Occorre spezzare l’involucro per scoprire il respiro che
si nasconde sotto la lettera della legge”.
Insomma,
non sono le trovate né i colpi di teatro che ci appassionano all’Antico
Testamento, ma il duro mestiere dello studioso che rispetta la Parola per
averla a lungo ruminata.
Una provvidenza oculata
Quella
che incontri passo dopo passo, testo dopo testo, prescrizione dopo prescrizione
è una provvidenza oculata e non svagata o disattenta: che rispetta le stagioni,
il maggese, la terra stessa che, come i suoi coltivatori ha bisogno di riposo,
il nido degli uccelli, la fame dei poveri ammessi a spigolare dopo la
mietitura.
Un
ritmo diverso: dove il riposo ha la medesima dignità del lavoro dovuto e duro,
e dove anche il benessere e i diritti degli animali da soma chiedono di essere
rispettati.
Il
genere che ritroviamo -annota puntualmente il Ravasi- nei testi sacri
dell’antichità e anche nell’Islam. Il che dice che il Libro, tutti i libri
sacri, in certo modo si tengono, ma non bastano. È il cuore dell’uomo che deve
rimettersi in strada; per questo il giubileo è anche un pellegrinaggio (niente
tuttavia a che fare con il turismo) con l’anima in spalla.
Neppure
tiene la contrapposizione tra un Dio severo e giudice dell’Antico Testamento e
un Dio pietoso e accogliente -materno come madre- del Nuovo Testamento. Neppure
in questo caso siamo autorizzati a prendere le distanze dai nostri fratelli
maggiori israeliti.
Quello
che il cardinale Ravasi ci conduce ad approssimare e conoscere è un Dio che non
teme di apparire ragioniere e geometra, pur di mettere al sicuro la giustizia e
la solidarietà. E in primo luogo la giustizia. Un Dio “fiscale” che entra nei
dettagli delle compravendite e ha l’aria di non tollerare deroghe nei confronti
dei suoi poveri. Per il Signore del giubileo il popolo di Dio è un popolo unito
perché formato da uguali, non solo sulla carta, ma con i piedi ben piantati per
terra, e con i conti e i perimetri che tornano.
Nell’epoca moderna
La
logica del giubileo emerge da queste pagine come un cannocchiale che guardando
dal passato remoto fissa le sue lenti sui problemi del presente. È così che,
assente dal Nuovo Testamento, il termine giubileo entra nella vita della Chiesa
settecento anni fa, quando il 22 febbraio del 1300, papa Bonifacio VIII
-certamente non additato come esempio di pietà-
emana la bolla del primo anno santo, anche se la struttura fondamentale
del rito verrà definita nel 1500 da Alessandro VI Borgia, altra figura di
pontefice non raccomandata come esempio ai seminaristi.
In
quest’oggi il problema della casa è tornato attuale in forme a dir poco
drammatiche, con cittadini senza casa e case senza inquilini. Lo stesso dicasi
del lavoro “che manca e che stanca di più del lavoro che stanca” (Aris
Accornero). Società liquide disgregate che impediscono di pensare il futuro non
soltanto per le nuove generazioni.
Come
recuperare allora il termine “anno di grazia”?
A
questo punto Ravasi prende le parti del Nazareno per illustrarci il senso nei
Vangeli dell’anno giubilare di Cristo. Il Vangelo come “lieto annunzio ai
poveri” e come tempo privilegiato della riconciliazione con Dio. Tutti i
simboli e tutti gli anni giubilari – molti gli straordinari – della modernità.
E soprattutto i passi del Nuovo Testamento che fondano la visione giubilare di
Gesù Cristo “non più quello di Israele,
ma il Giubileo cristiano, perché non si può accogliere un anno, ci accoglie
invece una persona”(p. 60). In tal modo “Gesù viene quindi ad annunciare
una giustizia anche sociale, che condanna una religiosità distaccata dalla
storia e limitata a incensi, ceri accesi e canti”(p.55). E infatti “non è
lecito guardare da un’altra parte” (p. 56).
Ad
andare per le spicce, si può ben dire che Ravasi sciorina tutto il retroterra
scritturale della proposta di papa Francesco. Senza mettere tra parentesi che
la stessa cristianità ha seminato la storia di male. E senza d’altra parte
ridurre equivocamente il giubileo a una questione socio-politica, proprio
perché restano dovuti, impliciti ed evidenti i suoi effetti sociali. La stessa
tensione utopica sottesa all’anno giubilare non va né sottaciuta né
depotenziata.
Papa Bergoglio
Resta
un ultimo link da individuare. Quello che lega profondamente questa riflessione
di Ravasi al magistero di Francesco. Perché Francesco insiste con parole
antiche che in questa fase storica suonano nuovissime alle orecchie degli
uomini siano essi credenti o meno?
Papa
Bergoglio non è un progressista, ma un radicale evangelico che fa risuonare
nuove anche parole della tradizione cristiana -potremmo anche scrivere Traditio- e dell’antimoderno.
Ha
confidato recentemente di non guardare la televisione da 25 anni: “per un
fioretto”. Produce un lessico dove non mancano le invenzioni linguistiche
curiosamente a cavallo tra italiano e castigliano: la più nota è inequità (fatica inutile tradurre).
Le
sue encicliche e il suo magistero quotidiano (le prediche mattutine in Santa
Marta) non si rivolgono ai credenti o agli uomini di buona volontà, ma al mondo
intero. Hanno la levità, la profondità e l’ostinazione di parole che ignorano i
confini nell’epoca dei fondamentalismi che invece erigono sempre nuovi confini
e li insanguinano. Partecipano del meticciato globale e quotidiano che
presuppone l’accoglienza ed esige la misericordia.
La
sua puntualità d’intervento non cessa di stupire e insieme commuoverci. Uno
stupore e una commozione di massa, che sembra ancora una volta annullare il
confine tra credenti e noncredenti. Forse ha ragione un amico che insegna
filosofia estetica a osservare che lo sguardo di Francesco non considera il
capitalismo un destino.
Anche
la sua è una miccia sempre accesa. E celiando con il recupero di una vecchia
sigla e sepolta del movimentismo italiano potremmo forse dire: Miccia Continua.
 |
| La copertina del libro |
Gianfranco Ravasi
Il significato del Giubileo
Edizioni Dehoniane 2015
Pagg. 82 € 8,00
***
TEATRO
TOMMASO
CAMPANELLA E UMBERTO ECO
Un dialogo
morale di Dante Maffìa
 |
| Dante Maffìa (foto: Paolo Quaranta) |
CAMPANELLA:
Non
sono mai frivolo, lo sai, ma appena ti ho visto, stamani, m’è venuto da pensare
se i nomi sono soltanto un involucro per farci riconoscere dagli altri, o se
invece sono, come diceva l’antico greco che l’Alighieri poi ricalcò, sostanza
del nostro essere. E quindi mi sono detto che se ti chiami Eco in qualche modo
sei eco di qualcosa che però mi sfugge. Ci hai mai pensato? O è troppo
peregrina la mia osservazione, appunto frivola?
ECO:
Come
dire che tu sei una piccola campana. Non sapremo mai esattamente come i nomi ci
si appiccicano addosso e poi diventano
la nostra identità. Non possiamo scegliere, c’è chi lo ha fatto e lo fa per noi.
Anzi, adesso si può, basta andare al Municipio di residenza e fare un cambio.
Tu non saresti stato più immediatamente riconoscibile se ti fossi chiamato
Settimontano Squilla?
CAMPANELLA:
In
che buffa discussione ci stiamo avventurando! Tu vieni a trovarmi qui a Stilo e io ti accolgo con
queste chiacchiere inutili. Perdonami. Devo dirti innanzi tutto d’essere
contento, Catarinella preparerà subito un bel pranzo alla calabrese. Lo mangi
il piccante, vero? Pasta di casa con la ndùja, un po’ di sopressata e di
formaggio. Dovrai accontentarti, Catarinella è ormai vecchia e fa quel che può.
Cipolla e lattuga sono del nostro giardino, roba genuina, sentirai il sapore.
ECO:
La
proverbiale accoglienza dei calabresi! Maestro, innanzi tutto, prima che il
vino ci annebbi (ti ho portato alcune bottiglie piemontesi che sono un delirio
ma forse ho sbagliato perché la tua è terra di vitigni secolari) vorrei
chiederti se posso avere il permesso di mettere sulla mia lapide (quando sarà,
facciamo i dovuti scongiuri) le ultime parole de La città del sole.
CAMPANELLA:
Permesso
accordato, figuriamoci. Vuoi che te lo
metta per iscritto?
ECO:
No,
mi basta la tua parola.
CAMPANELLA:
Allora,
dimmi a che cosa stai lavorando. Tu sai che ti ho seguito sempre con molto
interesse, anche se qui è difficile reperire i libri. Devo dirti che le tue invenzioni
sono geniali, hanno il senso delle cose e della magia, scusami l’autocitazione,
ma è per dirti quanto ti trovo in sintonia con me. Quell’isola del giorno
prima, poi, è davvero strabiliante.
 |
| Tommaso Campanella |
ECO:
Non
l’hanno capita in molti.
CAMPANELLA:
E
questo deve inorgoglirti, vuol dire che non sei banale, provvisorio, appetibile
ai giornalisti che, a quanto mi dicono, è una brutta razza di facinorosi
superficiali e carrieristi.
ECO:
Preferisco
non esprimermi in proposito. Io ho la sacralità della scrittura e mi indigno
quando lo sconcio entra in gioco nei libri o sulle pagine dei giornali, non ne
capisco la necessità, addirittura, perché la notizia non è mai obiettiva,
neutra, ma una lama arrugginita che infetta anime e menti.
CAMPANELLA:
Capisco
il tuo disagio. E’ scomodo vivere in un mondo di mediocri, di venduti. Non mi
fare ricordare i tradimenti, ti prego.
ECO:
Io
ho vissuto la lettura e la scrittura come una religione assoluta e sono venuto
a trovarti perché so che anche tu hai fatto altrettanto e in tempi in cui il
libro era quasi un oggetto misterioso. Ti devo l’esempio che mi hai dato, la
mia visita è innanzi tutto un atto di agnizione.
 |
| Umberto Eco |
CAMPANELLA:
Non
mi mettere scomodo, non mi imbarazzare. Ho sempre ricevuto calci nel sedere, da
tutti, anche dai papi nel momento del pericolo e dopo che si erano serviti di
me. Non parliamo di Richelieu, una belva con settante sette bocche fameliche.
ECO:
Ma
c’è qualcuno che hai sentito vicino a te in tanti secoli?
CAMPANELLA:
Una
straordinaria signora di nome Marguerite Yourcenar. E’ venuta a trovarmi e mi
ha portato un suo libro, L’opera in nero,
nel quale mi riconosce dei meriti. E adesso tu, che compi un viaggio impervio e
scomodissimo per venirmi a trovare per chiedermi di utilizzare delle mie parole
per la tua eternità. Ti sono grato, ogni parola che mi viene rivolta con
dolcezza, ogni azione che mi sottrae alla volgarità che mi circonda mi dà una
sorta di ebbrezza che durante la mia esistenza terrena non ho potuto mai
ricevere. Sbatacchiato da un convento all’altro mi hanno trattato da reietto,
da nemico della chiesa, non hanno mai voluto intendere che il potere per me non
sta nei codici, ma nell’amore per il prossimo e per Dio. Ma è una lunga
faccenda che avremo modo di discutere a lungo quando fra cento anni verrai
definitivamente qui, a Stilo.
ECO:
Avrei
tante cose da domandarti, ma sono emozionato, i pensieri corrono veloci e si
accavallano, dimmi soltanto se davvero gli scritti te li ha dettati Dio in
persona oppure è una leggenda.
CAMPANELLA:
Ogni
leggenda ha una parte di verità che sostanzia le parole e i fatti. Sì, io sentivo arrivare l’alito di
Dio che mi dettava, un fluire di pensieri alti che seguivano il suo fiato. Non
sempre sono stato in grado di registrare tutto, a volte Lui era frettoloso,
altre volte veniva chiamato per un impegno improvviso, altre ancora veniva
disturbato dai Profeti gelosi della sua scelta. Anche lassù ci sono fazioni e
camarille, ndranghete e mafie che fanno
la fronda e cospirano. Tu credi che in Paradiso abbiano mai accettato che il
figlio di un ciabattino sia stato scelto per portare la parola nuova al mondo?
Non crederlo mai, saresti un ingenuo. Ma io so perché Dio si è rivolto a me,
perché sulla questione del libero arbitrio avevo assorbito le lezioni di
Platone, di Aristotele, di Agostino, di Duns Scoto e avevo formulato una teoria
che rispecchia esattamente le Sue volontà. Non è una questione facile, è uno di
quegli enigmi che si trascineranno nei secoli dei secoli, ma io ci ero entrato in
pienezza, avevo, per esempio, capito che “la conoscenza, delle scienze umane,
se ben intesa, può collocare il nostro interrogativo al suo posto giusto: cioè
nel dominio oggettivo della osservazione empirica positiva -sociologica o
psicologica- ma nell’ambito della esperienza esistenziale vissuta, colta
attraverso una fenomenologia riflessiva”.
 |
| T. Campanella |
ECO:
Starei
ad ascoltarti ore e ore.
CAMPANELLA:
Verrà
il tempo, come diceva il poeta, i giorni volano in fretta, una sola
raccomandazione, non farti prendere mai dall’assillo della inutile coscienza, è
sempre il poeta a dirlo, che tutto
inutile sia. Il meglio di me credo di averlo dato in poesia, ma pare che sia
ritenuta difficile, ostica. Ma chi ci si è messo a leggerla ho visto che ha
saputo viverla, quel ragazzo calabrese così simile a me, così innamorato dei
tuoi libri. Perché non lo tieni di conto?
ECO:
E’
una raccomandazione?
CAMPANELLA:
E’
appena una segnalazione, ma so che sei troppo preso dai tuoi assilli e non hai
tempo per le relazioni e le promozioni. Quando ero alla Sorbona anch’io a volte
mi trinceravo nel mio fare quotidiano, ma adesso posso dire che un po’ ho
sbagliato. “Sol chi non lascia eredità d’affetti poca gioia ha dell’urna…”. Ma
non sta a me dirti quel che devi o non devi fare. Sono felice della tua visita,
del tuo ritenermi degno della tua attenzione.
 |
| U. Eco |
ECO:
A
proposito della tua poesia, Firpo e Bobbio dicevano che sei secondo soltanto a
Dante. L’hai incontrato?
CAMPANELLA:
Certo,
l’ho incontrato, ma non abbiamo legato, anche se io sono, poeticamente
parlando, dantesco fino in fondo. Come persona lui è astratto, non so come
dirti, vive dentro finzioni teologiche che non sa tessere e allora le rivolta e
le riapre con strafalcioni che mi fanno sorridere. Gli manca, per dirla tutta,
il fiato del quotidiano, del vissuto.
ECO:
Non
l’avrei mai pensato.
CAMPANELLA:
Perdonami,
sono stanco, mi stanco facilmente ormai. Un tempo riuscivo a studiare anche
quindici, sedici ore al giorno, ininterrottamente, preso dalla smania di
svelare i misteri della vita, del Cielo e dell’Amore. Mi hanno sempre
avversato, frainteso. Tu credi di non avere nemici per quello che hai scritto?
Non t’illudere, senza che l’abbia voluto hai pestato i piedi a un cardinale o a
un politico, a un invidioso, a un mercenario. Tu sei una grande mente, un
grande cuore, una risorsa umana straordinaria. Io posso dirtelo perché ormai
non sono soggetto a limitazioni e a paure di qualsiasi genere. La tua parola
vola alta, è come gli arcobaleni che vagano nel cielo accendendo luminarie che
devono servire a modificare la sostanza degli esseri umani nel loro cammino verso
la luce o verso la tenebra. La città del sole non è un luogo preconfezionato,
ma un luogo da organizzare e popolare continuamente. Con libri come i tuoi che
danno la consapevolezza.
ECO:
Non
mi sopravvaluti?
CAMPANELLA:
Non
essere troppo umile, l’eccesso di umiltà porta danni.
ECO:
Ancora
una domanda, ti prego, aspetta, aspetta.
CAMPANELLA:
Non posso, non posso.
***
LIBRI
ALDA MERINI. LA POETESSA
DEI NAVIGLI
 |
| Alda Merini |
Se vogliamo entrare davvero in
sintonia con il libro di Aldo Colonnello dedicato alla memoria di Alda Merini (Alda Merini la poetessa dei Navigli, Ed.
Meravigli, Pagg. 146 € 15,00), dobbiamo accettarlo per quello che realmente è:
una lunga, affettuosa e appassionata lettera d’amore. Chi si immergerà nelle
sue pagine si accorgerà subito che quella di Colonnello, nei confronti della
poetessa, (ma direi anche della donna), non è stata la semplice frequentazione
di un ammiratore affascinato dai suoi versi, o di un amico premuroso che, in
quanto tale, c’è sempre, anche nei momenti più difficili, con l’attenzione, la
sensibilità e la discrezione che una vera amicizia comporta. Tutto questo c’è,
ovviamente, ma la sua è stata qualcosa in più: la devozione quasi filiale (e
mai venuta meno) verso una creatura che si ritiene speciale, e che, proprio in
virtù di quella devozione, si è disposti a perdonarle ogni cosa: capricci,
impuntature, cambi d’umore, incomprensioni, scatti imprevedibili, umiliazioni,
scelte discutibili, modo di vivere, perché accecati dal nostro affetto. Del
resto, chi ha avuto modo di conoscere Alda Merini, sa quanto fosse spigoloso,
indipendente e per nulla reverenziale il suo carattere, e come fosse altresì generosa,
umana e disponibile; qualità che non sono molto diffuse negli ambienti
letterari milanesi, anzi. Accettarla com’era o tenersene alla larga: non
c’erano mezze misure possibili. Ed è anche per questo che io giudico stoica la
resistenza di Colonnello, e straordinaria la sua fedeltà all’amicizia. Scrive
in un passaggio del suo libro: “La
Poetessa (Colonnello usa rigidamente la maiuscola) non era certamente una santa, credo di poter dire non fosse neppure
umile, anzi era fortemente consapevole della propria limpida genialità, spesso
la faceva pesare, annichilendo il malcapitato di turno o imponendo una
personalità carismatica in contesti pubblici”. È tutto perfettamente vero,
ma aveva un pregio raro: non fingeva nei rapporti umani, era rimasta autentica
come la sua anima popolare, la lingua dialettale milanese che continuava a
parlare, il suo bisogno di poco, e non si era snaturata e imborghesita come il
quartiere divenuto finto e mercificato fino al midollo. Poeta lo era in ogni
fibra, naturaliter; e quello che
sentiva lo cacciava fuori quasi sempre nella maniera più immediata. Da anni non
prendeva appunti e non scriveva; preferiva dettare agli amici, per lo più al
telefono e nelle ore e nei momenti più diversi, notti comprese. Potevano venir
fuori meraviglie, da questa pratica istantanea e prettamente orale, e potevano
venir fuori cose non del tutto riuscite e che sarebbe stato meglio non mettere
in circolazione. Ma fra i suoi numerosi amici ed estimatori ce n’erano anche di
“disinvolti” che di scrupoli se ne facevano ben pochi. Ma non è questo il luogo per aprire un contenzioso.
 |
| Aldo Colonnello |
Di tale pratica “dettatoria” avevo beneficiato anch’io in anni diversi: nel 2001 per i due testi Silenzio e Favola, dettatimi al telefono il 10 gennaio di quell’anno e pubblicati nel prezioso volume collettivo “Le luci del Bauhaus” (Ed. Gutenberg); nel 2002 (e precisamente il 4 aprile) per la poesia Milano da me inserita nella ponderosa antologia “Poeti per Milano. Una città in versi” e pubblicata dalla Viennepierre edizioni. Erano passati nove anni dal libretto “Aforismi”, che le avevo pubblicato con una mia nota introduttiva nel 1992 nelle Edizioni Nuove Scritture. Pubblicammo quel libretto in due diverse ristampe cambiando la copertina (la prima volta con un’opera di Alberto Casiraghi, la seconda con una di Salvatore Carbone); Alda non si era fino ad allora cimentata con questa forma di scrittura, divenuta poi con gli anni piuttosto frequente. Nel 2006 mi salvò, letteralmente, da una incresciosa svista. Dovevamo andare in stampa con il numero 2 del IV anno del giornale “Odissea”, quello di dicembre, quando l’impaginatore si accorse, all’ultimo momento, che mancava la frase da inserire accanto alla testata. A ridosso del Natale non era cosa facile interpellare collaboratori e amici scrittori; e poi non tutti scrivevano aforismi e avevano pratica con il genere. Mi ricordai di Alda e le telefonai: “Sono nei guai” le dissi, mi bastano anche due sole righe, dobbiamo andare in stampa in meno di un’ora”. “Hai la penna?” mi chiese all’istante, “scrivi: Ricordati che due sole righe possono condannare a morte un uomo”. La profondità della frase e l’immediatezza con cui l’aveva formulata, mi lasciarono di stucco. Ero salvo. Telefonai Fulvio Chiodini in tipografia e potemmo andare in stampa.
 |
| La targa che ricorda Alda Merini sui Navigli |
Non c’è dubbio che da questo rapporto Colonnello (avrete certamente notato che si chiama incredibilmente Aldo: se non è questo uno scherzo del destino…) è uscito più ricco e cambiato. Egli ha potuto salvare per noi la memoria di un tratto di vita della poetessa; registrare i suoi incontri e quelli avuti dall’autrice con personalità fra le più varie; la partecipazione ad eventi spesso da lui sollecitati e voluti; gli aneddoti, i versi che gli dettava a voce e che lui diligentemente trascriveva, e dunque dobbiamo essergliene grati. Come grati dobbiamo essere alle Edizioni Meravigli che hanno pubblicato un libro che ci illumina su molti aspetti privati di una poetessa a cui abbiamo voluto bene; ricco anche di foto, in gran parte scattate da un altro amico intimo della poetessa, Giuliano Grittini, comprese quelle in cui Alda riceve gli ospiti distesa sul letto come una matrona romana. E quelle delle pareti della sua incredibile casa, zeppe di appunti, numeri telefonici, graffiti e disegni fra i più vari.
 |
| La copertina del libro |
***
CINEMA
ERMANNO OLMI. IL PRIMO SGUARDO
di Fulvio Papi
 |
| Ermanno Olmi |
Quando un
autore, un poeta, uno scrittore, un pittore, parla di se stesso e della sua
opera c’è quasi sempre un residuo un poco deludente. E del resto c’è da
prevedere un esito di questo genere non solo perché un’autobiografia, anche
quando ricerchi il solco della verità, è sempre un poco carente, sproporzionata
rispetto ai fatti accaduti, ma, nel caso di un artista, perché la sua opera è
sempre eccedente rispetto alle ragioni che l’autore trova per interpretarla a
vantaggio di un qualsiasi ascoltatore. E una ragione un poco segreta c’è.
L’esecuzione di un lavoro artistico, in tutti i suoi casi, chiama al suo autore
attenzioni, invenzioni, stratagemmi, verità, desideri che nella narrazione dell’autore
stesso vanno per lo più perduti. Su questo rapporto tutt’affatto non simmetrico
si potrebbe avanzare molte riflessioni. Qui, forse, ne basta una sola, la
manipolazione del materiale artistico, parole, colori, disegni, suoni, ha
sempre una sua contingente possibilità inventiva che è eccedente rispetto al
linguaggio che commenta l’opera. Non sono proprio per niente esperto di cinema,
ma credo che qualcosa di questo genere capiti anche nel montaggio di un film.
L’opera, a saperla interrogare, dice di solito qualcosa di più rispetto a
quanto l’autore nel suo progetto iniziale, e nel suo commento postumo, confessa
agli altri e anche a se stesso, di aver voluto fare. Questa è in fondo la
ragione per cui la critica, quand’è buona critica, collabora con l’opera d’arte
nella buona recezione del pubblico. È con questa premessa che ho letto con
grande attenzione l’intervista che Marco Manzoni ha fatto a Ermanno Olmi sulla
sua opera di maestro della cinematografia. Devo dire che questa volta tra il
racconto e l’opera (confesso però di non aver visto tutti i lavori di Olmi, ma
solo quelli che comunemente si ritengono più significativi) la distanza è
minima. Potrei forse allargarlo io stesso come interprete, quando una scena o
l’altra diventassero ragioni di un’ermeneutica personale. Ma nessuno mi chiede
o ho bisogno di un “supplemento” del genere. Dunque l’intervista. Olmi ha un
suo sguardo sul mondo, e uno sguardo è molto di più di un “batter d’occhio”,
poiché seleziona, valorizza, circoscrive, amplia nei suoi significati e infine
proviene da un modo di guardare che può avere per sé molte differenze che qui
non sto a elencare. Per Olmi lo sguardo è quello della empatia affettuosa. Egli
dice che l’origine di questa qualità deriva dal primo sguardo d’amore che si
scambiarono suo padre e sua madre, condizione felice per il suo ingresso nel
mondo. Certo questa è una mitologia che appartiene alla serie ricchissima delle
mitologie delle origini. Ma per Olmi questa origine ha per destino personale la
sua ripetizione nel rapporto con il mondo. Una ripetizione non è una
eguaglianza logica, è la continuazione di uno stile profondo e determinante nel
modo di scegliere e di capire i quadri del mondo e di prendervi parte. Manzoni
nell’intervista che non sono nelle condizioni di poter ripetere nella sua
storia, ha colto benissimo questa tema come senso della interrogazione
sollecitante al suo intervistato. E Olmi narra le configurazioni artisticamente
affettive del suo itinerario di grande interprete dell’arte cinematografica. E
ogni configurazione è necessariamente un giudizio che nasce e si sviluppa nella
medesima trama narrativa che ha lo straordinario vantaggio di essere un
racconto e una lezione morale. Non so, ma dal punto di vista “evocativo” (che
pure ha un senso) può essere che l’esordio di Olmi come documentarista abbia
avuto la sua parte positiva. Il documentario è un saper vedere per trare un
senso, e in questa direzione può essere anche una educazione cinematografica.
Di qui il sospetto nei confronti delle sintesi intellettuali che fanno
precipitare l’esperienza in una autosufficiente e arida discorsività. Ora
dovrei seguire la felice intervista di Manzoni in tutta la ricchezza delle
domande che un po’ chiedono e un po’ anticipano rispetto alle risposte di
Ermanno Olmi. È un compito che non riesco a svolgere, preso come sono dalle
suggestioni del clima del dialogo. Mi colpisce l’affermazione di Olmi “Non sarei capace di fare un film dal punto
di vista femminile”. E lo capisco
bene: il punto di vista femminile può essere solo una costruzione (che bene non
riuscì nemmeno a Freud), non è lo sguardo che nasce dalla propria esperienza. È
un’altra sorgente di vita. Eppure, se non sbaglio, nei film di Olmi il
femminile più che un soggetto è sempre parte di un destino. L’intervista di
Manzoni segue l’opera di Olmi, ne sollecita l’interpretazione quasi in attesa
di un’eco più sicura e più forte da parte dell’autore. Scopro in questo
percorso la fratellanza tra Olmi e Fellini, sulle prime, per me piuttosto
inattesa. Eppure c’è, mi fece osservare proprio Manzoni, nel regista riminese
un fondo emotivo che elabora una distanza che non può mai essere l’ombra di un
“poter esserci” ancora e meglio, è questa è una nota anche di Olmi. Si tratta
di far cadere questa “nota” in uno spartito musicale piuttosto che in un altro.
Lo sguardo di Olmi è poi sulla forma dell’esistenza contemporanea. Il regista
appartiene con la sua sensibilità (che poi è la scelta delle immagini) alla
lunga schiera, a cominciare da Dostoevskij, degli autori che vedono nel denaro
e nei suoi effetti sociali, la decadenza delle possibilità di una vita umana
dove sia la reciproca empatia sociale in armonia con l’essere naturale, a
stabilire un equilibrio dei reciproci sentimenti. Un “dove” l’essere umano non
diventa una “merce di scambio”. Il modo di rammentare questa ingloriosa
metamorfosi dell’essere uomo, da parte di Olmi, è una scelta di situazioni dove
uomo, parola e ambiente hanno una loro risonanza che è sulla soglia del
perdersi negli abissi del tempo. So che a Manzoni dovrei anche un’analisi delle
sue perfette pagine sulla poetica di Olmi, mentre la lettura dei riassunti dei
film di Olmi (che conclude il libro) mi reca più che altro il dispiacere della
mia Ignoranza. Il libro è ottimo. Posso confessare quale desiderio ha fatto
nascere in me? Vorrei vedere e rivedere “L’albero
degli zoccoli”, e tentare un mio approccio ermeneutico che apparterrebbe a
una mia passione un poco nascosta. Ma, si sa, non sarà la sola cosa perduta.
 |
| La copertina del libro |
Ermanno Olmi con
Marco Manzoni
Il primo sguardo
Bompiani editore 2015
Pagg. 190 € 12,00
***
TEATRO
L'ECO
di
Luca Marchesini
(una
gabbia con dentro un pappagallo)
PAPPAGALLO
(con voce, ovviamente, da pappagallo)
Crah. Crah. Ciao. Tu non mi senti. Crah. Che bella giornata. Mi senti
ma non capisci. Che bella giornata. Hanno ragione loro. Hanno
ragione. La finestra in alto. Forse dico la verità. No la finestra
in alto. Loro non dicono la verità. Io. Loro non dicono la verità.
Ciao. Hanno ragione loro. Mi senti ma non capisci. Siamo rimasti
soli: tu e io. Siamo rimasti soli: tu e io. Crah. Crah. Loro gli
idioti. Loro gli idioti. Siamo rimasti soli: tu e io. Loro gli idioti
salvano il mondo. O lo perdono? O lo perdono? Che bella giornata. No
la finestra in alto. Resta un altro po': ti pago. Siamo rimasti soli:
tu e io. Ciao. Ciao. Io come un antico augure. Che cosa pensi se
pensi? Ciao. L'intelligenza non salva il mondo. Vediamo se è uscito
il caffè. L'intelligenza non salva il mondo. Io come un antico
augure. Crah. Resta un altro po': ti pago. Siamo rimasti soli: tu e
io. Che cosa pensi se pensi? Crah. Crah. Intelligenza:
consequenzialità. Intelligenza: consequenzialità. Vediamo se è
uscito il caffè. Gli idioti salvano il mondo: ma a che pro? Gli
idioti salvano il mondo. Vediamo se è uscito il caffè.
Intelligenza: consequenzialità. Ciao. Fanatici o nichilisti.
Intelligenza: consequenzialità. Ce ne dobbiamo andare, noi due. Io
come un antico augure. Gli ultimi spiccioli. Ce ne dobbiamo andare,
noi due. Vediamo se è uscito il caffè. Solo non ti lascio. Solo non
ti lascio. Se almeno si fosse fermata un altro po'. Gli ultimi
spiccioli. Il gas intanto continua a uscire. Io come un antico
augure. Fanatici o nichilisti. L'intelligenza non. Solo non ti
lascio. La finestra in alto. No la finestra in alto. Crah. Crah.
Crah.
 |
| Luca Marchesini
***
|
PER UN PRIMO APPROCCIO ALLA CONOSCENZA DI
GIUSEPPE ANTONIO ARENA
di
Antonio Cugliari
 |
| Giuseppe A. Arena |
Il
27 settembre del 2015 l’Amministrazione comunale di Acri ha dedicato uno spazio
con una targa toponomastica a Giuseppe Antonio Arena, politico, sociologo, giurista
e poeta. In quella occasione ho parlato brevemente non di Arena poeta, ma del
politico e del saggista, cercando di legare il suo pensiero agli attuali
problemi del Meridione. Ritenendo di fare cosa utile verso le nuove
generazioni, ho deciso di scrivere un breve saggio sulla figura di Giuseppe
Antonio Arena e su Parentela ed
emigrazione di Fortunata Piselli, omaggiando, nel generale silenzio
dell’intellettualità meridionale, quelle poche figure che si opposero e
descrissero i flussi migratori come la causa principale del sottosviluppo del
Sud.
Giuseppe Antonio Arena nasce nel 1935 in
Acri un paese montano ai piedi della Sila cosentina. Avendo dimostrato sin da
piccolo poco interesse alla vita pastorale, il padre con molti sacrifici
l’avviò allo studio. Frequentò le scuole inferiori in Acri, il liceo classico
nel collegio italo-albanese di San Demetrio Corone ed infine l’università a
Napoli, dove giovanissimo si laureò in giurisprudenza.
Fin da studente universitario inizia la
militanza politica nel Partito Comunista Italiano, dove ben presto ricoprì
ruoli di primo piano. Giuseppe Arena aderisce al partito per la sua origine di
classe, e poi perché gli anni Sessanta vedono la Calabria attraversata da
grandi lotte bracciantili per l’occupazione delle terre. Negli anni cinquanta
la lotta per la terra non aveva raggiunto gli obiettivi sperati: erano state
occupate soprattutto le terre demaniali, come in Acri la montagna di Pietramorella
e il latifondo era stato appena sfiorato. In altre parole gli “uccelli grifagni” di paduliana memoria, che
avevano usurpato le proprietà del demanio, dove i contadini esercitavano da
sempre gli usi civici, non subirono alcun danno.
In quel tempo nel Partito Comunista
Italiano si fronteggiavano due linee contrapposte: la linea sindacale che
voleva il prosieguo della lotta per l’occupazione delle terre; quella politica
che cercava di allargare il blocco delle alleanze verso gli intellettuali, i
ceti medi e quella parte della borghesia delusa dalla politica clientelare della
Democrazia Cristiana.
In altre parole, il Partito Comunista
Italiano non si opponeva con decisione all’emigrazione dei contadini
meridionali verso il Nord d’Italia ed alla loro trasformazione in proletari. L’
industria del Nord in pieno boom economico necessitava di una nuova forza
lavoro ed il P.C.I. non contrastò tale esigenza, convinto che la trasformazione
dei contadini in proletari alla fine sarebbe tornata a vantaggio delle forze di
sinistra.
Giuseppe Arena si schiera a favore delle
lotte contadine ed entra in contrasto con la linea ufficiale del Partito, impersonata
in Acri dal senatore Francesco Spezzano. Lo scontro tra la posizione del
sindacato e quella del Partito diventa dura anche a livello regionale e vede
schierati in netta contrapposizione il Segretario Regionale del Partito Paolo
Cinanni e Luigi Silipo in rappresentanza del movimento dei braccianti.
La collocazione di Giuseppe Arena era
dettata, in parte dalla sua origine di classe, ma anche dalla sua profonda
conoscenza della storia del Meridione; egli aveva ben chiari tutti i limiti del
Risorgimento italiano, che per il Sud si era risolto in una totale annessione
al Regno Sabaudo. E tutti i meridionali che avevano combattuto con Garibaldi e
posto l’esigenza della redistribuzione delle terre, alla fine del processo di
unificazione si videro delusi, e chi si oppose venne combattuto come brigante. Con
la feroce repressione del brigantaggio furono distrutte tutte le economie, le
culture, i mestieri dell’intero Meridione.
Alla fine dell’Ottocento la “questione meridionale” fu risolta, ma
risolta è solo un eufemismo, con l’emigrazione forzata nelle Americhe, e per
tutta la prima metà del Novecento l’emigrazione ha rappresentato la valvola di
sfogo delle tensioni sociali. Alla fine della seconda guerra mondiale la musica
è sempre la stessa: o emigrare oppure morire di fame!
Giuseppe Arena non accetta questo
fatalismo ed assieme a pochi intellettuali calabresi organizza la lotta e con
convinzione aderisce al Movimento Contadino per l’occupazione delle terre. Responsabile
del Movimento Bracciantile era, allora, Luigi Silipo esponente di primo piano
del Partito Comunista Italiano. Nei primi anni Sessanta la Calabria è
attraversata da grandi sommosse sociali e la lotta tra gli agrari e i contadini
si fa sempre più dura.
Inaspettatamente il primo aprile del
1965 Luigi Silipo viene assassinato a Catanzaro. Sulla sua morte violenta vennero
fatte diverse congetture: la tesi più accreditata fu quella della vendetta di
qualche agrario infastidito dalla sua attività sindacale; si è anche parlato di
forti contrasti all’interno del P.C.I., a tutti erano noti i continui litigi
tra Paolo Cinanni, responsabile regionale del Partito, e Luigi Silipo capo del
sindacato regionale dei braccianti. Sta di fatto che con la morte di Silipo la
lotta contadina si affievolisce; frattanto da Roma sta per scendere in Calabria
un grosso dirigente del Partito, non ricordo se Longo o Natta, a normalizzare
gli eretici calabresi come il senatore Luca De Luca, il professore Pugliese e
lo stesso Giuseppe Antonio Arena.
Nel 2012 la Casa Editrice Rubbettino ha
pubblicato sul “caso Silipo” il libro “Blocco
52”. Personalmente ho trovato il lavoro interessante, ma lacunoso circa la
responsabilità politica del Partito Comunista Italiano e di tutta la Sinistra, in
merito all’oblio su Silipo e sulla sua attività sindacale.
Ritengo che quell’oblio voluto e imposto
ha rappresentato il definitivo coperchio calato sulla questione meridionale e
su quei pochi intellettuali che allora si opposero alla proletarizzazione dei
contadini del Sud. E oggi persino un giornale borghese come L’ESPRESSO può
titolare che il Mezzogiorno è definitivamente scomparso dal dibattito politico
e dall’economia del Paese.
Dopo la morte di Silipo, Arena comprende
che la battaglia contro l’emigrazione e per la redistribuzione delle terre è
definitivamente perduta, inizia il progressivo distacco dal P.C.I., si
trasferisce a Napoli e si dedica all’insegnamento ed alla ricerca. E nello
studio e nella ricerca trasferisce tutti i suoi valori e i suoi sogni, mettendo
a nudo i problemi del Meridione e dei ceti subalterni di cui si sentiva carne
dello stesso corpo e con gli occhi e la mente sempre rivolti alla terra
d’origine. Rileggendo lo scritto “Il
Sannio tra mito e realtà”, non ho potuto fare a meno di comparare il Sannio
con la montagna Silana: indomiti e valorosi i sanniti che si opposero ai
romani; indomiti e valorosi i bruzi che per difendere la loro libertà si
allearono con Annibale contro Roma. Identica la vita agricola e pastorale, infatti
entrambi i popoli ricavavano la ricchezza dalla pastorizia e dall’agricoltura.
La pastorizia si basava sull’allevamento degli ovini e dei bovini, l’agricoltura
poggiava sulla granicoltura, sulla viticoltura e l’olivicoltura. Dall’allevamento
degli ovini si ricavavano i latticini e la lana, pertanto la pecora era il
principale sostegno dell’economia dei popoli montani. Oltre ai latticini ed
alla lana, dalla pastorizia si ricavavano altri prodotti come le pelli
destinati a diversi usi. Nel Sannio, come nel Bruzio, le greggi migravano in
autunno verso le pianure, per far ritorno in montagna a primavera. Durante
questi spostamenti definiti “tranzumanze” avvenivano gli scambi dei prodotti
tra i pastori e gli uomini delle marine. Non è sbagliato dire che Giuseppe
Arena con la penna scrive del Sannio e del Molise, ma la sua mente e il suo
cuore sono sempre rivolti alla terra d’origine.
Non è possibile in questo breve scritto
parlare di tutte le opere di Giuseppe Arena, forse lo farò in un lavoro
successivo, ora mi limiterò a trattare brevemente quelle opere che ritengo più
rappresentative del nostro personaggio.
Inizio con l’opera “Prima della ragione” che porta il sottotitolo “cultura e diritto del popolo
in Vico e Sorel”.
Va precisato che prima di Arena, anche
il Padula, nei suoi studi storici e politici, aveva studiato il Vico e il
pensiero napoletano del Settecento. Sulla traccia del Vico, il prete di Acri, rifiuta
lo sviluppo storico in senso lineare ed affronta il tema delle vicende umane, sia
nel loro sviluppo, che nella decadenza. In altre parole: prima con Padula e in
seguito con Arena, un popolo eredita costumi e idee da quello precedente e, pertanto,
l’inizio del ciclo di una civiltà coincide con la decadenza e la fine di un’altra
civiltà. In questa sua opera Arena evidenzia che mentre per Cartesio l’era moderna
è l’era della scienza e della ragione, il Vico e il Sorel, entrambi antirazionalisti,
si contrappongono a questa teoria e la loro critica a Cartesio sfocia nella
contestazione del dominio della ragione. Personalmente ritengo che le opere
migliori di Giuseppe Arena siano “Francesco
Longano: la rivolta di un abate” e gli scritti su Luigi Serio.
Francesco Longano fu discepolo del
salernitano Antonio Genovesi, che per primo fondò nell’Università di Napoli la
cattedra di economia. Ma mentre il Genovesi, pur contestando il vecchio sistema
economico, non arrivò alla sua completa condanna, ed anche il Filangieri non
era andato oltre le istanze d’ispirazione borghese, il Longano (Arena)
conferisce alla lotta antifeudale un carattere nuovo e rivoluzionario. Per
l’abate molisano, una volta abolito il vecchio sistema economico, occorre
realizzare una profonda trasformazione delle strutture fondiarie e creare una
nuova struttura fondiaria fondata sulla piccola azienda contadina. Con il
Longano, quindi, la polemica antifeudale sale di toni e di contenuti fino ad
arrivare alla contestazione di qualsiasi società fondata sul dominio di classe.
Il Longano ritiene che la concentrazione della proprietà terriera sia alla base
della miseria del mondo contadino, pertanto, se si vuole trasformare questo
modello, occorre abolire qualsiasi forma di rendita attuando il principio democratico
di dare la terra a chi la lavora.
Concludendo, posiamo dire che il Longano
coglie appieno tutti i fermenti che agitavano la scena politica europea del XVIII
secolo e che anche a Napoli e in tutto il Mezzogiorno incominciavano a prendere
piede.
Per questa lucida visione il pensiero
dell’abate molisano può essere, senza dubbio, associato a quello degli “Araldi
della libertà” come Emanuele De Deo, Mario Pagano, Domenico Cirillo, Eleonora
Pimentel, insomma a tutta quella intellettualità che più tardi darà il sangue e
la vita in difesa della Repubblica Partenopea.
Brevemente
parlerò dell’opera su Luigi Serio, a cui mi lega un caro ricordo: Arena, prima
di darlo alle stampe, m’inviò copia del lavoro con la seguente dedica “a Tonino
Cugliari per una sempre maggiore comprensione delle istanze autenticamente popolari”.
 |
| Alcune delle pubblicazioni scritte e curate da Arena |
Luigi Serio grande giurista e poeta, come
il Longano, fu discepolo del Genovesi, passò dalle file monarchiche a quelle
repubblicane e divenne una delle figure più celebri del 1799 per la profonda
avversione al governo borbonico. Nacque a Massaquano nel 1744 e morì a Napoli
il 13 giugno del 1799 a 55 anni, combattendo eroicamente al ponte della Maddalena
contro le bande sanfediste del cardinale Fabrizio Ruffo, pronunciando le ultime
parole d’incitamento alla lotta in verace dialetto napoletano. Di lui ci
restano numerose poesie e articoli di vario genere. Con Luigi Serio, Arena
affronta l’annoso e mai risolto problema del rapporto tra intellettuali e
popolo, tra cultura d’elite e cultura popolare, il rapporto tra lingua e
dialetto. Oggi, come ieri, l’uso dell’informazione e del linguaggio è alla base
del dominio di classe che si realizza attraverso i processi di manipolazione
sia giornalistico che televisivo. Luigi Serio nella polemica con il Galiani
rivendica al popolo e alle classi subalterne l’autonomia del proprio patrimonio
linguistico. Il dialetto del popolo, secondo il Serio, deve essere naturale e
spontaneo, privo di tutte quelle forme grammaticali auspicate dal Galiani. Dall’insegnamento
di Luigi Serio deriva che l’errore della borghesia napoletana e di tutti i
giacobini, errore che portò alla sconfitta della Repubblica Partenopea del 1799,
fu quello di non aver saputo legarsi al popolo, perché del popolo non parlavano
la lingua; operazione che invece riuscì alla reazione borbonica, e pertanto i
contadini poveri, le plebi, i lazzari, invece di combattere a favore della
Repubblica si allearono con le bande sanfediste.
Come Luigi Serio anche Giuseppe Arena
alla fine del percorso intellettuale si riscopre poeta. Viste deluse le
aspettative politico-sociali, il nostro concittadino si rifugia nel privato e
forse trova nella poesia il lenimento alle proprie ansie esistenziali.
Con i suoi versi Arena ci consegna un
ultimo prezioso dono: “ci offre un grande
messaggio rivolto ai valori universali dell’amore, della libertà, del diritto, della
pace ritenuti come speranza di salvezza individuale e collettiva”.
Allorché mi regalò il suo primo libro di
poesie “Pietre e rose” scrisse nella
dedica: “a Tonino Cugliari, affinché
scopra l’amore e la poesia, il marxismo e l’economia sono veleni”.
Il primo ottobre del 1982 giorno del mio
quarantesimo compleanno, da Varsavia dove spesso si recava, mi spedì come
regalo una bella poesia:
Tu
hai quarant’anni
Ossia
quattrocentottanta mesi
Ossia
quattordicimilaquattrocento giorni.
Cammini
impaurito per strada
Come
un bambino di quattro anni
E
meditabondo come un vecchio di oltre cento anni.
Fermati
un momento
E
non avere più apprensione
Poi
continua, pellegrino del giorno e della notte,
a
correre a piedi nudi
nelle
terre di fuoco, senza sosta,
accompagnato
dall’arcano chiarore dell’Orsa Maggiore.
Io
sarò al tuo fianco,
impavido
soldato delle tenebre e della luce,
assieme
ad interrogare l’enigma della storia
e
strappare il filo spinato dei confini del mondo.
Quasi presagendo la morte in una sua
ultima poesia così scriveva: “I poeti
muoiono prima del tempo/muoiono senza conforto/esalando come ultimo respiro/un
verso che si perde nel grande pianeta della vita”/
Giuseppe Antonio Arena muore
inaspettatamente “senza conforto” a
Napoli il 10 maggio 1995.
Trattando la figura di Giuseppe Arena ho
inteso rendere omaggio a quei pochi intellettuali meridionali che, con le
azioni e con le opere, si opposero alla scellerata politica dell’emigrazione.
Oggi è chiaro a tutti come i flussi migratori, dall’Ottocento ai nostri giorni,
siano alla base dell'abbandono del Sud e della profonda crisi in cui siamo
sprofondati.
 |
| Volume collettivo sugli anni Ottanta a cui prese parte anche Arena |
ALCUNI
SCRITTI SAGGISTICI DI GIUSEPPE ARENA
Stato
e diritto in Giuseppe Palmieri (1968)
Introduzione
allo studio di F. Longano (1970)
La
rivolta di un abate (1971)
De
Attellis e le antichità italiche (1974)
Gabriele
Pepe tra politica e storia (1977)
Luigi
Serio linguista e politico (1978)
L’elogio
di Gaetano Filangieri (1981)
Il
Molise nel 1848: società e politica (1981)
Luigi
Serio: risposta al dialetto napoletano dell’abate Galliani (1982)
Il
Sannio tra mito e realtà (1982)
L’utopia
nell’illuminismo napoletano (1982)
Prima
della ragione: cultura e diritto del popolo in Vico e Sorel (1983)
Potere
e partecipazione (1983)
Lineamenti
della figura e dell’opera di Vincenzo Padula (1983)
LAVORI
IN VERSI
Pietre
e rose di Litofago GA (1981)
Ombre
del giorno (1995)
Numerosi anche i sui scritti su giornali
e riviste.
***
FILOSOFIA
Luce Irigaray. La sfida di un pensiero
alternativo
Amante
marina. Friedrich Nietzsche: l’altra
faccia
della filosofia occidentale.
della filosofia occidentale.
di Carolina Frabasile
 |
| Carolina Frabasile |
Luce
Irigaray, filosofa e psicanalista francese, a partire dagli anni Settanta del
secolo scorso ha dedicato tutta la sua ricerca all’elaborazione e alla
creazione di un pensiero della differenza sessuale. La differenza tra uomo e
donna è imprescindibile, benché la cultura occidentale la occulti: la
differenza sessuale è il conoscersi, l’appropriarsi delle proprie
caratteristiche e, nel rispetto di esse, di quelle degli altri. La donna, a causa
dei condizionamenti subiti, non ha avuto alcuna chance di autonomia rispetto al
pensiero maschile. Tali condizionamenti derivano da strutture di pensiero
maschilista, sviluppate nella loro massima espressione da paradigmi filosofici,
religiosi e psicoanalitici che vedono il maschile come soggetto esclusivo del
discorso.
L’autrice decostruisce il
modello razionale e religioso che da Platone ad Aristotele, da Plotino a
Cartesio, via via fino all’attualità, ha imbrogliato e imbrigliato la cultura
occidentale entro un archetipo maschilista autoreferenziale e dimentico di
un’alterità anch’essa pensante. La filosofa, scandagliando la tradizione della
metafisica occidentale, rimprovera a tale modello culturale un atteggiamento di
prevaricante fallocentrismo che conduce la verità, strettamente identificata
con un logos analitico, unicamente
alla presenza nella coscienza, violentando l’alterità dell’assenza. La metafisica
è accusata di fallocentrismo perché in essa la ricerca della verità non
predilige un effettivo contatto con l’altro, rispettandone l’irriducibile
alterità, ma la metodologia che la caratterizza si preoccupa primariamente di
riportare la differenza al giogo o gioco identitario e autologico.
Il pensiero metafisico
occidentale, proprio come avviene nella sessualità fallica, dove il piacere è
esclusivamente limitato a finalità narcisistiche, nella totale non curanza
dell’altro, del partner, si reca incontro all’altro solo per violentarlo e
annientarlo, neutralizzandone la specificità al fine di dissolvere il ‘tu’
nell’ ‘io’.
 |
| La copertina del libro |
Nelle pagine
che compongono Amante marina. Friedrich
Nietzsche, Luce Irigaray si fa portavoce del genere femminile, mettendolo
in dialogo con l’alter generis simbolizzato
da Nietzsche, sposo della voce narrante e insensibile alle esigenze di
quest’ultima. Con uno stile poetico, l’autrice smuove la scala di valori
dell’ideologia occidentale, viziata da un maschilismo imperante e autoreferenziale
che adombra la figura della donna, mettendola a tacere fin da principio.
Attraverso l’utilizzo di
un’eloquente simbologia naturale, Irigaray evidenzia le diversità intercorrenti
tra i due generi sessuali, giocando con le antinomie presenti nella natura
stessa: sole/terra, giorno/notte, luce/buio. L’autrice si affida ad immagini
poetiche tratte dal repertorio degli elementi naturali per attribuire alle sue
parole una carica di emotività evocativa, quasi come se il monologo femminile
sia stato scritto per essere inscenato. Con Amante
marina. Friedrich Nietzsche, Irigaray muove una critica all’intero sistema
della filosofia occidentale, substrato su cui si erige il tempio del logos maschile come logica
autoriflessiva del medesimo.
L’imputato è il pensiero
fallocentrico, il quale è accusato dall’autrice di aver obliato l’altro da sé,
di aver sepolto l’altra per far trionfare la propria logica. La vittima è la
donna, soffocata dal sistema filosofico sopra citato.
Irigaray si fa portavoce
della differenza sessuale opponendosi alla ragione maschile che vuole
rinchiudersi in se stessa senza vie d’uscita, avendo subdorato la pericolosità
femminile che sta nell’introdurre nuove categorie nella filosofia, nel proporre
una logica sovversiva rispetto a quella vigente, nello scardinare quei principi
su cui pone le fondamenta il pensiero occidentale. L’impianto ideologico
maschile fiuta tale rischio e reagisce praticando un ermetismo inscalfibile
tale che mette a tacere qualunque proposta differente e contraria alla propria.
L’autrice combatte contro
la logica del medesimo e si confronta con Nietzsche per dare voce alla sua
riflessione. Perché proprio con Nietzsche?
La scelta è mirata poiché
Nietzsche nel panorama del pensiero occidentale ha tentato di scavalcare la
ragione, sottraendole quel primato attribuitole dagli albori della filosofia.
Il filosofo in Al di là del bene e del
male scrive che «ogni filosofia nasconde anche una filosofia; ogni opinione
è anche un nascondiglio; ogni parola è anche una maschera¹.»
 |
| Luce Irigaray |
Tuttavia
Irigaray rimprovera lo stesso filosofo di non aver colto la diversità dell’essere
donna, avendo lottato contro il logocentrismo senza però tenere conto della
differenza sessuale, presupposto indispensabile per inaugurare una nuova forma
di pensiero. L’opera rivisita alcuni grandi temi nietzschiani, letti attraverso
una nuova lente: una prospettiva al femminile che illumini l’alterità della
donna, rischiarandone l’immagine a lungo occultata. Ecco l’intento di Amante marina. Friedrich Nietzsche: proporre
una linea di pensiero alternativa a quella vigente, capace di andare oltre
l’autoreferenzialità, cifra distintiva della metafisica occidentale, per
inaugurare una forma di filosofia dialogica. Irigaray propone una modalità
noetica che situi al centro la dialogicità, rimpiazzando quell’atteggiamento
analitico che nega in partenza qualunque possibilità di discussione.
Il testo si apre con un
flusso di coscienza da parte della donna, la quale è costretta ad abbandonare
il suo compagno per rinascere, recuperando la libertà da tempo perduta e
facendosi finalmente beffe di quella schiavitù psicologica per la quale «non
essere di nessuno era uguale a essere niente (2)».
Nelle pagine di Amante marina Irigaray mostra come il
pensiero occidentale assumerebbe caratteristiche diverse se alla base di esso
ci fosse una logica egalitaria, all’interno della quale il sesso maschile e
quello femminile comunichino e contino a pari merito. Se così fosse l’intera
cultura moderna avrebbe caratteristiche sociali e teologiche differenti, la
donna ricoprirebbe un ruolo attivo e propositivo, senza apparire solo come
l’ombra di un super-uomo che architetta le strutture del mondo, interpretando e
intenzionando quest’ultimo a suo piacimento.
L’autrice analizza le
figure femminili e maschili presenti nella religione greco-romana e in quella
cristiana, concludendo che, malgrado si tratti di due tradizioni che fanno
perno su princìpi eterogenei, tuttavia condividano la stessa interpretazione
del ruolo rivestito dalla donna all’interno della società civile.
 |
| Friedrich Nietzsche |
Mettendo
a Confronto Atena, figlia di Zeus, e
Maria, madre di Gesù, è chiaro come la cultura occidentale da millenni
attribuisca alla donna una natura unilaterale che si esaurisce in quella
corporea a cui dà espressione una voce maschile. La dea maggiore nella
mitologia è Atena, la quale è l’alter ego
paterno, l’incarnazione della mente maschile che agisce nel mondo. Atena dunque di proprio ha solo una natura corporea,
neppure gestita da lei stessa, ma alla mercé del volere paterno. In questo
senso al femminile è riconosciuta una mera valenza fisica arricchita di
un’animazione spirituale che però deve discenderle dall’uomo: alla donna non è
concessa alcuna sorta di indipendenza noumenica poiché il suo ruolo è quello di
offrire materia al pensiero maschile per poter apparire ed operare. E se Atena
si opponesse alle istruzioni che riceve da Zeus? Si muoverebbe nel mondo agendo
secondo il suo stesso pensiero, libera di esprimere i punti di vista che le
appartengono, cessando di fungere da porta voce. Maria invece è da sempre
presentata come colei in cui si è incarnato il Verbo di Dio, la sua figura non
è mai stata analizzata decontestualizzandola dalla nascita di Cristo. Sembra
quasi che la donna sia nata appositamente per donare al mondo il figlio
dell’uomo, poiché ciò che si narra della sua vita è vincolato alla nascita di
Gesù: nei testi sacri non è raccontato un solo episodio che abbia Maria come
protagonista assoluta. Ma che ne sarebbe dei Vangeli se la madre di Cristo
facesse valere la sua interpretazione della Parola di Dio? La teologia
cristiana smetterebbe di mortificare il corpo e finalmente si risolverebbe
l’antinomia corporeità/anima, concependo l’essere umano come una realtà
monadica in cui convivono pacificamente la materia e lo spirito.
 |
| Ritratto di F. Nietzsche |
Irigaray sfida il pensiero
maschile, interrogandosi su che connotati assumerebbe la tradizione
socio-religiosa occidentale se al genere femminile venisse accordata la
possibilità di interagire con l’altro sesso, di discutere con esso. L’autrice
non auspica la prevaricazione del femminile sul maschile, ma si batte per una
dia-logicità tra i generi per interdire finalmente la paralisi monologica
maschilista che pervade la nostra cultura.
L’autrice decostruisce il
sistema socio-filosofico occidentale, ponendo le basi per un pensiero
alternativo in cui il maschile e il femminile cooperino senza aver la pretesa
di sopraffarsi, nel rispetto dell’alterità reciproca.
Irigaray non ha
l’obiettivo di appiattire la differenza sessuale anzi, vuole acuirla affinché
l’uomo e la donna ottengano piena coscienza di sé attraverso il confronto con
un’alterità mai del tutto permeabile e conoscibile.
Note
1. F. Nietzsche, Al di là de bene e del male, 289, Adelphi, Milano, 1968
2. L. Irigaray, Amante marina di Friedrich Nietzsche, Sossella, Roma, 2003, p. 8
Luce Irigaray
Amante marina di
Friedrich Nietzsche
Luca Sossella editore, Ed. 2003
Pagg. 154, € 15,00
***
LIBRI
IRACCONTI DI GIORELLO
di Giuseppe
O. Longo
Il 16 dicembre 2015 si è svolta a Milano, al Circolo
Filologico Milanese, una presentazione incrociata di due libri: Il fantasma e il desiderio di Giulio
Giorello, presentato da Giuseppe O. Longo, e Antidecalogo, di Giuseppe O. Longo, presentato da Giulio Giorello.
Qui si riporta la presentazione fatta da Longo del libro di Giorello.
 |
| Giulio Giorello |
Nel delizioso racconto giovanile Il fantasma di Canterville (The
Canterville Ghost, 1887), Oscar Wilde ci narra delle angherie cui è
sottoposto un vetusto e dignitoso fantasma inglese da parte di due implacabili
e cinici gemelli americani, che ai fantasmi non credono affatto e che con il
loro scanzonato scetticismo portano lo spettro, che evidentemente esiste, alla
disperazione.
I cinque racconti che compongono questo libro di
Giorello sono improntati a un misurato razionalismo positivistico che, pur
mettendoci in guardia contro le suggestioni troppo facili, tuttavia non
disdegna di adottare quella che lo scrittore svizzero Peter Bichsel chiama “la
sospensione dell’incredulità”, senza la quale ogni racconto viene distrutto
dall’acido corrosivo dello scetticismo, impedendoci di godere di quella che è
la vocazione per eccellenza dell’uomo: la narrazione.
Ciascuno di noi, dalla nascita alla morte, non fa che narrare, narrarsi e farsi
narrare un seguito incessante di storie, e l’esito di questo infinito narrare è
la costruzione di un mondo semplificato, misto di fantasia e di realtà, più a
misura d’uomo, in cui stiamo meglio che nel mondo dato, troppo complicato e
impegnativo o, a volte, banalmente piatto.
In questo libro la sospensione dell’incredulità è
temporanea, e l’autore - con una certa qual crudeltà - riveste subito i panni
dello scettico, a mo’ del suo maestro spirituale Spinoza, protagonista del
primo racconto, L’uomo di Gorcum. Se
l’incredulità di Spinoza-Giorello ci riporta con i piedi per terra, rischia
anche di toglierci quel sottile piacere, quel brivido di suggestione psicosensuale,
quell’impalpabile godimento venato di masochismo che sempre si associa alla
costruzione di un mondo fantastico e inquietante. E che importa se quel mondo
non “esiste” nel senso comunemente associato a questo predicato? Anche le cose
che non esistono, come nota Edmondo De Amicis nella prefazione al volume Il diavolo di Arturo Graf, hanno una
forza immensa: come si spiegherebbero altrimenti i comportamenti bizzarri o
addirittura insensati, ma realissimi e a volte sanguinosi, adottati dagli
adepti di certe sette e religioni in base alle loro infondate credenze? Si
aggiunga poi che, a quanto pare, noi siamo fatti per credere: dice infatti
Giulio Giorello che “dai racconti sugli spiriti si capisce come gli uomini non
vogliono narrare le cose come sono, ma come le desiderano”, restando
impregiudicato il significato di quel “come sono” (poiché la realtà è
inattingibile, ciò che ci appare è sempre il frutto di un compromesso tra
oggetto e soggetto).
In effetti il mistero è sempre più suggestivo della
sua soluzione: la spiegazione, proprio perché ha esorcizzato e smontato il
mistero, ci lascia davanti alle ceneri fredde di quello che era stato un
incendio affascinante. In fondo noi corteggiamo sempre l’indicibile, che è
-paradossalmente- l’unica cosa di cui ci preme parlare: e se e quando
l’indicibile diventa dicibile non c’interessa più, perché ormai è detto. Nei
libri gialli lo scioglimento è sempre deludente e comunque inferiore alle
aspettative dolcemente tormentose, specie in quelli che offrono una soluzione
che si sarebbe potuta ricavare dagli indizi sapientemente disseminati
dall’autore. Penso ad Agatha Christie, mentre del tutto diversi sono i romanzi
di Simenon, in cui il commissario Maigret corteggia l’indicibile senza mai
prendere una posizione definita e alla fine la soluzione offerta non è quasi
mai la conseguenza imprescindibile di un meccanismo ben oliato, ma si ha la
sensazione che sia uno dei possibili esiti di una serie di contingenze: forma
aperta, che lascia al lettore una libertà interpretativa e costruttiva che
somiglia molto all’atteggiamento che ci obbligano ad avere i casi della vita,
semplici e indecifrabili.
La delusione che ci procura la spiegazione del mistero
(che cessa di esser tale) è bene illustrata da un racconto che Giacomo Leopardi
riporta nei suoi Pensieri:
Questo che segue, non è un pensiero, ma un racconto, ch’io pongo qui
per isvagamento del lettore. Un mio amico, anzi compagno della mia vita,
Antonio Ranieri, giovane che, se vive, e se gli uomini non vengono a capo di
rendere inutili i doni ch’egli ha dalla natura, presto sarà significato
abbastanza dal solo nome, abitava meco nel 1831 in Firenze. Una sera di state,
passando per Via buia, trovò in sul canto, presso alla piazza del Duomo, sotto
una finestra terrena del palazzo che ora è de’ Riccardi, fermata molta gente,
che diceva tutta spaventata: ih, la fantasima! E guardando per la finestra
nella stanza, dove non era altro lume che quello che vi batteva dentro da una
delle lanterne della città, vide egli stesso come un’ombra di donna, che
scagliava le braccia di qua e di là, e nel resto immobile. Ma avendo pel capo
altri pensieri, passò oltre, e per quella sera né per tutto il giorno vegnente
non si ricordò di quell’incontro.
L’altra sera, alla stessa ora, abbattendosi a ripassare dallo stesso
luogo, vi trovò raccolta più moltitudine che la sera innanzi, e udì che
ripetevano collo stesso terrore: ih, la fantasima! E riguardando per entro la
finestra, rivide quella stessa ombra, che pure, senza fare altro moto, scoteva
le braccia. Era la finestra non molto più alta da terra che una statura d’uomo,
e uno tra la moltitudine che pareva un birro,
disse: s’i’ avessi qualcuno che mi sostenessi ‘n sulle spalle, i’ vi monterei,
per guardare che v’è là drento. Al che soggiunse il Ranieri: se voi mi
sostenete, monterò io. E dettogli da quello, montate, montò su, ponendogli i
piedi in su gli omeri, e trovò presso all’inferriata della finestra, disteso in
sulla spalliera di una seggiola, un grembiale nero, che agitato dal vento,
faceva quell’apparenza di braccia che si scagliassero; e sopra la seggiola,
appoggiata alla medesima spalliera, una rocca da filare, che pareva il capo
dell’ombra: la quale rocca il Ranieri presa in mano, mostrò al popolo adunato,
che con molto riso si disperse.
Non si può non credere che nel molto riso del popolo
vi fosse, oltre al sollievo, anche una punta di frustrazione!
Nei suoi racconti, Giorello esita tra il razionalismo
alla Spinoza e la nostalgia della credulità (come in Le foglie della Sibilla, titolo che richiama un distico del XXXIII
canto del Paradiso): perché, come nota l’autore nel Prologo, forse non siamo noi che diamo vita ai nostri fantasmi,
bensì da loro prendiamo vita, cedendo -sottilmente- al desiderio di desiderare di credere in essi. Su questo desiderio del
second’ordine si basa l’adesione, sia pure provvisoria, che ci suscitano i
racconti dei grandi maestri anglosassoni: Joseph Sheridan Le Fanu (1814-1873) e
Montague Rhodes James (1862-1936), che l’autore prende a maestro e donno. Altrettanto
magistrali sono peraltro i racconti di fantasmi dovuti alla penna di Henry
James (1843-1916), tra cui memorabile per la sua impalpabile evanescenza Il giro di vite (The Turn of the Screw, 1898), e di Edith Wharton (1862-1937).
Se, come annuncia il titolo, i fantasmi -questi
ectoplasmi diafani ed elusivi, queste apparizioni quasi sempre serotine o
notturne e quasi sempre drappeggiate in bianchi sudari- se gli spettri sono,
sotto una forma o l’altra, i protagonisti dei cinque racconti del libro, è
anche vero che non tutti i fantasmi che vi appaiono (è il caso di dirlo) ne
hanno i connotati classici. Alcuni si rivelano volgari impostori (L’uomo di Gorcum), altri conservano il
loro statuto di spiriti capaci di influire sulla realtà materiale tramite
l’equivalente fantasmatico ma concretamente marmoreo di una ghiandola pineale a
forma di spada (L’angelo geloso),
oppure si materiano in effigi granguignolesche (La testa di moro), o scaturiscono dalle profondità abissali di
deliri matematici che a volte sono più pericolosi e gravidi di conseguenze
nefaste per l’equilibrio mentale che non i vaneggiamenti delle cantafavole (Le foglie della Sibilla), o infine
rivelano una natura tutt’altro che spettrale e si dimostrano capaci e vogliosi di
fornicare e di uccidere (Fuoco nella
pianura).
Gli aspetti ironici, parodistici e addirittura comici
irrompono nei punti dove la tensione narrativa rischierebbe di trascinare il
lettore all’interno di una credulità troppo corriva, agevolata dalla
suggestione di certe atmosfere e di certi ambienti (la locanda del Tapiro Rosso dove alloggia l’io narrante
delle Foglie della Sibilla o il
Palazzo stregato, pregno di lascivia, di Fuoco
nella pianura). Insomma, l’autore è sempre pronto a invitarci a una seduta
spiritica salvo poi rivelarci che si tratta in effetti di una bevuta in
compagnia.
Può tuttavia sorgere il dubbio se i fantasmi siano,
come ho affermato sopra, i veri protagonisti del libro: un’altra
interpretazione possibile è che il vero protagonista sia il corpo. A volte si tratta di un miserevole
nano che corre per la campagna all’imbrunire su un paio di trampoli per piegare
l’incredulità di Spinoza (L’uomo di
Gorcum), oppure di una creatura mostruosa, un vero e proprio sgorbio dalla
testa gigantesca issata su un corpicciuolo rachitico e nascosto da un saio (Fuoco nella pianura); a volte si tratta invece
del corpo di una donna non più giovanissima, ma ancora formosa e desiderabile,
che si abbandona ad amori servili (La
testa di moro). Nell’ultimo racconto (Fuoco
nella pianura) il corpo diventa primo attore indiscusso, presentandosi
nelle forme della bella archivista, obbligata a portare una seducente
giarrettiera dal nastro rosso e colta in momenti di solitaria intimità e
nudità; nella figura di donna che compare in un quadro, nuda e accovacciata in
mezzo alla campagna, in una posa quanto mai provocante; e infine nell’arciere,
l’orrendo gnomo macrocefalo coperto dal saio, di cui ho detto e che si rivelerà
un turpe stupratore e assassino.
Del resto non stupisce che il corpo sia comunque e
sempre il protagonista, poiché noi siamo
il nostro corpo: nasciamo, cresciamo, godiamo, soffriamo e moriamo con e nel
corpo, che resta il baluardo ultimo della nostra identità (non è un caso che le
prospettive aperte dal post-umano siano più meno tutte variazioni sul tema del
corpo e delle sue trasformazioni). Nell’Angelo
geloso si narra della morte dello scrittore Peter George, il cui corpo è
trafitto dalla spada di marmo dell’angelo, e nelle Foglie della Sibilla è il corpo del matematico Corrado Bozzolo che
viene ritrovato in mare, straziato dagli scogli, smangiato dai pesci e
squarciato da qualche altra entità cui, ovviamente, ci rifiutiamo di credere.
Queste aperture sugli aspetti raccapriccianti e
cruenti legati alla corporeità fanno pensare a Edgar Allan Poe (1809-1849) e
soprattutto allo scrittore che forse più d’ogni altro ha descritto l’orrore che
da un istante all’altro potrebbe scaturire dalla realtà in apparenza innocua
che ci circonda: Howard Phillips Lovecraft (1890-1937). Ma non si possono
trascurare altri interpreti delle infinite variazioni sul tema del corpo:
Ernesto Teodoro Amedeo Hoffmann (1776-1822), con i suoi racconti di meravigliosi
automi, in particolare bambole meccaniche talmente perfette da ingannare i
giovanotti che di loro s’innamorano perdutamente (ma Hoffmann di solito spiega
l’arcano o vi allude, palesando i trucchi della meccanica onirica e tenebrosa
che sta dietro le sue creature artificiali); Mary Wollstonecraft Shelley
(1797-1851), che nel suo straordinario romanzo gotico Frankenstein, o il moderno Prometeo
(nelle varie edizioni del 1818, 1823, 1831) imposta il tema del corpo e
della vita secondo le teorie scientifiche allora dominanti, basate
sull’elettricità come motore dei fenomeni vitali: tanto celebre fu questo
romanzo da entrare nell’immaginario collettivo e da spingere la (pseudo)cultura
popolare a usare il nome del protagonista, il barone Victor Frankenstein, per qualificare
in negativo certi prodotti della tecnologia attuale.
Anche la robotica attuale si misura ovviamente con il
corpo, e mi preme qui accennare al concetto di perturbante, introdotto da Ernst Jentsch (1867-1919) e analizzato a
fondo da Sigmund Freud nel suo trattato Das
Unheimliche (1919). Il perturbante è, detto assai rozzamente, ciò che
caratterizza il nostro atteggiamento di fronte a certi oggetti o situazioni che
sono insieme familiari ed estranei: come davanti a una figura ambigua, che si
offre a due interpretazioni percettive diverse, tra le quali non si sa
scegliere. Il tema del perturbante è stato introdotto in robotica nel 1970 dallo
studioso giapponese Masahiro Mori, il quale ha sostenuto, plausibilmente, che
al crescere della somiglianza che un robot umanoide presenta con un essere
umano, la nostra “simpatia” per il robot aumenta. Ma se la somiglianza supera
un certo livello, entriamo in uno stato di confusione, poiché da una parte vediamo che si tratta di qualcosa che ci
somiglia e al quale dunque siamo portati ad attribuire caratteristiche umane,
dall’altra sappiamo che si tratta di
un artefatto, al quale dunque non possiamo attribuire caratteristiche umane. A
questo punto la nostra simpatia subisce un calo improvviso e questa caduta è
stata chiamata da Mori avvallamento del
perturbante (Uncanny Valley in
inglese). Se poi la somiglianza continua a crescere, l’avvallamento si supera e
la simpatia torna a crescere. Resta da vedere se queste idee si possano
applicare ai fantasmi, agli spettri e alle apparizioni.
 |
| La copertina del libro |
Chiude il libro di Giorello un sostanzioso Epilogo, intitolato Spettri scarni e altro, in cui si propone, come rimedio sovrano
contro le visioni e gli incubi notturni, la birra, il porto e il whiskey.
Protagonista indiscusso di queste ultime pagine è Montague Rhodes James, che l’autore
assume come... spirito guida nel suo percorso attraverso le strade inquietanti
che serpeggiano dai cimiteri campestri delle brughiere inglesi o irlandesi alle
mura dei castelli danesi. A proposito: se lo spettro del defunto Re non è visto
solo da Amleto, ma anche da altri, si tratta di un’allucinazione collettiva
oppure di una prova di realtà? A suffragare la seconda ipotesi stanno le
rivelazioni del fantasma sulle circostanze della propria morte, benché si possa
far credito agli spettri di possedere cognizioni che non richiedono l’attributo
della realtà. In fondo se, come predica Berkeley, esse est percipi, ogni apparizione esiste in quanto tale, e,
ignorando le sottigliezze filosofiche, il fantasma dell’opera shakespeariana agisce
senza bisogno di esistere nel senso usuale, e banale, del termine.
Citando il racconto Una vista dalla collina di James, Giorello accenna alla possibilità
che certi strumenti ottici consentano di scorgere oggetti che a occhio nudo non
si vedono: allora esistono o non esistono, questi oggetti? Non può non venire
in mente la tecnologia della realtà
aumentata, in cui la visione offerta da occhiali speciali giustappone
alcune informazioni supplementari agli oggetti contemplati: una mirabile
conferma di quanto sosteneva Borges, cioè che il mondo è arricchito dalle
finzioni. Un mondo consistente nei soli oggetti concreti sarebbe ben misero e
ciò consente all’autore di motivare la propria giudiziosa posizione di scettico moderato, che rifugge dagli
opposti estremismi del vero credente e dello scettico integrale. Se per i suoi
preconcetti lo scettico integrale si nega le gioie e i brividi che offrono le
infinite sfumature possibili della realtà, il vero credente sviluppa
l’ossessione delle prove inconfutabili, magari basate su misurazioni di campi
elettrici e magnetici e su registrazioni video e audio, e, procedendo da
preconcetti opposti a quelli dello scettico integrale, ma altrettanto
incrollabili, elimina ogni sorridente ironia dalla realtà in cui vuole credere e si rintana in una inospite
caverna fattuale, attrezzata con le inossidabili apparecchiature dei cacciatori
di fantasmi. Che cosa poi sia la realtà resta uno di quei misteri che, come
dice George Steiner, rendono la vita degna di essere vissuta... L’ultimo grido
della moda, propugnato dai corifei della filosofia digitale, afferma che
l’essenza del reale è l’informazione: non bosoni e fermioni, non quarks e
leptoni, bensì sciami di bit animati da un’incessante computazione. In questa
visione l’Universo è un Grande Computer e Dio, smettendo i panni antiquati del
Grande Architetto e del Grande Orologiaio, diventa il Grande Programmatore.
Adottando l’informazione come principio primo, forse
si potrebbe affrontare il problema dell’immortalità dell’anima individuale in
modo nuovo: a meno che non finiscano in un buco nero, i bit non si distruggono
e quindi l’anima (necessariamente composta di bit) sopravvivrebbe alla morte
del corpo (altro aggregato di bit) e vagherebbe negli spazi siderali stimolata
dalla computazione di fondo, fino a trovare, per una felice o infelice
combinazione, un corpo in cui reincarnarsi: un corpo da animare proprio nel momento dell’incontro tra ovulo e spermatozoo. Chissà
se questa versione vagamente platonica dell’immortalità dell’anima sarebbe
stata accettata anche da Spinoza?
[Gorizia 25-26 dicembre 2015]
Giulio Giorello
Il fantasma e il desiderio
Mondadori, Milano, 2015
pagg. 120, € 18,00
***
LA CADUTA
DELL’IMPERO
di Gabriele Scaramuzza
 |
| La copertina del libro |
Non ricordo bene quando
ho conosciuto Fulvio Papi. O meglio, l’unica data certa è il 13-14 maggio 1967, a Reggio Emilia, in
occasione del Convegno di Studi Banfiani, di cui furono poi pubblicati gli Atti
col titolo Antonio Banfi e il pensiero
contemporaneo da La
Nuova Italia a Firenze nel 1969. Lì c’era sicuramente Papi, e
c’ero io; ricordo soprattutto il viaggio comune di ritorno verso Milano in
macchina, con sua moglie e Egle Becchi. Non risulta invece comprovata dai fatti
(e dai ricordi più circostanziati di Papi) la mia ipotesi (tenace) di averlo di
sfuggita incontrato prima, a Milano,
negli anni attorno al 1962,
in cui preparavo la tesi e dopo di essa continuavo a
occuparmi di Banfi. Frequentavo la casa di corso Magenta 50, dove ancora viveva
la vedova Daria
Banfi Malaguzzi.
I
primi scritti di Papi che ho letto, e mi sono rimasti impressi, sono La politica nel pensiero di Antonio Banfi
e Biografia - sul numero 43-44 di
“Aut aut” del gennaio-marzo 1958 (rispettivamente pp. 81-92 e 93-97) dedicato a
Banfi pochi mesi dopo la sua morte. E naturalmente poi ci fu la lettura, non
poco impegnativa per me, fu Il pensiero
di Antonio Banfi (edito da Parenti, Firenze 1961), indispensabile per la
mia tesi, e tuttora insostituibile per qualsiasi approccio a Banfi. Ho poi
sempre letto innanzitutto gli scritti, numerosi, e comunque imprescindibili,
ripetutamente dedicati a Banfi, fino a Antonio
Banfi. Dal pacifismo alla questione comunista, e fino alle ultime testimonianza
anche solo orali. Ho sempre tenuto presenti poi gli scritti concernenti gli
allievi di Banfi - da Vita e filosofia
(in cui per primo conia il termine “La scuola di Milano”, cui poi tutti noi
ricorreremo) a Gli amati dintorni e La memoria ostinata: relativi innanzitutto a Cantoni, Paci, Preti,
e in seguito a Anceschi, Formaggio, Bonfanti; da ultimo a Sini, Neri, che anche
di Banfi in anni più tardi sono stati allievi. Mi sono stati di grande aiuto
gli scritti, più ampi e pregnanti, ripetutamente dedicati alla poesia di
Antonia Pozzi e di Vittorio Sereni. E quelli volti all’arte, dalla letteratura,
alla poesia: dai saggi di filosofia dell’arte contenuti in La parola incantata al Dialogo
sulla poesia con Tomaso Kemeny, agli scritti sull’architettura. La passione della realtà, collegato già
nel sottotitolo al tema del fare, del farsi filosofia, l’ho collegato
indirettamente a Formaggio, alla base
della cui estetica sta il tema del fare. Oggetto di desiderio e di rimorso
resta invece tuttora per me Dalla parte
di Marx. Per una genealogia dell’epoca contemporanea, che mi ha subito
attratto, che ho scorso, ma non ho avuto finora modo di leggere interamente.
Tra
le altre opere lette, che mi hanno sollevato fertili interrogativi, ricordo
innanzitutto Le grandi confessioni e il
nulla e La biografia impossibile.
Già il loro titolo mi ha posto problemi, ma insieme da essi ho tratto utili
insegnamenti, di cui mi sono immediatamente appropriato, non so con quanta
legittimità.
E
non voglio tralasciare di menzionare qui gli scritti più letterari, la cui lettura
è quindi più agevole: L’albero d’oro.
Un’adolescenza immaginata, e Il
delitto del Miralago. Un’infanzia sotto il duce. Da ultimo mi è caro
menzionare Il lusso e la catastrofe,
impegnato su temi di grande attualità, la cui pregnanza mi si è rivelata anche
assistendo alla Scala a CO2 di
Giorgio Battistelli.
Il
pensiero di Fulvio Papi mi è di stimolo da anni, vuoi nel senso che ha trovato
consenso in me, vuoi nel senso che mi ha suscitato domande. È stato spesso
oggetto implicito di dialogo tra me e me, più di una volta ho cercato di confrontarmici,
non so con quanta cognizione di causa. Gli scritti di Papi non sono mai
semplici, tanto meno scontati; danno molto da pensare; almeno a me, ogni
lettura lascia sempre il dubbio di non aver afferrato tutto fino in fondo. Mi
sono tracciato personali vie d’accesso al suo pensiero, per orientarmici a modo
mio. Mi limito ora a pochi spunti cui ho fatto ricorso per avvicinarmi ad esso.
Il
primo riguarda un’affermazione di Enzo Paci
riferita a Banfi - che ritrovo nel suo Antonio Banfi vivente (in “Antonio Banfi e il pensiero
contemporaneo”, Firenze, La
Nuova Italia , 1969, p. 37): “Lo
scarto tra realtà e ragione, e quindi la dialettica -lo diceva espressamente e
molto spesso- fu la sua esperienza personale di una situazione storica vissuta
nella sua tragicità e nella sua realtà”. Dove sottolineerei il tono, per solito non rilevato (la personalità di
Banfi è vista per lo più come dominata da un incauto ottimismo), in cui a
parere di Paci è vissuto da Banfi quello “scarto”. Non ascriverei mai al pensiero
di Papi alcuna forma di ottimismo; mi ha sempre attratto il suo sguardo lucido,
disincantato, cui faccio spesso ricorso chiedendogli pareri non solo su
questioni filosofiche ma anche su problemi attuali. Quel suo “prender le cose
alle radici” (così me lo figuro), del tutto alieno da ogni luogo comune, mi è
sempre stato prezioso. Il termine “tragico” non mi sembra appartenga al suo
lessico, Papi non vi ricorre quasi mai (e non so se sia contento che qualcuno
vi ricorra parlando di lui); e tuttavia è ben consapevole di risvolti della
nostra esperienza vissuta che non saprei definire se non come tragici.
Il
secondo spunto si riferisce alle critiche di Banfi a quelle che chiama, nei Principi di una teoria della ragione, “teorie di un principio
reale del conoscere”, che postulano un “valore ontologico” del discorso, un’ immediata
aderenza delle parole alle cose. Di qui il trascorrere dell’attenzione di Banfi,
al di là di ogni realismo, dal “mondo della vita” al mondo del suo costruirsi
nelle forme della cultura. A questo proposito mi sembra pertinente ricordare i
bellissimi appunti di Banfi Sulla conoscenza
intuitiva,
pubblicati da Guido Neri (sul n. 54 di “aut aut”, novembre 1969, pp. 363-376). Non
a caso la filosofia di Banfi si delineerà negli anni Trenta essenzialmente come
una filosofia della cultura e non tout-court della vita.
Entrambi
questi spunti mi hanno aiutato a entrare meglio nel pensiero di Papi; o, quanto
meno, questa è stata per me uno strumento (non so quanto corretto) per
accostarmi al suo mondo. Mi ha colpito da subito in lui (traduco con parole sommarie)
il concentrarsi del suo pensiero sui percorsi mediante i quali “il reale” si
costituisce in mondi simbolici; come riflessione dunque, più che sul suo darsi,
sulle vie del suo costruirsi, che affonda le proprie radici nei contesti storico-temporali
da cui ha tratto alimento.
L’appannarsi
dell’orizzonte ontologico del pensiero, lo scollarsi delle parole dalle cose,
l’ho vissuto come qualcosa che mi riguarda. E ha come risvolto la disgregazione
dei valori che da quell’orizzonte traggono linfa. Proprio a questa “crisi”,
quale si delinea nel periodo della decadenza dell’impero asburgico, Papi dedica
tra le più affascinanti riflessione della sua tersa e fertile terza età.
Certamente,
nella mia ottica, sullo sfondo lontano dell’interesse di Papi per il tema della
“crisi” agiscono le riflessioni di Banfi; anch’esse risalgono agli anni tra le
due guerre mondiali in cui escono le grandi opere di Broch, Musil, Roth, Svevo,
pur così diverse per atmosfere, figure e temi dal mondo banfiano. Non è un caso
che alla “crisi” Banfi dedichi le importanti riflessioni degli anni 1934-35,
consegnate in appunti da poco riediti: dopo una prima pubblicazione da Scheiwiller
nel 1967, ormai introvabile, sono ora disponibili, con la prima prefazione di Carlo
Bo e le nuove postfazioni di Fabio Minazzi e Fulvio Papi, nella riedizione
apparsa da Mimesis nel 2013. Mi piace pensare che non sia casuale che
l’interesse di Papi per la “crisi” (del resto serpeggiante nelle sue opere da
sempre) sia riemerso in modi pronunciati in anni più o meno coevi alla
ripubblicazione degli scritti di Banfi sul tema.
In
quest’ambito si colloca l’ultimo libro di Papi, che voglio qui segnalare: Il poeta, l’Impero, la morte (ediz.
Ibis, Como-Pavia, 2015). Oggetti ne sono soprattutto Hermann Broch, cui è dedicata
più della metà del volume; ma insieme una sottile attenzione è rivolta a Josef
Roth e a Italo Svevo. Sullo sfondo delle sue riflessioni è ben presente Robert
Musil, sui cui uscirà presto da Mimesis un libro a sé stante. Tutte le opere prese
in considerazione da Papi -da I
sonnambuli a La marcia Radetzky a
La coscienza di Zeno, per non dire di
L’uomo senza qualità- hanno visto la
luce allorché l’impero asburgico è ormai alle spalle. Con un senso di nostalgia
da parte di alcuni, e di liberazione da parte di altri soprattutto in Italia.
Le
pagine più impegnative e dense sono quelle su Broch, non solo su I sonnambuli, ma anche su La morte di Virgilio. Avevo apprezzato,
pro domo mea, la predilezione di Broch per Kafka, sapevo però della su grande
attrazione per Joyce. Nell’insieme, per me nuove e affascinanti sono state le
pagine dedicate ai rapporti tra Broch e Joyce, al saggio su James Joyce e il presente (disponibile
nella nostra lingua in “Poesia e conoscenza”, a cura di Saverio Vertone,
prefazione di Hannah Arendt, Lerici, Milano, 1965, pp. 229-263) e in
particolare alla presenza di Joyce in La
morte di Virgilio.
Di
Roth sono presi in considerazione La
marcia di Radetzky e, meno, La Cripta
dei Cappuccini. Interessante, e nuova per me, è l’attenzione di Papi per la
ricezione di Roth in Italia, e a Milano in particolare: “L’opera di Roth
racconta un ambiente lontano dal contesto letterario in cui l’esperienza dei
giovani della Milano degli anni Trenta poteva specchiarsi”. Come noto, in quel
contesto predominante era il fascino di Tonio
Kröger e di La montagna incantata
(a quei tempi non ancora magica). A
Milano le opere di Roth erano lette soltanto come un racconto realistico e
‘commovente’”. E del resto in linea generale la lettura di Roth in Italia era
segnata più dall’ammirazione per il grande scrittore che non dalla sua nostalgia
per gli Asburgo. Così in Svevo non vi sono nostalgie del passato imperial-regio:
egli era “certamente filo-italiano”, e considerava “la scomparsa dell’impero
asburgico come un evento storico inevitabile e positivo che avrebbe consentito
la libera determinazione” dei popoli che di quell’impero erano stati parte.
Le
inarrivabili analisi di Papi coinvolgono lateralmente la letteratura triestina
(da Stuparich all’Anonimo Triestino a Fausta Cialente). Colpisce il clima
generale di disgregazione dei valori, di caduta di senso presente nelle pagine
di Papi, l’atmosfera del mondo triestino da lui amato che in fondo tutto
avvolge, anche laddove di Triste non si parla. Le pagine di Papi -last but not
least- contengono infine indispensabili chiarimenti circa il clima culturale
che avvolge La coscienza di Zeno. Tra
questi segnalo le notazioni sulla temperie socio-economico di Trieste, il tema
della coscienza (con netti riferimenti a Kant e a Hegel), il ruolo dei rapporti
con la psicanalisi. A proposito di quest’ultima, essa è sì la prospettiva utile
a far scattare la molla della scrittura del romanzo: è lo psicanalista che suggerisce
al proprio paziente di “mettere per iscritto le sue esperienze”, di tenere “una
sorta di diario della propria vita”, di scrivere, con evidenti intenti terapeutici.
Zeno accetta la proposta; non gli appartiene però la visione delle cose da cui
la psicanalisi trae alimento. La guarigione dalle sue nevrosi per lui non è
psicanalitica, ma epistemologica, riguarda il suo modo di concepire la scienza:
solo l’analisi scientifica qui è risolutiva. Condividendo un’atmosfera allora
diffusa a Trieste, “Zeno è di formazione intellettuale positivista”,
evoluzionistico-darwiniana; non romantica, intuizionistica. E del resto lo
stesso Svevo era “positivista, socialista a suo modo, lettore dell’Avanti e di Critica sociale”.
Fulvio Papi
Il poeta, l’Impero, la
morte
Ibis
Edizioni - 2015
Pagg.
96 - € 8.
***
PER
MILANO CON BENJAMIN
di Gabriele Scaramuzza
 |
| La copertina del libro |
È un grande piacere
sentirsi presi per mano da Rosalba Maletta e girovagare con lei per Milano, e
con una guida come Walter Benjamin. Abbiamo dunque un compagno d’eccezione con
noi, ci stupiscono e ci stimolano le sue note sulla Centrale, il Monumentale,
il Duomo, Brera, il Cenacolo, D’Annunzio a teatro; con tanta vita che fa loro
da contorno. I testi di Benjamin (soprattutto dal Passagenwerk e dal Kunstwerk) ci proiettano verso una Milano
che non è più. Ma è Rosalba Maletta, e con lei siamo noi, che passeggiamo a
Milano, con gli occhi pieni del nostro oggi. Non a caso il libro vaga con lo
sguardo asciutto di Benjamin, con occhio vigile e nessuna concessione a toni
celebrativi o retorici, tra la celebre Expo 1906 e quella di cento anni più
tarda, appena conclusa. Sei anni dopo l’Expo 1906 infatti, alla fine di maggio
del 1912, “Walter Benjamin capita nella città lombarda nota ai viaggiatori del
Nord per la potenza industriale e la preminenza in ambito economico e
finanziario. Ed è dunque insieme a questo viaggiatore tanto singolare che ci
incammineremo per le vie e i quartieri di Milano. Sostiamo con il suo sguardo e
le sue immagini pensanti (Denkbilder)
dinanzi all’organismo difforme, variegato e pulviscolare dove flânerie e time-lapse si intrecciano e si combinano chiamando il passante ad
aprire canali sensoriali intorbiditi dalla ratio
efficientista e anestetizzati dal principio della prestazione” (pp. 13-14).
“La
nostra ricognizione della città […] si compie grazie a un pensatore come
Benjamin, il quale mal si presta a cannibalizzazioni, omologazioni e altri usi
impropri. Ben lungi dal poter essere bollate come passatiste e inadeguate, le
sue riflessioni ben si attagliano alla presenza pervasiva e capillare della
rete nelle nostre vite e nelle relazioni che intratteniamo” (p. 17). Ed è
soprattutto col Benjamin dei passages
di Parigi tra le mani che Rosalba Maletta compie le sue escursioni nello spazio
e nel tempo di Milano.
I
tempi del libro talora si distendono nella lentezza del nostro svagato
passeggiare, talaltra si contraggono in sguardi presi da quel che verrà, si
proiettano ansiosi nel domani, fino al nostro oggi. Questa doppia prospettiva
prende; è la realtà del nostro vagare tra il passato ancora bruciante che
“dice”, e l’attualità dei nostri passi convulsi. Questa oscillazione del tempo
è il nostro presente. La nostra vita non si svolge in un tempo uniforme e
continuo, non è ma vive di questi strappi, di queste proiezioni; qualcosa
permane, l’urto con la folla ci appartiene ancora, Benjamin lo ha scolpito in
modo memorabile.
Questo
libro di Rosalba Maletta attrae anche perché non si sospettava che Milano fosse
stata oggetto di tanta acuta attenzione da parte di Benjamin, che dell’Italia
frequentava luoghi ben più affascinanti e celebri. Per Kafka -che visita Milano
solo l’anno immediatamente precedente il soggiorno milanese di Benjamin- è
diverso, dato che Milano è una delle pochissime località italiane che visitò, e
ci restano osservazioni concentrate, intense, e in certo modo paradigmatiche, e
fatte oggetto di molte riflessioni.
Queste
brevi righe colgono nulla più che un invito alla lettura di un libro
affascinante e nuovo come questo che ci consegna Rosalba Maletta.
Rosalba Maletta,
A Milano con Benjamin.
Soglie ipermoderne tra flânerie e time lapse (1912-2015)
Mimesis,
Milano 2015, pp.153, € 12.FRANCO ESPOSITO
 |
| Franco Esposito nel suo giardino di Stresa (Foto: Mirella G.) |
UVA GRECA
Ti ho sognata che sparivi come una nuvola.
Le tue labbra dolci come un acino di uva greca.
Ti ho sognata leggera e trasparente come la falce
di luna che illumina le acque dello Jonio.
Ho parlato in sogno con te dove si sente il mare.
L’alba accendeva semi di luce su Sibari
accarezzava la prima ruga sulla tua fronte.
I limoni profumano sbiaditi dal sole.
Le campane di un altro Natale.
[Stresa 2015]
Omaggio ad Adriano Manesco
di Chiara Sironi
 |
| La copertina del libro |
Un omaggio per
commemorare e rendere giustizia a un amico che non c’è più. Così si presenta il
volume recentemente pubblicato per Mimesis Edizioni, Un amico fragile. Testimonianze e ricordi per Adriano Manesco, a
cura di Virgilio Melchiorre, con la partecipazione di Sibilla Cuoghi, Anna
Ferruta, Elio Franzini e Gabriele Scaramuzza.
Adriano Manesco, la cui triste vicenda è nota dalle
pagine di cronaca nera dell’ultimo anno e mezzo, è il protagonista e il
destinatario di una serie di ritratti che raccontano con familiarità e
discrezione frammenti della vita dell’uomo e dell’intellettuale che è stato. Nelle
pagine di questo libro sono raccolte le testimonianze e i ricordi di molti
amici, che per lunghi anni sono stati vicini a Manesco; i ricordi personali e
intimi che gli autori dei saggi hanno voluto condividere si arricchiscono qui di
suggestioni di carattere più squisitamente filosofico, in omaggio a un’esistenza
investita nell’inesauribile ricerca di «una
risposta alla domanda sugli ultimi sensi»[1].
Il volume, è bene sottolinearlo, non è una biografia e
non voleva esserlo nelle intenzioni dei curatori: sia per la forma che per la
finalità si discosta infatti da un testo biografico. Rispetto a una
tradizionale biografia, questo testo trascende i limiti di un punto di vista particolare e individuale, a
favore di una polifonia che compone in modo armonico il ritratto di un amico e
di un intellettuale di grande valore.
L’immagine che
con vigore emerge da queste pagine è quella di «un uomo
interessato alle diverse culture, che è vissuto con naturalezza nel mondo della
classicità greca come in quello delle tradizioni orientali, di India,
Cina, Giappone. Ugualmente era curioso di conoscere le persone, la loro umanità
e unicità, e desideroso di comunicare generosamente quanto sapeva. Adriano
Manesco ha trasmesso valori di rispetto per la dignità umana e interesse per la
crescita culturale e civile»[2].
Per Manesco «non c’era
aspetto del mondo per cui provasse indifferenza, tutto attirava il suo sguardo
e lo interessava»[3],
perciò «invitava a guardare dietro e sotto le apparenze e anche gli oggetti
più comuni e quotidiani diventavano nuovi e originali»[4]. Rigoroso nei suoi studi, quanto saldo nei
suoi principi morali, «tra
le virtù prediligeva la gentilezza, la cortesia, la buona educazione, quelle
disposizioni d’animo che rendono semplici e gradevoli i rapporti umani»[5].
Esistono molti modi e forme per difendere la dignità di
un amico strappato alla vita in un modo così violento: la scelta del curatore e
dei collaboratori di questo volume è stata innanzitutto quella di salvaguardare
la memoria di Manesco e di farlo attraverso la testimonianza diretta di chi ne
ha conosciuto il pensiero, il modo di esprimerlo e gli onesti valori di cui si
faceva portatore. Quella che viene restituita in queste pagine è l’autentica
voce di Adriano Manesco, che rivive attraverso l’affetto e la stima sincera
delle persone a lui più care.
Note
1.V. MELCHIORRE, “Alla
ricerca degli ultimi sensi dell’essere” in Un amico fragile.
Testimonianze e
ricordi per Adriano Manesco, p. 14.
2. Dalla quarta di
copertina.
3. S. CUOGHI, “Adriano
ovvero della curiosità” in Un amico fragile.
Testimonianze e ricordi
per Adriano Manesco, p. 38.
4. Ivi, p. 36.
5. Ivi, p. 37
Un amico fragile.
Testimonianze e ricordi per Adriano
Manesco,
a
cura di V. Melchiorre, con la partecipazione
di
S. Cuoghi, A. Ferruta, E. Franzini,
G.
Scaramuzza,
Mimesis,
Milano-Udine 2015, 136 pp., 14 €.
***
Clemente Rebora nella prestigiosa collana
I
Meridiani di Mondadori
 |
| Cofanetto |
“Non c’è nulla di più bello del Canto dei cantici”:
queste parole mi tornano in mente questi giorni mentre leggo l’opera completa
su Clemente Rebora, pronunciate da
uno dei personaggi dell’Uomo senza qualità, il capolavoro di
Robert Musil, lo scrittore austriaco morto nel 1942, grande testimone della crisi
del nostro Novecento. Parafrasando le stesse parole, voglio farle mie e
suggerire: “Non c’è nulla di più bello che la poesia di Clemente Rebora”:
parole, che Adele Dei con la collaborazione di Paolo Maccari hanno fatto a loro
e ci hanno regalato questa magnifica
opera omnia su : Clemente Rebora –
Poesie, Prose e Traduzioni – I Meridiani Mondadori pagg.1330, euro 80 ).
Malgrado la mia consuetudine di discutere e scrivere da più di quarant’anni da Stresa, o in giro per
l’Italia e l’Europa del nostro don Clemente vedo con una certa emozione che la
mia testardagine che ho dimostrato sia con la mia rivista di cultura
Microprovincia sia con gli importanti e
determinanti Convegni e pubblicazioni in sintonia con altri amici sparsi in
tutta Italia e soprattutto attorno al Centro Rosminano di Stresa è stata premiata. Naturalmente ho seguito con trepidazione giorno per giorno, mese per
mese questa indispensabile e definitiva opera completa su
Clemente Rebora e devo ammettere che
questi giorni con il volume tra le mani, tremanti dall’emozione, posso
tranquillamente sottolineare che mi ha impressionato la tenacia, la
puntigliosità, di Adele Dei, ma mi ha sorpreso , soprattutto, la sua dote innata di critico di professione e di
organizzatrice, la dimostrazione subito nell’introduzione al volume con la sua
lievità di scrittura e la discrezione con cui è riuscita ad entrare in
profondità nell’opera e nella vita di un poeta complesso e tormentato come
quella di Clemente Rebora.
 |
| Copertina di Microprovinca |
Dalla nascita a Milano 1885, educazione
rigorosamente laica, senza riferimenti religiosi. Gli studi di qualsiasi
ragazzo della borghesia milanese di quel periodo. La laurea in lettere con la
tesi sul Romagnosi che verrà pubblicata sulla ((Rivista d’Italia)) col titolo:
Romagnosi nel pensiero del Risorgimento. Insomma, un laico la cui lezione
affonda le radici in Cattaneo, Gioberti, Mazzini. Nel 1914, lo troviamo a Novara.
quella Novara non lontana dall’amato e scalato Monte Rosa, la città come scrive
il 5 aprile del’14 a Prezzolini: ((vive come gli stantuffi delle sue belle
locomotive che lo spostano (...) ogni giorno tra Milano e Novara)). Infatti,gli
fu assegnata l’insegnamento d’italiano nella Regia Scuola tecnica ((Galileo
Ferraris)). Quaranta ore la settimana di lavoro dalle 6 alle 19 a Novara, poi
le scuole serali a Milano. L’incontro, forse più importante fu con Giuseppe
Prezzolini (direttore della Voce) l’alfiere in quel periodo di un grande
rinnovamento morale italiano, miseramente
fallito. ((Rebora, eccellente impressione, animo saldo, sicuro, fa e fa
bene, che meraviglia sono questi giovani in provincia)). Dai Diari di Giuseppe
Prezzolini 1900-1941. Nel 1913, uscirono i Frammenti lirici, affidati per la
stampa proprio a Prezzolini presso la Libreria della Voce. a dispetto degli
sforzi di Rebora e dei suoi amici, i Frammenti non ebbero l’eco sperato. Solo
in seguito i Frammenti vengono analizzati e
percepiti come gemme che
nascondevano un mondo nuovo con cui Rebora assimilava il suo tempo e se ne
faceva il portavoce. L’oscurità dei versi, di cui si parlerà in seguito dei
Frammenti, non derivava dal proposito di nascondersi, ma della intraducibiltà
dei pensieri che il poeta voleva
esprimere. Altra tappa fondamentale per Rebora é l’incontro con Sibilla Aleramo
e Lydia Natus. Un capitolo, soprattutto, quello vissuto con Lydia Natus, molto
importante come uomo, ma devastante per l’impatto con la brutalità della guerra
appena scoppiata. La sua sopravvivenza, scrive padre Umberto Muratore nella sua
splendida biografia, diventava una questione di giustizia cosmica, assoluta:
quei morti anonimi ed insepolti gli avevano affidato un compito che neppure la
sorte poteva non rispettare, tanto era sacrosanto: O ferito laggiù nel
valloncello,/Tanto invocasti/Se tre compagni interi/Cadder per te che quasi più
non eri,/Tra melma e sangue/Tronco senza gambe/E il tuo lamento ancora,/Pietà
di noi rimasti/A rantolarci e non ha fine l’ora,/Affretta l’agonia,/Tu puoi
finire,/E conforto ti sia/Nella demenza che non sa impazzire,/Mentre sosta il
momento,/Il sonno sul cervello,/Lasciaci in silenzio -/ Grazie,fratello. Anche
se alla fine sono solamente Lydia e la
poesia le luci che lo aiutano ad attraversare il tunnel dell’abbrutimento nelle
trincee del Carso. Intanto, matura un altro grande avvenimento nel 1920, escono i Canti anonimi, che hanno come
esergo un frammento del 1914 : ((Urge la scelta tremenda/Dire si,dire no/A
qualcosa che so)). Dopo la singolare esperienza del 1928, la famosa conferenza
degli Atti dei Martiri Scillitani quando: ...((La Parola zittì chiacchiere
mie)), Rebora si avvicina alla chiesa. A differenza di altre conversioni nel
tempo, avvenute all’insegna della rumorosità e del clamore, il suo itinerario a
Cristo é stato un evento intimo, strettamente riservato e personale, del quale
solo pochissimi amici furono messi a conoscenza. Più che al plauso esterno,
egli era interessato a sbloccare l’imprigionamento dell’esigenza battesimale.
Da questo straordinario capitolo della ((Chiamata)), la biografia di padre
Umberto Muratore, affronta per la prima volta la parte nuova e più impegnativa
del nostro don Clemente. Lo affronta con grande amore e partecipazione, soprattutto
dall’entrata nell’ordine dei rosminiani. Una miniera di notizie, di riflessioni
inedite di un Rebora che cerca con tutte le sue forze di recuperare il tempo
perduto. L’uscita di questo prezioso e imponente Meridiano secondo me, è riuscito ampiamente a colmare quel vuoto di cui tanto abbiamo sentito parlare,
soprattutto da Gianfranco Contini,da Oreste Macrì fino a Carlo Bo a portare
Rebora nell’Olimpo dei grandi poeti del Novecento. Voglio sottolineare con forza che la biografia
reboriana di padre Umberto, i tre numeri monografici di Microprovincia e altri
importanti studi pubblicati dalla Casa Editrice Interlinea dell’amico Roberto
Cicala, secondo me, sono stati di
fondamentale importanza per Adele Dei che si è trovata la strada spianata per
il suo importante lavoro di recupero e di scelta del materiale reboriano. Da
parte mia voglio aggiungere che solo chi è capace di trovare un po' di conforto
e d’illuminazione nella poesia, nella grande poesia, può leggere questo
meraviglioso Meridiano, dal periodo
cosiddetto oscuro di Rebora fino alla sua santità, che ho
sempre trovato di una grande intensità spirituale oltreché poetica. Nelle note
dei suoi ultimi anni, sia in poesia che nella vita quotidiana non
c’è il tempo neppure per guardarsi attorno, salvo l’aiuto ai poveri che
bussavano alla porta del collegio, e la solidarietà con gli infermi. L’ultimo
periodo, infine, coincide con il ritorno alla grande poesia con i : Canti
dell’infermità 1957 di genere sacro, con le sue tremende e vertiginose metafore
che ci portano indentro nel tempo a gareggiare con i suoi Frammenti, con la
purificazione dei suoi peccati, con l’annuncio unanime di chi lo avvicinava
nella sua indiscutibile ascesa alla
santità. Muore a Stresa nel 1957 la sua tomba dal 1985 si trova nel Collegio
Rosmini difronte a quella del padre Fondatore della Congregazione nella
chiesa del Crocifisso sul Colle Rosmini.
La sua grande eredità poetica viene rivalutata post mortem da quasi tutti gli
studiosi italiani. Ma quello di cui oggi sono convinto, è che il suo ricordo è vivo non solo nei cuori dei suoi numerosi lettori, come uno
dei maggiori poeti del nostro Novecento e questo Meridiano ne è la
dimostrazione, ma che è altrettanto vivo nei cuori dei più umili dei più
semplici come lui sperava con tutte le sue forze.
Franco Esposito
***
MARIA DILUCIA
 |
| Finestra fiorita |
VERITÀ?
E licenzio i pensieri
Lasciando libera la mente
L’assenza crea un vuoto
che permette ai ricordi di incontrarsi.
Rivedo sguardi non colti,
Verità sfuggite
E le bugie tra l’altro mal recitate.
Rileggo, riformulo, comprendo
Che le risoluzioni su cui
Ho costruito la mia vita
Sono basate su dati
Malamente colti!
A chi devo chiedere perdono?
Chi devo odiare?
Cerco di riempire la mente
Con l’orizzonte
Ma lei implacabile
Mi rimanda i visi
Di chi ho offeso
E di chi ha goduto ad umiliarmi
Lasciando che rimorsi e rancori
Giochino a palla
Con la mia anima.
HO BISOGNO DI POESIA
Sola,
in un deserto di donne e di uomini,
fuggo per evitare di essere travolta
dal fiume assordante di inutili parole.
Confusa,
senza punti di riferimento,
mi sforzo fino alle lacrime
inutilmente.
Incomprensibile mi è la realtà:
ambigua, mistificata, falsificata.
Forse
rappresentata
da disumani registi.
Ordita da ciechi,
inconsci che ormai tutti
graffiamo l’orlo dell’abisso.
In questo cimitero di speranze
ho bisogno di poesia.
Per non essere schiacciata
da questa opprimente montagna d’ottusità
ho bisogno di poesia
Per impedire all’avido mostro della disperazione
di divorarmi.
Ho bisogno di poesia!
SILENZIO
Se potessi avere a mia disposizione
un po’ della vostra attenzione,
un po’ del vostro tempo,
per dire ciò che penso
non vi direi niente.
Vi chiederei di ascoltare il vostro cuore,
non me.
Poiché tutto è stato detto
e tutto è stato ascoltato
E non potete più fingere di non sapere.
Se proprio qualcosa non vi è chiaro
chiudete i vostri occhi
e ascoltate con attenzione
quella voce che dentro di voi
da tempo,
da troppo tempo urla.
Inascoltata urla.
Laura Margherita Volante
 |
| Opera di Mario Bracigliano |
ASSENZA
In preda all’atarassia
nell’accoglienza
giaccio abbandonata…
del cosmico silenzio
il fragore del mare
e anche il volo
che s’allontana…
dimora
assente è l’anima
alla sua ombra.
RITORNI
Cercherai le tue
radici
fra i rami
rinsecchiti
scansando sulle nevi
l’orma dei tuoi avi…
e calerà nel suo rituale
la sera.
È il ritorno alla nostra terra
sulle vie del vento
che muore in un sospiro.
Non c’è lapide e neppure
un altare
ma solo il silenzio
dell’eterno e muto
divenire.
di Luigi Scala
 |
| Luigi Scala |
Colui che è passato alla storia della letteratura come
poeta contadino, aedo delle bettole, anima popolare della Grande Madre Russia,
Esenin, muore nel 1925, all'età di soli trent'anni, stroncato dal peso di una
spiccata sensibilità e di cocenti disillusioni: ancora oggi non è dato sapere
se suicida, "suicidato" o eliminato su commissione (forse del governo
comunista sovietico). Nell'interno di diradare le nebbie
dei tanti luoghi comuni che ne hanno avvolto l'esegesi nel corso degli anni,
con particolare riferimento alla sua ultima produzione letteraria, Esenin si
palesa come un lirico cantore della morte, anzi più che della morte sic et
simpliciter, di quella misteriosa malattia (depressione, morbo esistenziale,
chiamatela come volete), il cui sbocco naturale, soprattutto per gli spiriti
eletti, è spesso la morte, autoimposta o eteroindotta, ma comunque voluta e
ricercata come una liberazione.
Il
male oscuro di Esenin veste i panni di un sinistro uomo nero, e “L'uomo nero” è appunto il titolo del componimento che rappresenta,
a mio avviso, l'esempio più riuscito di quel lirismo funerario di cui si
parlava prima.
Nell'ambito
della produzione poetica di natura testamentaria, questa poesia di Esenin fa il
paio con la sua ultima, quel “Congedo” di cui gli
si attribuisce la paternità, che, secondo la vulgata, egli avrebbe dedicato e
consegnato ad un amico il giorno prima del suo trapasso.
Ma,
laddove nel “Congedo” il lirismo stempera in
un'amarezza ghiacciata ed insanabile, prodromica all'estremo gesto che di lì a
poco avrebbe posto fine alle sofferenze del Poeta, lo stesso lirismo si mostra
in tutta la sua pienezza ne “L'uomo nero”.
In
questo componimento uno Esenin già in preda ai fantasmi del suo tormento, instaura
con l'uomo nero un dialogo intessuto di dolci ricordi e funeste considerazioni.
Lo spunto per queste riflessioni è dato da un libro (da Esenin giudicato con
epiteti quali "turpe" o "abominevole"), che l'uomo nero sta
sfogliando e descrivendo a voce alta e che ripercorre la vita di un poeta
elegante (Esenin medesimo), proveniente da un paese di teppisti e ciarlatani.
Costui
amava una donna, che egli stesso chiamava "bambina cattiva" o, come
altri traduttori hanno trasposto in maniera meno edulcorata, "lubrica
puttanella". Esenin, però, rifugge da questi ricordi, ormai votato ad un cupio
dissolvi che non contempla possibilità di appello.
Si
noti la capacità del Poeta di far convivere negli stessi versi espressioni e
termini evocativi di sensazioni tra loro antitetiche, ma che, nella sua penna,
arrivano a fondersi armoniosamente: all'eleganza del Poeta fa da contrappunto
la sua provenienza, che denota un ambiente se non degradato, almeno decadente
(ma elegiaco al tempo stesso), popolato da teppisti e ciarlatani; e la donna
che egli ama teneramente è paragonata ad una prostituta dei bassifondi. Amore e
laidezza, eleganza e pidocchiume: la poesia di Esenin trapassa gli steccati che
separano l'aulico dal popolare, il cattivo gusto dalla raffinatezza più ricercata:
è come se le scarpe di copale del Poeta incedessero nel fango senza
insudiciarsi.
È
proprio questo che ci fa sentire un'infinita dolcezza nel senso di putredine
che aleggia in tutto il componimento. È proprio questo
che ci spinge a parlare di lirismo della morte.
È
proprio questo che rende l'addio in versi di Esenin, sia pur nella sua
crudezza, un lieve arrivederci.
 |
| Una foto del giovanissimo Esenin con pipa |
DUE POESIE DI ESENIN
Amico mio, amico mio,
sono molto molto malato.
Io stesso non so da dove mi venga questo male.
Se sia il vento che sibila
sul campo vuoto e deserto,
o forse, come a settembre al boschetto,
è l'alcool che sgretola il cervello.
La mia testa sventola le orecchie,
come fa un uccello con le ali.
La mia testa non è più capace
di ciondolarsi sul collo.
Un uomo nero,
nero, nero,
un uomo nero
siede sul mio letto,
un uomo nero
non mi lascia dormire per tutta la notte.
L'uomo nero
scorre il dito su un libro turpe
e, con canto nasale sopra di me,
come un monaco su un morto,
mi legge la vita
di un certo mascalzone e furfante,
cacciando nell'anima angoscia e paura.
L'uomo nero
nero, nero...
"Ascolta, ascolta", -
mi farfuglia, -
"nel libro ci sono molti bellissimi
pensieri e progetti.
Quest'uomo
viveva nel paese
dei più repellenti
teppisti e ciarlatani.
In dicembre in quel paese
la neve è pura fino al demonio,
e le bufere mettono in moto
i più allegri filatoi.
Quell'uomo era un avventuriero,
ma della marca migliore
La più alta.
Egli era elegante,
e per giunta poeta;
anche se piccola,
afferrava la sua forza,
e una certa donna,
che aveva quarant'anni e passa,
lui la chiamava bambina cattiva
e la sua amata".
"La felicità - diceva,- è destrezza di mente e mani.
Tutte le anime maldestre
sono note per la loro infelicità.
Non importa,
se molti tormenti
sono frutto di gesti
tortuosi e menzogneri.
Nelle tempeste, nei temporali,
nella gelida vita,
nelle perdite gravi
e quando sei triste,
apparire sorridente e semplice -
è l'arte più sublime del mondo".
"Uomo nero!
Non osare questo!
Tu non sei in servizio
come un palombaro.
Che m'importa della vita
di un poeta scandaloso.
Per favore, a qualcun altro
leggi e racconta".
L'uomo nero
mi guarda fisso.
e gli occhi si tingono
di un vomito azzurro,
quasi volesse dirmi,
che io sono delinquente e ladro,
che in modo svergognato e impudente
ha derubato qualcuno.
Amico mio, amico mio
sono molto molto malato.
Io stesso, non so da dove mi venga questo male.
forse è il vento che sibila
sul campo vuoto e deserto,
forse, come a settembre al boschetto,
è l'alcool che sgretola il cervello.
Notte di gelo...
La pace al bivio è silenziosa
sto solo alla finestra,
non aspetto né amico né ospite
tutta la pianura è ricoperta
di una calce friabile e molle,
e gli alberi, come cavalieri,
sono a raduno nel nostro giardino.
Da qualche parte piange
un uccello notturno malefico.
I cavalieri di legno
seminano un rumore di zoccoli.
sono molto molto malato.
Io stesso non so da dove mi venga questo male.
Se sia il vento che sibila
sul campo vuoto e deserto,
o forse, come a settembre al boschetto,
è l'alcool che sgretola il cervello.
La mia testa sventola le orecchie,
come fa un uccello con le ali.
La mia testa non è più capace
di ciondolarsi sul collo.
Un uomo nero,
nero, nero,
un uomo nero
siede sul mio letto,
un uomo nero
non mi lascia dormire per tutta la notte.
L'uomo nero
scorre il dito su un libro turpe
e, con canto nasale sopra di me,
come un monaco su un morto,
mi legge la vita
di un certo mascalzone e furfante,
cacciando nell'anima angoscia e paura.
L'uomo nero
nero, nero...
"Ascolta, ascolta", -
mi farfuglia, -
"nel libro ci sono molti bellissimi
pensieri e progetti.
Quest'uomo
viveva nel paese
dei più repellenti
teppisti e ciarlatani.
In dicembre in quel paese
la neve è pura fino al demonio,
e le bufere mettono in moto
i più allegri filatoi.
Quell'uomo era un avventuriero,
ma della marca migliore
La più alta.
Egli era elegante,
e per giunta poeta;
anche se piccola,
afferrava la sua forza,
e una certa donna,
che aveva quarant'anni e passa,
lui la chiamava bambina cattiva
e la sua amata".
"La felicità - diceva,- è destrezza di mente e mani.
Tutte le anime maldestre
sono note per la loro infelicità.
Non importa,
se molti tormenti
sono frutto di gesti
tortuosi e menzogneri.
Nelle tempeste, nei temporali,
nella gelida vita,
nelle perdite gravi
e quando sei triste,
apparire sorridente e semplice -
è l'arte più sublime del mondo".
"Uomo nero!
Non osare questo!
Tu non sei in servizio
come un palombaro.
Che m'importa della vita
di un poeta scandaloso.
Per favore, a qualcun altro
leggi e racconta".
L'uomo nero
mi guarda fisso.
e gli occhi si tingono
di un vomito azzurro,
quasi volesse dirmi,
che io sono delinquente e ladro,
che in modo svergognato e impudente
ha derubato qualcuno.
Amico mio, amico mio
sono molto molto malato.
Io stesso, non so da dove mi venga questo male.
forse è il vento che sibila
sul campo vuoto e deserto,
forse, come a settembre al boschetto,
è l'alcool che sgretola il cervello.
Notte di gelo...
La pace al bivio è silenziosa
sto solo alla finestra,
non aspetto né amico né ospite
tutta la pianura è ricoperta
di una calce friabile e molle,
e gli alberi, come cavalieri,
sono a raduno nel nostro giardino.
Da qualche parte piange
un uccello notturno malefico.
I cavalieri di legno
seminano un rumore di zoccoli.
Ecco di nuovo questa cosa nera
che siede sulla mia poltrona,
solleva un po' il suo cilindro
e incurante butta all'indietro le falde del pastrano.
"Ascolta, ascolta! -
mi fa con voce sgradevole, guardandomi in faccia,
ancora più vicino
ancora più vicino mi si inchina. -
non avevo mai visto che qualche
delinquente
in modo così inutile e sciocco
soffrire d'insonnia.
Ah, forse mi sono sbagliato!
Perché adesso c'è la luna.
Di che cosa ancora ha bisogno
questo piccolo mondo mezzo addormentato?
Forse, con le sue grosse cosce
"lei" verrà di nascosto,
e tu le leggerai
la tua fiacca lirica ormai sfiatata?
Ah, io amo i poeti!
gente divertente.
In loro trovo sempre
una storia famigliare al cuore,
come quella di una studentessa piena di brufoli
e di un mostro dai lunghi capelli
che le parla dei cosmi,
tutto bramoso di desiderio sessuale.
Non so, non ricordo,
in un villaggio,
forse, in quel di Kaluga,
o forse, in quel di Rjazan',
viveva un ragazzo
in una semplice famiglia contadina,
con i capelli gialli,
con gli occhi azzurri...
Ed ecco che divenne adulto,
e per giunta poeta,
anche se piccola
afferrava la sua forza,
e una certa donna,
che aveva quarant'anni e passa
lui la chiamava bambina cattiva,
e la sua amata".
"Uomo nero!
Tu sei un pessimo ospite.
Questa fama di te
da molto tempo corre in giro".
Sono furibondo, fuori di me,
e vola il mio bastone
giusto addirittura contro il suo muso,
alla radice del naso
La luna è morta,
azzurreggia alla finestra l'alba.
Ah tu, notte!
Che m'hai combinato, notte?
Me ne sto in piedi qui col mio cilindro.
Non c'è nessuno con me.
Sono solo...
Con uno specchio in frantumi...
solleva un po' il suo cilindro
e incurante butta all'indietro le falde del pastrano.
"Ascolta, ascolta! -
mi fa con voce sgradevole, guardandomi in faccia,
ancora più vicino
ancora più vicino mi si inchina. -
non avevo mai visto che qualche
delinquente
in modo così inutile e sciocco
soffrire d'insonnia.
Ah, forse mi sono sbagliato!
Perché adesso c'è la luna.
Di che cosa ancora ha bisogno
questo piccolo mondo mezzo addormentato?
Forse, con le sue grosse cosce
"lei" verrà di nascosto,
e tu le leggerai
la tua fiacca lirica ormai sfiatata?
Ah, io amo i poeti!
gente divertente.
In loro trovo sempre
una storia famigliare al cuore,
come quella di una studentessa piena di brufoli
e di un mostro dai lunghi capelli
che le parla dei cosmi,
tutto bramoso di desiderio sessuale.
Non so, non ricordo,
in un villaggio,
forse, in quel di Kaluga,
o forse, in quel di Rjazan',
viveva un ragazzo
in una semplice famiglia contadina,
con i capelli gialli,
con gli occhi azzurri...
Ed ecco che divenne adulto,
e per giunta poeta,
anche se piccola
afferrava la sua forza,
e una certa donna,
che aveva quarant'anni e passa
lui la chiamava bambina cattiva,
e la sua amata".
"Uomo nero!
Tu sei un pessimo ospite.
Questa fama di te
da molto tempo corre in giro".
Sono furibondo, fuori di me,
e vola il mio bastone
giusto addirittura contro il suo muso,
alla radice del naso
La luna è morta,
azzurreggia alla finestra l'alba.
Ah tu, notte!
Che m'hai combinato, notte?
Me ne sto in piedi qui col mio cilindro.
Non c'è nessuno con me.
Sono solo...
Con uno specchio in frantumi...
CONGEDO
O caro amico, ci vedremo ancora,
che sempre nel mio cuore tu rimani.
Ormai di separarsi è giunta l’ora,
ma promette un incontro per domani.
Caro amico addio, senza parole,
senza lacrime, senza dispiacere.
Morire non è nuovo sotto il sole,
ma nuovo non è nemmeno vivere.
***
Il bicentenario di Giovanni Meli 20 dicembre
1815/2015
di Francesco
Zaffuto
 |
| La copertina del libro |
In occasione del Bicentenario di Giovanni Meli la
casa editrice I Buoni Cugini ha pubblicato un’opera complessa e particolare
inserendo in un solo volume: il romanzo di Luigi Natoli “L’Abate Meli”; il
prezioso Studio critico di Luigi Natoli su Meli, tutte le poesie di Meli che
Natoli scelse per il suo trattato “La Musa siciliana”, ed un’ampia appendice
con tante poesie di Giovanni Meli in siciliano e traduzione in italiano a
fronte. Meli visse a Palermo (4 marzo 1740 - 20 dicembre 1815) in anni in cui
si sentivano arrivare da lontano gli echi della Rivoluzione francese e dopo quelli delle campagne napoleoniche, non
fu investito direttamente da quegli eventi, inveì dalla lontana Sicilia contro
gli eccessi della Rivoluzione francese e contro le sanguinose campagne
napoleoniche; predicò la pace e prese il meglio di quell’epoca, il pensiero
illuminista.
La scelta di Meli di operare in siciliano è simile, per
molti aspetti, a quella fatta da Gioacchino Belli con il romanesco. Il Belli
costruì un monumento al popolo romano e si servì del romanesco per mettere in
bocca al popolo un buon senso in cui si specchiava la ragione illuminista. Per
Meli la scelta di scrivere in siciliano fu una liberazione dal convenzionalismo
accademico, un ritorno alla freschezza dell’impressione e dell’espressione; a
volte parlano personaggi mitologici, a volte gli animali, a volte lo stesso
Poeta, ma il linguaggio ritmico del suo siciliano è scelto per evidenziare la
schiettezza della ragione illuminista. La stessa scelta fu operata in Lombardia
da Carlo Porta (1775-1821) che visse in un periodo storico vicino a quello del
poeta siciliano.
Il romanzo di
Natoli “L’Abate Meli” venne
pubblicato a puntate dal Giornale di Sicilia a partire dal 16 settembre 1929 e questa edizione dei Buoni
Cugini Editori fa riferimento ai testi
originali di quella pubblicazione. Non è un romanzo biografico sul poeta
siciliano, è un particolare intreccio narrativo per evidenziare la poetica e la
filosofia del Meli. Il romanzo scorre su due binari: quello di un’ intricata
vicenda avventurosa e amorosa dove i buoni sono perseguitati ingiustamente; e
quello della vita del poeta Giovanni Meli che interviene in aiuto solidale di
due giovani amanti perseguitati. Nella costruzione del romanzo Natoli mantiene
una netta dicotomia tra il male e il bene come se fossero due entità
mitologiche che si confrontano: da una parte Don Bartolo che riassume tutto
l’assurdo del male capace di generarsi nella specie, che si caratterizza per
l’attaccamento al denaro, vive nella falsa coscienza dell’onore, con ottusità,
senza pensiero, con eccessi di ira, ed arriva fino al delitto; dall’altra parte
il Meli che si caratterizza per l’empatia, la gratuità, che si rivolge al pensiero e alla ragione, e
vuole coniugare il dovere con l’amore.
Spesso Natoli nel suo romanzo, all’interno delle vicende,
cita le poesie del Meli che diventano il filo conduttore in diversi momenti
narrativi, e la poesia che esprime il profilo etico del poeta è la Pace. Il
senso della pace che percorre Meli non può prescindere dal senso della
giustizia ed è un tutt’uno con questa. Meli non fu mai ricco e spesso le
difficoltà lo costrinsero, come Giuseppe Parini, a bussare alla porta dei potenti; Natoli lo descrive in questo bussare ai
potenti anche per aiutare gli altri.
Natoli nel romanzo ci presenta l’Abate Meli a 50 anni:
vestito sempre con l’abito scuro di religioso, ma in realtà poeta, scienziato e medico; soprattutto poeta.
Sul titolo di Abate di Meli, Natoli nel secondo capitolo
così narra: “Vestiva di nero, alla guisa degli abati ed infatti lo chiamavano
“l’abate Meli”. Ma non lo era, anzi non era neppure chierico, né aveva i
quattro ordini e la tonsura, che prese l’ultimo anno della sua vita per
ottenere l’abazia che non ottenne. Era semplicemente il “dottor Meli”, e si
vestiva da abate per avere libero accesso nei monasteri…”. Da questo passo si
desume che Natoli, nel suo romanzo del 1929, continua a sposare la tesi
biografica di A. Gallo che affermava che il poeta prese gli ordini nell’ultimo
anno di vita. Tesi confutata dalla
ricerca storica di Edoardo Alfano che, con il suo studio pubblicato nel 1914,
dimostrava la totale assenza di menzione sulla presa degli ordini di Meli nei i
documenti degli archivi della chiesa palermitana. Certo fu lo stesso Meli che
affermò in un suo memoriale poetico di aver preso gli ordini; nel settembre del
1815 inviò al duca d’Ascoli il memoriale affinché lo presentasse al Re per
perorare l’affidamento di un’abazia in Palermo. In questo memoriale in versi
intitolato “Siri” si possono leggere
questi versi:
...Prezzi e bisogni
criscinu, e mancanti
Su l’introiti, e
addossu nun si trova
Chi lu vacanti
titulu d’abbati,
Chi impignari ‘un po’ pi pani e ova,
Si supra na
cummenna la bontà
Di Vostra Maestà
non ci lu nchiova.
Iddu è già preti chiù di la mità:
La tunsura e
quatt’ordini ingastati
Dintra di l’arma si
li trova già…
(Prezzi e bisogni crescono, e mancanti/ sono gli
introiti, e addosso non si trova/che il vuoto titolo d’abbate/ che non può
utilizzare per il pane e le uova, / se sopra una commenda la bontà / di Vostra
Maestà non ce l’appende. /Lui è già prete per più della metà: / la tonsura e
quattro ordini incastonati/dentro nell’anima se li trova già).
G.A. Cesareo,
nella sua biografia su Meli (1924 “La
vita e l’arte di Giovanni Meli”), parla di “bugiola” diffusa dallo stesso
poeta e così la spiega: “Certo, la nomina non sarebbe stata improvvisa; qualche
sentore n’avrebbe egli avuto anche prima: se fosse necessario, sarebbe sempre
stato in tempo per mettersi in regola. Ma prendere gli ordini sacri quando
ancora non aveva alcuna fondata speranza di conseguire il suo intento, e mentre
tutti in Palermo riconoscevano che viveva in concubinato con una vedova dalla
quale aveva avuto figlioli, gli doveva saper male. E non lo fece…”
Non sappiamo
perché Natoli, scrittore e storico attento, preferisce parlare di voti presi
l’ultimo anno della sua vita, mantenendo la tesi del Gallo, comunque sono fatti
successivi al periodo di tempo narrato nel romanzo e Natoli ben descrive un
Meli sensibile al fascino femminile e alle pulsioni della vita. La “cicala”
Meli non rinunciò alla vita e a tutti gli aspetti della sua bellezza, volle
vivere e poetare, nella sobrietà, nella pace e nella giustizia; e se Meli dice
che “dintra di l’arma” (dentro la sua
anima) è Abate, non dice una bugia, se si considera il suo rigore morale e il
profondo senso di cristianità che è riuscito a legare con il suo pensiero
illuminista. Meli portò quel modesto abito scuro che era comune ai medici e
agli abati, esercitò la sua attività di medico per 5 anni a Cinisi in provincia
di Palermo (e forse quell’appellativo di Abate iniziarono a darglielo in quel
paese); a Palermo continuò a portare quell’abito scuro e modesto che lo
distingueva dagli uomini della sua epoca (fine settecento) che si ornavano di
parrucche, merletti e calze di seta; Natoli nel descriverlo in una sala di
nobili, avvolto nel suo abito scuro, dice che pareva un calabrone in mezzo a
tanti fiori; nello spettro dei colori rovesciato della coscienza Meli diventava
il fiore più luminoso in mezzo a tante ombre. Lo Studio critico dedicato a
Giovanni Meli, pubblicato nel 1883, Natoli lo scrisse quando aveva appena 26
anni. Studio prezioso per la conoscenza delle opere e per l’attenta
documentazione, può essere utile a chi non conosce il poeta siciliano e anche a
chi lo conosce in profondità. È uno studio condotto a tutto campo, che va dalle
opere maggiori fino agli inediti e alle lettere del Meli. Presenta il grande
poeta siciliano nella sua centralità filosofica e letteraria e lo libera dal
luogo comune di solo rappresentante dell’Arcadia, prendendo le distanze anche
da esponenti della critica letteraria del calibro di De Sanctis.
Meli fu arcade se si guarda al suo repertorio metrico, ai
riferimenti alla tradizione classica, allo sfondo agreste delle sue liriche; ma
per lo spirito e per la sua impronta morale e filosofica fu un poeta ben più
complesso. Natoli dimostra questa complessità evidenziando l’opera “L’Origini di lu munnu”, dove la dissertazione di Meli spazia su tutte le teorie
filosofiche.
Nell’esaminare la “Bucolica” Natoli coglie che in Meli
“il centro è l’amore delle cose che scherza nella varietà, ne l’incostanza, nel
disordine; e in quell’armonia dilettosa, che egli il poeta, formavasi nel suo
cervello, nel sentirsi concorde ed uno con la natura”.
Nella parte finale del suo saggio Natoli cita la lettera
di Meli al barone Refhuens dove parla delle sue aspirazioni di vita, del suo
rapporto con la poesia, delle sue disgrazie, delle sue amarezze, del suo
rigore: “nonostante, mercé di un parco vivere ho tirato avanti decorosamente,
senza aver contratto mai un soldo di debito, e senza avere obbligo ad anima
vivente della mia tenue sussistenza, salvo alle mie fatiche …”
Il volume L’Abate Meli si conclude con una appendice di
circa 200 pagine di poesie di Giovanni Meli con una traduzione a fronte. Si è
voluta proporre una traduzione letterale come guida per godere dello stesso
fraseggio poetico siciliano del Meli. La maggior parte delle parole scelte dal
Meli sono ben comprensibili; e il lettore, dopo aver trovato il significato
delle parole più astruse, può agevolmente ritornare sul testo in siciliano e
ascoltarne la sua musicalità.
***
LIBRI
LE PAROLE EVOLUTE
di Angelo Gaccione
 |
| Sonia Scarpante |
Questo è un libro che nasce dal proprio sangue e
dalla propria carne, dunque bisogna prenderlo sul serio. Sto parlando di “Parole evolute” di Sonia Scarpante che
porta come sottotitolo ‘Esperienze e tecniche di scrittura terapeutica’. Il
sottotitolo rimanda subito a qualcosa che vuole presentarsi come frutto di
un’esperienza vissuta, e, insieme, come un vero e proprio procedimento
scientifico. L’edizione stessa, EdiScience,
vuole rammentarcelo, così come la prefazione di un medico, il primario di
oncologia dell’ospedale di Legnano Sergio Fava. Di libri che hanno messo al
centro varie forme dell’espressività umana ed artistica, come metodo di cura
per il disagio e patologie fra le più diverse, ne esistono parecchi. Alcuni
pionieri hanno cominciato diverso tempo fa. I poeti, gli aedi, i drammaturghi,
i favolisti, hanno iniziato addirittura nell’antichità, i narratori molto più
tardi; in età più moderna gli psicanalisti hanno fatto dell’uso della parola
dei pazienti, il nucleo fondante della loro indagine su quel grumo oscuro che è
l’inconscio, per rimuovere fantasmi di ogni sorta. Dentro alcune istituzioni
totali, psichiatri ed altri terapeuti (ne ho conosciuti alcuni), hanno
utilizzato la pittura e altre forme di manualità creativa con i loro pazienti,
ottenendo buoni risultati dal punto di vista dell’equilibrio mentale, come da
quello più strettamente artistico. Una di queste mostre (molti anni fa)
realizzata con disegni e pitture provenienti da quei luoghi di pena, l’ho anche
presentata. Per quanto riguarda l’uso della scrittura, praticando questo insano
mestiere ormai da un tempo remoto e avendo letto una discreta quantità di
pagine, se non si considera l’atto della scrittura come un puro impulso
narcisista (oggi sempre più diffuso), ma come un bisogno vitale,
insopprimibile, e per molti aspetti necessario, non sono del tutto sicuro che
esso sia “solo” terapeutico. La quantità di suicidi nell’ambito degli scrittori
è tuttora alto, e quello dello scrittore resta un mestiere a rischio. Nessuno
può ignorare come all’esaltazione creativa di un lavoro ben riuscito,
corrisponda un’altra faccia della medaglia: quella del vuoto, della dannazione,
del concetto che sfugge, della materia che non si lascia addomesticare e
prendere forma. E come forma non
s’accorda all’intenzion dell’arte perché a risponder la materia è sorda… A
queste insidie si aggiunge un pericolo più profondo, inscindibile com’è da una
sensibilità spesso rovinosa, tremendamente intensa, ricettiva, esposta. È un
sentire non comune che non si accontenta di alcun rimedio e molto spesso non ne
trova uno che possa medicarlo. Ma ovviamente non nego che ad un livello di più
bassa “temperatura” possa funzionare. Del resto buona parte di quanto uno
scrittore produce se non è proprio autobiografia, è comunque materia attinta
dalla sua esperienza fisica o intellettuale; visionaria o memoriale poco
importa. Sonia Scarpante parte proprio da qui: dal procedere autobiografico dei
suoi corsisti. Ho scritto all’inizio che il suo è un libro nato dalla propria
carne, e dunque vero. Il metodo lo ha sperimentato prima di tutto su se stessa,
come spiega bene nella nota introduttiva: “ (…) La scrittura autobiografica è
uno strumento di conoscenza dalle potenzialità sorprendenti, è un mezzo in grado
di svelarci, di far affiorare alla nostra consapevolezza esperienze rimosse ma
cruciali per noi e per la nostra vita di relazione”. E ancora: “ Grazie alla
scrittura ho imparato a confrontarmi con la faccia poliedrica di ciò che ognuno
di noi chiama il suo me stesso…” e
così di seguito. Basterebbero solo questi brevi spunti qui segnalati a darne il
senso e l’importanza. Per l’autrice in particolare, perché quella che noi tutti
concepiamo come una sorta di autoanalisi liberatoria, lei l’ha svolta (in scrittura)
proprio partendo da un grave problema di salute e di dolore, per vicende che la
vita, (ahimè!) riserva a ciascuno di noi, anche se nelle forme più diverse. La
scrittura autobiografica le è servita come terapia, per guardare più a fondo in
se stessa e dare ordine al magma che la assediava. Ha funzionato magnificamente
questo processo, questo viaggio doloroso, per uscire dal tunnel. Ma ha
funzionato perché in qualche misura è stata spietata: ha guardato dentro di sé
senza barare, rimestando fra le macerie più dolorose senza mentire e mentirsi.
Ed è forse solo a questa condizione che la terapia, la “cura”, può riuscire;
che il viaggio alla fine può approdare in un altrove pacificato e sereno. Per
lo meno questo è quello che è avvenuto a lei. Fra le parti più intense e
commoventi del libro ci sono anche una serie di lettere rivolte a varie figure:
quelle al padre mi sono sembrate le più drammatiche e insieme le più poetiche.
Non è facile scrivere lettere come queste e portare le proprie confessioni e le
ferite del proprio cuore ad un punto così estremo. Siamo sempre bloccati da un
pudore che ci trattiene; da uno slancio che non riesce quasi mai a farsi gesto
concreto, e poi finiamo per pentircene quando è sempre troppo tardi. Non mi
piace l’espressione “elaborare il lutto”,
la trovo sminuente e banale davanti alla maestà del dolore che ha bisogno di
toccare i suoi estremi. Non c’è alcun lutto da elaborare; c’è l’opera paziente
del tempo che arriverà a lenire, ma non a cancellare, com’è sempre avvenuto nelle
tragedie umane. Ma sono tuttavia sicuro che questa pratica che Sonia Scarpante
ha sperimentato in prima istanza sulla sua persona, e che sta così efficacemente
e con successo portando avanti da alcuni anni nei suoi incontri e seminari (il
suo libro ne dà ragione sia con dati evidenti, prove, progetti concretamente
realizzati; sia con le tecniche, i metodi di approccio, le esperienze
raccontate), proprio per quella esperienza umana che l’ha segnata, per il fondo
gelido del dolore che le è appartenuto, ha saputo farsi metodo di cura e dono,
per alleviare altra sofferenza.
 |
| La copertina del libro |
Sonia Scarpante
Parole evolute
Esperienze e
tecniche di scrittura terapeutica
EdiScience 2015
Pagg. 276 € 18,00
***
POESIA
FRANCESCA DONO
 |
| Francesca Dono |
Disposti gli uccelli
Disposti gli uccelli
l’estate sbuccia placida
dai cenci.
Forbici sopra viscere spicciole
che sanno ingroppare
e di prua oltremare.
-Non seguitemi con le ossa
Gassate-
Del gobbone (Nazi)
via le gocce sudice
amare di tremori
e reni e fibre
di corte marziale.
Deflagrano parole
sulle schiene oscurate
blu la coscienza
dell’esausto
(tu vecchio mio)
ancora impervio
alla brughiera
vago di un velivolo
bislacco.
Sembri non durare
ogni volta che finisci a durare.
Acqua di circondario
romanzi e muroni.
Alla sassaia
smerciano un poeta
-roba da strapazzo-
Che torni estate
la donna sta svanendo
madre di un ventre
e di terra la sua spina.
e di terra la sua spina.
AFORISMI
di Laura Margherita Volante
*Mafia capitale. Se nel
nome un destino: Tronca un nome e una speranza…
*Quando si combatte la
violenza con la violenza questa trova il suo nutrimento bulimico e rigoglioso
di veleni.
*Il ladrocinio dei
politici rischia di diventare il lasciapassare dei ladri di democrazia…
*Statistica. Se l’80%
della popolazione si droga il delirio generale è nella norma dell’anomalia.
*La resilienza sta alla
rinascita come una foglia alla caducità.
*In Rete. Nella tela di ragno tessuta dai demoni del dio denaro siamo
invischiati dalla sua bava. Sbavano le pantegane assetate, ma finiranno come
mosche nella propria ragnatela.
*Il problema dei sessi =
os-sessi-one
*È la fine!? Il caos di una società al collasso,
incancrenita da metastasi ambientali e
incapace di governare ciò che è diventato ingovernabile. Avere tutto e
non saperne fruire il più grave peccato dell’umanità, che è andata contro
natura e contro ogni legge universale di armonia.
*La polis governata dai
poeti. Un sogno eluso per effetto di un’evoluzione della specie arrestatasi per
ogni forma umana che deformata precipita nelle fiamme dell’inferno tra miseria
guerra malattia violenza: demoni e principi di uomini senza cuore senza
cervello senza anima. La vita morirà tra i suoi stessi scheletri!
*La vita è un soffio le
cui illusioni fanno vivere meglio di bagni di realtà dove affogano i sogni.
*Per indifferenza si può
essere invisibili, ma chi è indifferente non esiste… RACCONTARE
COME SCRIVERE CON INCHIOSTRO CHE SI SCOLORA
di Adamo
Calabrese
Nella mia casa d’infanzia la credenza con la
vetrinetta racchiudeva il servizio delle chicchere per il caffè da usare solo
in caso di visite eccezionali: la sorella di mio padre, la zia Adelina che
veniva da Napoli, l’anarchico amico di mio padre quando usciva dal carcere in
virtù di qualche raro permesso per buona condotta, il mio Angelo custode
invocato da mia madre perché illuminasse i miei compiti di aritmetica, veri
enigmi che rattristavano la mia vita che avrei voluto dedicare a ben altro.
Ben altro?... cioè andare per i campi, aspettare
sull’orlo delle cave che da quelle acque morte affiorasse il dinosauro
antidiluviano, leggere arrampicato sugli alberi, stare accucciato e zitto… in
un angolo della stanza dove mio padre scriveva.
Mio padre scriveva con una cannuccia sormontata da un
fantastico pennino di acciaio in forma di pinnacolo gotico. Scriveva fitto
fitto, intingendo la penna nell’inchiostro preparato da mia madre spremendo
ribes, more e altre bacche di siepi. L’inchiostro stentava a seccarsi ma una
volta asciutto formava sulla carta una ragnatela di indefinita tinta di cielo
al tramonto che, purtroppo, andava progressivamente impallidendo fino a sparire
del tutto. Di tutto ciò che ha scritto mio padre non è rimasto nulla, i suoi
manoscritti non sono che fogli ingialliti dove nell’infinito silenzio del tempo
che passa dilagano pallide macule. Che fare? Ho ripreso la penna di mio padre
ed ho cominciato a scrivere dal punto dove lui ha smesso di scrivere. Mentre
scrivo tornano le ombre dei miei genitori, della zia Adelina, dell’anarchico, del
mio Angelo custode e di tanti altri che hanno accompagnato la mia vita. Io scrivo
e il popolo ultraterreno si accalca intorno a me, come una folla che teme di
perdere il treno. Ciascuno ha qualcosa da dire: “Attento ai verbi, bada di non scialacquare
gli aggettivi, vai a capo, questa parola non esiste, controlla sul dizionario,
quest’altra parola sa di muffa, eccetera, eccetera…” Come si può scrivere in
tali condizioni? Ognuno dice la sua e c’è chi si arrabbia se non seguo i suoi
consigli, soprattutto la zia Adelina, la parente più petulante. Chi meno
interferisce è l’anarchico, lui vorrebbe che scrivessi in russo come Dostoevskij,
ma poiché ciò è impossibile resta in silenzio con la riga sulla fronte incisa
come una ferita. C’è un modo per mettere tutti d’accordo. Io scrivo e le ombre
ultraterrene cantano. Cantano ciò che io scrivo, aggiustandosi con perfetto
orecchio musicale. Cantano il “Magnificat” e tutto ciò che è intorno a me trema
come per lo scoppio di un tuono. Mia madre alza un dito e mi allerta: “Temporale,
temporale! Chiudi la finestra…”
[Novembre 2015]
***
L’AFORISMA |
| De Troy Jean Francois "Allegoria del tempo che scopre la virtù" |
***
INCHIOSTRO NERO
Tre inediti di Alessandra
Paganardi
(dalla silloge “Angeli guardiani”)
Ulivi
conficcati nell’asfalto
saranno
questa sera le tue braccia
che
non ho qui con me – parole e basta
arrampico
e raccolgo lungo i muri
di
una periferia color del sale
dai
buchi ovali di plastica dura
tutte
le sedie aspettano poesia
strapperei
il passaporto della mente
ora
o fra poco se una cruna invidiosa
non
avesse nel nostro tempo magro
aperto
un varco senza congiuntivi
il
letto sfatto di un torrente avaro
la
fame che fa il vuoto dall’interno
del viso, l’accartoccia in ruga
***
Sconteremo
questo troppo giorno
la
pelle arresa ostaggio della luce
nella
vigna bambina
non
prevedevi un orto di cemento
dentro
cortili guariti d’attesa
dallo
zaino sudava
lento
odore di sonno e di parole
la
mantide affondava le sue chele
nel
pasto di cicala
le
crude cellule in cerca di sole
l’inutile
armatura
gli
acini secchi sparsi sull’altare
ritornato poesia
***
no
reentry beyond this point
non
torneremo indietro
se
tutto infine sprofonda
sul
contrafforte bellissimo fragile
la
duna nella sabbia la pietra nel fiume
l’ala
calata dopo il volo
il
piacere nel chiuso del sangue
gli
alveari salvati dai fiori
involontari
vicini di casa
serrati
fra le braccia della notte
questo
giorno che non ha conosciuto
santi
ma solamente primavera
tu
non segnarlo più sul calendario
non
obbligarlo di nuovo a morire ***
Una poesia inedita di Ikeogu Oke
Attraverso Le Sue Lettere
(Per Mary-Lou e Don Burness)
che muta quando scopre
un cambiamento...
L'amore non muta in
poche ore o settimane,
Ma impavido resiste al
giorno estremo del giudizio ... ".
William Shakespeare, Sonetto
116
Solo una volta ho incontrato Mary-Lou:
Uno sguardo passò attraverso i nostri occhi;
Dietro di lei c'era un uomo, spingeva una sedia a rotelle
sulla quale lei sedeva nel auditorium (1) al Brown (2).
I suoi occhi, quando l'ho guardata, hanno sprigionato una
certa luce,
Una luminosità antica desiderosa di non smettere mai di
splendere;
Il suo viso partorì un sorriso che deve aver brillato ancor
più luminoso
Nei giorni più giovani, l'alba dolce con raggi di oro
brunito:
L'ictus aveva impallidito la sua avvenenza, ma non la
bellezza della sua anima.
Che cosa potrebbe indurre un uomo così forte da spingere una
donna
Su di una sedia a rotelle in modo così profondo nella sala
dove il mondo
Si era riunito per onorare il mio maestro (3)?
Mi chiedevo.
Ora lo so, attraverso le sue lettere (4):
Linee, linee di un sentiero con un lume di tenerezza;
Pensieri luminosi brillano nelle loro vesti di fascino;
Il desiderio danza attraverso le pagine in delicato
silenzio;
La cultura si estende in arcobaleni e rotola in
caleidoscopi;
Le parole intendono parole di dolce solidarietà, come
Mary-Lou e Don.
Ikeogu Oke
Abuja, 10 luglio 2015
Note
[1]. L'auditorium: The
List Art Centre Auditorium at Brown University
[2]. Brown: Brown University, in Providence, Rhode
Island, U.S.A.
[3]. Il mio maestro: Chinua Achebe (1930-2013), in
postumo onore del quale è stata tenuta una conferenza alla Brown University dal
1 al 3 Maggio, 2014.
A margine di un saggio sulla bellezza
Già il
sottotitolo del libro di Simona Chiodo La bellezza, che suona Un’introduzione
al suo passato e una proposta per il suo futuro, dice qualcosa di significativo
e condivisibile. Sappiamo da subito che oggetto della ricerca non è solo la
tradizione in cui l’idea di bellezza si è costituita - che è comunque
scrupolosamente interrogata. Ma, e questo è ancora più decisivo, il suo senso
per noi oggi (lo testimonia l’ottica teorica del tutto contemporanea da cui la
bellezza è vista), e il suo possibile destino futuro. Affrontare un tema di scontato rilievo quale
quello della bellezza significa innanzitutto riscattarne la rilevanza nel
nostro oggi, dopo che per anni è stato messo al bando dalla riflessione
estetica: “dopo decenni di periferizzazione torna a essere importante negli
studi filosofici”, scrive l’autrice. Senz’altro i suoi studenti, come mi ha
detto una volta, le hanno chiesto di chiarire i termini del problema del bello.
Ma certamente lo chiede la situazione contemporanea, in cui la bellezza resta
un presupposto inespresso, anche e tanto più se contestato.
*
Quello della bellezza resta un punto di vista che dà
tregua e riposo. Parlare di bellezza significa tematizzare un valore - il valore
più alto nel mondo estetico e magari artistico (le due cose non è detto
coincidano), quello che tutti li riassume e li giustifica. Non è un caso che
“modificazioni del bello” siano chiamate le categorie estetiche, che esprimono
il vario colorarsi del valore estetico in diversi contesti. Il bello è l’ideale
verso cui in vari modi tende la vita estetico-artistica.
Personalmente, anziché parlare di bellezza stricto sensu
preferirei parlare di valore estetico e di riuscita artistica, e di una loro
radice comune. La bellezza lato sensu è proprio questa radice comune; non deve
togliere tuttavia l’ampio svariarsi del valore. Ricercare le radici comuni,
individuarle, è inevitabile; ma da evitare è anche ogni reductio ad unum
(parlare di bellezza contiene in sé questo rischio), se si vogliono “salvare i
fenomeni” in tutta la loro ricchezza di differenze e di identità. Nel suo modo
di scrivere Chiodo annoda tutto, come se ogni cosa sgusciasse nell’altra;
intesse con buona mano, ma insieme tende a ricondurre una cosa all’altra:
tendenzialmente (metafisicamente) a un’unica radice - attenta più alle identità
che alle differenze. Così il termine bellezza sfuma le diversità (modificazioni
del bello, categorie estetiche), con un atteggiamento più riduzionista che fenomenologico.
Ne disperde la varietà dei sapori. Non mancano insistiti ritorni, stilemi
ripetuti, indugi di troppo; certi punti appesantiscono la lettura e erodono
l’attenzione (la mia quanto meno). Ma perché non dire che questo lavoro di
Chiodo, piaccia o non piaccia, ha una sua inconfondibile tonalità “estetica”, e
indubbie qualità “artistiche”, che esprimono la sua spiccata personalità, la
sua imprescindibile tensione all’unità? Anche questo dà quiete.
*
Nel libro non è tematizzato il terreno in cui si alimenta
la decisione di parlare della bellezza. Questa ha a proprio sfondo cose non
dette, che hanno a che vedere col modo di vivere il problema, con gli sfondi
vissuti da cui può nascere la voglia di discuterne. Parafrasando un passo delle
Lettere a Milena di Kafka, si può dire che il bisogno di bellezza nasce, più
che in analogia con un proprio stato felice, dal “profondo inferno” di una
situazione storica ed esistenziale, di esasperazione e di disperazione, in cui
si è capitati. Non siamo solo le mete cui aspiriamo, i risultati che
raggiungiamo (e che possono essere buoni o apparire miseri se confrontati con
quelli raggiunti da altri), ma anche la fatica, il piacere o i dolori, le
difficoltà che abbiamo attraversato per raggiungerli. Anche di questo, parlando
di mete e di valori, dovremo tener conto. Nell’ottica di Chiodo la bellezza
riguarda un fine cui si tende, più che non il terreno da cui affiora, più che
non il cammino laborioso che conduce a esso, più che non gli effetti che
produce nella realtà in cui si genera. Tocca le nostre speranze, gli ideali che
pur sempre orientano la nostra vita, più che non quanto di fatto ne resta nel
mondo in cui viviamo; incarna le nostre più ottimistiche attese. Occorre anche
però subito sottolineare che solo la meta ci permette di orientarci nel
cammino, e di parlare di eventuali deviazioni, o cadute. La bellezza resta
comunque l’ombra nascosta che ci accompagna, per lo più taciuta, anche nelle
ricerche su ciò che più si scosta da lei: non solo il sublime, il comico, il
tragico o il grazioso, ma persino il brutto. E dunque ben venga questa
tematizzazione diretta di essa.
*
L’esergo dostoevskiano, tutt’altro che scontato, già dà
un’indicazione pertinente di quanto seguirà nel libro. Simona Chiodo già nella
premessa chiarisce: la bellezza è “esperienza estetica di qualcosa di reale
(che osserviamo) che, anche se non è, e non può essere, ideale, sembra quasi
portarci, comunque, a qualcosa di ideale (che immaginiamo)”; e ancora: “può
soddisfare un essere umano che sta osservando qualcosa di reale, ma la cosa
eccezionale che la bellezza fa è potere soddisfare un essere umano che sta
immaginando qualcosa di ideale”. Ricapitolo a modo mio: bella è l’esperienza
(osservazione) di qualcosa di reale (di sensibilmente dato dunque) che
soddisfa, e soddisfa perché nel reale immagina qualcosa di ideale. Parlare
della bellezza con gli strumenti che l’odierna filosofia anglosassone mette a
disposizione la fa apparire in una luce nuova, la mostra sotto un punto di
vista da cui rivela aspetti inediti. Costituisce un approfondimento di tratti
tradizionali della bellezza (ad es. il suo porsi come termine medio tra reale e
ideale) visti però in una luce inedita.
*
Quanto al metodo di cui Chiodo si avvale, questo studio
riecheggia un precedente lavoro, che aveva di mira la fondazione del dualismo
(e dell’empirismo): Apologia del dualismo. Il procedere filosofico era, ed è,
più vicino al razionalismo che all’empirismo; cosa che non si può certo
rimproverare. D’altronde, una teoria dell’empirismo non è detto debba essere
essa stessa empirista; e allo stesso modo una teoria della bellezza non é detto
debba essere essa stessa “bella”. Il libro ha un suo spessore che non esisterei
a definire “metafisico” o “totalizzante”; il discorso si muove nell’ambito
della “credenza” più che della “certezza”. Tuttavia: davvero si possono evitare
i rischi di totalizzazione? O non resta questo rischio uno sfondo tanto più
presente quanto meno tematizzato? La
tendenza a effetti di assolutizzazione - e di universalizzazione indebita - ci
appartiene. Riguarda tutti noi la tentazione di cedere all’ “ambizioso gesto
universale del libro” (le parole sono di Benjamin). Rischi di “dogmatizzazione”
sono inevitabili. L’autrice ne è peraltro consapevole; e non è cosa da poco. È
positiva la coscienza che questi rischi vanno evitati, finché si può. Fino al
limite, almeno, in cui si toccano convinzioni vissute, senza cui la vita non si
tiene insieme.
*
La bellezza, le qualità estetiche, o il loro
offuscamento, la loro parziale realizzazione o la loro stentata sopravvivenza
sono un tratto insopprimibile della scrittura. Affiorano sempre nei modi (anche
i più “scientifici”) in cui ci si esprime. Anche scritti apparentemente tutti e
solo centrati, diciamo per brevità, sui contenuti, non mancano di una
dimensione significante contenuta nelle pieghe “indirette” del loro
articolarsi. Ricordo il vero e proprio veto posto, in ambienti pur
accademicamente qualificati, sulla considerazione del problema dello stile di
un filosofo, considerato una qualità del tutto superflua, anche nel senso di
priva di rilevanza oggettiva. Allora in gioco era Kant, l’ostinata inibizione a
soffermarsi sui significati consegnati nelle qualità secondarie della sua
scrittura. Con ciò si era resi ciechi a un tratto della realtà di Kant, e della
realtà tout-court; con danno per la formazione degli studenti. Saper scrivere
era considerata una qualità irrilevante, sovente ignorata, quando non ritenuta
controproducente. Riconoscerla, più che un complimento, esprimeva una riserva.
Passavano sotto silenzio i mondi di significati che in quelle sfere subliminali
si esprimono. Del resto anche nei rapporti umani non si è colpiti dai modi,
prima ancora che da quel che “oggettivamente” si dice?… “e il modo ancor
m’offende”…
Non devono mancare, nell’esperienza di un libro,
considerazioni impregiudicate sui lati significanti della scrittura. Su modi che in prima istanza
possono prendere, suscitare interesse, talvolta avvincere. Anch’essi sono
parte, e non indifferente, della verità che gli scritti vogliono comunicare.
Un modo di procedere che non rimuova le proprie valenze
estetiche lo si vorrebbe d’altronde veder applicato a tutte le realtà che hanno
bisogno di duttili strumenti di comprensione, non solo discorsivi.
*
La mia tendenza leggendo è a spostarmi ai margini del
testo di Simona Chiodo (anche per mancanza di un’esperienza adeguata del mondo
filosofico in cui opera): a collocarmi cioè nel mondo dei presupposti che
motivano la sua scelta. E certamente in questo metto in gioco anche dei miei
presupposti. Mi dà da pensare il suo modo di essere nei suoi scritti. Chiodo si
vive bene nel ritmo del suo discorso - un ritmo “amorevolmente” (è il caso di
dirlo) sostenuto da letture, intuizioni, conferme, rinvii. Si “vuol bene”
insomma mentre scrive, questo fa piacere. È benvenuto anzi, soprattutto quando sono in gioco persone di cui si
intuiscono malesseri e disagi, e infine hanno quanto meno trovato un luogo
accogliente. Resta il senso di un filosofare in atto, che si sviluppa sotto gli
occhi del lettore. Un senso dinamico che include lo stile argomentativo, un
gusto teoretico ma insieme letterario, una modalità “artistica” dunque. Il
meccanismo discorsivo è stringente nella sua logica, rigoroso; Chiodo sa
chiudere in uno stretto cerchio temi di assoluta rilevanza. Ci vuole
disponibilità alla concentrazione a leggere i suoi libri, una mente non
affaticata. L’andamento non è rettilineo, bensì piuttosto a spirale, con
ritorni quasi refrain che ne
allargano il senso. Tutto fa sempre pensare (troppo? ma questo riguarda
me).
*
Anche in questo studio sulla bellezza, come nell’apologia
del dualismo, Chiodo privilegia, nel modo di argomentare, la congiunzione sullo
stacco, la ripresa fluida, un movimento continuo che si riprende e si
ripropone. Stende una rete di relazioni, un tessuto di rimandi culturali, trame
unificanti - del resto ricche, affascinanti più delle giustapposizioni, delle
separatezze incomponibili. Relazioni sono anche le citazioni, come lo sono i
frequenti riferimenti, a opere d’arte, eventi culturali di cui il libro è ricco
– benvenuti, anche perché danno respiro a un lavoro che altrimenti rischierebbe
di chiudersi su se stesso. Le sono
estranee le enfasi, questo è apprezzabile. C’è una tensione del pensare, encomiabile.
Ammirevole l’energia teorica (Simona Chiodo ha istinto teoretico, non è poco)
con cui si confronta con altri. Il lavoro non è da storici della filosofia, ha
andamento “teoretico” appunto, se si vuol seguire la nota falsariga.
Simona Chiodo
La bellezza.
Un’introduzione al
suo passato e una proposta per il suo futuro.
Ed. Bruno Mondadori, 2015
Pagg. 182 - € 18,00
Pagg. 182 - € 18,00
PERSONA. IL NUOVO LIBRI DI EMILIO RENZI
di Fulvio Papi
 |
| La copertina del libro |
I nostri
giorni sono ancora prossimi alle rovine di quello che fu un diffuso storicismo
(molto più complesso di quanto non immaginasse Popper nel suo celebre libretto)
e da queste rovine sono nate domande su “chi siamo”, “che cosa possiamo essere”,
“come siamo” nella condizione di parlare, quali sono i “dispositivi” che ci
condizionano, e - in questa complicata situazione - quale possa essere oggi
quella “cura di sé” che fu tipica della cultura antica. È naturale che in
questo movimento accadesse che alcune parole guadagnassero il livello del
discorso meditativo e altre scendessero agli inferi della dimenticanza. Vediamo
alcune parole che sono scese nel loro abisso. Il “cittadino” di Rousseau ha
assunto quasi un tono parodistico; “compagno” è una parola che sottintende una
comunità di senso e di tempo che non esiste; la parola “repressione” - divulgata,
sbagliando, da una sinistra psicoanalitica - non lo si adopera nemmeno nei casi
in cui avrebbe un senso; la parola “borghese” non ha più alcuna generalità; persino
il potentissimo “soggetto” - che in filosofia apparteneva sia agli idealisti
che, in modo diverso, ai fenomenologi - è al tramonto. Oggi si dice “soggettività”.
È rinata invece con estrema
energia intellettuale la parola “persona”, che ha assunto un valore oppositivo
ad ogni condizione dell'uomo che sia costretto a soggiacere a violenze e soprusi
di ogni genere. Persona è il bambino che soffre la denutrizione, persona è
l'uomo che subisce una guerra, persona è la donna che è violentata nella sua
esistenza da ogni forma sociale e culturale di dominante maschilismo, persona è
l'individuo soggetto a insensate ma dure opposizioni politiche, persona è anche
chi debba scontare pene giudiziarie. Direi che la parola “persona” ha assunto
numerose supplenze semantiche e così ha assunto una forte rilevanza ontologica.
Nel bel libro di Emilio Renzi vi
è implicita tutta questa vicenda come pre-cognizione effettiva che conduce al
superiore livello della riflessione filosofica, esplorata poi in tutta
l'estensione del pensiero contemporaneo. Nella nostra provincia filosofica la
parola “persona” era proprietà intellettuale dei pensatori di tradizione
spiritualistica che oggi pochi ricordano. Nella Filosofia del diritto di Rosmini, persona ha una doppia (ma
connessa) valenza. Per un verso è la natura spirituale della creatura di Dio,
per altro il principio della persona è informato dalle linee di una ragione che
è norma di giustizia. I filosofi spiritualisti italiani non hanno valorizzato
questo secondo aspetto, che - al contrario - appartiene del tutto al
personalismo francese di Maritain e di Mounier, ben noto tra noi negli anni
passati, dal tempo in cui una rivista personalista come «Esprit» costituiva un
ponte diretto con i marxisti dell'umanesimo e della alienazione. Renzi sul tema
della persona ci conduce attraverso le grandi filosofie di Renouvier, Husserl, Scheler,
Merleau-Ponty, ciascuna con le sue particolari tonalità teoriche che però non
posso riprendere in questa breve nota. Farò un'eccezione per il caso (che mi
chiama personalmente) di Banfi. Nel 1942 il filosofo scrive alcune note
fondamentali sul tema della persona, rimaste inedite sino a quando l'iniziativa
e la solerzia di Livio Sichirollo (un altro amico carissimo perduto) non le
hanno rese pubbliche. Gli inediti di Banfi hanno ciascuno una sua storia che è
tutta da capire. In questo caso la riluttanza alla pubblicazione credo
derivasse proprio dalla egemonia spiritualista che esisteva in Italia intorno a
quel tema. Se comprendiamo bene il significato di “persona” in queste note banfiane
possiamo vedere con facilità la connessione con il suo saggio di due anni
successivo intorno a Moralismo e moralità.
“Persona” si diventa - secondo Banfi - quando nella esperienza individuale si
abbandona il sistema pacificato che ha condotto la vita quotidiana per porsi un
problema ideale della propria vita che apre un orizzonte nuovo alla ricerca,
nel sacrificio necessario del lontano “io”, di partecipazione a un senso
tendenzialmente universale. Può parere strano, ma nella casta scrittura banfiana
c'è persino una parentela con la letteratura esistenzialista, nella quale un
nuovo sentimento della vita spezza l'opacità quotidiana dell'abitudine
consolidata. Più da vicino, il senso banfiano della “persona” nelle
rielaborazioni teoretiche personali dei suoi allievi è presente come moralità
delle loro filosofie: come “soggetto” in Paci; nell'umanesimo “non enfatico” di
Cantoni; nel corpo dell'arte di Formaggio e via dicendo. Per quanto riguarda
Banfi, vorrei ricordare che una parte della sua tesi del 1909 con Martinetti
era proprio dedicata all'ultimo Renouvier che scrive pagine mirabili sulla
persona, allora certamente prossima per Banfi alla rigorosa e affascinante
presenza della “coscienza” in Martinetti. Banfi ritrova però nella concezione
della persona di Renouvier un limite rilevante nella mancanza di una più compiuta
dialettica tra persona e mondo, tra soggetto e oggetto, come aveva imparato
proprio in quel periodo dalla lettura appassionata di Hegel. Merito rilevante
di Renzi (la cui scrittura, senza nulla perdere, arriva ai problemi teorici centrali
senza quegli acrobatismi verbali e quelle noie espositive di tanti testi) è il
collegamento sociale della visione personalistica con il senso che Adriano
Olivetti dava alla sua impresa industriale e alle iniziative sociali e culturali
che davano un valore collettivo non solo monetario al profitto. È il caso
storico in cui gli uomini si tramutano da merce a persone. E da qui,
politicamente, sarebbe il caso di ricominciare.
Emilio Renzi,
Persona
Una antropologia filosofica nell’età della
globalizzazione,
Ati -Editore Milano 2015SPILLI
. Causa di morte sociale. Uccide
più l’indifferenza della malattia.
. L’indifferenza neutralizza
qualsiasi forma di prevenzione.
. L’indifferenza è il silenzio
assordante di spari annunciati di una società senza famiglia…
. Un
movimento politico che deve rispondere ad una regia di burattinai non è
democratico.
. Il mondo è
fatto a scale… accattivante è scenderle alla Wanda Osiris.
. Un paese
per vecchi. Per non soffrire di solitudine oggi ci si sposa in età matura
procreando da anziani…
. L’uomo
violento è un impotente.
. Società
violenta contro natura. Inutile andare contro natura. La morte sa arrivare da
sola.
. Castello
di carte. Se lo spirito forte sposta anche le montagna, il materialismo crolla
alla minima scossa.
. Qualcosa mi
sfugge: l’attimo sfuggente da repentina corruzione…
. Accoglienza.
Nelle città morte i turisti sono visti come alieni per cui la voce Turismo è
una causa persa…
. La fame
d’amore dell’Occidente si nutre solo se elimina la fame nel mondo.
. La
razionalità è generatrice di alibi…
. L’Arte è
viva quando è attraversata da quel dolore che apre varchi sull’infinito, dove
c’è la storia del cosmo in ogni sua piega oscura…
. I comici
pieni di dolore ballano sul palco la tarantola del cervello…
. Leggere
genera empatia. Infatti è la conferma di due anime in una.
. C’è chi è
poeta e chi fa il poeta.
. Metti un
fiore… Nei cimiteri i fiori invece di essere rubati vanno acquistati per
adornare le tombe in stato di abbandono.
. Il cimitero
dovrebbe essere la rappresentazione dell’Eden dove lo spirito aleggia fra
resine ed olezzi.
Laura Margherita Volante***
POESIA
CARLA CANTINI
Tre poesie inedite
Dice un asceta antico...
Dice un asceta antico che nei boschi è il segreto
della vita e dal fogliame loro più ebbe inteso
di quanti sacri scritti assiduamente compulsati
E diceva, per esempio, le nervature guarda
delle foglie: il filame sono delle mani
i riposti segni che dicono il destino
E i diritti alti tronchi radici slancio, strada -
i rami, aperte braccia del coraggio; quando
reclini, il dolore che innanzi a sé non vede
Anche diceva - un albero ricorda non è albero
solo - le fronde e il tronco e i bei rami
fioriti a primavera; è ricovero e nido
è rifugio e tana ai molti che non sai
casa di chi non vedi. E tanto ancora si cela
alla tua vista - e pure come la linfa esiste
E il giovane vigore guarda dei torrenti
e il lento scivolare dei ruscelli che smorzano
nel fiume - come all'ora nostra noi...
Ma questo asceta non tutto disse -
forse non seppe, mai.
***
Settembre
Dolce ti stemperi settembre
nei tramonti tardivi che l'oro
antico scrive - sulla piana
vastità ti stendi
tra tortore di perla.
***
E ti rivedo
A volte un sorriso breve -
un contrasto d'ombre - baluginìo
di qualcosa mai
dimenticato. E ti rivedo -
oltre le stagioni
e i tempi - intatto.***
LIBRI
Emilio Renzi: La centralità della persona
La "concretezza" della Persona sta nel
suo essere un plenum di pensiero ed
empiria, diritti e "storti" della Storia. Persona sta nella Comunità,
comunque intesa (e criticata) e nella Città dell'Uomo, che io vedo (amo vedere)
come Città cosmopolita.
 |
| La copertina del volume |
Così Renzi esprime in sintesi il senso del suo lavoro,
ampiamente argomentato da varie riflessioni e da una serie di puntuali
accostamenti ai testi. Un primo riferimento (p. 28) è dato dal personalismo laico di Renouvier
(1815-1903), ma troviamo anche un passo di Bobbio (p. 44) secondo il quale la
persona è una conquista storica e non una sorta di 'ατομοs. Sartre diceva del
resto, con efficace espressione: "L'uomo è una monade che fa acqua".
La persona infatti “è, in quanto è dentro a una storia” (p. 107). Anche il
relazionismo di Paci è chiamato in causa, in quanto in esso "il soggetto è
persona concreta". (p. 65). Il sottotitolo del libro contiene il termine Antropologia filosofica, in quanto la
nozione di persona, così come nel testo viene intesa, non può prescindere dalla
dimensione interculturale, con tutti i conflitti che ad essa si riferiscono.
Come ricorda Renzi, vanno riconosciuti i diritti
dell’uomo, anche a prescindere dal Traité
di Voltaire (p.125), che pure affronta il discorso con chiarezza. Credo
tuttavia che il problema riguardi anche gli inevitabili scontri che si creano
davanti a diversi e inconciliabili modi di sentire, che andrebbero risolti
dall'interno. Attualmente il problema si presenta in una dimensione
internazionale, ma la sofferta questione dei rapporti fra nord e sud in Italia
dovrebbe pure averci indotti a riflettere già da tempi remoti. Oggi direi che
il problema delle "disgiunture" si pone come qualcosa di importante e
di non facile soluzione, perché si tratta di conflitti profondi fra ovvietà ed
evidenze diverse, per definizione non mediabili. Dal punto di vista
sociologico, la Bibbia rappresenta il caso fortunato in cui le religioni delle
dodici tribù riuscirono a fondersi in una sola in cui come sempre "Baal
cavalca le nuvole", ma il nuovo Adonai “sta sopra i cherubini",
includendo le varie credenze in uno schema unitario. Un caso del genere
tuttavia non mi pare sia più accaduto; in India assistiamo a conflitti tremendi
fra musulmani e indù, che non hanno avuto tregua nel trascorrere di oltre mille
anni. Fatti analoghi si riscontrano anche altrove, benché i conflitti non
sempre siano atavici: in alcuni casi, come nella ex Iugoslavia, sembrano
causati da interventi in parte mediatici e attuati in periodi molto recenti. In
ogni caso la soluzione, dice Renzi, non può consistere in un: “Multiculturalismo,
che sbocca in un vestito di Arlecchino di quartieri l'un contro l'altro
accostati, impermeabili e potenzialmente ostili”, perché il problema esige un
risposta ben più profonda. Se la persona, come abbiamo detto, è una conquista
storica, ci sarà bene un motivo storico di unificazione, valido anche oggi per
noi, e legato al continuo modificarsi di ogni tradizione, che pur caratterizza
la nostra epoca. "Le dure lotte politiche" in atto (p.121), purtroppo
inevitabili, dovrebbero alla fine aprire spazio a un'antropologia nuova, capace
di superare i conflitti che stanno lacerando intere nazioni.
Il libro di Renzi costituisce un valido contributo per
ragionare in questo senso, riconoscendo che l’uomo non è solo il prodotto
dell’oggettività storica, ma è anche il risultato della ragione critica
esercitata dagli uomini.
Gianni Trimarchi
Emilio Renzi
Persona.
Una antropologia
filosofica nell’età della globalizzazione
ATI editore Milano, 2015
Pagg.138 € 15,00***
LA MAGNOLIA CONTRO LE PERSIANE
Un racconto di
Alessandra Paganardi
I ricoveri ospedalieri nei mesi caldi sono quasi
una fortuna. Se non sei troppo debole puoi passare gran parte della giornata
all’aria aperta, senza avvertire il fastidio della reclusione. Trascinare la flebo, è vero, pesa un po’: ma
basta immaginare che sia un carrello o un passeggino, collegato al tuo corpo
con catene gentili. Di fronte alle panchine del giardino c’è una vasca con
qualche pesce rosso per rallegrare i lungodegenti. Tutto questo non è male e
oggi, poi, mi sento pienamente in forze.
Se ci fosse qui Amadi il mio carrello sarebbe ancor più
leggero: una culla d’aria.
La vista dell’acqua mi rallegra sempre. Forse perché
l’acqua è stata un elemento importante per la mia generazione. Sono nata in una
cascina fuori città ed ero l’ultima di quattro fratelli, fra i quali Nuccia, la
terza, aveva otto anni più di me. Negli anni del dopoguerra, quando dopo le
commerciali mi stabilii a Milano per cominciare a lavorare, anche lei si era già
sposata. A scuola riuscivo bene: il giorno del diploma l’insegnante di
stenografia disse a mia madre che ero già una segretaria fatta e finita. Presi
in affitto un appartamento a pochi isolati dall’ufficio; portai con me una zia
materna, l’unica ancora vivente e ormai anziana. Dalle nostre finestre al
secondo piano si vedeva scorrere la roggia Vettabbia. Non puzzava come adesso,
mi ricordava anzi qualcosa dei nostri fossi e dei nostri orti. Forse per questo
mia madre, dopo la morte di mio padre e l’esaurimento delle ultime attività
della cascina, ci raggiunse ben presto.
Si trovava molto bene lì, forse meglio di quanto mi trovassi io. Ho sempre ammirato il suo spirito d’adattamento, così tipico delle donne del suo tempo. Per me, invece, tutto era cambiato troppo in fretta in pochi anni, come se la storia ed io avessimo vissuto una burrascosa adolescenza parallela, poi un repentino arresto. Avevamo sempre avuto tante persone intorno, quasi abitassimo in un porto o in una città di frontiera. Prima i miei fratelli, zii e cugini, poi la gente che veniva da noi a comperare uova, galline e conigli; infine gli sfollati che cercavano riparo e ristoro per qualche giorno, prima di proseguire per le colline. I miei genitori erano molto generosi: io non potevo ancora capire tutto, ma sentivo che nella nostra casa si respirava un clima di solidarietà. Credo non abbiano mai esagerato con la borsa nera; condividevano al giusto prezzo un benessere che sfuggiva a tutti dalle mani, ma che proprio per questo, pur assottigliandosi, diventava sempre più grande e prezioso. Un po’ come certi tramonti caldi in autunno, quando sembra di poter afferrare col viso gli ultimi strappi di sole.
Si trovava molto bene lì, forse meglio di quanto mi trovassi io. Ho sempre ammirato il suo spirito d’adattamento, così tipico delle donne del suo tempo. Per me, invece, tutto era cambiato troppo in fretta in pochi anni, come se la storia ed io avessimo vissuto una burrascosa adolescenza parallela, poi un repentino arresto. Avevamo sempre avuto tante persone intorno, quasi abitassimo in un porto o in una città di frontiera. Prima i miei fratelli, zii e cugini, poi la gente che veniva da noi a comperare uova, galline e conigli; infine gli sfollati che cercavano riparo e ristoro per qualche giorno, prima di proseguire per le colline. I miei genitori erano molto generosi: io non potevo ancora capire tutto, ma sentivo che nella nostra casa si respirava un clima di solidarietà. Credo non abbiano mai esagerato con la borsa nera; condividevano al giusto prezzo un benessere che sfuggiva a tutti dalle mani, ma che proprio per questo, pur assottigliandosi, diventava sempre più grande e prezioso. Un po’ come certi tramonti caldi in autunno, quando sembra di poter afferrare col viso gli ultimi strappi di sole.
La città si rivelò subito tutt’altra cosa. Persino
incontrare i vicini sulle scale aveva sempre alcunché d’imbarazzante, come se i
saluti fossero costantemente messi all’asta. In ufficio le cose non andavano
molto diversamente: con le coetanee era difficile scambiare una parola e ancor
più con le impiegate esperte, circondate com’erano da un cliché di severa
riservatezza, quasi di mistero.
Fu proprio il lavoro in ditta a farmi incontrare donna
Milena. Era stata l’amante di un gerarca ucciso dai partigiani all’inizio della
Resistenza; presto, avvalendosi di appoggi importanti, aveva inaugurato una casa
di piacere di prima classe, quasi di fronte a quella che poi divenne la sede
definitiva della ditta. Con gli anni la nostra impresa era cresciuta e il mio
titolare aveva appaltato la contabilità di vari negozi e attività vicine, fra
cui il bordello di donna Milena. Alla fine di ogni mese, poco prima dell’ora di
pranzo, avevo il compito di ritirare e riportare personalmente i registri.
Era una donna molto riservata; portava con sé il passato
con l’eleganza distratta con cui s’indossa un abito di circostanza, una divisa
quasi non più nostra. Mai una volta la vidi compiere un gesto volgare, eppure
certo n’era capace. Forse aveva frequentato brillantemente una specie di scuola
di volgarità, come altri cercano di frequentare senza esito tutti i possibili
corsi di stile. Ammiravo il suo sguardo, penetrante anche se mai diretto, che
prendeva a calci la svenevolezza e respingeva la malinconia, allo stesso modo
in cui una bella signora rifiuta un cavaliere troppo insistente. Mi apprezzava
anche lei; lo seppi poi dai fatti, molto di rado dalle parole. I discorsi sono
l’accompagnamento musicale degli eventi: alcune persone sanno comporre sinfonie
complesse che arricchiscono tutto, altre realizzano capolavori con un
unico, sobrio assolo.
All’inizio degli anni Cinquanta conobbi Elio e ben presto
ci fidanzammo. I suoi genitori erano proprietari di una pasticceria prossima al
centro storico, distante non molte fermate di tram dalla mia abitazione; la
nostra officina meccanica forniva i pezzi di ricambio alle loro macchine
impastatrici. Aveva un paio d’anni più di me e aveva già preso in mano con
successo la fiorente attività della casa. La pasticceria si trovava a pochi
metri dalla parrocchia del quartiere e la domenica mattina, quando andavo a
trovare il mio promesso sposo per una breve passeggiata e poi lo affiancavo in
negozio, vedevo sfilare una piccola Milano vestita a festa: bambini urlanti,
spesso gli stessi, ma di colori sempre diversi da una domenica all’altra;
cinquantadue fogge mai ripetute una volta, soprattutto fra le femminucce. I
genitori si davano da fare a calmarli con un cannoncino o una meringa, prima di
brandire con orgoglio il nastro del vassoietto ondulato di cartone, contenente
il resto del bonus festivo. Ai genitori di Elio davo una mano nella contabilità,
che non era il punto forte del loro erede: mi divertivo, in fondo per me era un
po’ come andare al cinematografo. Ero abituata a feste completamente diverse:
non così cadenzate e frequenti, tutte ordinatamente farcite di creme chantilly
e baci di dama. Ricordavo riti più rari, sanguigni e terrestri: sapevano di
enormi catini, di panni stesi lontano dalla tavola, raggiunta di corsa sotto il
pergolato; non somigliavano a quelle concitate passerelle settimanali attorno
ad un bancone, per conquistare infine il traguardo ambito di un registratore di
cassa.
Pochi anni dopo il nostro arrivo a Milano, mia zia
cominciò a manifestare disturbi neurologici progressivi ed ebbe bisogno di cure
continue. Mia madre, che era più giovane, scelse di essere ricoverata insieme
con lei in una casa di riposo, che ospitava anziani ancora autosufficienti e
altri che non lo erano più. La retta per i disabili era a quasi totale carico
dello stato e le due pensioni bastavano per pagare la pigione e soddisfare i
bisogni di mia madre. Credo che l’abbia fatto per affetto nei confronti della
sorella, alla quale era molto legata, ma soprattutto per non gravarmi di un
peso. Era consapevole di togliermi un sostegno economico e morale importante,
ma sapeva che questa nuova responsabilità avrebbe fatto da catalizzatore per le
mie scelte future. In fondo non ero mai vissuta sola. Era il momento di
provare.
La casa era divenuta troppo grande e onerosa per me e la
scelta più ovvia sarebbe stata quella di cercare una sistemazione diversa, cambiare
lavoro oppure affrettare le nozze. La prospettiva di continuare il mio mestiere
di contabile alloggiando in un appartamento più scomodo e magari distante,
certo, non mi faceva impazzire; tuttavia l’idea di entrare nella vetrina di
Elio come un friabile frollino a fianco di una sontuosa cioccolata, con la
routine feriale degli impasti quotidiani e il variopinto zoo festivo di coretti
e comunioni, adesso mi entusiasmava ancor meno. Quando ci eravamo messi insieme
non avevo pensato seriamente a tutto ciò. Chissà perché succede questo:
soffriamo di presbiopia verso il passato e siamo invece così miopi riguardo al
futuro, come se le leggi del tempo dovessero mutare per ragioni misteriose a
nostro favore. Soltanto da vicino, ingrandita a dismisura dalle lenti concave
di una decisione improrogabile, cominciavo a veder chiaro in me stessa.
Glielo dissi d’estate, la sera del suo compleanno, mentre
mi mostrava con fierezza la meritata Lancia Coupè ricevuta in regalo dal padre.
Credo non si aspettasse la notizia del mio abbandono, eppure trovò assai
rapidamente il modo di farsene una ragione, anzi di addebitare il fallimento
unicamente a me. Mi disse che ero in gamba e avevo il senso degli affari, ma in
fondo i sorrisi ironici con i quali guardavo le vetrine e i clienti, uniti al
mio modo un po’ troppo personale di vedere il mondo e di santificare le feste,
non avevano mai convinto molto né lui né i suoi genitori. Aggiunse anche che
una futura brava moglie avrebbe aspettato il giorno del matrimonio prima di
concedersi, o almeno si sarebbe presentata al fidanzato al netto assoluto di
esperienze precedenti. Da buon imprenditore, Elio stava trasformando la rottura
del fidanzamento in una vera e propria partita doppia, con l’acuta
constatazione che sventare un disavanzo passivo giustificasse gli investimenti
a fondo perduto realizzati su di me in vista del mancato matrimonio: certo non
mi attendevo tragedie sentimentali, ma questa virata mi rattristò alquanto. Poi
mi tornò in mente la cascina, la bella confusione fra interno ed esterno, i
corteggiamenti dei coetanei, consumati senza troppo pudore in cortili e
fienili; pensai ai baci che avevo dato e ricevuto al riparo da ogni calcolo, al
piacere di vedere me stessa fiorire libera e sana, dopo la paura della guerra e
dei bombardamenti così vicini. Incominciai a ridere tanto forte che Elio,
divenuto ancor più rosso della sua auto nuova di fiamma, andò su tutte le furie
e mi cacciò via.
Sposò una pia maestra d’asilo, di buona famiglia e più
anziana di lui, con una perenne acconciatura a chignon che rendeva la sua testa
simile a un cannolo siciliano. Ebbero un’unica figlia, nata da genitori già
maturi; la esponevano con fierezza delicata, come si fa con un prezioso pan di
zucchero. Verso la fine degli anni Settanta seppi che la pasticceria,
nonostante gli incassi sempre eccellenti, era stata con grande urgenza venduta.
Correva voce che, amorevolmente coccolata fra creme e biscotti, la figlia
avesse manifestato un tale rifiuto di qualunque cibo e un deperimento così
devastante, da costringere i genitori a cessare l’attività e a ricoverarla in
una casa di cura specializzata, per scongiurare il peggio. Preferii non
domandare mai più nulla di loro.
Poco dopo la rottura con Elio mi licenziai. Il
capoufficio non fece storie e non mi negò, come invece temevo, la piccola
liquidazione che mi spettava. Lo vidi sinceramente dispiaciuto di perdermi come
impiegata; ma forse avrà pensato che un’indocile ragazza di campagna si
rimpiazza in fretta con qualcun'altra, magari disposta ad essere pagata ancor
meno e a cedere su vari fronti.
Andai per l’ultima volta a consegnare il registro alla
signora Milena e le dissi senza troppi preamboli che volevo lavorare per lei.
Non mi fece discorsi materni, né tantomeno tirate moralistiche: non era il
tipo, e poi aveva capito benissimo che io stessa ero poco incline alle
confidenze. Si accertò che avessi compiuto i ventuno anni e mi diede da
sbrigare alcune commissioni di tipo burocratico. Mi disse anche che ci teneva
moltissimo che io continuassi a tenere la contabilità dell’impresa e che,
naturalmente, questo incarico sarebbe stato conteggiato a parte. Tre giorni
dopo mi presentai all’ora stabilita per la visita medica e la settimana
successiva divenni ufficialmente ospite della casa.
Furono anni tranquilli: lo dico senza vergogna né
rimpianti. La pigione era gratis e la doppia attività di giovane prostituta e
di contabile mi rendeva più di quanto avessi mai immaginato. Milena era una
manager speciale: manteneva le distanze, ma si rapportava a noi con simpatia e
con un intuito tutto suo, che la portava quasi a presentire ciò che non andava.
Era la prima ad accorgersi quando qualcuna di noi aveva un turbamento e
riusciva sempre a intervenire con intelligenza. Se i problemi erano gravi, se
una ragazza non ce la faceva più o aveva grosse difficoltà personali, l’aiutava
a trovare con discrezione un altro lavoro; le dava anzi un incentivo economico,
proporzionato all’anzianità e all’impegno. Non vivevamo segregate, ma neppure
esposte senza nessuna protezione al giudizio impietoso della gente: nel tempo
libero andavamo in gruppo al cinema o a ballare in altri quartieri, a volte
accompagnate per pura cavalleria da clienti scapoli o vedovi, dei quali eravamo
diventate quasi amiche; a volte da sole, come fossimo ragazze normali. Nessuna
di noi si è mai sentita schiava o prigioniera.
La zia morì al ricovero e mia madre le sopravvisse di
alcuni anni, circa la loro differenza d’età. Non seppe mai nulla della vita che
avevo scelto: mi vedeva tranquilla e credeva che fossi cresciuta di livello
presso l’ufficio in cui lavoravo. Forse sospettava una relazione con qualche
uomo facoltoso, ma non mi fece mai domande. Neppure la rottura con Elio la
stupì. Andavo a trovarla ogni domenica e avevo sempre cura che non le mancasse
nulla, che si trovasse bene sotto ogni punto di vista.
La mia attività nella casa di piacere non durò a lungo. A
metà degli anni Cinquanta, un po’ per intuito e un po’ per le informazioni
privilegiate che riceveva dai suoi amici approdati in parlamento, donna Milena
aveva già capito che la legge sulla chiusura non si sarebbe fatta attendere.
Decise allora di anticiparla e di iniziare i lavori di ristrutturazione, per
trasformare il bordello in un piccolo hotel.
Un giorno, poco prima della chiusura, Milena mi convocò
nel suo ufficio e mi propose di restare al suo fianco, per dirigere l’albergo e
gestire le attività successive. Nei suoi piani la nuova casa non doveva
diventare uno squallido hotel equivoco, ma una pensione cittadina di passaggio:
il piano terra, quasi una dependance isolata, sarebbe stato riservato agli
incontri a pagamento, il primo piano era destinato alle coppie furtive e
l’ultimo alla normale clientela a buon mercato. Bastava organizzare bene orari
e stagioni e governare con intelligenza gli avventori occasionali, quelli meno
affidabili e più pericolosi per il decoro della casa. Il sesso clandestino, per
mercimonio o per passione, avveniva da sempre in tutti gli alberghi del mondo e
non sarebbe stata certo una legge a fermarlo: l’importante, per evitare un
rapido e sicuro degrado, era non appiccicarsi l’etichetta di bordello
alternativo mordi e fuggi, lasciando tuttavia nell’atmosfera quel sottile velo
di ambiguità che poteva persino solleticare gli appetiti dei visitatori,
inducendoli a ritornare.
Secondo lei ero perfetta per questo compito. Avrei
continuato ad abitare lì e avrei diviso gli utili al cinquanta per cento,
diventando ufficialmente sua socia.
La proposta, oltre che allettante, era estremamente
ragionevole. Accettai.
Per tutto il periodo della mia attività manageriale
occupai una stanza al primo piano. Donna Milena aveva ristrutturato l’edificio
in modo da riservarsi un appartamentino privato al piano terra, dietro la
reception. Questa divisione logistica ci permetteva di avere il controllo sulle
attività più delicate e d’ intervenire in caso di problemi.
L’esercizio andava molto bene. Donna Milena, pur avendo
centrato i suoi sforzi sul decoro e sulla dignità della casa, non negava mai un
riparo a chi ne avesse bisogno. Una notte accolse una ragazza scappata di casa
senza domandarle nulla e al mattino la convinse a tornare dai suoi genitori,
prima che se ne accorgessero e la denunciassero in questura. Nei mesi più
rigidi stazionavano spesso da noi dei senzatetto dignitosi e gentili, donne soprattutto,
che chiedevano poi di pagarci almeno simbolicamente. Ospitammo per quasi un
mese una sartina vedova, che non poteva più permettersi l’affitto della casa in
cui abitava: ci regalò dieci coperte all’uncinetto per le stanze più belle del
secondo piano.
All’inizio degli anni Settanta Milena, ormai
ultrasessantenne, espresse la volontà di ritirarsi a vita privata. Era stanca,
senza nessun parente; aveva invece un discreto talento per la pittura e
intendeva passare gli ultimi anni sani della sua vita dedicandosi finalmente a
fare quadri. Mi lasciò libera di dividere equamente con lei il ricavato della
cessione dell’esercizio, oppure di continuare l’attività con un nuovo socio,
dopo il ritiro della sua quota e di una rendita personale. Non ebbi dubbi. Erano
stati anni entusiasmanti e prosperi, ma non avrebbe avuto più senso proseguire
senza di lei. Dovevo organizzare da capo la mia vita, ma ero nelle condizioni
ideali per farlo. A quarant’anni, senza figli né radici, mi aspettava un
capitale tutto mio da investire. Ero un rampicante agile e testardo, che poteva
impiantarsi ovunque. Bastava scegliere il muro giusto.
Vent’anni di lavoro a fianco di donna Milena mi avevano
insegnato molto; penso inoltre
di avere un discreto talento per gli affari immobiliari.
Ogni volta che entro in una casa in vendita si mette in moto qualcosa
d’importante in me, come se i muri volessero suggerirmi un po’ della storia di
chi è passato di lì, ha cenato, pianto e goduto, talora è morto. La casa è un abito strano:
ancor più mutevole di noi, ma troppo grande per seguirci, è destinata a
sopravviverci. Come il guscio
inamovibile della chiocciola che siamo stati.
Scelsi di investire il mio denaro nell’acquisto di tre
appartamenti a Porta Lodovica, a pochi isolati dall’università Bocconi. Lo
stabile era una casa stile vecchia Milano senza ascensore, abitata in gran
parte da persone molto anziane. L’università era in fase di rilancio dopo i
fumi del Sessantotto. Ero certa che, in capo a pochissimi anni, tutta la zona
sarebbe considerevolmente aumentata di valore.
Affittai l’appartamento all’ultimo piano a tre studenti e
a pianterreno, in una posizione tranquilla e defilata, organizzai grazie alle
mie conoscenze una nuova casa d’appuntamenti che funzionava soltanto di giorno,
ad orari assai discreti. Io stessa abitavo da sola in un monolocale situato
sopra la garçonnière.
Le mie previsioni si avverarono in pieno. Dopo una decina
d’anni lo stabile venne completamente ristrutturato, ascensore compreso, e la
domanda salì alle stelle. Gli studenti erano ormai disposti a pagare pigioni
altissime per avere un alloggio, soprattutto se non distante dall’università e
dignitoso.
Fu in quel periodo che decisi di chiudere definitivamente
con l’attività della casa d’appuntamenti. Avevo risposto a un’inserzione su una
rivista specializzata in enologia: un consorzio cercava personale esperto,
disposto a brevi spostamenti per organizzare le esposizioni e seguire il
marketing. Nel curriculum, con la complicità di alcune conoscenti di donna
Milena, indicai come referenza la direzione di vari alberghi.
Mentre mi trovavo a Rimini per una fiera incontrai Amadi.
Era il mese di marzo, faceva ancora parecchio freddo e mi colpì la sfumatura
livida della sua pelle scura, così poco avvezza ai rigori invernali. Stava
appartata rispetto alle altre, quasi dando le spalle alle automobili che
passavano, senza fumare. Conoscendo bene l’ambiente mi resi subito conto che
doveva essere arrivata in Italia con una di quelle organizzazioni che
riscuotono subito tutto il possibile e poi lasciano le ragazze sole, preferendo
reclutarne sempre di nuove. Mi fermai e le chiesi se volesse bere qualcosa.
Sembrava cauta, ma non spaventata; mi disse di non aver avuto il tempo di
cenare la sera prima. La pasticceria del lungomare avrebbe sfornato di lì a
poco i krapfen; proposi allora di mangiarne uno con lei. Una volta rifocillata,
mi confidò di avere i documenti con sé e in regola. Non aveva un vero e proprio
protettore: sapeva bene l’italiano, era arrivata dalla Nigeria con la promessa
di un lavoro, aveva pagato molto cari il viaggio e la sistemazione in un
appartamento con altre ragazze; però non conosceva bene le persone che avevano
riscosso il tributo, e comunque aveva già saldato da tempo il suo debito.
Ci sono decisioni che sembrano rapide, ma solo perché
sono loro a decidere noi. Alla fine del mio incarico lasciai il consorzio e
ritornai a Milano con Amadi. A poca distanza dall’università era in vendita una
vecchia latteria a due luci, spaziosa e in discrete condizioni. Proposi di
comperarla con il denaro che avevo messo da parte e trasformarla in una tavola
calda: io avevo imparato a cucinare molto bene e vantavo una lunga esperienza
di esercizi commerciali; in quella zona, inoltre, gli affari non sarebbero
certo mancati.
In effetti non mancarono. Non so se per la grazia e la
voglia d’imparare di Amadi, se per la mia esperienza o per il fatto che
scegliemmo una formula decisamente diversa dalle altre: una trattoria
specializzata in piatti vegetariani. Era una bella alternativa ai vari Burghy e
Mac Donalds allora emergenti, soprattutto considerando il fatto che la zona nel
suo insieme stava diventando sempre più alla moda, pur conservando una specie
di apparenza alternativa. A mezzogiorno venivano soprattutto studenti; la sera
era la volta delle coppie tranquille e delle compagnie curiose, che
apprezzavano la novità e poi si affezionavano al luogo e al nostro modo di
lavorare originale, allegro e preciso.
Nei miei luoghi e momenti importanti ho sempre avuto di
fronte a me una magnolia.
Sono alberi che s’incontrano quasi all’improvviso e nei
luoghi meno prevedibili, anche all’interno dei cortili di città. Nel giardino
dietro il bordello di Milena c’era una magnolia, ingranditasi al punto tale da
sfiorare le mie persiane quando le aprivo. Ne ho appena vista una fuori dalle
finestre di quest’ospedale; ne incontrai un’altra poco distante dal reparto di
rianimazione, dove accompagnai Amadi nella sua breve agonia.
Non è vero che esistono beni senza prezzo. E’ una fiaba
per adulti, che rassicura e consola. La verità, assai meno romantica, è che i
beni più preziosi sono desiderati da tutti e non ce n’è mai abbastanza per
ognuno. Allora, anche se non lo si dice, si concordano tacitamente graduatorie
e priorità: non in base al bisogno, che quando esiste è uguale per tutti, ma
soltanto in base a quanto potrebbe costare o rendere la scelta di farli avere a
certuni invece che ad altri.
Per salvare Amadi, comunque, non fu possibile alcun
riscatto. Chissà che cos’è stato a portarsela via così presto, senza
possibilità di appello, chiamandola per nome una volta sola, in maniera
sommessa e perentoria. Hanno parlato di emorragia subaracnoidea: una parola
strana, da entomologo curioso e un poco sadico. Forse è stato il clima, forse
la durezza impersonale di un mondo che non conosceva, anche se l’aveva accolta
con amore. Ciascuno dovrebbe poter morire, se lo vuole, nel luogo dov’è nato.
Ma non è più così importante, se il posto che ti ha visto nascere è morto a sua
volta, se non ha conservato più nulla di ciò che ricordavi.
Sapevo che non c’erano speranze per Amadi e sono stata
con lei ogni istante, fino alla fine. Sull’orlo della vita, sul ponte che
trasforma il peso nero del sonno in un decollo leggero e senza storia, spero
davvero che non si sia sentita troppo sola, troppo triste e troppo lontana.
E’ sempre soltanto una questione di tempo. Basta
aspettare, e succede quasi tutto.
Non c’è mai un’unica vita nell’esistenza di una persona.
Ce ne sono almeno due o tre, ma una pesa più delle altre e fa pendere da una
sola parte il piatto della bilancia: è la nostra vita, quella che viviamo. La
chiamiamo scelta, talora vocazione, ma non accade esattamente così. Io non
parlerei neppure di destino.
Si è fatto tardi. Nel rientrare in camera per le
iniezioni e la cena sono passata davanti a quest’ultima magnolia. Le tapparelle
automatiche salgono e scendono senza toccarla. Non somiglia alle altre che
ricordo: è più piccola, sembra più giovane, anche le foglie sono più luminose.
In fondo nessun albero è mai uguale ad un altro.
***
UN SAGGIO DI MAURO GERMANI SU GABER
Giorgio Gaber:
dialettica negativa e nuovo umanesimo
di Angelo Conforti
 |
| Il poeta e critico Mauro Germani |
Il boom
L’Italia degli anni ’50 e ’60 non è soltanto il Paese
della ricostruzione e del miracolo economico. C’è un profondo rinnovamento
culturale in atto che coinvolge tutti i settori della produzione intellettuale
ed artistica. Anche il mondo della musica cosiddetta «leggera» sta radicalmente
cambiando, sotto l’influenza del rock and roll, ma anche degli chansonniers
francesi.
Tra i tanti personaggi emergenti del periodo ben presto
si segnala Giorgio Gaber, cantante e autore poliedrico, formatosi anche alla
scuola del jazz, e interessato a fondere entrambe le suggestioni più in voga,
quella americana e quella d’Oltralpe. È uno sperimentatore, curioso e aperto,
garbato e ironico, dotato di un’ottima mimica e di una presenza scenica
efficace. Il suo successo cresce costantemente. Si rivela un partner ideale per
Mina, con cui fa coppia in alcuni varietà del sabato sera. Le sue canzoni hanno
spesso un tocco di originalità e di sensibilità per la dimensione del
quotidiano che si esprime in una serie di titoli che attraversarono tutti gli
anni ’60, come La ballata del Cerutti, Trani a gogò, Porta Romana, Il Riccardo,
Barbera e champagne, Come è bella la città, La Chiesa si rinnova, Suona
chitarra.
Ma Gaber non scrive solo canzoni. Già nella stagione
‘60/’61 mette in scena Il Giorgio e la Maria, regia di Giancarlo Cobelli, al
Teatro Gerolamo di Milano, una pièce teatrale recitata in coppia con Maria
Monti. E nel 1966, a Studio Uno, a fianco di Mina, si esibisce in un piccolo
sketch da lui scritto e recitato, Il Tic, stupendo pezzo di teatro in cui
emergono con evidenza tutte le sue doti mimiche, gestuali, vocali, oltre alla
sua attenzione per le tematiche sociali, che all’epoca sta già caratterizzando
alcune delle canzoni che abbiamo citato.
Il ‘68
Tutte le energie innovative di quegli anni si coagularono
nel grande movimento del ’68 che sembrò aprire nuovi orizzonti per il futuro
della società italiana. Ma l’attentato terroristico alla Banca dell’Agricoltura
di Milano, con tutto quel che significava sul piano politico e sociale sconvolse
tutti gli scenari plausibili e aprì una lunghissima stagione di degrado che
coinvolse pressoché tutte le componenti del Paese.
Probabilmente già allora, più in profondità, nelle
dinamiche socio/culturali in atto si stava già preparando la centralità della
televisione e la conseguente mutazione antropologica cui avrebbe dato origine
nei decenni successivi: quella trasformazione nel costume, nella mentalità e
negli atteggiamenti che Jean Baudrillard ha chiamato “il delitto perfetto”, la
sostituzione del mondo virtuale televisivo al mondo reale, l’uccisione della
realtà da parte della tv.
Gaber intanto era diventato un vero mattatore del varietà
televisivo, ma continuava a sperimentare: l’album concettuale L’asse di
equilibrio è del 1968, nei due anni successivi gira per i teatri con Mina, a
contatto diretto col pubblico. Poi un altro Lp anomalo, Sexus e politica con
Virgilio Savona (testi di autori latini). Da agosto a ottobre del 1970 conduce
l’ultimo varietà televisivo del sabato, E noi qui. Gaber è all’apice del
successo, ma forse è tra i pochi che han già intuito quale sarà la parabola
televisiva, già sospetta il delitto perfetto. E allora abbandona la
televisione. Apre la porta del cielo di cartapesta dello studio, come farà anni
dopo in un celebre film il protagonista del Truman show, per uscire nel mondo
reale e non tornare più indietro.
La svolta: da «personaggio» mediatico a «persona» reale
Nei trent’anni successivi il declino dell’Italia sembrerà sempre più irreversibile e ben pochi furono coloro che lo capirono per tempo e seppero sottrarsi, senza rimpianti, alla logica della società dello spettacolo preconizzata da Guy Débord, cioè alla logica del consumismo, della mercificazione della cultura e della trasformazione della merce in spettacolo. Gaber fu tra questi e in quei decenni percorse, con estrema coerenza, una strada totalmente alternativa e lucidamente critica, una strada di ricerca, di sperimentazione, di autenticità, di rapporto onesto, sincero, lucido e critico con la realtà concreta, totalmente altra rispetto alla realtà virtuale della tv.
Nei trent’anni successivi il declino dell’Italia sembrerà sempre più irreversibile e ben pochi furono coloro che lo capirono per tempo e seppero sottrarsi, senza rimpianti, alla logica della società dello spettacolo preconizzata da Guy Débord, cioè alla logica del consumismo, della mercificazione della cultura e della trasformazione della merce in spettacolo. Gaber fu tra questi e in quei decenni percorse, con estrema coerenza, una strada totalmente alternativa e lucidamente critica, una strada di ricerca, di sperimentazione, di autenticità, di rapporto onesto, sincero, lucido e critico con la realtà concreta, totalmente altra rispetto alla realtà virtuale della tv.
In quegli stessi decenni alcuni intellettuali inseguivano
l’utopia della postmodernità individuando nella perdita del senso di realtà e
nella moltiplicazione delle immagini un fattore altamente positivo, liberatorio
e fonte di emancipazione. Nel contempo quasi una società intera si lasciava
tentare dalla promessa che la televisione faceva a tutti e a ciascuno di
diventare famosi almeno per 15 minuti, secondo la profezia di Andy Wharol.
Gaber, invece, procedeva «in direzione ostinata e
contraria», per usare le parole di un famoso cantautore come Fabrizio De André.
Con una scelta radicale e, in qualche modo, clamorosa rifiutava definitivamente
di trasformarsi in un personaggio del mondo virtuale e sceglieva, da tutti i
punti di vista, di ritrovare il rapporto con la realtà: con il pubblico, con
gli avvenimenti, con il contesto socio-culturale e politico, con la fisicità
della comunicazione. Il teatro, uno dei mezzi di comunicazione e di spettacolo
più antichi, gli consentiva di oltrepassare tutti i limiti e le contraddizioni
moderne e postmoderne, garantendogli la possibilità di tornare ad essere una
persona reale, di esprimere pienamente se stesso, di esercitare il proprio
spirito critico e la propria creatività, senza limiti e condizionamenti di
sorta. Non a caso la parola persona ha un pregnante significato
ontologico-esistenziale ma anche teatrale.
Il teatro del
pensiero
Da qui inizia il saggio di Mauro Germani (Giorgio Gaber.
Il teatro del pensiero, Editrice Zona, Arezzo, 2013) che ricostruisce in modo
appassionato ed esauriente tutta l’opera del Gaber «filosofo ignorante»,
intellettuale libero e disincantato, cultore del dubbio, strenuo difensore del
pensiero critico, analista anche spietato di una decadenza spaventosa, di
“un’idiozia conquistata a fatica”, trent’anni dedicati al Teatro/Canzone e al
Teatro d’Evocazione, i due grandi percorsi di sperimentazione e innovazione
artistica e culturale in cui si è espressa, con grande originalità, l’inventiva
e la multiforme creatività di Gaber e dei suoi collaboratori, primo fra tutti
Sandro Luporini, coautore dei testi di canzoni, monologhi e prose.
Innanzitutto Germani ricostruisce il percorso di Gaber
alla ricerca di una espressione teatrale originale e autentica, dai primi
spettacoli «in cui prosa e musica, monologhi e canzoni si alternano e sono
funzionali gli uni agli altri all’interno di un discorso unitario», attraverso
le produzioni successive in cui la scrittura teatrale sarà sempre più
elaborata, fino al teatro di sola prosa, fondato sulla
«rievocazione/rappresentazione» di una storia, ma anche sulla riflessione,
l’autoironia e il distacco critico.
In un capitolo successivo Germani chiarisce il ruolo
peculiare svolto dalla musica nell’opera di Gaber, mettendo in luce quelle
componenti che fanno del suo teatro un caso unico nel panorama musicale
italiano, anche in rapporto a quei cantautori cui è stato talora erroneamente
accostato. La dimensione teatrale, la scrittura dei monologhi che si alternano
alle canzoni, la complessità del ruolo della musica, la ricerca di incisività e
di fisicità della comunicazione non hanno pressoché nulla a che vedere con la
ricerca di «poeticità» tipica dei cantautori e con i loro recital che non
prevedono una specifica strutturazione teatrale, anche quando si svolgono in
teatro.
I temi
esistenziali
Con rigore metodologico Germani analizza poi i più
importanti temi che Gaber e Luporini hanno trattato nei sedici spettacoli che
hanno ideato e messo in scena tra il 1970 e il 2000.
Un tema centrale riguarda «l’enigma del corpo», la sua
ambivalenza e problematicità e il rapporto con la mente. Si tratta di un tema
esistenziale che presenta anche importanti riflessi sociali. Esso ha a che fare
con la ricerca dell’autenticità, dell’integrità del soggetto, del superamento
della scissione patologica tra pensiero e azione, tra intenzioni e
atteggiamenti, che spesso rende contraddittorie le nostre esistenze. Tra
l’altro, un autentico rinnovamento sociale è possibile soltanto grazie a persone
che abbiano ritrovato la loro «interezza». Non a caso Germani sottolinea la
dimensione fisica dei suoi spettacoli, in cui la parola si faceva corpo: «I
suoi movimenti erano tutt’uno con i pensieri, le emozioni e i sentimenti che
esprimeva» (M. Germani, Giorgio Gaber. Il teatro del pensiero, cit.).
Un altro dei temi fondamentali del teatro di
Gaber/Luporini è quello dell’amore, «inteso come sentimento che dovrebbe essere
espressione di pienezza, appartenenza reciproca e responsabilità» (M. Germani,
cit.). Dopo una lucida analisi delle forme alienate dell’amore, ridotto a
routine, a sessualità meccanica, a forma di evasione o di trasgressione
rispetto all’ipocrisia delle convenzioni sociali, l’amore autentico si rivela
come un «ideale da raggiungere», che esige la fedeltà a noi stessi, richiede
«una vera e propria rivoluzione del nostro modo di essere» e riguarda la
pienezza della nostra apertura all’altro e al mondo, alla «realtà in tutte le
sue manifestazioni» (ibidem).
La società e la
politica
Germani dedica una corposa parte centrale del suo saggio
all’analisi critica che Gaber/Luporini riservano alla critica della società e
del potere, anche alla luce dei loro fondamentali riferimenti filosofici e
culturali: Céline, Sartre e l’esistenzialismo, Pasolini, la Scuola di
Francoforte (Adorno e Horkheimer).
Viene così ricostruito il percorso degli spettacoli di
Gaber, dalla denuncia della mediocrità piccolo-borghese del signor G, alla fine
dell’illusione rivoluzionaria che il movimento del ’68 aveva fatto creder possibile,
dalla finta libertà obbligatoria del modello capitalistico e consumistico, che
conduce al disfacimento del soggetto ed al suo asservimento alle mode, nonché
allo strapotere mediatico, all’indignazione per una progressiva
disumanizzazione della società, dalla fine delle illusioni di una generazione
che ha perso («il volo mancato» di una «razza in estinzione») alla nuova
barbarie che dilaga sul finire del millennio e che è il frutto paradossale
dello sviluppo capitalistico/borghese e segna la rinuncia al pensiero e alla
libertà autentica, nel nome del mito dominante del successo.
Giustamente Germani sottolinea «la sua [di Gaber]
straordinaria capacità di interpretare i fenomeni sociali, ma anche di intuire
in largo anticipo i loro possibili sviluppi, di precorrere quindi i tempi»
(ibidem). A questo proposito è interessante citare, tra i tanti, il brano
tratto da «Mi fa male il mondo - seconda parte», canzone-prosa dello spettacolo
E pensare che c’era il pensiero (1995-96), in cui, riferendosi alla tv
italiana, si parla di «grande libero mercato delle facce. Facce facce... facce
che lasciano intendere di sapere tutto e non dicono niente. Facce che non sanno
niente e dicono di tutto. Facce suadenti e cordiali con il sorriso di plastica.
Facce esperte e competenti che crollano al primo congiuntivo». Vien da pensare
a ciò che avrebbero scritto Gaber e Luporini se avessero conosciuto Facebook,
il grande libero mercato mondiale delle facce che trionfa, in un’epoca che,
come ha scritto di recente il sociologo Luciano Gallino, è contrassegnata dalla
sconfitta del pensiero critico e dalla «vittoria della stupidità» (L. Gallino,
Il denaro, il debito e la doppia crisi, Einaudi, Torino, 2015)
Ma non si può chiudere questo paragrafo senza accennare
al fatto che Gaber è tutt’altro che un «apocalittico» e che la sua lunga
battaglia polemica è stata sempre orientata alla ricerca dell’autenticità,
della pienezza di vita, della libertà che è anche responsabilità, dello spirito
critico. Ricorda Germani che la coscienza critica e la dialettica negativa,
mutuate dai filosofi francofortesi, sono sempre legate all’utopia, nel senso
costruttivo del termine. Perciò, «l’ultimo messaggio di Gaber, espresso nella
canzone-prosa Se ci fosse un uomo, consiste proprio nell’esortazione ad
“immaginare un neo-rinascimento / un individuo tutto da inventare / in continuo
movimento”» (Germani, cit.).
Altri temi: la
morte, Dio e l’uomo
Gaber non si tira indietro neanche di fronte al tema
della morte, nonostante sia possibile parlarne soltanto rispetto alla morte
degli altri, dal momento che la propria morte resta fuori dalle esperienze
esistenziali possibili. L’approccio al tema è, come sempre, mutuato dalle
fenomenologie tipiche dell’esistenzialismo, di cui tutta l’opera di Gaber
costituisce in qualche modo un prolungamento. La morte rivela, come altre
esperienze radicali della vita (l’amore, ad esempio) la nostra impotenza, fa
emergere sentimenti nascosti, contraddizioni, paure, ansie, ipocrisie.
Ma c’è un’altra morte che preoccupa Gaber e riguarda la
dissoluzione del soggetto, l’alienazione totale dell’individuo, che non sa più
essere persona, ma si lascia manipolare dalle mode, dai poteri occulti, quello
dei media e quello delle merci. È la imminente morte dell’uomo occidentale che,
con echi del Nietzsche di Così parlò Zarathustra (1883), Gaber denuncia con
modalità ricorrenti lungo tutti i suoi spettacoli. Ci torneremo più avanti.
Infatti, prima di tornare a parlare dell’uomo, Germani
analizza la peculiarità del concetto di Dio che emerge dagli spettacoli di
Gaber. Si tratta di un Dio immanente, che nulla ha a che vedere con il Dio
delle religioni positive, con i loro dogmi, culti e rituali. Contrario a tutti
i dogmatismi e a tutti gli assoluti, nei confronti dei quali continua a far
appello alla necessaria ed auspicabile rinascita del pensiero critico, Gaber si
dichiara laico e seguace del dubbio. Il Dio di Gaber rappresenta l’«essenza del
pensiero», è un «Dio interiore […] che coincide con la ricerca stessa, con la
sete di conoscenza e verità» (Germani, cit.) ed è, pertanto, capace sia di
violenta indignazione che di profonda pietas.
Anche Dio, negli spettacoli di Gaber, rimanda pur sempre
all’uomo, che costituisce, infine, il centro di tutto il suo teatro, uomo
«inteso non come soggetto assoluto, ma come individuo concretamente esistente»
(ibidem).
Germani osserva che quella di Gaber «è una sorta di
fenomenologia dell’esistenza, uno sguardo rivolto alla condizione umana nella
sua totalità, non chiusa quindi in se stessa, ma aperta e attraversata da
tensioni e problematiche che investono anche la sfera sociale, politica ed
economica […una] indagine appassionata intorno all’esistenza e alle sue
possibilità, ai suoi drammi e ai suoi dilemmi, alle sue speranze e alle sue
paure» (ibidem).
Come abbiamo visto poco sopra, Gaber e Luporini
percorrono senza infingimenti tutte le tappe della spaventosa deriva
antropologica dell’uomo occidentale, ma nel contempo, rifacendosi a Nietzsche,
auspicano l’avvento di una sorta di oltreuomo, dotato di «una nuova coscienza»
(titolo di una canzone-prosa dell’ultimo spettacolo di Gaber, Un’idiozia
conquistata a fatica, 1997-2000): è «l’urgenza di un uomo migliore» e la
«necessità di una spinta utopistica» (ibidem) che possano dare origine ad un
nuovo umanesimo e a un nuovo rinascimento, al culmine di «questo nostro
medioevo» (Gaber, Luporini, «Se ci fosse un uomo», Io non mi sento italiano, cd
postumo, 2003).
Il pensiero libero
Rendere possibile un nuovo rinascimento dipende
soprattutto dalla riscoperta del pensiero, che costituisce l’essenza di tutta
l’opera di Gaber negli ultimi trentatre anni della sua vita e del suo lavoro:
«teatro del pensiero», secondo l’icastica e perfetta formula con cui lo ha
definito Germani:
«Il pensiero cui tende tutta l’opera di Gaber non è
l’affermazione di un sapere organicamente costituito, né tantomeno di una
specifica ideologia, quanto uno slancio, una tensione ideale che vuole essere
tutt’uno con l’esistenza, con l’esserci, qui e ora, dell’uomo. È la spinta
utopica che cerca di dare un senso concreto al nostro essere nel mondo […]
Questa tensione è per Gaber qualcosa di “fisico”, non è mai astratta, deve in
qualche modo essere carne […]» (Germani, cit.).
A questo proposito Germani cita la canzone «Un’idea» che
già nello spettacolo del 1972-73 Dialogo tra un impegnato e un non so,
esprimeva, con la geniale invenzione del «mangiare un’idea» per renderla carne,
la possibilità di fare un’autentica rivoluzione, per poter costruire «un
individuo compiuto /cosciente e intero», esigenza che troviamo ribadita
nell’ultimo spettacolo, Un’idiozia conquistata a fatica (1997/2000), con la
canzone «Il luogo del pensiero», in cui si sottolinea l’urgenza di tale
necessità con i versi «cominciando da adesso / prima che l'uomo muoia / nel
grande vuoto del suo successo» (Gaber, Luporini, cit.).
Possiamo concludere con le parole di Germani, in cui
mirabilmente si sintetizza tutto il senso dell’opera di Gaber e della sua
scelta di vita: «Essere una persona: è questo l’obiettivo cui deve tendere il
pensiero. Un pensiero davvero libero, non condizionato dalla società o dalla
dittatura del mercato, dalla compra-vendita delle idee» (Germani, cit., corsivi
nostri).
 |
| La copertina del libro |
Mauro Germani
Giorgio Gaber. Il teatro del pensiero
Editrice Zona,
2013
Pagg. 162 € 15,00
ACQUA
Da: Poesie per Hastings
Phlebas II
Dissimulano oscuri flutti e ampie maree,
disperse le membra di Phlebas (1) il fenicio,
capostipite dei morti d’acqua innumerevoli
negli equorei cimiteri del Mediterraneo.
Oh, marinaio avvolto nel torpore profondo
di bruna pelle d’annegato, levigata appena
dall’abissale limo, dalla carezza sinuosa
di nere alghe in capigliature fluttuanti,
t’affacciasti all’imbocco dei porti serrati,
respinto esule, sul ciglio di sponde sicure.
Noi, sulla riva d’approdi inespugnabili
volgemmo ostili al tuo sguardo esausto
muto diniego, ti respingemmo lontano
fino a che l’onda nera sommerse le membra
e si chiuse, cupo sepolcro verde del mare,
sulle tue diafane ossa sbiancate, Phlebas,
il fenicio, macchia nell’incerta nostra memoria.
1) Phlebas, il capostipite dei morti annegati, in La
terra desolata, di T. S. Eliot
Mare oscuro
Cosa riflette lo specchio nero del mare
quando lo sguardo appena lo sfiora?
Della luce, subitanea l’oscillazione
vivida nell’inquieto suo tremare, poi
oltre quella cresta sottile di spuma,
altra luce ci avvolge densa e sontuosa
lucida come il dorso nero dell’orca
che ogni ansia placa in silenzio muto.
Chiudiamo gli occhi, sotto le palpebre
l’oscuro suo peso ci preme, ci chiama
al torbido sonno d’un oblio abissale.
(Lavacro primigenio s’attende dall’alto
d’acqua incontaminata a purificare il mondo
a dissetarne le arse terre e vuote
i raminghi animali docili e sgomenti, e l’uomo
prima che, per avidità, tutto distrugga)
Piove, dunque, fitto e quasi senza requie
sui selciati soffocanti, sugli squamosi embrici
sulle cuspidi e le cupree guarnizioni risonanti,
entro tremuli fogliami di miseri giardini e orti
cinti d’aggrovigliate siepi nei sentieri folti,
passaggi dell’uomo e docili bestie erranti.
Piove sugli erti terrapieni, sui binari morti
sulle arcate dei viadotti e degli svincoli
sui percossi asfalti di sobborghi desolati
sconvolti dalle piaghe dei binari scintillanti.
Piove distillando cristalli argentei nella luce;
piove corrente acqua su labbra disseccate,
scende in rivoli dalle dita verso l’alto tese e
filtra tiepida tra serici capelli e folte chiome,
trema sulle nostre palpebre con cura lieve,
limpida agli occhi dona sguardo impavido,
e battezza i corpi nostri attoniti allo sdegno,
mentre, assetata la terra avida s’imbeve.
Claudio Zanini
SUITE PER UN BASSOTTO
di Alberto Giovanni
Biuso
 |
| Copertina del volume |
C’è qualcosa di «ctonio e impenetrabile» (Alcibiade, p. 39) nel legame che unisce Giuseppe (Pino) Longo ad Alcibiade, il suo cane bassotto nano a pelo lungo, qualcosa che in questo racconto emerge con tutto l’enigma e la potenza di ogni vero amore.
Nato il primo agosto del 1998, Alcibiade ha vissuto un’infanzia
terribile in mano a una coppia di giovani sposi farabutti che ne facevano
occasione e vittima dei loro litigi. Abbandonato, fu raccolto da Pino e da Tiziana,
diventando parte essenziale della loro famiglia, affetta - come l’autore
afferma con autoironia - «da bassottismo cronico, la nostra casa è un
bassottaio dei più saldi e inamovibili, è un covo di feticismo bassottistico»
(19).
Giovane e in piena forma, Alcibiade ha subìto l’andare degli anni
e la potenza del tempo, senza perdere però la «dignità e compostezza» con le
quali stoicamente vive la sua vecchiaia (92). È in ogni caso evidente quanto
l’errore di Cartesio sia clamoroso. Considerare queste magnifiche creature
delle macchine è stato davvero indegno della grande mente del filosofo. A
confutare un errore storicamente spiegabile ma comunque inaccettabile è anche
la semplice osservazione che «se smonto
una macchina posso rimontarla, se smonto Alcibiade non posso rimontarlo» (78),
così come non sarebbe possibile rimontare Cartesio una volta che lo si fosse
smontato. La vita, infatti, questa realtà così evidente e sfuggente, è una
struttura/funzione irriducibile a qualunque meccanismo, anche il più raffinato.
La suite per bassotto ben si coniuga quindi alle riflessioni che Giuseppe O. Longo
conduce da sempre sull’umano e il postumano, sul tempo che siamo, sulla
corporeità che ci costituisce. E questi sono infatti i temi principali del
libro, i quali emergono in filigrana dal racconto del legame tra Alcibiade e i
suoi genitori umani, «un legame che sta sotto e oltre ogni ragionamento,
concetto, pensiero razionale, un legame che pesca nelle profondità del tempo,
nell’antica alleanza primordiale tra uomo e cane, ma che supera il rapporto di
utilità reciproca, di reciproco aiuto e di mutua assistenza, per colorirsi di
affettività allo stato puro. Consanguinei, gli animali, nostri compagni di
viaggio, usciti, quale più quale meno, dalle caverne della storia, dalle
profondità dei millenni» (21-22).
La corporeità di questo legame straripa nell’energia, nella
baldanza, nel coraggio di Alcibiade, in questa «cosa viva e morbida e grande,
che è piena di tiepido sangue, che ha gli occhi e la pelle e il muso caldo e
umido» (13). La corporeità degli animali che la corporeità dell’animale umano
continua a offendere, violentare, divorare, squartare, in una tremenda follia
antropocentrica che sembra non placarsi mai nella feroce varietà delle sue
forme.
Che pensieri atroci!
Ma sono pensieri apotropaici, servono a esorcizzare il terrore, il male, la
ferocia che si annidano in ogni essere umano, come un nucleo puzzolente, pronto
a sgorgare all’esterno, e quante volte nel corso della storia è uscito a
fiotti, quel nucleo di fetida malvagità, e quante volte nella vita quotidiana
ci sentiamo sull’orlo del baratro, ci sentiamo capaci di atti enormi, senza
rimedio sulla terra e nel cielo.
[…]
Lui si spaventò, si
rattrappì tutto, e poi ringhiò. In quel ringhio avvertii la disperata rivolta
dello schiavo contro il tallone che lo schiaccia, sentii secoli di ribellioni
soffocate nel sangue, sentii l’urlo degli animali sacrificati, sbudellati,
squartati senza possibilità di difesa dall’uomo, questo essere che a volte mi
appare davvero come il flagello del creato (47).
Un’affermazione, quest’ultima, che conferma la radice unitaria e
gnostica del pensiero di Longo; radice che emerge chiara, geometrica,
appassionata, nella varietà dei suoi romanzi e dei racconti.
In uno dei suoi testi teatrali (Il cervello nudo, Nicolodi editore,
Rovereto 2004) Longo immagina un ingegnere che non riesce a sostenere il
sentimento di colpa per aver generato macchine capaci di soffrire, talmente
«uguali a noi» (31) da provare angoscia, pianto e nostalgia. Naturalmente
questi artefatti siamo noi, sono gli umani e tutti gli altri animali: tutto ciò
che è vivo, ha sensibilità, può soffrire perché fatto di materia che autodivora
se stessa.
Come si è
inconsapevoli del groviglio delle radici, della compatta oscurità (per miglia e
miglia) della terra che sorregge e nutre le foreste, come si è inconsapevoli
dei miliardi di vermi e insetti che in ogni istante vivono e muoiono
instancabilmente accanto a noi (dietro i tramezzi, sotto i pavimenti, per entro
le travi, tra le zolle dei giardini, nella mota degli stagni, nel fango dei
viottoli, per i campi), mangiando, rodendo, triturando, avanzando verso le
insondabili mete prefisse al loro istinto di conservare e perpetuare la stirpe,
formando una cieca feroce invincibile massa di zampe, squame, èlitre, chele,
pungiglioni, un’armata ottusa e potente, invisibile ma pronta a balzare
dall’ombra per sterminare i cani gli orsi gli umani, per divorarne le carni le
membra i corpi con fauci indifferenti e inesauste, inoculando veleni,
succhiando il sangue, nutrendosi di feci e deiezioni, trasformando col corpo il
cibo in escrementi e gli escrementi in cibo per i mangiatori di rango inferiore
(i funghi, i licheni, le alghe, i microbi, i batteri, i virus), immerso tutto
questo spietato affaccendamento nell’implacabile lavorio del mondo che si
fabbrica giorno per giorno e giorno per giorno si distrugge senza fatica e
senza rimorso.
(Squilli di fanfara
lontana, Mobydick, Faenza,
2010, 81-82)
Magnifica pagina, questa, nella quale si allarga all’universo e
alla materia che tutto lo compone quella carnalità istintiva e insieme
cerebrale, quell’erotismo raffinato e selvaggio che intridono tutta l’opera di
Longo, anche quella saggistica: «Con la sua riottosa propensione al peccato,
con la sua imbarazzante capacità seduttiva, con la sua scandalosa attività
copulatoria, con la sua miserabile caducità, con la sua caparbia resistenza
all'imperialismo della ragione, il corpo si è sempre opposto all'aspirazione
filosofica e scientifica di costruire un mondo puro, asettico, durevole:
aspirazione che tocca il suo culmine nel Novecento con l'impresa
dell'intelligenza artificiale funzionalistica»
(Scenari con
simbionte, in «Il Giornale
della Filosofia», n. 14, anno 5, numero 2, maggio-settembre 2005, 22).
In un’altra pagina il corpo di un uccello, di un pavone
urla, un urlo alto e
tenuto, di strazio, una domanda, un’invocazione ai recessi, ai segreti
penetrali, ai lari antichi, a le messi, su su, là, dopo i diroccati castelli e
le brevi piane, dopo le bionde vigne e i tabernacoli, sul popolo dei vivi e
dormienti, un’invocazione che andava e andava, e intorbidava i sogni,
sollevando fremiti e ignorati sussulti dal sonno, svegliando i cani sull’aie
che ora si rispondevano a lungo con tristi ululati, in uno smarrimento che pur
si chetava a poco a poco, tornando nel seno della placida notte soggiogata…(Squilli di fanfara lontana, 78).
Al cuore della vita c’è il nostro desiderio di essere padri e
madri, vale a dire di «mettere al mondo un’altra solitudine per curare la
propria [che] è un delitto forse ancora più infame» (L’acrobata, Einaudi 1994, 67).
Sì è vero, «è terribile la facilità con cui si può mettere al mondo un essere
umano: è un atto che chiunque può compiere con leggerezza, ma i cui effetti
sono duraturi e devastanti», un atto con il quale ci allontaniamo dalla «gioia,
[che è] proprio l’antitesi di quel piacere acre e convulso» senza il quale,
«forse, la specie si estinguerebbe, e con essa il dolore associato alla carne»
(Ivi, 141-142).
Una trappola, la definisce il Narratore. Ordita da qualche
incapace divinità che prova e riprova ha saputo soltanto costruire palazzi di
dolore e fondamenta di pianto, instillando in ogni ente e relazione «il germe
del proprio disfacimento» (Ivi, 149), moltiplicando una «moltitudine sterminata
che nei millenni ha invaso la terra e continua a moltiplicarsi senza ritegno»,
generando una «massa di carne […] irrimediabilmente soggetta al dolore» (Ivi,
69) e capace di infliggere agli altri animali nei macelli «atrocità impassibili,
decapitazioni, torture, ferocia allegra e gratuita, gli uomini come le bestie,
le bestie come gli uomini» (Ivi, 102).
Nell’Acrobata il
personaggio forse più dolente ma anche più dignitoso e più calmo -Tommaso - dà voce alla dottrina secondo cui
«il mondo nel quale noi viviamo, quello che ti vedi intorno anche in questo
momento, non è il mondo vero, non è il mondo definitivo» (Ivi, 79) poiché il
vero mondo - che possiamo solo sperare esista - è «un mondo di luce, anzi
nemmeno di luce: un mondo di silenzio» (Ivi, 80), mentre il mondo in cui
viviamo «era un fallimento totale, ed era giusto […] che dovesse essere quanto
prima sostituito da qualcosa di meno imperfetto, in cui se non altro ci fosse
meno sofferenza per tutti, anche per me»
(Ivi, 154).
In Alcibiade gnostica è la dinamica tra la luce e le tenebre che fa da sfondo a
una acuta e dolente riflessione sull’abitare contemporaneo, sulla distanza che
abbiamo posto tra i nostri spazi così ben irrigiditi e la calda vita animale
che noi stessi siamo ma che tendiamo a eludere, a ignorare:
Com’è triste e
disadorna una casa senza cani o senza gatti […] Quella che Le Corbusier
chiamava appunto con metallica freddezza machine à habiter. La razionalità troppo spinta che progetta costruisce case del
genere rischia di uccidere per eccesso di luce. Noi umani abbiamo bisogno
dell’ombra e della penombra, del contrasto luce-buio e figura-sfondo, del
chiaroscuro che fornisce il senso della profondità spaziale e temporale, dunque
il senso della storia, l’ombra lunga del passato e la prospettiva del futuro: è
nella stratificazione della storia e delle storie, dei racconti e dei
significati, delle esperienze e dei ricordi e dei presagi che sta il senso
della nostra vita. E gli animali, in particolare i cani, ci aiutano a scoprire,
o almeno a rincorrere, il senso di questa nostra indecifrabile esistenza. Non è
uno slancio verso il basso, non è una spinta regressiva: confrontandoci con il
cane, guardandoci nello specchio che esso ci offre, riusciamo a capire molte cose
di noi stessi: per differenza e per analogia. (23)
Di tale infinito gioco tra le tenebre e la luce è parte
consustanziale il destino di morte che pertiene a ogni cosa viva. Longo narra
l’inevitabile decadere di Alcibiade come se fosse una metafora universale
dell’amore e della morte: «Anche lui se ne andrà: mi sforzo di parlarne con
freddezza, ma so che il dolore sarà grande, e cerco di anticiparlo, cerco di
discorrere tra me e me ogni giorno un po’ con questa morte, per abituarmi
all’idea, per attingere forza e stoica sopportazione» (26); «Ma so che è lì,
come è lì il pensiero della mia morte» (95).
Il libro si chiude sull’inevitabile malinconia di ogni finitudine,
redenta però dall’abbraccio che ancora l’uomo e il suo animale possono
scambiarsi. Segno che «anche se la vita mangia sé stessa tutto rientra in una
sorta di ordine cosmico che lenisce ogni tribolazione» (99-100).
Un ordine, un’armonia anche musicale, che questa suite è riuscita a
trasmettere con l’emozione matematica che della scrittura di Longo rappresenta
la cifra, la bellezza.
La Suite per bassotto si inserisce perfettamente nell’opera di Giuseppe O. Longo,
scrittore triestino e universale, le cui pagine ne fanno uno dei più fisici e
insieme simbolici tra i maestri contemporanei della parola, intrisa la sua
opera di un filo indistruttibile di angoscia e tuttavia rivolta in ogni istante
e in ogni sillaba a qualcosa che qui e ora riusciamo soltanto a intravedere ma
la cui certezza è matematica. Qualcosa che, al di là di ogni dolore, è e sarà
una gioia pura. Luminosa.
Giuseppe O. Longo
ALCIBIADE
Una suite per bassotto
Ed. Il Cerchio,
Rimini 2015
Pagine 107, € 15,00
POESIE INEDITE
Laura Margherita Volante
VERITÀ
Oltre i miei occhi
c'è il cielo che s'infiamma.
Oltre la mia mano
c'è il vento che rintocca.
Oltre il mio pensiero
c'è la nube che di verità rischiara.
CANNE
Il mondo si distrae
nel vuoto ego
della canna fumaria
e poco s'accorge di quella canna
che scrive in aria coriandoli di fumo
per cadere in gelida cenere
d'un fuoco mai
acceso.
VELENI
di Laura
Mar gherita Volante
•L'ignoranza è la gemella della cattiveria...
•Chi riceve doni da casato...s'accasa.
•Omoaffetività. L'anaffettivo è contro natura, non
l'essere umano.
•I libri sono flebo di ferro che portano ossigeno al
cervello.
•Cogito ergo sum. Più nulla è secondo natura, ma secondo
idiozia contagiosa
a ripetere come pappagalli le frasi celebri senza
pensarne di nuove...
•Chi vive la vita di un altro non s'accorge di averne una
propria.
•L'onestà prevede un'unica linea di comportamento: retta!
•Sgarbi immaginabili. Le capre belano su fb i “mi piace”
sui post-eriori...
•Terra! Terra! Schiavitù è avere tutto non potendolo
fruire...
•A scoppio ritardato. I “vu cumprà” girano sulle spiagge
da trent'anni
e c'era chi comprava i rolex patacca per darsi delle
arie. Ora scoppia il problema,
sfuggito di mano rolex compreso.
•Immigrazione è il boomerang della memoria storica.
•I muri sono tombe dell'umanità.
•Meglio i graffiti dei griffati con i tagli nei jeans...
•Terremoti. Scosse e urla della Terra atterrita dagli
orrori.
•Il silenzio racconta ciò che le parole non dicono.
•Se la gallina vecchia fa buon brodo, quella dalle uova
d'oro ha il culo sfondo.
•Gli interrogativi tentano di capire ciò per cui non v'è
risposta alcuna.
•L'artista trasfigura la realtà rivelando la misteriosa
profondità del reale.
•La vita è un quadro dipinto con i colori dell'anima.
di
Michela Beatrice Ferri
Il 21 febbraio
2015 il “The New Yorker” compie 90 anni. A celebrare il suo compleanno, la
copertina, “Nine for Ninety”. Scrive sul
numero del 16 febbraio 2015 la designer Francoise Mouly: «When the magazine’s editor, David
Remnick, asked me months ago to think of ways to celebrate our ninetieth
anniversary, I knew at least where to start: with the cover of the very
first issue, from February of 1925, by the art editor Rea Irvin. That
image, of a “starchy-looking gent with the beaver
hat and the monocle”, so effectively established the
magazine’s tone that it was published, nearly unchanged, every February until
1994. Later dubbed Eustace Tilley, the magazine’s presiding dandy has since
been parodied, subverted, or deconstructed on most of our anniversary covers».
Vi spiego la storia del The New Yorker –rivista
tra le più note al mondo, tra le più curate e raffinate nello stile– che ha
ospitato i maggiori scrittori americani contemporanei, come Philip Roth e
Jerome David Salinger ed altri autori di rilievo come Alice Munro, Vladimir
Nabokov e John Updike. I fondatori della rivista furono Harold Ross, direttore
della testata «Stars and Stripes», e sua moglie Jane Grant, giornalista del
«New York Times».
Pubblicato da Condé
Nast, è nato nel febbraio del 1925 come settimanale e ora
pubblica 47 numeri annualmente. L’intenzione era quella di creare una rivista
connotata dall’umorismo sofisticato. La prima sede della rivista fu al 25 West
45th Street di New York City. Raffinatezza cosmopolita e splendide copertine
che sono considerate opere artistiche caratterizzano questo strumento.
Anche la filosofa
Hannah Arendt scrisse per il The New Yorker: fu autrice di testi pubblicati tra
il 1963 e il 1977. La sua collaborazione con il The New Yorker è nota perché ha
portato alla stesura del saggio: Eichmann in Jerusalem: A Report on the
Banality of Evil.
Si veda un articolo
pubblicato sul The New Yorker, dedicato al suo reportage:
Questo saggio riprende
il resoconto che l’autrice pubblicò come corrispondente del The New Yorker per
il processo ad Adolf Eichmann, gerarca nazista catturato in Argentina nel 1960,
processato a Gerusalemme nel 1961 e condannato a morte il 15 dicembre 1961. L’esecuzione
di Adolf Eichmann avvenne il 31 maggio del 1962 per impiccagione.
Il New Yorker inviò a
Gerusalemme una giornalista per seguire il processo ad Adolf Eichmann, rapito
da agenti del Mossad in Argentina e portato a Gerusalemme per essere processato
per i suoi crimini. Quella giornalista era Hannah Arendt. Il film che la vede
protagonista, “Hannah Arendt”, di
Margarethe Von Trotta, ricostruisce questa vicenda.
ADDIO A MARY-LOU
L’emozionante e
commovente lettera del poeta americano Don Burness, amico e collaboratore che
qui pubblichiamo, è stata scritta, come egli stesso ci informa, poche ore prima
della morte della sua adorata Mary-Lou. Un sodalizio affettivo ed intellettuale
lunghissimo, il loro, che li ha tenuti uniti fino alla fine. Don le ha dedicato
un numero consistente di poesie, e siamo certi che Mary-Lou e il bassotto
Yoshi, sono state le persone che ha più profondamente amato nella sua vita.
Forse qualcuno si stupirà che io usi qui la parola persona riferita a un cane, ma chi ha posseduto una di queste
creature, sa bene cosa intendo dire. Siamo grati a Don di averci mandato questa
preziosa lettera: la dedichiamo a noi stessi e a quei lettori che hanno potuto
in questi anni leggere i suoi scritti poetici e letterari prima sulle pagine
del nostro giornale e poi nella bella ed elegante edizione della “Biblioteca di
Odissea” pubblicati nel 2012. Per quella occasione Don era venuto a Milano per
parlare della sua poesia ed incontrare gli amici italiani. Claudia Azzola si
era messa subito a disposizione e aveva aperto il suo salotto letterario. Io
stesso ne avevo fatto un resoconto sulle pagine di “Odissea” e a testimonianza
di quel piacevole e amichevole incontro, rimangono numerose foto. Fu in quella
occasione che mandai in regalo a Mary-Lou una copia del mio Cd “Mater purissima”, sapendo quanto lei
amasse la musica. Al rientro negli Stati Uniti in una lettera a Max Luciani
(traduttore per “Odissea” dei suoi testi) per ringraziarci dell’accoglienza e
delle belle ore passate assieme, Don ci informava che Mary-Lou dopo aver
ascoltato il Cd disse: “Quando
morirò dovete suonare questa musica”. Considerammo queste parole come un
fausto esorcismo: le persone che ci sono care vorremmo fossero eterne.
Purtroppo a distanza di circa 3 anni Mary-Lou se n'è andata. C’è un verso di un
poeta persiano dell'XI secolo, Omar Khayyâm, che così recita: “Spuntammo su
dalla terra, e ce ne andammo col vento”. È il nostro destino.
A Mary-Lou il nostro ricordo, a
Don il nostro abbraccio. (Angelo Gaccione)
Lettera a
Mary-Lou da Don
Rindge. (USA) 4
gennaio 2015, ore 23,00
 |
| Mary-Lou e Don Burness |
Mia cara, cara Mary-Lou,
Oggi, quando sono arrivato in ospedale c'era poesia come lo
è stata la nostra storia per oltre 50 anni. Mi hai sentito entrare nella tua
camera ed hai allungato la mano per toccarmi. Mi è stato detto che tu non ti
eri mossa di una virgola per tutto il giorno, eri così debole. E stavi lì -
mostrandomi come hai sempre fatto, l'amore, la tenerezza, che sono stati al
centro della nostra vita.
Ho scritto volumi di poesia per te, mia musa. Non c'è
davvero nulla di nuovo da dire. Ma vedendoti morire - è così triste, eppure
guardandoti, c'è qualcosa di sublime. Ho avuto soggezione di te per anni e anni
- vedo la stupida commedia dell'uomo, poi ti guardo e vedo un mondo migliore.
Ho letto molte lettere che mi hai scritto nel 1970, 1971,
1972, mentre ero in viaggio in Europa. Che bello da parte tua lasciarmi libero
di conoscere il mondo - e sempre, ovunque io sia andato, sei stata il mio
porto, sei stata la mia stella del nord. Le tue lettere - affettuose,
perspicaci, letterarie - scrivevi di Lessing e di Fromm, di Dickens e Mozart –
si animano, ed eri solamente nella metà
dei tuoi 40 anni. Ora hai 88 anni e come Roxanne, alla fine, sei così fragile,
così impotente. Ma ce l'abbiamo fatta grazie soprattutto a te, alla tua
saggezza, al tuo impegno totale verso Don e Mary-Lou. La nostra storia non ha
mai avuto cali. È una luce, è un fiore nel deserto.
Siamo stati fortunati. Abbiamo vissuto a lungo insieme. Non
sarò solo - la tua essenza sarà con me fino al giorno della mia morte. Le
nostre risate, i tuoi seni perfetti, la tua immensa felicità, il tuo intelletto
abbagliante ed il solo puro divertimento per tutto. Con te ho vinto alla
lotteria della vita. Sarai viva domani, quando verrò a farti visita?
Quindi ti sto scrivendo questa lettera anche se penso che
non la leggerai. Se sarai viva domani te la leggerò. E se non sarai viva farò
lo stesso.
Buonanotte mia cara, ti adoro, e buon viaggio.
Tuo Donald
(Mary-Lou è morta quattro ore dopo che questa lettera è
stata scritta).
(Trad. italiana di Max Luciani)
Mary-Lou Burness era nata il 12 agosto del 1926 a Waltham,
Massachusetts. Dal 1968 Rindge è stata la sua dimora con molte avventure e
soggiorni in Francia, Spagna, Italia, Nigeria, Messico e il suo amato
Portogallo.
Letteratura ed arte sono state il centro della vita di
Mary-Lou. Andava settimanalmente alla Memorial Library di Ingalls a cercare
libri. Tra gli scrittori ammirava soprattutto Marcel Proust e Wilfred Owen. Tra
i pittori aveva un’alta considerazione di Vermeer, Monet e Mark Rothko.
Letter to Mary-Lou from Don
Ridge (Usa)
11 pm 4 january 2015
My darling,
darling Mary-Lou,
Today when
i came into the hospital there was poetry as our story has been for over fifty
years. You heard me enter your room and you reached out to touch me. I was told
you had not moved one iota all day, you were so weak. And there you were -
showing me as you always have the love, the tenderness, that has been at the
center of our lives.
I have
written volumes of poetry for you, my muse. There is really nothing new to say.
But watching you die – it is so sad and yet looking at you, there is something
sublime. I have in awe of you for years and years – I watch the stupid comedy
of man and i look at you and I see a better world.
I have been
reading many letters you wrote to me in 1970, 1971, 1972, while i was traveling
in Europe. How lovely of you to set me free to know the world – and always
wherever i went, you have been my harbor, you have been my north star. Your
letters – affectionate, insightful, literary – you wrote of Lessing and Fromm
and Dickens and Mozart – come alive and you were only in your mid 40s. Now you are
88 and like Roxanne at the end, you are so frail, so helpless. But we did it
thanks mostly to you, your wisdom, your total commitment to Don and Mary-Lou.
Our story never sags. It is light, it is a flower in the desert.
We were
lucky. We lived a long time together. I will not be alone – your essence will
be with me until my dying day. Our laughter, your perfect breasts, your immense
happiness, your dazzling intellect and just the sheer fun of it all. With you I
won life's lottery. Will you be alive tomorrow when I visit you?
So I'm
writing you this letter even though you won't read it. If you are alive
tomorrow I will read it to you. And if you are not alive I will do the same.
Bonne nuit
ma chère, je t'adore et bon voyage.
Ton Donald
(Mary- Lou
died four hours after this letter was written).
ARTE
AL MET DI NEW
YORK
la mostra più
importante sul cubismo degli ultimi trent’anni
di
Michela Beatrice Ferri
NEW YORK. “Cubism. The Leonard A. Lauder Collection. Braque.
Gris. Leger. Picasso”: con questo titolo apre a New York la mostra più importante sul cubismo degli ultimi
trent’anni. Allestita al Metropolitan Museum, l’esposizione rimane aperta al
pubblico dal 20 ottobre al 16 febbraio 2015 dopo una preview durata dal 16 ottobre al 19
ottobre scorsi. Per la prima volta vengono
presentate le 81 opere dalla collezione del magnate dei cosmetici Leonard
Lauder, che nell’aprile del 2013 aveva promesso di donarle al Metropolitan
Museum di New York. Le opere di Georges Braque (1882-1963), Juan Gris
(1887-1927), Fernand Léger (1881-1955) e Pablo Picasso (1881-1973), per la
prima volta proposte in pubblico tutte insieme includono icone come “Il Nostro
Avvenire è nell'Aria” e “Donna in Poltrona (Eva)” di Picasso, “Il Violino:
Mozart Kubelik” di Braque, “Testa di Donna” di Gris.
Solo
un anno e mezzo fa, il 9 aprile 2013 il New York Times con un articolo a firma
della giornalista Carol Vogel aveva annunciato l’evento storico nel mondo
dell’arte: il Cubismo in arrivo, finalmente, sulla Fifth Avenue con 34 Pablo Picasso,
17 Georges Braques, 15 Fernand Léger e 15 Juan Gris. Queste opere, per un
valore complessivo di oltre un miliardo di dollari, sono state da raccolte dal
signor Lauder nell’arco di quattro decenni per dare vita alla “The Leonard A.
Lauder Collection”. Gli esperti ritengono che la raccolta sia tra le migliori del
mondo, superando probabilmente quelle del Museum of Modern Art di New York,
dell’Hermitage di San Pietroburgo e del Centre Pompidou di Parigi. «In un colpo
solo questo dono mette il Metropolitan Museum all’avanguardia per l’arte
dell’inizio del ventesimo secolo», ha commentato il direttore del museo, Thomas
Campbell. Si tratta di un dono straordinario che trasformerà ancora una volta
l’assetto del Metropolitan Museum.
A curare l’esposizione la storica dell’arte e curatrice
privata per Lauder, Emily Braun, e la curatrice del Metropolitan Museum,
Rebecca Rabinow, che assieme hanno curato un catalogo dedicato alla mostra, edito
dalla prestigiosa Yale University Press. Questa grandiosa esposizione ha
portato alla luce gli studi sulle origini del Cubismo come fenomeno artistico
d’avanguardia e ha posto al centro dell’attenzione il collezionismo di Lauder e
la sua attrazione per questo movimento che sconvolse la tradizione del dipinto,
rivoluzionando il modo in cui gli artisti vedevano il mondo e aprendo la strada
alla pura astrazione che avrebbe dominato l’arte occidentale nei decenni
successivi.
Lauder acquistò per curiosità la prima opera cubista nel
1976: si trattava di una tela di Légere presa da Sotheby’s. In seguito continuò
a selezionare con accuratezza dipinti e opere dell’avanguardia, per creare così
la sua preziosa collezione. Per raccontare come questo insieme di opere è stato
magistralmente raccolto, nella mostra al Metropolitan Museum sono esposte anche
fotografie della residenza in cui Lauder conservò la sua collezione fino al
momento della donazione. «Sono stato
trascinato nel Cubismo perché era un fenomeno artistico interessante e
complicato. Mi sembrava che ogni dipinto avesse una chiave», ha dichiarato
Leonard Lauder.
Il magnate ha promesso che continuerà ad aggiungere altri
capolavori alla collezione del Metropolitan, tra cui alcuni papier collé di Gris, e una grande
varietà di famose serie di Léger. «Tutti dicono che il Metropolitan Museum è
uno dei migliori musei al mondo. Per me, invece, è il migliore al mondo»,
ha detto Leonard Lauder alla presentazione dell’esposizione, sottolineando che
con la donazione ha voluto restituire qualcosa alla sua città qualcosa di
prezioso, definendo il Cubismo un punto fondamentale per la storia dell’arte
del ventesimo secolo.
Il percorso espositivo è stato studiato per evidenziare
l’evoluzione dello stile di questa avanguardia. Nelle prime sale i colori
protagonisti sono io bianco e il nero, per poi passare ad opere con una
ricchezza di colori sempre maggiore. Tra le opere in mostra ci sono i lavori di
Picasso “The Scallop Shell” (1912), “Woman in a Chemise in an Armchair”
(1913-1914) e diverse immagini legate a “Les Demoiselles d'Avignon”. Vi è anche
il suo “The Oil Mill”, un raro paesaggio dipinto in un villaggio catalano nel
1909. L’opera, passata di generazione in generazione nella famiglia di un
collezionista francese, per settant’anni non era stata esposta al pubblico. Si
tratta di una delle prime immagini cubiste comparse sulla stampa italiana, dove
nel 1911 fu riprodotta in una provocazione-analogia con il movimento futurista:
conosciuta nel nostro Paese come “Il
mulino (da olio)”, fu la prima opera di Picasso ad essere vita in Italia, e
fu fonte di ispirazione per l’avanguardia futurista. Tra le molte opere vi sono, di Braque: “Violin (Mozart/Kubelick)”
(1912), e “Composition (The Typographer)” (1918-1919); di Gris: “Head of a
Woman” (1912) e “Portrait of Mme Cézanne after Cézanne (1916); di Léger “Houses
under the Trees” (1913) e “Three Women” (1920).
Grazie
al supporto di un gruppo di amministratori e sostenitori, tra cui lo stesso Leonard
Lauder, il Metropolitan Museum ha istituito un nuovo centro di ricerca per
l’arte del Novecento: il “Leonard A. Lauder Research Center for Modern Art”,
che costituirà un centro documentazione e di collezioni d’archivio, dove potrà
essere condotta la ricerca di approcci innovativi per lo studio della storia
del cubismo, le sue origini e la sua influenza. Il nuovo centro è stato
immaginato dal signor Lauder come un mezzo per porre in dialogo l’arte
contemporanea del Metropolitan Museum con le proprie collezioni enciclopediche.
Ogni anno due nuovi destinatari riceveranno una borsa di studio biennale per
sostenere la ricerca mirata su tutti gli aspetti del modernismo.
AMERICANA
di Michela Beatrice Ferri
In
un giorno, la memoria di due statunitensi:
Saint Elizabeth Seton e Thomas Stearn Eliot
In questo testo voglio ricordare una
Santa e un poeta, entrambi statunitensi: Elizabeth Ann Bayley Seton e Thomas
Stearns Eliot. Si tratta di due figure che presentano solo due punti in comune
tra loro: l’essere nati negli Stati Uniti e l’essere scomparsi il 4 gennaio.
Esattamente sei mesi prima del 4 luglio,
il 4 gennaio i cristiani cattolici che vivono negli Stati Uniti ricordano
Elizabeth Ann Bayley Seton. Santa Elizabeth –nata a New York il 28 agosto 1774
e morta a Emmitsburg il 4 gennaio 1821– è stata la prima Born American ad essere canonizzata nella storia: papa Paolo VI la
proclamò santa il 14 settembre 1975. All’età di diciannove anni Elizabeth Ann
Bayley –questo il suo cognome da nubile– nata in una famiglia episcopaliana,
sposò il commerciante protestante William Magee Seton con cui ebbe cinque
figli. Quando il marito si ammalò, i medici consigliarono loro di intraprendere
un viaggio in Italia: fu così che nel novembre del 1803 i coniugi Seton
sbarcarono a Livorno. William Seton vi morì il 27 dicembre 1803 e venne
seppellito in quello che oggi si conosce come l’Antico cimitero degli inglesi.
Fu proprio in Italia che Elizabeth Seton cominciò ad avvicinarsi al
cattolicesimo: per trovare sollievo al dolore della scomparsa del marito, venne
portata da alcuni conoscenti a visitare il Santuario della Madonna delle Grazie
a Montenero. Si dice che fu proprio dopo una celebrazione liturgica in questo
santuario che Elizabeth Ann decise di diventare cattolica. La prima chiesa al
mondo dedicata alla Santa statunitense si trova proprio a Livorno. Fondatrice
di opere di carità, Elizabeth Ann Seton rimane nel cuore degli americani per la
sua opera verso i bisognosi.
Il 4 gennaio 1965 moriva Thomas Stearns
Eliot. Cinquant’anni fa. Nacque il 26 settembre 1888 a Saint Louis, nel
Missouri. Qui il nonno paterno di Eliot era stato tra i fondatori della nota
Washington University. A partire dal 1906 Thomas frequentò la Harvard
University e proprio ad Harvard si formò il poeta che conosciamo. Per il
cinquantesimo anniversario della sua morte, rileggiamo la Quinta Parte (What the Thunder Said) del poema The Waste Land:
V. Ciò che disse
il tuono
Dopo
la luce rossa delle torce su volti sudati
Dopo il silenzio gelido nei giardini
Dopo l’angoscia in luoghi petrosi
Le grida e i pianti
La prigione e il palazzo e il suono riecheggiato
Del tuono a primavera su monti lontani
Colui che era vivo ora è morto
Noi che eravamo vivi ora stiamo morendo
Con un po’ di pazienza
Dopo il silenzio gelido nei giardini
Dopo l’angoscia in luoghi petrosi
Le grida e i pianti
La prigione e il palazzo e il suono riecheggiato
Del tuono a primavera su monti lontani
Colui che era vivo ora è morto
Noi che eravamo vivi ora stiamo morendo
Con un po’ di pazienza
Qui
non c’è acqua ma soltanto roccia
Roccia e non acqua e la strada di sabbia
La strada che serpeggia lassù fra le montagne
Che sono montagne di roccia senz’acqua
Se qui vi fosse acqua ci fermeremmo a bere
Fra la roccia non si può né fermarsi né pensare
Il sudore è asciutto e i piedi nella sabbia
Vi fosse almeno acqua fra la roccia
Bocca morta di montagna dai denti cariati che non può sputare
Roccia e non acqua e la strada di sabbia
La strada che serpeggia lassù fra le montagne
Che sono montagne di roccia senz’acqua
Se qui vi fosse acqua ci fermeremmo a bere
Fra la roccia non si può né fermarsi né pensare
Il sudore è asciutto e i piedi nella sabbia
Vi fosse almeno acqua fra la roccia
Bocca morta di montagna dai denti cariati che non può sputare
Non
si può stare in piedi qui non ci si può sdraiare né sedere
Non c’è neppure silenzio fra i monti
Ma secco sterile tuono senza pioggia
Non c’è neppure solitudine fra i monti
Ma volti rossi arcigni che ringhiano e sogghignano
Da porte di case di fango screpolato
Non c’è neppure silenzio fra i monti
Ma secco sterile tuono senza pioggia
Non c’è neppure solitudine fra i monti
Ma volti rossi arcigni che ringhiano e sogghignano
Da porte di case di fango screpolato
Se
vi fosse acqua
E niente roccia
Se vi fosse roccia
E anche acqua
E acqua
Una sorgente
Una pozza fra la roccia
Se soltanto vi fosse suono d’acqua
Non la cicala
E l’erba secca che canta
Ma suono d’acqua sopra una roccia
Dove il tordo eremita canta in mezzo ai pini
Drip drop drip drop drop drop drop
Ma non c’è acqua
E niente roccia
Se vi fosse roccia
E anche acqua
E acqua
Una sorgente
Una pozza fra la roccia
Se soltanto vi fosse suono d’acqua
Non la cicala
E l’erba secca che canta
Ma suono d’acqua sopra una roccia
Dove il tordo eremita canta in mezzo ai pini
Drip drop drip drop drop drop drop
Ma non c’è acqua
Chi
è il terzo che sempre ti cammina accanto?
Se conto, siamo soltanto tu ed io insieme
Ma quando guardo innanzi a me lungo la strada bianca
C’è sempre un altro che ti cammina accanto
Che scivola ravvolto in un ammanto bruno, incappucciato
Io non so se sia un uomo o una donna
– Ma chi è che ti sta sull’altro fianco?
Se conto, siamo soltanto tu ed io insieme
Ma quando guardo innanzi a me lungo la strada bianca
C’è sempre un altro che ti cammina accanto
Che scivola ravvolto in un ammanto bruno, incappucciato
Io non so se sia un uomo o una donna
– Ma chi è che ti sta sull’altro fianco?
Cos’è
quel suono alto nell’aria
Quel mormorio di lamento materno
Chi sono quelle orde incappucciate che sciamano
Su pianure infinite, inciampando nella terra screpolata
Accerchiata soltanto dal piatto orizzonte
Qual è quella città sulle montagne
Che si spacca e si riforma e scoppia nell’aria violetta
Torri che crollano
Gerusalemme Atene Alessandria
Vienna Londra
Irreali
Quel mormorio di lamento materno
Chi sono quelle orde incappucciate che sciamano
Su pianure infinite, inciampando nella terra screpolata
Accerchiata soltanto dal piatto orizzonte
Qual è quella città sulle montagne
Che si spacca e si riforma e scoppia nell’aria violetta
Torri che crollano
Gerusalemme Atene Alessandria
Vienna Londra
Irreali
Una
donna distese i suoi capelli lunghi e neri
E sviolinò su quelle corde un bisbiglio di musica
E pipistrelli con volti di bambini nella luce violetta
Squittivano, e battevano le ali
E strisciavano a capo all’ingiù lungo un muro annerito
E capovolte nell’aria c’erano torri
E sviolinò su quelle corde un bisbiglio di musica
E pipistrelli con volti di bambini nella luce violetta
Squittivano, e battevano le ali
E strisciavano a capo all’ingiù lungo un muro annerito
E capovolte nell’aria c’erano torri
Squillanti
di campane che rammentano, e segnavano le ore
E voci che cantano dalle cisterne vuote e dai pozzi ormai secchi.
E voci che cantano dalle cisterne vuote e dai pozzi ormai secchi.
In
questa desolata spelonca fra i monti
Nella fievole luce della luna, l’erba fruscia
Sulle tombe sommosse, attorno alla cappella
C’è la cappella vuota, dimora solo del vento.
Non ha finestre, la porta oscilla,
Aride ossa non fanno male ad alcuno.
Soltanto un gallo si ergeva sulla trave del tetto
Chicchirichì chicchirichì
Nel guizzare di un lampo. Quindi un’umida raffica
Apportatrice di pioggia
Nella fievole luce della luna, l’erba fruscia
Sulle tombe sommosse, attorno alla cappella
C’è la cappella vuota, dimora solo del vento.
Non ha finestre, la porta oscilla,
Aride ossa non fanno male ad alcuno.
Soltanto un gallo si ergeva sulla trave del tetto
Chicchirichì chicchirichì
Nel guizzare di un lampo. Quindi un’umida raffica
Apportatrice di pioggia
Quasi
secco era il Gange, e le foglie afflosciate
Attendevano pioggia, mentre le nuvole nere
Si raccoglievano molto lontano, sopra l’Himavant.
La giungla era accucciata, rattratta in silenzio.
Allora il tuono parlò
DA
Datta: che abbiamo dato noi?
Amico mio sangue che scuote il mio cuore
L’ardimento terribile di un attimo di resa
Che un’èra di prudenza non potrà mai ritrattare
Secondo questi dettami e per questo soltanto noi siamo esistiti, per questo
Che non si troverà nei nostri necrologi
O sulle scritte in memoria drappeggiate dal ragno benefico
O sotto i suggelli spezzati dal notaio scarno
Nelle nostre stanze vuote
DA
Dayadhvam: ho udito la chiave
Girare nella porta una volta e girare una volta soltanto
Noi pensiamo alla chiave, ognuno nella sua prigione
Pensando alla chiave, ognuno conferma una prigione
Solo al momento in cui la notte cade, rumori eterei
Ravvivano un attimo un Coriolano affranto
DA
Damyata: la barca rispondeva
Lietamente alla mano esperta con la vela e con il remo
Il mare era calmo, anche il tuo cuore avrebbe corrisposto
Lietamente, invitato, battendo obbediente
Alle mani che controllano
Attendevano pioggia, mentre le nuvole nere
Si raccoglievano molto lontano, sopra l’Himavant.
La giungla era accucciata, rattratta in silenzio.
Allora il tuono parlò
DA
Datta: che abbiamo dato noi?
Amico mio sangue che scuote il mio cuore
L’ardimento terribile di un attimo di resa
Che un’èra di prudenza non potrà mai ritrattare
Secondo questi dettami e per questo soltanto noi siamo esistiti, per questo
Che non si troverà nei nostri necrologi
O sulle scritte in memoria drappeggiate dal ragno benefico
O sotto i suggelli spezzati dal notaio scarno
Nelle nostre stanze vuote
DA
Dayadhvam: ho udito la chiave
Girare nella porta una volta e girare una volta soltanto
Noi pensiamo alla chiave, ognuno nella sua prigione
Pensando alla chiave, ognuno conferma una prigione
Solo al momento in cui la notte cade, rumori eterei
Ravvivano un attimo un Coriolano affranto
DA
Damyata: la barca rispondeva
Lietamente alla mano esperta con la vela e con il remo
Il mare era calmo, anche il tuo cuore avrebbe corrisposto
Lietamente, invitato, battendo obbediente
Alle mani che controllano
Sedetti
sulla riva
A pescare, con la pianura arida dietro di me
Riuscirò alla fine a porre ordine nelle mie terre?
Il London Bridge sta cadendo sta cadendo sta cadendo
Poi s’ascose nel foco che gli affina
Quando fiam uti chelidon –
O rondine rondine Le Prince d’Aquitaine à la tour abolie
Con questi frammenti ho puntellato le mie rovine
Bene allora v’accomodo io. Hieronymo è pazzo di nuovo.
Datta. Dayadhvam. Damyata.
Shantih shantih shantih
Riuscirò alla fine a porre ordine nelle mie terre?
Il London Bridge sta cadendo sta cadendo sta cadendo
Poi s’ascose nel foco che gli affina
Quando fiam uti chelidon –
O rondine rondine Le Prince d’Aquitaine à la tour abolie
Con questi frammenti ho puntellato le mie rovine
Bene allora v’accomodo io. Hieronymo è pazzo di nuovo.
Datta. Dayadhvam. Damyata.
Shantih shantih shantih
































































