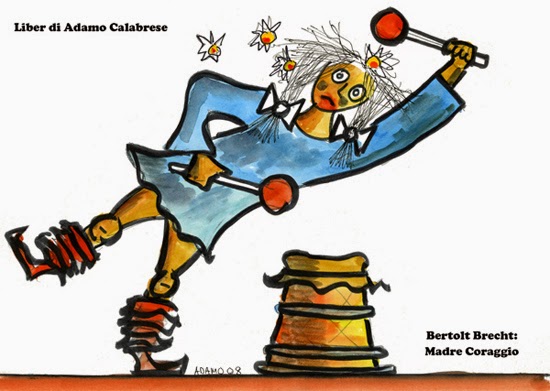Libri
IL DESIDERIO D’ INFINITO
di Giancarlo Consonni
 |
| Carlo Simoni |
Commento
al romanzo di Carlo Simoni:
Quei monti azzurri
(Castelvecchi, Roma 2019)
Tra
i documenti conservati a Recanati sono presenti dei quaderni di Paolina
Leopardi che, per volontà degli eredi, non sono accessibili al pubblico. È
forse da lì, dal desiderio di forzare quel segreto, che a Carlo Simoni è venuta
l’idea di inventare un diario tenuto dalla sorella del grande poeta. Il
risultato è un romanzo storico in forma diaristica: consistente in quanto in quel
quaderno si immagina si sia venuto depositando nel periodo che va dal luglio 1817
al novembre 1819. Scandito mensilmente, il romanzo presenta quattro
interruzioni corrispondenti all’ottobre 1817, al febbraio e al maggio 1818 e all’ottobre
1819, in cui si ipotizza che Paolina non metta mano al diario. Il libro si
compone così di 24 capitoli, corrispondenti ad altrettanti mesi.
L’arco
temporale non è scelto a caso: va dall’avvio dello Zibaldone per
concludersi poco dopo la composizione de L’infinito. Si tratta di un passaggio
cruciale anche per la vita di Paolina: corrisponde grosso modo al periodo che,
per lei, va dai 17 ai 19 anni, quando, sul «limitare/ di gioventù», si
manifesta «il primissimo fiore della vita».
Simoni
attiva fin da subito un doppio sguardo: quello di Paolina e quello su Paolina.
Nel fissare sulla pagina ogni evento, piccolo o rilevante, che interessa la
vita dell’amatissimo fratello, l’autrice immaginaria del diario si trasforma
nella figura alata di un osservatore/messaggero. Per suo tramite il lettore è immerso
nello spazio domestico di casa Leopardi e nei suoi ancoraggi esterni (il borgo,
la campagna, i luoghi delle passeggiate consentite ai soli figli maschi); ma
soprattutto è “gettato” (per usare la nota espressione di Maurice
Merleau-Ponty) nelle relazioni interne al nucleo familiare, regolate
dall’ambizione, mista a frustrazione, del padre Monaldo e dalle chiusure bigotte
e maniacali della madre Adelaide Antici. La ferma certezza di Adelaide che
l’isolamento nell’universo domestico sia, tanto più per la figlia, la via
salvifica dalle tentazioni mondane si salda alla convinzione di Monaldo che
tutto ciò che può nutrire lo spirito possa essere ritrovato nella grande
biblioteca da lui messa insieme con tenacia e passione. Orientamenti ossificati
che si traducono in una chiusura possessiva nei confronti della prole (sette
figli, di cui due morti in tenera età).
Il
diario registra un succedersi serrato di eventi spesso minimi e apparentemente
insignificanti, ma anche passaggi cruciali nella vita di Giacomo: lo stabilirsi
di rapporti epistolari con Pietro Giordani, la morte di Teresa Fattorini (stroncata
a vent’anni, nel settembre del 1918, dalla tubercolosi: a lei dieci anni dopo
il poeta dedicherà la canzone A Silvia), l’esplodere della passione
amorosa per Geltrude Cassi e, soprattutto, il suo incontro con la poesia, non solo
da studioso ma da poeta.
Da
subito si delineano alcuni fili conduttori che, intrecciandosi, imprimono alle
memorie apocrife la vis narrativa di un romanzo. Il motivo preminente è la
condizione d’isolamento in cui sono costretti Giacomo, Carlo e Paolina (i tre
fratelli maggiori di casa Leopardi, nati a poco più di un anno di distanza
l’uno dall’altro): una condizione che, ben presto, è da loro vissuta come una clausura.
Il diario/romanzo dà conto, in un crescendo, della sofferenza che prende corpo
e che culmina nel tentativo di fuga di Giacomo, miseramente fallito.
Con
tocco leggero e sapiente, Simoni non manca di inserire qua e là elementi che preannunciano
il dramma. Così, a evocare la prigionia, nelle prime pagine del diario sono richiamati
i piccoli volatili: un canarino, un fringuello, un
passero solitario -, regalati, uno dopo l’altro, ai figli del padrone dal
cocchiere di casa Leopardi, Giuseppe Fattorini, padre di Teresa, alias Silvia. Anche
il confronto che Paolina istituisce fra la sua condizione e quella di Teresa evoca
la comparazione tra l’essere in gabbia e il poter volare in libertà.
Alla
tenaglia possessiva dei genitori si oppone, come può, la resistenza che,
ciascuno a suo modo, oppongono i tre fratelli. Il trio è rinsaldato da un
grande affetto e da un’intesa che si spinge fino alla complicità; ma, a
complicare i rapporti, interviene ben presto la disuguale caratura
intellettuale: l’emergere della personalità di Giacomo introduce disparità che,
anche senza volerlo, portano a ridurre il fratello e la sorella a ruoli “di
spalla”: di confidenti, di allievi, di copisti e, sempre, di ammiratori. Da cui
l’insorgere inevitabile di inclusioni ed esclusioni.
 |
Consonni durante il suo intervento
alla Sala del Grechetto
della Biblioteca Sormani
A sin. Simoni, al centro A. Prete |
La
più colpita dalle esclusioni è, manco a dirlo, la sorella, verso la quale i
fratelli, a cominciare dal maggiore, tendono a replicare l’atteggiamento
protettivo dei genitori. Ma Simoni sa complicare il quadro facendo intravedere
un rapporto carsico fra Paolina e Giacomo: un legame basato sul mutuo cercarsi
e riconoscersi simili: nel profondo dell’animo e nella sofferenza che vi si va accumulando.
L’autore porta in superficie il legame in un paio di episodi: il soccorso
amorevole di Paolina al fratello intirizzito da un acquazzone e l’abbraccio tra
i due con cui si conclude il romanzo. Ma Simoni fa in modo che tutto il diario
apocrifo sia percorso incessantemente da sguardi, cenni, mezze parole,
accensioni, silenzi, scoperte, incomprensioni, precipitazioni, incantamenti, piccole
e grandi disperazioni: tumulti e tremori, fatti di tutto e di niente, dove apparenze
e sommovimenti profondi si saldano in una tensione restituita con grande
finezza.
Carlo
Simoni ha fatto rivivere nei suoi romanzi personalità come Gustav Klimt, Thomas
Mann e Walter Benjamin, misurandosi con sfide da far tremare i polsi. Ma qui, nel
dare vita a Paolina Leopardi, è alla sua prova più ardua. E il risultato è ancor
più convincente. La sua Pilla è del tutto credibile: il ritratto a tutto tondo
di un’adolescente alle soglie della giovinezza a cui è riservato un doppio
destino crudele: quello di reclusa (costantemente in bilico tra il finire in un
convento e l’andare in sposa a un marito che spetta ad altri scegliere) e quello
di una persona a cui la sorte ha negato la bellezza fisica. Un dramma, quest’ultimo,
esaltato, per contrasto, dall’essere la bellezza un riferimento cardinale per i
tre fratelli, forse la più intima trama che li lega; quando invece, scrive la
Paolina di Simoni, «i più» «solo vedono […] e considerano, e son capaci
d’amare» «l’esteriore sembiante», «ché l’anima per bella che possa essere, non
si dà a vedere…» (p. 55).
Nel
1821 (ovvero due anni dopo la chiusura del diario immaginario), nella canzone Nelle
nozze della sorella Paolina - il matrimonio con Pier Andrea Peroli di
Sant’Angelo in Vado, com’è noto, non andato in porto -, il poeta oserà parlare di
«beltade onnipossente». Se nella formula c’è un nucleo di verità - da Giacomo
direttamente sperimentato nell’invaghimento per Geltrude -, è altrettanto vero
che non meno «onnipossente» può essere l’assenza di bellezza fisica, per gli
effetti devastanti che può avere soprattutto per chi è «nel fior degli anni». Nella
confessione/riflessione che Paolina fa sulla propria condizione - dalla
‘scoperta’ del proprio corpo fino all’autoritratto impietoso, ulteriormente
ribadito dalla consapevolezza che quel corpo non ha «conosciuto le mutazioni
leggiadre che fan d’una fanciulla una donna» (p. 81) - il diario apocrifo raggiunge
alcuni dei suoi momenti vertiginosi.
 |
| La copertina del libro |
Con
l’invenzione del diario, Simoni mette in campo un efficacissimo espediente
narrativo: il lettore può avvicinare gli accadimenti che interessano Giacomo per
quanto è consentito a Paolina. E questo, mentre
rende ancor più credibile la fictio, consente all'autore di condividere con il lettore una consapevolezza implicita: il centro attorno a cui gravita la narrazione - lo svolgersi, in quei 28 mesi, della vita Giacomo Leopardi e che ciò
che matura nel suo intimo - è intuito, fatto oggetto di assidue congetture e,
qua e là, persino intravisto, come si trattasse di apparizioni: di materia
incandescente che però resta per lo più inaccessibile. Viene così in chiaro,
tra le valenze del romanzo, anche quella filosofica. Un modo ulteriore di porsi
in simbiosi con il protagonista.
Se
avesse fatto ricorso alla descrizione diretta dei personaggi e degli eventi,
difficilmente l’autore avrebbe conseguito un risultato altrettanto efficace. Grazie
invece alla modalità adottata – una forma mediata di scrittura, che si spinge
fino a un raffinato esercizio di stile che allude all’italiano cólto d’inizio
Ottocento – ha potuto implicare il mistero e gestire con sapienza narrativa i disvelamenti.
A
sospingere il farsi del romanzo sono, in tutta evidenza, la curiosità, il
desiderio e la dedizione, nutriti da un’ammirazione sconfinati. Che sono di
Paolina Leopardi - e, in filigrana, di Carlo Simoni - ma che finiscono per confondersi
con quelli dei lettori che amano l’opera di Leopardi. Mentre l’acribia dello
storico - è da lì che Simoni proviene - assicura solidi ancoraggi alla
narrazione, ogni inezia che si deposita sulla pagina alimenta lo sviluppo di
una sinfonia fatta insieme di minime vibrazioni e di un movimento largo e
avvolgente, dove il tema principale lascia, qui e là, spazio a temi secondari
non meno avvincenti. Finendo per identificarsi, almeno in parte, con Paolina,
il lettore viene così immerso nella materia incandescente della vita.
Allo
stesso tempo, poiché Giacomo, almeno secondo Simoni, non consente alla sorella
(implicata per lo più come copista) di leggere tutto ciò che la sua penna fissa
sulla carta, e ancor meno di condividere fino in fondo tormenti e passioni, si viene
a creare una situazione che rasenta il paradosso per cui il lettore può
“vedere” connessioni tra gli accadimenti e gli scritti (in varia forma) di Giacomo
Leopardi che a Paolina non sono accessibili ma che pure sono innescate/suggerite
dalle “sue” stesse parole. Grazie a questo, e ad altri accorgimenti, in chi
legge all’immedesimazione si affianca la distanza. In tal modo l’io narrante
assume ancor più lo spessore di personaggio: l’“autrice del diario” è la deuteragonista,
non inferiore, quanto a valenza umana e a sottigliezza di sguardo, del
protagonista, il grande, immenso Giacomo Leopardi.
Si
forma così un trio - Paolina, Carlo Simoni e il singolo lettore - che dà al
testo una forte connotazione teatrale.
Il
passaggio sulle scene del diario/monologo comporterebbe un ovvio intervento di
adattamento, ma è, mi sembra, già chiaramente delineato.
Il culmine del romanzo è
la scoperta furtiva di Pilla del manoscritto de L’infinito. A ben vedere
il diario apocrifo non è che una lunga premessa a questo evento. Se il commento
“in diretta” di Paolina Leopardi tocca punti altissimi, l’intero libro sembra
pensato per favorire l’avvicinamento del significato di questa lirica, dove
l’ansia di libertà, e la sofferenza che l’accompagna, si sublimano nell’incanto
e nel desiderio di un abbraccio cosmico.