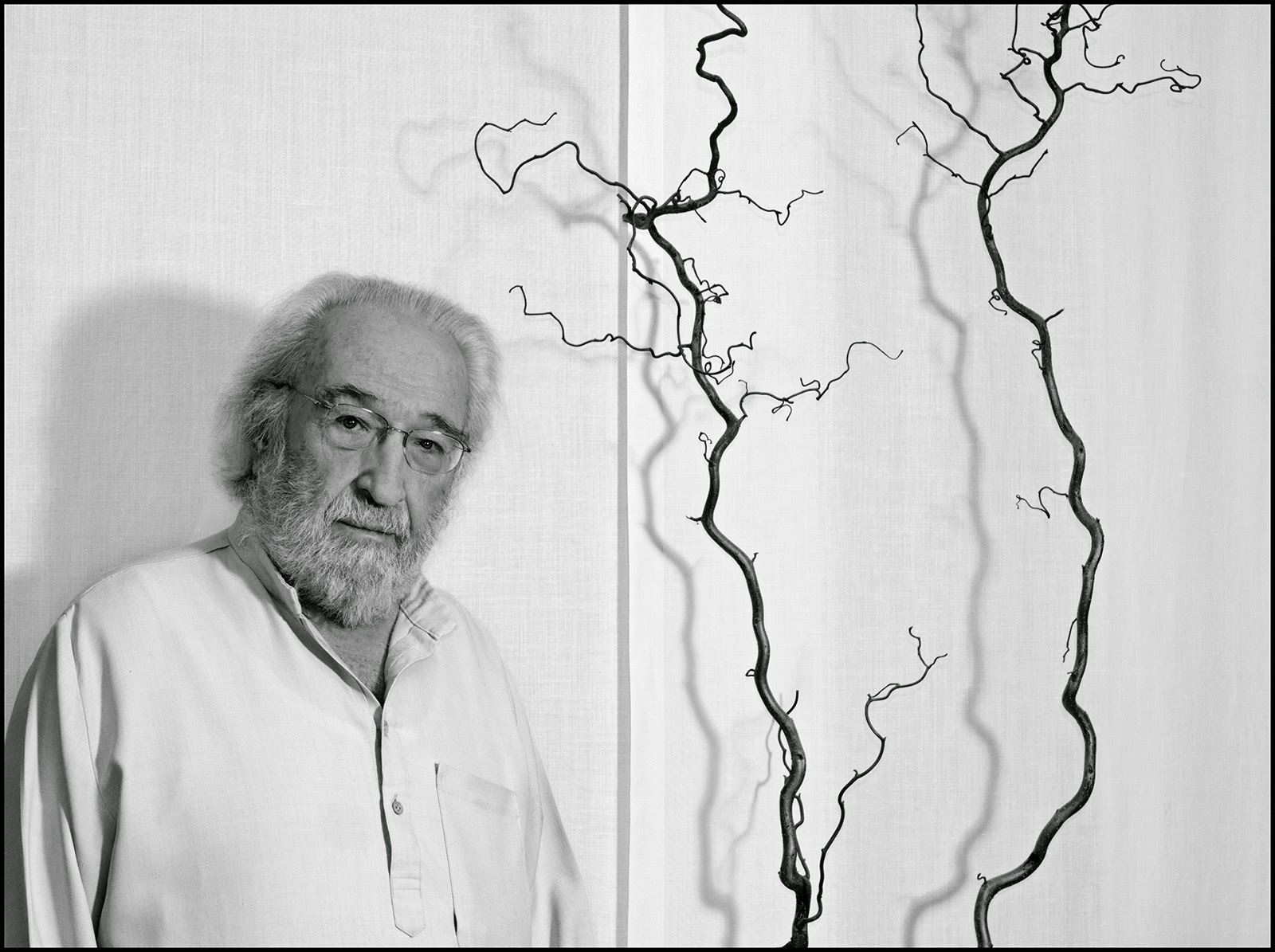L’ANNIVERSARIO


ADAMO CALABRESE
L'IMMORTALITA' DELLA NEVE
Hamelin, che disegnava paesaggi con boschi e castelli per l’illustrazione di fiabe, faceva la punta alle matite davanti alla finestra ed ogni tanto alzava gli occhi guardando scorrere la sua vita. Era l’inizio dell’inverno e c’era già stata qualche nevicata, subito sciolta in pioggia.
FRANCO DIONESALVI
ADELE
DESIDERI
Il
poeta perseguitato
Ars
amandi
Poesia
civile
L’ultimo
canto del tossico
La
puledra previdente
Il
pastore metafisico
Il genio incontentabile
Effetti sismici
Tragedia del falegname
GIUSEPPE DE VINCENTI
IN MEMORIA DEL PADRE

LEONARDO NOBILI

DARIO PERICOLOSI
STEFANO RAIMONDI
Dalla raccolta inedita:

È uscito in traduzione italiana, un libro piuttosto corto (128 pagg., 14 euro) del francese Philippe Forest “Anche se avessi torto” che ancora non ho letto, da di cui so qualcosa grazie a una nota di Elisabetta Rasy uscita su “Il Sole 24Ore”. Partiamo da Freud che nel 1917 pubblicò “Lutto e melanconia” nel quale descrive quel che dovrebbe essere il lavoro -o elaborazione- del lutto.
[ ¹Il Dizionario “Il Morandini”, annuario critico sui film della stagione è compilato con la collaborazione della figlia Luisa, ma porta ancora il nome della moglie Laura. Nota di A. G.]


“Pasolini poeta”

LISA ALBERTINI
Rosario, in distinto abito nero si muove grossolano, parlando forte e sconnesso sulla strada bianca di luce. Tra due file di case basse e quadre, nel giallo polveroso di terra. Guarda, dietro gli occhiali a specchio, ogni raro passante. Gli si rivolge, gesticola, sembra aggredirlo. Nel suo intimo, tuttavia, non vi è protervia. Dice parlando a caso, sparando al sole. Lo guardano di rimando, gli occhi s'interrogano, chiedendo tranquillità.

ANNALISA BELLERIO
TOMASO KEMENY
IL MITO DELLA “NUOVA” AZIONE POETICA
Una forma oscura s’è staccata dal disegno di un muro scrostato e ha cominciato a camminare per la città. E più cammina e più cresce fino a diventare un gigante: la testa, il collo, le spalle, sopra i tetti delle case, il busto e le gambe tra le strade. Con le mani prende i passanti, le automobili, i tram e li scaglia. Prende un cane. Il cane lo morde e lui lo schiaccia tra le dita, fino a fargli uscire gli occhi dalle orbite,
i denti dalle gengive.
Un luogo comune solidamente radicato nella sinistra, rivoluzionaria e non, vuole l’azione politica di Breton e dei suoi amici dilettantesca e superficiale. Per confutare il pregiudizio e documentare fino a che punto la loro attività fu ragionata e aderente alle necessità di una prassi autenticamente rivoluzionaria basta seguire la cronaca degli eventi. Si vede allora come il surrealismo, lungo l’arco di ben quarant’anni, sia stato autorevolmente presente in tutti i momenti chiave -piccoli o grandi che fossero- della storia contemporanea con prese di posizione chiarificatrici. Nessun altro movimento culturale può rivendicare una tale continuità di interventi politici, altrettanto lungimiranti e su un periodo di tempo così lungo. Il sogno a occhi aperti dei surrealisti non fece mai perdere loro di vista la realtà nella quale lottavano.

"Odissea" è grata al poeta Giulio Stocchi che nonostante la sua drammatica
situazione di salute, come si può leggere in questa tremenda lettera agli amici
che ci ha fatto pervenire, non ha voluto far mancare la sua voce per il I anniversario
dell'edizione in Rete del giornale. E' proprio con questo scritto di Stocchi che apriamo
la pubblicazione dei 100 testi d'autore per "Odissea".
*** ***
*** ***
MARIA CARLA BARONI
LIVIA CORONA
OMAGGIO FOTOGRAFICO A MILANO
 |
| La bacheca della Biblioteca Sormani con la locandina di "Odissea (27 settembre 2013) |
 |
| Max Luciani (a sinistra) Angelo Gaccione (a destra) |
Nell’estate
del 2013 “Odissea” cartacea compiva 10 anni di vita.
Il 27 Settembre di quello stesso anno, alla presenza di
tanti amici
e collaboratori, in una Sala del Grechetto della
Biblioteca Sormani
di Milano bella piena, un incontro pubblico tirava le
somme di quella
esperienza, e decideva di passare ad una nuova fase: dal
cartaceo alla Rete;
da Gutenberg a Bill Gates, come avevamo titolato la prima
pagina dell’ultimo
numero, con la lettera ai lettori che abbiamo poi riprodotta
sulla prima pagina
dell’edizione on line. In quell’incontro, presero la
parola diversi amici:
dal filosofo Fulvio Papi al filosofo Gabriele Scaramuzza;
dal saggista e scrittore
Giovanni Bianchi al saggista e critico d’arte Giorgio
Colombo, dal filosofo
Roberta De Monticelli al sociologo Nando Dalla Chiesa.
Tante anche le testimonianze
di affetto, i messaggi, le presenze qualificate in quella
Sala.
Dalla Chiesa, che intervenne subito dopo il direttore
Angelo Gaccione, accolse la
decisione di quel passaggio con molto entusiasmo, e
predisse un’espansione esponenziale
di contatti e di lettori a seguito dell’immissione in
Rete del giornale. Cosa che è davvero
e fulmineamente avvenuta, sia per la disponibilità di “Odissea”
a sostenere tutte le battaglie
civili e culturali possibili come aveva fatto con l’edizione
cartacea, sia per la sua autorevolezza
morale che ne fa un punto di riferimento e di vicinanza
ideale per gli strati sociali e culturali
più diversi. Ora siamo qui a festeggiare un altro
anniversario: il primo di “Odissea” in Rete,
testata rossa come il suo appassionato rosso cuore. In
questo primo anno gli scritti ospitati sono stati tantissimi (solo la prima
pagina ne ha ospitati circa 500) e i contatti sono diventati decine di
migliaia. Probabilmente sono cambiati i lettori, altri se ne sono aggiunti e
sicuramente il mezzo
virtuale della Rete è molto diverso dallo strumento
cartaceo. In più, concepito come strumento
di Rete, “Odissea” ha finito per svolgere, accanto alla
funzione di analisi e riflessione a più lungo termine che aveva già, anche una
funzione tipica del quotidiano. Da questo punto di vista è incredibile la
quantità di materiale che arriva dalla società civile, dai movimenti sociali e
dagli ambienti culturali. “Odissea” ha sempre sostenuto questa ricchezza e
questa pluralità e continuerà a farlo. Sarà sempre dentro la conflittualità
dialettica, fuori dagli intrighi di potere che combatterà, e in prima fila per la difesa dell’etica pubblica e degli
interessi collettivi. Più di un amico ha segnalato che fra i meriti di “Odissea”,
c’è quello di aver messo al centro della sua azione, la moralità pubblica; per
noi è un motivo di orgoglio e di onore, soprattutto in anni di degenerazione
etica della politica. È un compito che ci siamo assunti e a cui non verremo
meno. “Odissea” continuerà ad essere la coscienza critica e morale della
Nazione, ai lettori chiediamo di essere solidali e di difendere assieme a noi
queste ragioni.
Angelo Gaccione
CENTO AUTORI PER ODISSEA
DON LUIGI CIOTTI
DON LUIGI CIOTTI
FULVIO PAPI
 |
| Fulvio Papi |
NOBILTÀ DELLA POLITICA
E BENE PUBBLICO
Quando
(raramente) capita di ascoltare alla tivù un dibattito politico si ha
l’impressione che i limiti del lessico e le modalità dell’argomentazione,
ovviamente dal punto di vista formale, non siamo molto lontani dalle
discussioni dei giornalisti sportivi intorno a una partita di calcio. Se si fa
eccezione del mio caro e vecchio amico Cacciari, filosofo autore di opere che
hanno avuto una loro sicura importanza nella nostra cultura, che ha l’aria di
un principe stizzito e costretto (perché mai?) a discutere con i suoi bovari
sul rendimento del latte del suo parco mucche. Tuttavia poiché, in ultima
analisi, è sempre il campo oggettivo del discorso, il suo sedimento, le sue
regole e i suoi fini, a orientare la modalità del linguaggio, è obbligatorio
dire che è la forma attuale della politica a dettare implicitamente le forme
dell’argomentazione, il suo tesoro informativo e il suo desiderio di una
comunità vincente.
Uno storico di grande valore disse recentemente che al
tempo di Luigi XIV gli intellettuali erano tutti dalla sua parte. Se non ci si
rendesse conto che la proposizione aveva uno scopo divulgativo, si potrebbe
discutere sulle parole, ma sarebbe una chiacchiera vana, perché l’essenziale è
ampiamente condivisibile. Un discorso a parte si dovrebbe fare per gli autori
di filosofia politica che soprattutto facevano tesoro della loro cultura
classica, è certo però che il teatro del “grande secolo”, così come la poesia,
le opere letterarie, la pittura, come la filosofia, che, nel sapere culturale,
abbandonava del tutto le modalità della logica aristotelica, e nel campo
religioso apriva spazi per una interiorità individuale, non avevano niente a
che fare con un discorso che sfiorasse la legittimità del potere assoluto del
re. C’era certamente il problema dell’efficacia di quei corpi intermedi che già
Montaigne considerava positivamente nella sua Bordeaux, ma che lo stato si
identificasse con la centralità regale era un’opinione comune come quella che,
a livello astronomico, considerava la luna come appartenente all’universo. Un
pensiero non cambia se non c’è una ragione materiale che con la scoperta della
sua forza non muti un equilibrio concettuale. Non è ovviamente la stessa cosa a
livello epistemologico quanto muta un paradigma scientifico, attraverso
processi molto complessi teoricamente e socialmente rispetto al livello
politico quando una realtà sociale, squilibrata rispetto all’ordine esistente,
fa valere i propri scopi come diritti oggettivi e legittimi che, sia a livello
concettuale che a livello delle istituzioni politiche, devono venire
riconosciuti dal potere politico.
 |
| Angelo Gaccione e Fulvio Papi |
La storia dell’equilibrio
politico in Inghilterra tra potere regale e potere del parlamento, il “compromesso”
di Locke come spesso si dice, deriva da una conflittualità storica che segna il
passaggio dallo stato assoluto allo stato moderno che, in forme diverse, si
articola sui famosi tre poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. I quali
poteri, come stancamente si ripete, non furono teorizzati da Montesquieu, ma
indicati da Montesquieu come migliore sistema politico raggiunto nella situazione
inglese. Anche se il potere giudiziario non doveva essere tanto ben costruito,
se Bentham si pose il problema della sua
riforma. Ora qui, proprio per i limiti del discorso, non è possibile
seguire le vicende delle varie formazioni dello stato moderno, dove “politico”
è l’atteggiamento dei discendenti americani dall’antica emigrazione nei
confronti della corona inglese, sino alla guerra. Politico fu il potere del
discorso filosofico intorno ai diritti naturali dell’uomo nei confronti del
diritto divino conferito al potere regale. Questa tesi di Furet, quanto alla
Francia, è stata criticata, ma è certamente il momento storico in cui la teoria
filosofica diventa un diritto politico. Altrimenti che cosa faceva Hegel a Tübingen
con il suo albero della libertà?
Perché vi sia politica nella
modernità occorre sempre che una solidarietà sociale, oppure con lessico
filosofico, vi sia un soggetto storico che a livello simbolico rappresenti i
propri diritti, e, a livello pratico si impegni per la loro realizzazione: l’alleanza
tra proletariato, intellettuali socialisti e rappresentanza parlamentare fu l’asse,
almeno europeo, della politica tra Ottocento e Novecento che poteva condurre a
una forma elevata di civiltà. Dico “poteva” perché l’idea che nel 1914 vi sia
stato il suicidio dell’Europa è condivisa ormai in un’area più vasta che non
era quella della letteratura “asburgica”. Poi i 60 milioni di morti come
prosecuzione della prima guerra mondiale in un altro conflitto (1939-1945), le
stragi criminali dei regimi totalitari e razzisti. E poi, ancora la nostra
storia, molto complessa e da studiare analiticamente ma purtroppo spesso
oggetto solo di chiacchiere da mercato editoriale. Domandiamoci, solo qual è il
tema dominante di questa vicenda.
Già i deputati del parlamento
inglese del 1930 sostenevano che la pressione degli interessi economici sul
legislativo, rendeva molto difficile l’esercizio politico. Prendo questo
piccolo esempio sostanzialmente per mostrare come non sia un’assoluta novità
storica il fatto che l’estensione dei
poteri economici, produttivi, di mercato, finanziari, diventino elementi
fondamentali che entrano in relazione diretta con il potere politico, anzi sono
molto spesso la forza obiettiva che seleziona l’élite politica. Ho detto
precedentemente che, nella modernità, occorre l’energia sociale di un soggetto
che si autoriconosce, per dare un volto all’azione politica. Oggi una proposizione
siffatta non è vera.
L’espansione del potere
economico ha certamente i suoi operatori (spesso privilegiati non solo senza
merito ma con gravissime colpe comuni alla loro ingordigia), ma appare più
simile alla metafora di una macchina (ho trovato la metafora nei Nobel dell’economia)
che detta le sue leggi agli operatori, di quanto non assomigli a quella volontà
morale che al vecchio Kant sembrava la molla di una nuova storia. È questo l’ambiente
in cui la politica trova il suo spazio e i suoi interpreti. E qui naturalmente
giocano le storiche e tradizionali differenze tra stato e stato o tra luogo e
luogo. Non in Italia, dove siamo purtroppo in una incompiuta unità statale, e
da questo punto di vista va considerata la nostra storia, la situazione
relativa al dominio dell’economia diventa ancora più grave perché esso si
manifesta secondo potenti equilibri locali che costituiscono la base di una
diffusa corruzione che ha acquistato ancora più forza (anche se pare paradossale)
quanto più si sono incrementate le autonomie locali, tanto care all’idealismo
politico del nostro Cattaneo.
Di fronte a una frana così
disastrosa viene voglia di ricordare che la politica è la ricerca del maggior
bene possibile per una comunità. Impresa così difficile che persino, ai suoi
tempi, per mostrare questa finalità, Platone ha dovuto scrivere la “Repubblica”, un’opera che “in assoluto”
può costituire un modello, ma nella relatività del mondo è sempre stata
ritenuta una straordinaria utopia.
Se ci guardiamo allo specchio,
a noi tutto ciò non serve tanto, ma piuttosto una puntigliosa “gute Wille” (buona volontà) kantiana,
unita però a una conoscenza, a una vera conoscenza teorica, di quale sia il bene
pubblico e la via per conseguirlo. La formazione di una élite politica passa di
qui, dove la tivù non è conoscenza, ma può essere utile; dove Internet non è
democrazia, ma può servire.
Altrimenti al di là delle
chiacchiere “da qualsiasi parte vengano”, è bene ripetere il celebre verso di
Vittorio Sereni: “non sempre giovinezza è
verità”.
[Le foto (archivio Odissea) sono state eseguite da Fabiano Braccini nello studio di Fulvio Papi il 7 luglio 2014]
FABIO MINAZZI
L’IMMAGINE EINSTEINIANA DELLA CONOSCENZA
Questo è il
disegno con cui Albert Einstein, il 7 maggio 1952, rispondeva ad un suo amico
(Maurice Solovine) che gli chiedeva: per te che cosa è la conoscenza
scientifica? In primo luogo è singolare che per rispondere a questa domanda
concernente la scienza Einstein ritenga opportuno ricorrere ad un disegno. Nel
disegno la linea E indica il Lebenswelt,
ovvero il mondo della vita e del senso comune, mondo in cui tutti noi siamo
sempre inseriti (premi Nobel inclusi).
Tuttavia, poco sopra questo mondo del senso comune, osserva Einstein, qualcosa
fluttua nella nostra mente. Si tratta della nostra fantasia, ovvero della
capacità creativa con cui l’uomo immagina alcune idee e giunge ad alcuni
assiomi (per esempio all’idea che E=mc2 ovvero che l’energia sia equivalente al prodotto della
massa moltiplicato per la velocità, al quadrato, della luce). Da questa idea
possiamo poi costruire, deduttivamente,
una teoria scientifica. Come la costruiamo? Attraverso una deduzione
logicamente coerente, deduzione che Einstein indica con i tratti continui che
da A scendono ad S, S’ e S’’. Poi da questa conseguenze ricavate entro una
determinata teoria si cerca di tornare al piano del mondo della vita e del
senso comune. Tuttavia, in questo caso Einstein traccia una linea tratteggiata.
Perché? Perché questo “ritorno” al mondo della prassi – mediato dalla
dimensione sperimentale e dalla tecnologia – costituisce sempre un passo assai
problematico, non privo di insidie e di molteplici incertezze.
Ebbene, guardando complessivamente ed unitariamente questo
disegno, Einstein sottolinea come questa costituisca la sua immagine della
conoscenza scientifica. Se infatti guardiamo questo disegno in modo unitario e
globale ci appare subito chiaro che il sapere scientifico si costruisce intrecciando criticamente (ovvero:
motivatamente, attraverso precise argomentazioni) due polarità affatto opposte
e contrastanti: quella del pensiero e quella dell’esperienza. Non solo: il
disegno di Einstein mette in chiara evidenza come il cuore della scienza sia
rappresentato da quel piano concettuale
entro il quale costruiamo le teorie, le cui conclusioni ci permettono poi di
costruire un ponte verso il mondo della vita. Questo piano decisivo per il
pensiero scientifico costituisce il suo orizzonte concettuale e di pensiero. Pace quei filosofi – come Heidegger -
che sostengono invece che la scienza non sarebbe in grado di pensare. Al
contrario Einstein ci dice invece che il cuore pulsante della scienza è proprio
il suo pensiero concettuale con cui ogni elemento deve superare il vaglio di
una critica pubblica. Poi, come si è visto, Einstein non dimentica affatto il
ruolo, altrettanto decisivo e fondamentale, della tecnologia. La scienza non è infatti
solo la costruzione di un linguaggio specialistico che ci parla del mondo
attraverso alcune teorie, perché la scienza configura anche una manipolazione
attiva ed operazionale del mondo. Attraverso questo intervento tecnologico il
mondo è messo del resto nella condizione di confermare, o falsificare, le
nostre stesse teorie, esercitando un ruolo di primaria importanza. Infine, ma
non da ultimo, si vede come per Einstein tutto il complesso del procedere
scientifico riconosca un ruolo, affatto fondamentale e decisivo, anche alla fantasia e alla capacità creativa del pensiero umano, grazie al quale possiamo
appunto immaginare nuove teorie e nuove idee con cui scopriamo aspetti inediti
del mondo. Né basta: lo schema di Einstein ci fa anche comprendere come
l’andamento del pensare scientifico sia, al suo interno disciplinare,
“ciclico”, muovendosi entro una feconda spirale sempre aperta e senza fine: si
parte così dall’esperienza comune per collocarsi ai suoi antipodi per poi
ritornare – attraverso alcune precise e rigorose mediazioni critiche, teoriche
ed anche tecnologiche – al mondo dell’esperienza. Ma, naturalmente, il punto di
arrivo non coincide mai con quello di partenza. Esattamente entro questo
“scarto” critico si situa il guadagno di
conoscenza che ogni disciplina arreca al nostro patrimonio
tecnico-scientifico, contribuendo in tal modo a modificare la nostra stessa
percezione della vita, del mondo e dell’universo. Per questo si può in primo
luogo concludere, con Einstein, che la scienza pensa e che il suo è un pensiero
forte, in grado di modificare la nostra stessa condizione vitale.
Ma lo schema einsteiniano ci permette anche di comprendere
come l’oggetto scientifico di cui si
occupa ogni disciplina, costituisca sempre un costrutto teorico, mediante il quale possiamo cogliere aspetti
differenti del mondo. Meglio ancora: ogni disciplina scientifica opera un
“ritaglio” del mondo, costruendo il proprio oggetto di studio e di ricerca. In
altri termini lo schema di Einstein ci aiuta a vedere come ogni disciplina
scientifica istituisca sempre un proprio autonomo “universo di discorso”, entro
il quale elabora un suo determinato linguaggio, sue specifiche categorie
concettuali, sue peculiari regole di deduzione, suoi particolari criteri
protocollari (di verificazione e di falsificazione), etc. Insomma, per dirla
con una felice immagine di un filosofo del Novecento come Edmund Husserl, il fondatore
della fenomenologia, ogni particolare disciplina istituisce una sua propria,
specifica ed autonoma, “ontologia regionale”, per mezzo della quale il
patrimonio tecnico-scientifico dell’umanità si amplia e si dilata, secondo
molteplici curvature. Il che non apre affatto al relativismo, perché, semmai,
ci ricorda, invece, come ogni verità, propria di ciascuna disciplina, si
radichi sempre entro un determinato e circoscritto “universo di discorso e di
operatività tecnica”. Con la conseguenza che tutte le verità scientifiche
risultano essere “assolute” unicamente in relazione alla particolare teoria
entro la quale vengono definite. In tal modo l’assolutezza di una conoscenza
entro un determinato ambito disciplinare rinvia all’oggettività di ciascuna conoscenza scientifica.
Questo fecondo suggerimento
einsteiniano ci consente così di comprendere, epistemologicamente, come la
conoscenza umana scaturisca sempre non dalla generalizzazione, per astrazione,
delle esperienze (secondo la classica immagine induttivista), bensì da una particolare teoria o da una particolare
idea, mediante la quale siamo in grado di costruire, prescrittivamente, un determinato oggetto-della-conoscenza. I trattini con cui ho scritto “oggetto-della-conoscenza” indicano che
questo “oggetto” non può essere compreso se viene rescisso dalla teoria entro
la quale si struttura e si norma questo stesso oggetto scientifico. Naturalmente
questo approccio prescrittivo richiede di confrontarsi con la dimensione
sperimentale, che ci consentirà, appunto, di controllare il suo preciso valore predittivo, ovvero la sua capacità di saper
anticipare, in modo corretto, il comportamento del mondo secondo determinate
leggi. In ogni caso questa impostazione ci fa capire che per conoscere il mondo
non ci si può limitare ad osservalo passivamente, perché, al contrario, per
conoscere il mondo occorre possedere delle idee (feconde) mediante le quali
possiamo scoprire nuovi aspetti, inediti, della realtà. La conoscenza
scaturisce sempre da nuove idee e da nuovi pensieri che devono sottoporsi ad un
doveroso controllo sperimentale. Lo slogan “fatti, non teorie” è quindi del
tutto fuorviante, perché senza “parole” non avremmo neppure i “fatti”
scientifici…

ADAMO CALABRESE
L'IMMORTALITA' DELLA NEVE
Hamelin, che disegnava paesaggi con boschi e castelli per l’illustrazione di fiabe, faceva la punta alle matite davanti alla finestra ed ogni tanto alzava gli occhi guardando scorrere la sua vita. Era l’inizio dell’inverno e c’era già stata qualche nevicata, subito sciolta in pioggia.
Prima della successiva neve Hamelin prese la corriera per il
paese di sua madre e gli parve di tornare indietro nel tempo, di essere ancora
il ragazzo che accompagnava la madre in visita alle sorelle. Come allora fu il
solo a scendere alla fermata prevista sulla strada provinciale e di là s’incamminò
lungo la stradina che seguiva il canale. Via via allungava il passo cercando di sfuggire alla pioggia
incombente. Arrivò ansimante davanti alla casa. Faticò con la chiave nella
serratura arrugginita. Spinse la porta ed entrò.
Strofinò un fiammifero suscitando remoti sentori di zolfo. I
suoi genitori lo attendevano seduti al tavolo della cucina. Erano serenamente
assorti come nella foto del loro sposalizio. Le loro mani teneramente
congiunte. Lei col cappello e la veletta, lui con la stilografica d’oro nel
taschino della giacca. Quando il fiammifero si spense Hamelin cercò la candela
che trovò sulla cornice del camino; la accese sprigionando una fiamma da vetrata ecclesiastica. Nella fuga
delle ombre erano spariti anche i suoi genitori. Sul tavolo era rimasto il
grave librone di suo padre con le commedie di Shakespeare.
Intanto la pioggia si era infittita ed il suo costante
fluire ricordò ad Hamelin l’antico diluvio. Hamelin salì la scala di legno che
portava al piano di sopra. Ad ogni passo la scala bisbigliava, ma la sua voce
era così confusa con gli scricchiolii del legno che Hamelin si dovette fermare
e tendere l’orecchio.
“Ti ascolto.” disse Hamelin e la scala raccontò di
quell’inverno quando era caduta tanta neve da seppellire il paese, lasciando
fuori solo i camini più alti. Hamelin sorrise
e riprese a salire.
Al piano di sopra la camera da letto dei genitori lo accolse
con sussiegoso inchinarsi di ombre. Nel centro vegliava il maestoso letto
matrimoniale, gonfio per l’abbondante trapunta dorata. Soffici i cuscini, due
al posto del padre, uno al posto della madre. Hamelin cercò sui cuscini le
impronte dei genitori ma non vi riscontrò alcun segno come se lì avessero
dormito fantasmi senza peso. In terra, ai piedi del letto, la scaldina di legno
con il vassoio di rame per il deposito della brace ancora colmo di cenere. Hamelin
si chinò e affondò la mano nella polvere grigia che volò via come soffiata da
un improvviso respiro. Davanti al letto la toilette con lo specchio. Hamelin
passò la mano sul piano di marmo dove erano allineati spazzole e pettini, poi
alzò lo sguardo. Nello specchio incontrò gli occhi ridenti di suo fratello
bambino. Hamelin lo salutò con un cenno, l’immagine ricambiò e si dissolse lasciando
nel cristallo l’alone del suo sorriso.
Hamelin si inginocchiò davanti allo specchio, chiuse gli
occhi e ascoltò la pioggia che scorreva sul tetto, scivolava nei camini,
scendeva dentro le grondaie con voce umile e paziente, come se non volesse dar
peso alla fatica del viaggio che aveva intrapreso sopra oceani e monti per finire
su quella casa appena rischiarata dalla candela.
Hamelin si rialzò e si accostò al dignitoso armadio di legno
dove erano custoditi gli abiti dei genitori. Schiuse le ante in un fuggi fuggi
di tarme che si inabissavano nei tessuti. Hamelin accarezzò gli abiti del padre
che dondolarono come se pudicamente gioissero. Poi, con cura, cominciò a
spogliarsi per indossare i vestiti paterni. Si tolse le scarpe, si cambiò la
biancheria, si infilò una camicia di lana, gli scuri pantaloni, una giacca a
doppio petto. Infine si attorcigliò intorno al collo e alla testa lo scialle
che suo padre usava d’inverno, a tarda sera, quando la stufa era ormai spenta e
lui restava desto ancora a lungo a leggere nonostante sua moglie lo chiamasse
più volte, ma non ottenendo risposta si
addormentava nel suo tenue sonno popolato da animali parlanti.
 |
| L'immortalità della neve (dis. di Adamo Calabrese) |
Il mattino dopo Hamelin tornò in città. La pioggia si era
mutata in nevischio a segnale dell’inverno che si avvicinava a grandi passi. Hameli
raccolse i suoi disegni dedicati ad “Hansel e Gretel”, chiamò un taxi e si fece
portare all’aeroporto. Prese il volo che aveva prenotato per Francoforte.
Sull’aereo parlò con il vicino di posto, un viaggiatore che andava al Capo Nord
per
l’annunciata eclissi
di sole. A Francoforte salì sul treno per Hanau dove i fratelli Grimm lo
aspettavano. Viaggiò per tutta la notte mentre il finestrino del treno si
copriva di ghiaccio. Nello scompartimento, di fronte ad Hamelin, era accucciato
un vecchio che parlottava nel sonno, si svegliava di frequente e allarmato chiedeva
dove fosse. Hamelin gli rispondeva approssimativamente nominando qualche
stazione che aveva visto fugacemente passare in un lampo di sfocati fanali. Il
vecchio scuoteva la testa:
“Quando arriveremo a Betlemme?” sospirava.
Giunto ad Hanau, Hamelin prese un tram che lo condusse alla casa dei Grimm. Suonò il
campanello. Un cane abbaiò chissà dove. Suonò ancora. Silenzio. Chiamò dalla
strada enunciando il proprio nome. Si schiuse una finestra. Apparve suo padre: molto
vecchio, più vecchio di quando era morto: i baffi ingialliti, un cappuccio di
lana calato fin sulla fronte, gli occhiali in bilico sul naso che stavano per
cadere. Hamelin sbottonò il cappotto e allargò le braccia per mostrare gli
abiti che indossava. Il vecchio riconobbe i propri vestiti e lo invitò
esultante: “Sali, Sali!”
e, a sua volta, protese le braccia. Stavano così quando si
udì la voce della madre che chiamava il marito: “Vieni a letto, fa freddo,
vieni a letto!”
Il padre si ritrasse. La porta era socchiusa. Hamelin entrò,
salì la scala e giunto di sopra fu in una vasta stanza.
 |
| Adamo Calabrese a sin. a des. Seregni in piedi Gaccione |
I suoi genitori erano nel loro letto matrimoniale con la
trapunta dorata, stavano seduti contro i cuscini addossati dietro le spalle.
Con un filo di voce suo padre leggeva il librone di Shakespeare. Sua moglie lo
ascoltava, protendendosi verso di lui, ora accarezzandolo, ora voltando le
pagine del libro.
Il fratellino di Hamelin, era in piedi davanti alla
finestra, sorrideva e aveva levato il braccio indicando la neve che cadeva
fittissima: le torri, i campanili, i camini, i tetti, i monumenti nelle piazze,
le insegne degli alberghi, le cupole dei teatri, i tendoni dei circhi, gli
alberi tutto, tutto era immacolato e silente, tutto era immortale come un
paesaggio dipinto.
(Luglio 2014)
+.jpg) |
| Franco Dionesalvi |
Ho
trovato
Ho trovato un volantino
del mago Sapienza
dice che è della
dinastia dei maghi egiziani
pratica scienza
talismanica, chiromanzia e telepatia
se siete infelici
telefonate.
La foto che vi è
apposta in bianco e nero
ha le sembianze
di un impiegato del
catasto un po’ svagato.
Chissà se è vera maga
la sapienza,
se sa darsi conforto
dal suo fato di stare
sempre sola.
 |
| Adele Desideri
Cinque testi poetici inediti
|
DI SANGUE E SUDORE
C’è un
momento nel quale
ogni
parola è sale,
ogni
gesto un taglio
che il
volto deturpa.
C’è un
momento nel quale
il
pozzo - che l’orto nasconde,
risucchia
speranze e virtù.
I
piedi legati,
il
corpo segnato dai colpi,
sprofondi
nel fango, nel buio.
Di
sangue e sudore il petto bagnato,
- i
graffi sul ventre,
oscilli
sul muro di sassi
tra il
tempo perduto
e le
meste riprese del nulla.
Non
c’è porto, né fine,
solo
questi tuoi giorni
e
l’attimo che ti ha donato
il
respiro, la libera scelta, la colpa.
Luna bugiarda
Montmartre, via Madonnina 27, Milano
Mi
trafiggi la nuca,
mi
imbrigli nel lutto.
Ma in
tre, tu sai,
questo
gioco non vale.
Sono
la donna di picche,
aggrumo
dolori,
nel
castello dei pazzi
il re
semina orrore.
La
luna - tu non lo sai -
è
calante, bugiarda.
Ti
sfido a tressette,
la
lotta è ferina,
acceco
i tuoi occhi,
ti
vinco, ti anniento.
Nella
zuffa mi avvedo
di un
sole annerito.
Sei
teatro, finzione,
sei
una luce sfumata.
Mi
dileggi? Se vuoi,
cambiamo
le carte.
Perdi
tu, io proseguo,
nel
cappello altre storie.
Sei un
disegno incompiuto
- io
volevo il tuo amore.
Una stella non la vedi
La
vita l’hai imparata a poco a poco:
non
hai occhi per cercare le pulci, combatti
i
leoni con fucili a salve. Quando
il
cielo si fa buio, tu scorgi il sole,
ma una
stella non la vedi. Mi hai offerto l’armatura
- prete
senza crocefisso.
Non il bosco,
l’ombra,
le sorgenti, ma il vento lieve
tra i
monti sussurra questo male
che
non so dire. Sarò con te nell’incedere
dei
passi stanchi - poi ti indicherò
l’ultimo
respiro, lo spettro, la luna.
L’arciere omicida
Sfilo la freccia dal petto.
Tendo l’arco: miro al cuore.
E non scocco, acuminata
- la freccia.
Ma ricordo il sospetto
- diffido, aggiro l’intrigo.
Siedo a tavola - mi nutro.
Visioni barocche
La
stoffa crespata reclina spettrale
-
riecheggia un pianto sconsolato. Il lume
nel
ventre si accende - un trono,
quattro
segni di acquerello. Il capitello
a lato
regge un muro incurvato.
Nel
legno persiste il dolore, il principio
di un
amore.
Un quadro appeso, la vita.
GIUSEPPE
BONURA
Poesie di Seconda mano
 |
| Giuseppe Bonura |
I giochi poetici
che qui pubblichiamo, avrebbero dovuto apparire su “Odissea” cartacea, dove Bonura aveva una sua rubrica fissa. Ne ho sempre
rimandato la pubblicazione perché
i lunghi testi saggistici e satirici (la sua rubrica si
chiamava Satyricon) erano sempre molto taglienti e legati all’attualità politica e culturale del
Paese: si veda il libro in cui abbiamo
raccolto quegli scritti (Giueseppe Bonura “Satyricon”, Ed. Biblioteca di Odissea,
2011, pagg. 128 € 10,00), e questi mi sembravano un gioco, un puro
divertissement.
Li avevo tuttavia conservati con l’intento di farne buon uso
alla prima occasione. Lo faccio ora che lui non c’è più; vi troverete tutta la
gioiosa ironia che lo contraddistingueva.
Angelo Gaccione
***
Il
poeta perseguitato
Settembre, andiamo, è tempo di migrare.
Ora in terra d’Abruzzo i creditori
fanno schiamazzi e mi voglion linciare.
Ars
amandi
Tanto gentile e tanto onesta pare
La donna mia quand’ella altrui saluta
Che è arduo capir ch’è una puttana astuta.
Poesia
civile
Italia mia, poiché il nuotar è indarno
Mi tuffo dal ponte e annego nell’Arno.
L’ultimo
canto del tossico
Sono solo nel cuor della Terra,
trafitto da un ago di pera,
ed è subito nera.
La
puledra previdente
O cavallina, cavallina storna,
portavi sfiga e facevi le corna.
Rimembranze
Sempre cara mi fu quest’ernia all’inguine che mi riporta al tempo in cui mi amò una vergine.
Inconvenienti
fisici
Meriggiare pallido e sordo
Sotto una gronda rotta
E ritrovarmi lordo.
Il
pastore metafisico
Che fai tu, lana, in ciel?
Dimmi, che fai, silenziosa lana?
Il genio incontentabile
All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne
Continuo ad avere un sacco di paturnie.
Effetti sismici
Ei fu. Siccome un mobile
si staccò dal muro,
lo centrò in pieno
e ci rimase duro.
Tragedia del falegname
Nel mezzo del cammin nel duro legno
a un tratto si spezzò la vite,
e col martello fu aspra lite.
Insoliti luoghi per il mondo: aforismi a più
voci
A cura di Cesare
Vergati
1.Claudia Azzola:
La maggior parte degli eventi che fanno il vivere sono velati sotto
il tumulto
degli eventi manifesti.
2.Meeten Nasr: Gli aforismi sono i fiori del deserto della
poesia.
3.Angelo Gaccione:
Un cieco ne accompagna sempre un altro.
È per questo
che la Storia procede a caso, anzi a tentoni.
4.Angela Passarello:
Il talento era una moneta sorda.
5.Cesare Vergati:
Chiedono apatia i passionali tardivi.
6.Alberto Casiraghy:
Oggi mi sento un giocattolo inquieto.
7.Rinaldo Caddeo: L'angoscia è l'ora esatta di un
orologio guasto.
8.Roberto Carusi:
In hoc sogno vinces.
IN MEMORIA DEL PADRE
 |
| Ritratto al pastello 1 |
 |
| Ritratto al pastello 2 |
 |
| Ritratto al pastello 3 |
 |
| Ritratto a matita |

OLTRE LA SOGLIA
 |
| Leonardo Nobili |
Il video ispirato dall’universo Dantesco, (Inferno, Purgatorio, Paradiso), tratta i problemi, i sentimenti e le contraddizioni umane, che nonostante il passato dei secoli, sono attuali anche oggi.
Le anime erranti, cercano liberazione dal buio alla luce verso la purificazione attraversando “La porta del cielo” alla ricerca della libertà.
Pagina dopo Pagina
L'opera
video rappresenta una sorta di viaggio nella memoria, attraverso la lettura
simbolica di un libro di piombo, forma materica che conserva il passato e
diviene così contenitore del tempo. Attorno a questo centro propulsore prendono
vita pagine strappate da vecchi libri, scolorite e ingiallite dal tempo, ma
portatrici di messaggi e pensieri sempre attuali, che durano in eterno.
Scrive Ives
Celli del lavoro performativo di Leonardo Nobili:
“Nobili, artista
concettuale eclettico, approfondisce le versioni dell’umano nel cammino verso
le forme coercitive del profondo. La sua ricerca nell’arte non si ferma
nell’icona rituale di un contesto puramente formale, ma oltrepassa il senso
dell’estetica conservando un’etica di richiamo nel conservare il rito e il
simbolo, di una cultura di appartenenza. Nobili ha impegnato la sua carriera
nella ricerca dell’identità collettiva
dell’uomo, sempre più contaminato dal frenetico cambiamento ambientale, dove nascono
i conflitti dell’interiore. Le sue opere appartengono alla cultura
introspettiva e rappresentano un viaggio nella memoria. In questo contesto
emergono le composizioni che risultano letture del ricordo. Nobili è
interessato a conservare il passato e lo proietta in forme materiche dove si
possa documentare l’evento emotivo con forza espressiva, per non
disperdere la lacerazione del tempo
nella propria evoluzione.
I libri
materici dell’artista appaiono in questo percorso testimoni del passato che trasmette la cultura del
presente. Le lettere, la poesia, la scrittura emergono come messaggi di un
timbro regale che accompagna l’uomo nel
cammino spirituale verso la conoscenza.
Le opere di
Nobili diventano la ragione del conservare per non disperdere le identità del
vissuto,
per
ricordare ciò che non si può cancellare, sigillando in questo modo la memoria.
Nell’esposizione
emerge il protocollo della storia, come catalogazione e come mistero di ciò
che
scompare, per riemergere, incatenando il concetto del tempo che appare inesorabile.
L’arte di
Nobili esprime proprio questo; un’alternanza tra quello che è già passato e
quello che deve avvenire in una lenta e angosciante ricerca del ricordo e della
perdita di esso, che inclina l’emozione
a cogliere
nei materiali, la capacità di trattenere quello che fugge nella nostra ragione
e che in qualche modo appartiene al nulla. Quindi l’artista nelle sue opere
esalta la pulsione interiore, come l’esule esalta i ricordo e l’appartenenza
senza via d’uscita.
Nobili sostiene:
“Ciò che ci appartiene fa di noi testimoni di ciò che siamo, nel cammino del
vivere”

DARIO PERICOLOSI
IL RE DEL PARCO LAMBRO
Era una mattina di dicembre di
qualche anno fa. La notte aveva nevicato tanto e, alle prime luci del
giorno, un manto bianco e soffice ricopriva gli oltre 770.000 mq del
più grande polmone verde di Milano. Il fiume Lambro, da cui prende
nome questa piccola “Amazzonia” nella giungla metropolitana, era
una scura e gelida vena che tagliava in due l'enorme parco. Passato
il ponte, mi trovai davanti alla “Capanna dello zio Tom”. In
questo locale ci sono venuto tante volte con gli amici e i vari amori
della vita. Camminavo con una certa fatica, e lasciavo dietro di me
le impronte sulla bianca pelle di quella che era la strada lunga
circa 2.500 metri. La strada delimitava il perimetro del parco urbano
progettato da Enrico Casiraghi e inaugurato nel 1936. Ippocastani,
robinie, sofore, cipressi calvi, olmi, pioppi, platani, salici
piangenti ecc. erano ovattati da una candida veste natalizia. A un
certo punto, vidi venirmi incontro di corsa Gianni, un runner
che tutti conoscono, anche la flora del parco. È il re del Parco
Lambro: corre tutti i giorni sul perimetro stradale con il caldo, il
freddo, la pioggia, la neve. Sembrava l'uomo delle nevi quella
mattina con il suo abbigliamento scuro: correva sulla neve, nei punti
dove le ruote di un auto avevano segnato un binario naturale. Mi
passò vicino salutandomi, io feci altrettanto con la mano guantata.
Il parco sembrava una vallata del Trentino Alto Adige. Le cinque
cascine sparse all'interno dell'area verde avevano l'aspetto delle
baite di alta montagna. L'aria pulita dava la percezione di non
essere in un parco dentro la metropoli, bensì in un'oasi
incontaminata con flora e fauna. Tornai a casa con il cuore gonfio di
felicità come un bambino. Tenevo in una mano una manciata di neve
che si sarebbe sciolta nella mia mente come ricordo di quel bianco
luccicante parco e del suo re.
 |
| L'ingresso della Capanna dello zio Tom |
STEFANO RAIMONDI
 |
| Stefano Raimondi a casa Fornasetti, maggio 2013 |
Dalla raccolta inedita:
Le sole
*
Lascia che le
pietre dicano
gli scorci dei
perdoni.
*
Come sei bella Milano
lasciata qui sola tra le vie
nella luce dell'estate che annaspa
come una cicala nelle urla
fragili ed acute delle ore.
Come sei bella Milano
cacciata dentro le tue rovine:
angoli perduti sotto il manto, cripte
di San Giovanni in conca dappertutto.
E non ti resta altro che un reperto
di cielo incorniciato
a far da garante al tuo-mio
stato di profugo e testimone
di silenzio messo in pace
che si ruba piano piano
come i merli scuri fanno
quando tolgono il mattino
lenti lenti dalla notte.
[4 luglio 2013]

MORANDO MORANDINI
IL MIO LUTTO
È uscito in traduzione italiana, un libro piuttosto corto (128 pagg., 14 euro) del francese Philippe Forest “Anche se avessi torto” che ancora non ho letto, da di cui so qualcosa grazie a una nota di Elisabetta Rasy uscita su “Il Sole 24Ore”. Partiamo da Freud che nel 1917 pubblicò “Lutto e melanconia” nel quale descrive quel che dovrebbe essere il lavoro -o elaborazione- del lutto.
Da parte di chi ha subito una grave perdita consiste, in
sostanza, nell’ubbidire “al comando della realtà”. Consiste nel fare in modo
che tutto ritorni come prima: ritirare la libido
-dice Freud- da tutto ciò che è connesso all’amato perduto e dedicarla a
qualcosa o a qualcun altro. Poco importa se, una decina d’anni dopo, sembra che
avesse cambiato idea quando gli morì la figlia Sophie; in una lettera del 1929
scrive a un amico nelle sue stesse condizioni, che in questi frangenti “si
rimane inconsolabili, non si troverà alcun compenso”.
Secondo Forest, nella seconda metà del secolo scorso, il
lavoro del lutto diventa imperativo, un dovere sociale per obbedire
all’aspirazione al benessere. Nel suo libro -titolo preso da un dialogo de “I fratelli
Karamazov” di Dostoevskij- lo scrittore smaschera questa ideologia del
“diritto al soddisfacimento” per affermare il proprio personale e irriducibile
dolore per la morte della sua bambina Pauline, avvenuto dieci anni prima, per
impedire “che tutto ciò che è stato scompaia nel gelo nauseante dell’oblio”.
Forest l’aveva già fatto nei libri precedenti: scrivere per trattenere, non per
perdere, rivivere il dolore contro il lavoro del lutto che definisce
“evacuativo”. Per rivendicare il dolore che, citando Kierkegaard, ci fa cadere
dal “generale e ci restituisce alla nostra impervia e solitaria singolarità.
Nel suo ultimo libro, però, Forest diventa meno
personale, più oggettivo: analizza “l’ostilità del contesto”. Secondo lui, la
nostra è una società allergica al dolore. Lo esorcizza in molti modi: spesso
espliciti e spettacolari, talvolta subdoli, più perversi. Fa un esempio
concreto: per chi lo conosce o, in generale, per la “gente”, è difficile capire
perché sua moglie Hélène, giovane e forte, non voglia avere un altro figlio.
Per loro è imbarazzante la fedeltà al dolore. È l’ideologia dell’ottimismo a tutti
i costi, della ostilità alla dimensione tragica dell’esistenza, dell’obbligo
della rimozione, dello sforzo di rendere produttivo il dolore e renderlo
un’opportunità di trasformare il suo patetico destino in una success story.
Pur dichiarandosi d’accordo con Forest, la Rasy nel suo
articolo avanza un dubbio: sì è così, eppure non è così. L’evacuazione del
tragico, quel cerchio perfetto che vuole racchiudere la nostra vita
-dalla politica alla pubblicità- esiste, ma c’è sempre
stata e continua a esserci in ogni comunità, una dissidenza, una
insubordinazione, una insofferenza che si sottraggono agli imperativi del tempo
e che oppongono le verità individuali e la nuda voce della vita agli imperativi
del tempo e della società. Non a caso conclude, citando la lettera scritta da
Freud nel 1929: “Tutto ciò che può subentrare, anche se riempisse il posto
rimasto vuoto, resta qualcosa di diverso. E, a dire il vero, è giusto che sia
così. È l’unico modo per proseguire l’amore da cui non si vuol desistere”.
Come ho risolto io questo dilemma? Non è facile
rispondere per diversi motivi. Anzitutto il mio caso personale è diverso da
quelli finora citati. Non ho perduto un figlio, ma una moglie che era già, con
me, in età avanzata, dopo più di mezzo secolo di convivenza. Mi è venuto da
dire, anzi da scrivere pubblicamente, nel 2004, meno di un anno dopo: “Toccava
a me andarsene per primo”.
Senza dubbio ero sincero nell’esprimere quel sentimento,
quello stato d’animo. Eppure c’è un’ambiguità in quella frase: in fondo, per
una coppia, andarsene per primi significa evitare, scaricare sull’altro un
dolore più o meno grande.
Inoltre in questi ultimi anni non riesco bene a
distinguere quanto questo lavoro sia dipeso dalla mia volontà e quanto dalle
circostanze, dal mio prossimo. Il Dizionario dei film Zanichelli¹ è un
dizionario di famiglia. Dal 2004 a Levanto facciamo il “Laurafilmfestival”, una
rassegna cinematografica di famiglia. Allargata, però. Sui massa-media fanno
quasi sempre il nome mio, attribuendomi meriti e responsabilità, mentre in
realtà la maggior parte del lavoro di preparazione e organizzazione è svolto da
Amedeo Fago e dalla sua compagna di vita, Lia Morandini, mia figlia
primogenita, lavoro svolto a Roma dove abitano, lavoro al quale contribuiscono
mia figlia Luisa, e (durante il suo svolgimento in Levanto) mia nipote
Francesca Fago e le sue amiche, oltre al contributo molto apprezzato in cucina
del nostro amico, l’attore Giovanni Vettorazzo. Nel 2009 sono stati pubblicati
“Dall’uno all’altra”, libretto di poesie/fotografie
di M.M. e Francesca Fago, nonno e nipote, edito da Barbieri Selvaggi di
Manduria (Taranto) e il “Dizionario del
cinema junior”, firmato da M.M. e Luisa Morandini (Gallucci ed. Roma) nel
quale il lavoro è stato svolto in gran parte da mia figlia. Nel 2010 è uscito
(con cd accluso) il libro “Il Morandini
delle donne” (Editore Iacobelli) scritto con il mio nipote omonimo Morando
Morandini jr. sulla presenza femminile (registe, attrici, scrittrici, ecc.) nel
cinema italiano dal 1945 a oggi. Zio e nipote, un altro libro di famiglia.
In questi ultimi anni di solitudine non pochi amici o
conoscenti mi hanno domandato: come stai? come ti senti? Quasi sempre rispondo
che sono protetto su due lati dal dolore: il lavoro (non poco, anzi in certi
giorni anche troppo) e gli affetti: delle mie figlie (mio figlio Paolo abita da
molto tempo a Cuba sebbene quasi ogni anno ritorni a Milano, in casa mia) e
dagli amici.
L’iniziativa di fare un piccolo festival di cinema a
Levanto è nata in forma spontanea, collettiva, famigliare. Non saprei
rispondere con precisione a chi mi domandasse: a chi per primo è venuta l’idea?
In nessuno di noi esiste, credo, una forma di idealizzazione di Laura, moglie,
madre e nonna. È un modo per farla restare tra noi per qualche tempo ancora, a
Levanto dove ci siamo conosciuti e anche sposati nel 1951, e dove, al cimitero,
sono raccolte le sue ceneri insieme con quelle del suo amatissimo padre.
Il tema del dolore di ricordare in opposizione alla
necessità di dimenticare mi ha sempre interessato a vari livelli, privati e
pubblici. Per concludere questo discorso con parole semplici: credo di aver
riversato sui miei figli e nipoti, continuandolo, una parte dell’affetto che
avevo per Laura. Li amavo, ovviamente, anche prima. Oggi più di prima.
.JPG) |
| Morandini e Gaccione (foto: F. Braccini) |
[ ¹Il Dizionario “Il Morandini”, annuario critico sui film della stagione è compilato con la collaborazione della figlia Luisa, ma porta ancora il nome della moglie Laura. Nota di A. G.]

ATTILIO MANGANO
POESIA DIFFUSA
 |
| Attilio Mangano |
Ancora una volta,
navigando in rete, ho riscoperto o constatato l'enorme diffusione delle
poesie nel nostro paese (e non solo,
credo si possa parlare di un fenomeno globale). Certo tutti sono più o meno a conoscenza dell'esistenza di un vero sottobosco, che va ben oltre la pura e
semplice stampa di volumetti di poesia
presso tipografie locali oltre che in molteplici collane editoriali gestite da
piccole e grandi case editrici. Chi segue da tempo questo universo si ricorda
che esistono una decina e forse più di collane meritatamente famose con case
editrici importanti, che hanno un loro circuito stabile, tale per cui i poeti
davvero affermati, "quelli che contano" e che finiscono con l'entrare
nelle antologie scolastiche, non sono poi tantissimi e si possono riconoscere
abbastanza facilmente. Ma questo vuol dire davvero che occorre banalmente
distinguere tra i "poeti laureati" (Montale) di serie A, e un
susseguirsi di serie B, C, D etc., che puoi riconoscere dal loro stesso curriculum,
dal fatto di aver vinto uno o più premi letterari e di avere fatto a loro modo
carriera. Chi obiettasse che volersi limitare a un tipo di analisi
"sociologica" del problema, magari anche per ironizzare su stili,
mode, sub-culture e via discorrendo, rischia di commettere un errore
interpretativo e una certa faciloneria interpretativa, ha dunque ragione: in
fin dei conti è pur sempre vero che il mondo di coloro che vogliono essere o
sono davvero "scrittori" è un campo variegato in cui coesistono grandi
e piccoli autori,che non può essere giudicato con semplici unità di misure
mercantile (libri stampati, libri venduti, riviste specializzate, presenza
nelle librerie etc.) e che ogni giorno ha le sue novità e le sue sorprese, i
suoi successi speciali, i suoi fan, i suoi critici professionali. La morte precoce di uno scrittore di grande
successo come Giorgio Faletti è oggi il
caso del giorno e ci conferma come sia sempre possibile l'emergere di nuovi e importanti scrittori di
successo accanto a una rete più vasta Ma in fondo si osserva anche che ciò che vale spesso per romanzieri e scrittori anche di tipo giornalistico non vale
allo stesso modo per i poeti, che non arrivano a vendite clamorose di migliaia
di copie (anche se casi come quelli
della poetessa Alda Merini, coi suoi solenni funerali di massa, esistono e
contano a loro volta). Il problema vero è capire se si è compiuto anche per il
campo della poesia un salto di qualità grazie a internet e alla rete, per cui
contano meno di un tempo i volumetti, le tipografie, la partecipazione a
concorsi e premi letterari e conta sempre di più la presenza di siti e blog, sicché solo a
provare a indicare nei motori di ricerca la voce poeti italiani contemporanei
si rimane davvero sbalorditi per il numero, per la scoperta di come sia
difficile contare, calcolare, riconoscere. E' il fenomeno dei MOLTI IN POESIA,
come lo ha definito un amico (e poeta a sua volta) come Ennio Abate con un
blog omonimo che raccoglie parte di questo sterminato mondo multiplo e affida loro lo spazio che essi stessi
cercano e si meritano. A me oggi è successo, ma non era e non è la prima volta,
di andare alla ricerca di questo universo in rete e di incappare subito, primo
esempio ma per niente unico e raro, di un sito intitolato SCRIVERE(
<http://www.scrivere.info/>) che ogni giorno pubblica decine o centinaia
di nuove poesie inviate da lettori e autori, che si alternano nel commentare e
partecipare. Mi sono permesso di segnalare questo episodio in quanto emblematico, non so io stesso cosa
dire e pensare oltre ciò che ho fatto finora, ma mi piacerebbe davvero che altri intervenissero, che nascesse una discussione, non tanto per polemizzare (con
chi, di grazia?) ma per capire le implicazioni e rispondere alla domanda su cosa significa e rappresenta questa presenza dei molti in poesia, una
svolta, una rivoluzione culturale, una moda, un tic? E quanto un processo del
genere è destinato (per cosi dire "dal basso") a cambiare culture di
massa e pratiche sociali nel nostro paese nell'epoca della globalizzazione?

“Pasolini poeta”
“L’unica legittimità di un discorso
circoscritto alla sola poesia viene dal fatto che esso può recare un contributo
alla comprensione di una delle personalità tra le più complesse del ‘900”,
scrive F. Baldini nell’Introduzione a “Tutte
le poesie” di P.P. Pasolini (Meridiani, Mondadori. Milano, 2009).
Mi
sembra necessario, pertanto, estrapolare alcuni aspetti di un’analisi di un
altro grande poeta “del paesaggio” e “della natura” -mi piace definire anche
Pasolini in questo modo-, Andrea Zanzotto[1],
che ha scritto pagine molto ispirate e originali sul nostro autore. Questo,
allo scopo di conoscere meglio il terreno, l’humus da cui trae origine e
sviluppo la poesia di Pasolini, soprattutto dei primi e degli ultimi tempi
della sua vita-scrittura.
“è giusto qualificare Pasolini
soprattutto col nome di poeta? Sì (…) La ricerca, lo sperimentalismo di
Pasolini, coincidendo con lo stesso destreggiarsi fisico di un corpo-psiche…nel
mondo per sopravviverci, sono stati rischiati secondo la figura del poeta”.
Pasolini “puntò alla poesia totale”, come superamento delle divisioni del campo
artistico in una superiore “unità «superpoetica» e forse la identificò nel
cinema…senza perdere di vista il parlare-scrivere, o meglio, l’«affabulazione»
come fattore essenziale della poesia”. Continua Zanzotto: “La prima fase della
poesia di Pasolini, quella del dialetto friulano, in coincidenza del linguaggio
materno col linguaggio popolare (mentre coesisteva la lingua «alta» della
borghesia), poté davvero essere edenica e colorata di riverberi felibristici e
decadentistici…Era una poesia che poteva sentirsi “pura”, in sintonia con i
miti degli anni ’30-’40, perché nell’alone dell’inizio le gioie e i dolori
“divini” di Narciso tutto inglobavano come nuclei concentrici, nel modo più
latteo. In questa fase l’io-corpo, il paese, il tempo circolare della campagna,
costituiscono un mondo nel quale ognuno, più che compagno (quale potrà forse essere
domani) è “fratello”, couterino di ogni altra persona, anche nelle
ramificazioni delle parentele reali (e linguistiche) e nella omogeneità delle
esperienze. Pasolini non uscì mai del tutto da questo sfero, in cui da ogni
ferita e da ogni peccato si diffonde tuttavia un riverbero celestiale”[2].
La conclusione
dell’analisi della prima poesia pasoliniana spetta a Nico Naldini, curatore con
Zanzotto di questo libro, e sperimentatore con il cugino Pier Paolo Pasolini
della realtà della terra friulana, condivisa sia dal punto di vista
esistenzial-linguistico che letterario, come, ad esempio, è stata l’esperienza
dell’Accademia di lingua friulana: “La consuetudine con il mondo contadino
divenne presto, per P.P. Pasolini, visionarietà o nostalgia di immagini antiche
con usanze secolari di una lingua che, prima dell’influsso veneto, era
scaturita da antiche sorgenti romanze, da liturgie religiose piene di
sentimento, di carità”.
Ritornando a
Zanzotto, il suo studio sulla poesia del contemporaneo e quasi conterraneo
Pasolini così si intreccia con la propria ispirazione lirica. Le raccolte
poetiche successive, “L’Usignolo della
Chiesa cattolica”, controcanto in
lingua nazionale “alta” marcata sul versante religioso, e “Le ceneri di Gramsci” su
quello politico, “non avrebbero mai potuto avere la meglio su questa intensità
di piacere primo, anche se intriso di morte… morte nominabile, però, (che) sta
a due passi dal poeta, in un cimitero campestre in cui tutto è accarezzato e
quasi richiama la risurrezione, cellula tra le cellule viventi”. Così è il
paesaggio intorno con i profumi e i colori dei fiori e delle piante, “secondo
la ricca botanica delle varietà locali” raccolte ne “La meglio gioventù”.
La constatazione
del “fallimento dei miti rivoluzionari (ceneri gramsciane), l’utilizzazione
della propria diversità psico-sessuale come baluardo contro la
depersonalizzazione di singoli e gruppi nel clima della massificazione
neocapitalistica (…) sono i temi sui quali Pasolini mobilita la sua passione
che genera poesia (…) restando sempre maestro fanciullo, ideologo impossibile,
infine poeta civile[3]. Egli
non rinuncia a sondare altre vie,…passa sulla testa delle avanguardie a
quell’aldilà della lingua che il cinema metaforizza, pur accentuandosi in lui,
l’invariante poetica pura, l’amore per la poesia fatta di parole”.
La stessa
“inutilità ed emarginazione della poesia gliela faranno apparire come l’unica
possibile resistenza alla marea della massificazione”, fino a un ripiegamento alle
sue origini dialettali. Il dialetto e le culture locali, di nuovo viste come
unico polo di opposizione al progressivo cancellarsi di ogni identità ed etica
personale e comunitaria. “La nuova gioventù” è un ricamminare sopra “La meglio
gioventù”. Quel passato lontano era futuro anche se non si realizzò, perché era
sepolto nel proprio nutrimento (verità in accordo con un bioritmo cosmico), era
sotterra come è sotterraneo il seme: fatto marcire anziché fiorire. “La
disperata vitalità di Pasolini era pur sempre attiva e i fatti di poesia che
nascevano da questo ritorno sono di alto, inatteso valore. Si tratta ancora del
sogno d’un procedere più che mai solo e nudo, come agli inizi del suo parlare,
di ogni vero parlare”.
1.Pasolini,
“Poesie e pagine ritrovate”, a cura di A. Zanzotto e N. Naldini, Lato Side 25.
Roma, 1980
2.Altri autori
così commentano questa fase: “Autentico félibre, …linea melodica carica, ma
semplice, il poeta inventa una nuova fisicità verbale, materia di poesia”.
(Contini, “Dialetto e poesia”). “L’uso del dialetto trascina all’indietro dal
figlio alla madre…alla scoperta di un tempo che torna su se stesso,
conformandosi ai cicli delle stagioni, con la compresenza dell’antico nel
nuovo, …della morte nella vita”. (Asor Rosa, “Scrittori e popolo”). La poesia
in dialetto si fa portavoce di ciò che sta morendo (la cultura contadina),
sguardo rivolto all’indietro, alle origini, alla madre, a ciò che è passato
insieme, sia dal punto di vista individuale che storico-antropologico.
(Mengaldo, “Problemi”).
[3]
Dal ’55 al ’70, dopo “Le ceneri”, le altre raccolte riferite a questo periodo
sono “La religione del mio tempo”, “Poesia in forma di rosa” e “Trasumanar e
organizzar”. Zanzotto definisce questi quattro libri, scritti a Roma, “densi,
sbalzati, acremente collegati al moto reale e contraddittorio degli eventi nei
quali essi tendono a incidere, ad agire”.

LISA ALBERTINI
LIMONI DI SICILIA
.jpg) |
| Lisa Albertini |
Rosario, in distinto abito nero si muove grossolano, parlando forte e sconnesso sulla strada bianca di luce. Tra due file di case basse e quadre, nel giallo polveroso di terra. Guarda, dietro gli occhiali a specchio, ogni raro passante. Gli si rivolge, gesticola, sembra aggredirlo. Nel suo intimo, tuttavia, non vi è protervia. Dice parlando a caso, sparando al sole. Lo guardano di rimando, gli occhi s'interrogano, chiedendo tranquillità.
Da Santa Tecla, alta su un infinito di mare, con sassi
neri di lava a margine dell'acqua e macchie verdi e gialle di mirto e ginestra
sui colli intorno, arriva a un bivio con il cartello. Diretto a Scilichenti,
cammina di buon passo. Ora non parla.
Percorre la strada stretta accosto a un campo di limoni.
Vicino, abita Rocco. Coltiva fiori e limoni da una vita,
ma solo oggi sembra accorgersene. Guarda la piante fiorite con sorpresa, quasi
non le conoscesse. Stanno tra i fusti carichi di limoni. In piccole rotonde a
colori solari, fra sassi in cerchio. Rosario si ferma. Incerto, chiede a Rocco
la strada per Silichenti. L'altro è sorpreso. Di solito non parla, agli
occhiali a specchio. Ma fa eccezione.
“Avanti sempre e poi, quando finisce il campo di limoni,
gira a destra”.
Rosario sembra non capire. “Beh, se vuole l'accompagno”.
Insieme, vanno avanti un poco. Rocco si ferma.
“Qua c'erano i resti di una casetta greca. Si vedevano i
muri e persino il riquadro d'ingresso. L'abbiamo trovata molti anni fa. Ero
giovane, allora, e continuavo a scavare. Ma poi la vide uno dell'intendenza e
avvisò che mi avrebbero tolto il campo, per cercare reperti. La interrai e
dissi che non l'avevo vista. Che era un groppo di vecchi sassi dell'Etna. Ci
cresce sopra questa pianta di limoni. C'erano qui i Greci, molti anni fa. La
nostra terra tra colli e mare piaceva. Vi facevano anche il teatro, la pòlis, la loro vita, insomma. Li sento,
sa? Nelle notti di plenilunio c'è un borbottio sotterraneo che emerge dal
terreno, qua, tra i limoni. Nessuno lo sa. Me lo tengo per me, per non perdere
la terra”.
Rosario taceva, ma ora dice “Ah!”. Rocco, solo adesso
sembra accorgersi di fatto dell'altro. Si chiede chi sia, comprende di aver
troppo parlato e zittisce.
Sono ormai verso la fine del campo. Rocco parla di nuovo.
“Ecco, ci siamo, adesso gira di qua, a destra, e tra una
mezzora arriva a Scilichenti.”
Si avvia, per tornare ai suoi fiori. Chissà se ha visto
il limone della casetta, pensa. Magari ne parla a qualcuno. Non gli rimane
tuttavia il tempo di preoccuparsi. In fondo alla curva si volta per salutarlo e
vede Rosario inciampare e cadere a terra, senza rialzarsi. Accorre. Deve
essersi imbattuto il un ferro che sporge tra i sassi. E' svenuto. Per bagnargli
il capo gli toglie gli occhiali.
Un occhio è chiuso e l'altro non c'è più. Poco dopo, al
risveglio, quello chiuso si apre appena e rimane strizzato; le immagini
sembrano entrarvi a fatica da una fessura. Rocco lo guarda stranito.
“Stai meglio, ora?”. L'altro si vorrebbe alzare, ma lui
lo ferma. “Il sole picchia, rimani un po' qua, all'ombra.”
Discorrono di limoneti, dei Greci e poi del mare. Rosario
si è rimesso gli occhiali e ora riprende a parlare forte, con tono sarcastico,
come se recitasse in una commedia dell'arte.
“Mi cerco una pianta di limoni per me. Voglio
ricominciare a vivere. Gli anni che ho vissuto sino ad oggi: uno schifo. I
limoni dolci di Sicilia sono vita, speranza. Mi hanno detto che, a Scilichenti,
un tale ne vende le piante, ha il vivaio”.
Rocco lo guarda con aria assente. Un tipo strano è costui, pensa. E come farà a
portarla, a piedi e senza un occhio. Ma l'altro si alza e riprende il cammino.
Rocco lo saluta.
“Prendi la corriera!”, gli grida dal tornante di sotto.
Accosto alla nuova strada c'è un aranceto. Rosario annusa
il profumo di zagara che ne esce. Dolce, inebriante. Vacilla, ma si tiene a un
ramo. Cammina, ora abbastanza spedito. Vuole arrivare prima di pranzo.
Nel pomeriggio la corriera blu passa e suona, alla curva
stretta sotto il sicomoro. E' mezza vuota. Dietro, un tipo con vicino una bella
pianta di limoni si sbraccia dal finestrino. Lo vede la gente in attesa, alla
fermata di Santa Tecla. Saluta tutti, ha gli occhiali a specchio. Dice che la
vita è bella e i limoni portano fortuna. Quelli che li hanno vicino, campano
più a lungo.
“Fortunati voi, non morrete”, continua a dire sorridente,
sbracciandosi dal finestrino.
“Sole, mare e limoni vicini, non morrete. Non morrete,
siete salvi…”
PAOLO MARIA DI STEFANO
BORGHI UMBRI
pensieri e parole di terra e di fuoco
“La ceramica è il
parlare dell’anima della terra e della sua gente, quella che i poeti cantano
“spirito del tutto e dell’insieme” – dice Alessandra – “è una lingua nata dall’incontro
della terra con il fuoco.”
Credo di essermi perduto tra le colline, pentito del
fastidio arrecato al silenzio dal pur
contenuto mormorio di un motore irrispettoso.
E da un tempo per me infinito.
“Le distanze non si misurano in chilometri, ma in orizzonti
da superare”: Alessandra ricorda l’insegnamento del nonno pianista, felice
anche perché la strada trascorre danzando con quella lentezza che per il
musicista era l’essenza della conoscenza e della interpretazione. Sorride, Alessandra.
“Mi sembra di sentire il pianoforte di nonno Tullio. Secondo me, suona con la natura.
Come se fosse in concerto. Ti ricordi del pianoforte nella limonaia?”
“Mi sembra di sentire il pianoforte di nonno Tullio. Secondo me, suona con la natura.
Come se fosse in concerto. Ti ricordi del pianoforte nella limonaia?”
Poi, d’improvviso appare Compignano, borgo di un’Umbria
costruita sul modello amato dai trovatori e dai poeti e dai pittori e dai
retori d’un cuore verde vivo ancora forse perché in fondo trascurato da un
progresso che sembra avere grandi difficoltà ad aprire le menti e il cuore di persone che hanno trovato il proprio ideale
di vita negli orizzonti disegnati dalle onde cullanti delle colline dal canto
sommesso di armonie secolari, grandiose nella assoluta semplicità. E che nel
trascorrer quasi immobile del tempo si nutre di tranquilla sicurezza, di
immutabili certezze.
Forse, la parte più viva della libertà. Che è fatta, la libertà, anche dalla consapevolezza di
inserirsi nella natura senza forzarla, lasciandosi accogliere.
Così, a Compignano – come anche in altri borghi di questa
Italia quasi sconosciuta – sembra che le case e le vie siano il prolungarsi
istintivo dei colli e della armonia della natura.
Quel “sempre” in attesa vive nel lampione e si nutre degli
alloggiamenti dei vasi, vuoti di nuovo e immobili, forse anche ricordo di un
tempo che potrebbe tornare.
E il vicolo digradante verso un infinito annunziato dai
fiori, una promessa ripetuta dai rampicanti poco più lontano, alti come a
fuggire il contatto con la plastica estranea della sedia.
E l’armato impietrito al sommo dell’arco che apre il borgo,
quasi un altolà ad un presente invasivo e non ancora passato, forse anche
ricordato dal fantasma in degrado, ma non per questo meno minaccioso.
Anche eco di una antica saggezza: cancellare ciò che è stato
non è possibile; trasformarlo in monito certamente sì. E non credo sia stato un caso che poco più in basso,
incastonate a terra, vivano ancora le foglie cadute un infinito fa. Proprio come le conchiglie fossili che abitano Milano, con
le quali Alessandra da sempre ha parlato e dalle quali ha ricevuto i principi vivi
del suo essere architetto.
Principi soprattutto di semplicità, che ispirano il lavoro
di Maria Pia Imperiali che da Compignano ha ricevuto ed a Compignano ha
lasciato una parte dell’anima, e che forse dalle foglie impietrite nell’argilla
ha tratto l’amore per la ceramica e per l’essenziale semplicità di un fenomeno
elementare perché naturale, ma proprio per questo di complessità assoluta.
Perché la terra che diviene terracotta e gres e porcellana a
contatto con il fuoco è forse quanto di più naturalmente semplice si possa
immaginare, seppur frutto di reazioni chimico-fisiche che trasformano argille, feldspato
di sodio e di potassio, sabbia silicea, ossidi di ferro, allumina e quarzo in
quella ceramica che da sempre ha impegnato gli uomini in sforzi così di
ulteriori trasformazioni come di elaborazione di forme e decorazioni, così
anche facendo della terra cotta un linguaggio d’arte. Fin dalla notte dei
tempi. E forse proprio per vincere la notte qualcuno ha cominciato a cuocere la
terra alla luce del fuoco ed a decorarla in modo che rimanessero cristallizzati
temi e piaceri e deliri espressi in segni e colori divenuti sempre più
complessi.
E forse non è un caso che proprio la ceramica sia divenuta
l’arte che meglio sembra esprimere lo spirito d’una terra e dei suoi abitanti,
divenendone paradigma.
Ma che sembra aver prodotto un effetto in qualche modo
distorto: un diffuso immobilismo nelle forme e nelle decorazioni, naturalmente
con più di una eccezione. Certo è, comunque, che quando si fa riferimento ad
Orvieto, a Gubbio, a Deruta (come a Bassano, a Faenza, ad Albisola, a
Caltagirone, a Capodimonte, a Faenza, a Mondovì, a Vietri, a Torrita di Siena e
via dicendo - i comuni che in Italia hanno parlato con la ceramica sono almeno
una settantina) l’immagine rarissimamente esce dai confini creati da uno stile
cristallizzato e comunemente accettato. Quando lo fa, il riconoscere l’opera e
l’autore come descrittori dell’anima del
territorio è certamente difficile. Dal che, anche, la carenza di innovazione.
Così, le ceramiche raccontano di sé perpetuandosi in una
clonazione infinita.
Tra le ceramiche umbre, i piatti di Orvieto sembrano i più
sobri, mentre quelli di Deruta devono almeno in parte la propria notorietà ad
un grado di complessità decorativa mai più superato, seppure in qualche modo
presente con variazioni anche importanti in più di un territorio.
Perché ogni terra del
mondo si rivela costruendo personalità diverse su di un linguaggio
comune. E come accade per il seme lasciato al vento, che germoglia in un grano
di terra fertile tra sassi immoti, parla a chi è in grado di ascoltarlo e
genera espressioni d’arte che la raccontano.
Ecco, allora, che borghi ignoti e fuori dal tempo si
rivivono nella poesia dei figli più attenti e pronti, e Compignano narra di sé
nella ceramica di Maria Pia Imperiali.
Tra passato e presente ogni
contraddizione scompare, e la
semplicità degli inizi torna all’oggi e
diviene creatività. Così accade per questo vecchio che ascolta e impara dalla
giovane creatura, forse un angelo, che lo guarda negli occhi, tesa a sua volta,
forse, a scoprirne i pensieri segreti e le nostalgie.
E poi, la dolcezza del profilo di una gentildonna forse
evocata a Compignano, dallo sguardo carico di nostalgia, tono su tono perché
espressione di tutto un mondo rapidamente tracciato nell’intreccio della natura
che avvolge il borgo.
E Compignano creato, come quel volto, dal paesaggio
stesso, espressione viva delle ondulate
colline nate dall’infinito e all’infinito dirette.
.JPG) |
| Compignano |
.JPG) |
| Compignano |
- (Le foto di Compignano sono di Paolo Maria Di Stefano.
- Per le ceramiche, fotografie di repertorio
- Per i lavori di MP Imperiali, foto dall’artista)

ANNALISA BELLERIO
IL PAESE SENZA MERAVIGLIA
“Cat, dog, horse, snake, bird,
fish, rabbit…”
Seduta su un cuscino in camera
sua, con il libro di inglese aperto davanti, Alice ripeteva la lezione per la
terza volta. Doveva prepararsi al compito in classe.
Guardò la buffa figurina del
coniglio e sospirò. Che bello potersi inserire dentro la testa un file della lingua inglese e così
ritrovarsi a saperla perfettamente senza bisogno di studiarla e fare fatica. E
così anche per le altre materie. Tutto scaricato direttamente nel cervello, in
un colpo solo. Fine della scuola, dei compiti, dei voti, e un sacco di tempo a
disposizione per divertirsi.
Continuò a fantasticare
osservando il coniglietto bianco (o era lui a osservare lei?), finché il libro
le cadde di mano.
Il coniglio scappava fuori dalla
pagina e Alice non poteva fare a meno di seguirlo. Correvano, non sapeva verso
che cosa.
Quando si sentì troppo stanca, si
fermò e si guardò intorno. Dove si trovava? Il paesaggio era irriconoscibile.
Era forse capitata nel paese delle meraviglie, o su un altro pianeta. Oppure
era sempre sulla Terra, ma in un futuro imprecisato. Non erano solo le
caratteristiche ipertecnologiche del luogo a impressionarla, ma anche l’aspetto
dei suoi abitanti. Erano bellissimi. Le donne sembravano tutte modelle, gli
uomini attori o atleti.
Il coniglio riprese a correre e
lei a seguirlo fino all’interno di un edificio e giù, in un sotterraneo. Un
ambiente da film di fantascienza. Un signore con una specie di tuta spaziale le
andò incontro.
“Sì, lo so, ti sei prenotata per
l’inglese. Solo quello? Posso scaricarti anche quattro o cinque lingue
contemporaneamente. Comunque c’è da aspettare”, la avvisò indicando una porta,
e ritornò in una grande stanza con tre poltrone su cui erano sedute tre persone
con degli apparecchi sulla testa, come addormentate. Sembrava una scena di Matrix.
Alice entrò nella sala d’attesa,
dove c’era una ragazza. Si sentì subito in imbarazzo, lei così piccolina, col
caschetto castano e la sua aria paffuta di fronte a quella stangona dal fisico
perfetto e una massa di strepitosi capelli rossi. Si sedette un po’ tesa.
“Per cosa sei qui? – si informò
la ragazza – Io per l’aggiornamento in fisica nucleare. Mi chiamo Scarlet.”
“Io sono Alice. Voglio imparare
subito l’inglese. Ho saputo che si può fare, anche con altre lingue
contemporaneamente.”
“Certo, ma non l’hai fatto da
piccola? Tutti sappiamo sei o sette lingue, ma appunto per questo non ci serve
più a niente perché non c’è più nulla da tradurre. Ma tu non sei di qui, vero?”
le chiese Scarlet, guardandola dalla testa ai piedi e facendola arrossire.
“No, io…”
In quel momento entrò un tipo
atletico, che le ricordò qualche personaggio famoso.
“Gli allenamenti virtuali sono
qui?” domandò.
“No – rispose la ragazza rossa –
è l’altro corridoio, a sinistra.”
Il tipo rivolse ad Alice
un’occhiata incuriosita e se ne andò.
“Allenamenti virtuali?” si stupì
lei.
“Che c’è di strano? Per mantenere
muscoli, tono eccetera. Possiamo farci inserire anche la pratica degli sport,
ma poi c’è il mantenimento.”
“Be’, allora non conviene fare i
veri allenamenti?”
“Ma così non si fa fatica. Puoi anche
migliorare l’aspetto fisico cambiando un po’ le caratteristiche scelte dai tuoi
genitori. Io ora vorrei provare i nuovi modelli di occhi, quelli argentati.”
Alice sgranò i suoi, e osservò
meglio la ragazza che aveva di fronte. A guardar bene, il colore blu elettrico
degli occhi faceva un po’ a pugni col rosso dei capelli, che a sua volta
stonava con la pelle abbronzatissima. L’argento che effetto avrebbe fatto?
Cercò di cambiare argomento. “Ti
interessi di fisica nucleare?”
“No, ma sono rimasta indietro. A
dire il vero, anche in ingegneria aerospaziale, in biologia marina e in
tecniche artistiche. E in taglio e cucito. Un po’ alla volta, devo mettermi in
pari.”
Alice era atterrita. “Come fai a
trovare il tempo per dedicarti a tutte queste cose?” chiese con un filo di
voce.
“Non mi dedico a nessuna di
queste cose, ma se non le so e gli altri sì, come faccio? Il problema è trovare
il tempo di sottoporsi di continuo al loading,
col rischio di interferenze e di intolleranze.” La voce di Scarlet tradiva
l’ansia. “Volevo una camicia bianca e l’altro giorno ho preso la tela per
farmela da sola. Poi invece mi sono ritrovata non so come a dipingerci sopra
coi colori acrilici. E di recente ho scoperto che l’inserimento del violino mi
ha procurato un’allergia.”
Alice non sapeva come alleggerire
la tensione. “Vedo che suoni anche la chitarra”, disse notando lo strumento
appoggiato nell’angolo dietro una sedia. “Io sto imparando, mi piace molto. Hai
voglia di farmi sentire qualcosa?”
Senza entusiasmo, Scarlet
imbracciò la chitarra e suonò un virtuosistico pezzo di arpeggio.
“Sei davvero brava”, riconobbe
Alice. Tecnicamente, l’esecuzione era ineccepibile, ma fredda, meccanica, priva
di personalità. “Poi vai a suonare da qualche parte? Hai un gruppo?”
“Oh no. Tutti sanno suonare nella
stessa maniera e così a nessuno interessa ascoltare nessuno. La chitarra mi
serve come contenitore per tenerci dentro i grilli.”
“I grilli?!?” Alice credeva di
avere capito male.
“Sì, i grilli che vado a cercare
e poi vendo. Ma ormai ne sono rimasti pochi e così li allevo e li faccio
cantare. Sono l’unica a farlo e alla gente piace ascoltare i grilli. È il mio
lavoro.”
“Il tuo lavoro? Ma se sai sette
lingue, sei un pozzo di scienza, suoni, dipingi…”
Già, si interruppe Alice. Ma
anche tutti gli altri sapevano le stesse cose. In quel mondo non c’erano
scuole, insegnanti, traduttori, scienziati, poeti, artisti, atleti… Tutti
potevano essere tutto, senza fatica e senza talento, e dunque non c’era bisogno
di nessuno, non si provava ammirazione per nessuno. Niente interessi, emozioni,
passioni. In quel paese delle meraviglie mancava la meraviglia.
Così Scarlet si era costruita
un’abilità solo sua, e con i suoi grilli era riuscita a stupire, oltre a lei,
anche tutto quel popolo di saputelli imbottiti di sterili nozioni.
Voleva andar via da quel posto.
Voleva scappare via veloce, come un coniglio…
Alice si risvegliò, accoccolata
sul cuscinone in camera sua. Accanto a lei per terra c’era aperto il libro di
inglese, con le figure e i nomi di animali. Il coniglio la guardava… divertito?
Rimase ancora un po’ in silenzio,
pensierosa. Poi raccolse il libro e, con pazienza, ripeté: “Cat, dog, horse,
snake, bird, fish, rabbit…”.
ADAM VACCARO
 |
| Adam Vaccaro - Firenze 2013- |
Altro oro
Quando il danaro non è più segno d'oro splendore
di sole chiarore di sale di valore riflesso del fare
ma solo mina vagante tra le dita di invisibili croupier
sul tavolo dell'immenso magma dei debiti imposti
al mondo – vuoto che risucchia e vomita come
ventre di balena ogni minuta vita nel suo vortice
che pare privo di uscite - tocca alle sue vittime
cercare ancora ancora e ancora scarto e scatto
di riprendersi la vita senza più aria come smarrita
provando ancora a ridarle valore e altro oro.
TOMASO KEMENY
IL MITO DELLA “NUOVA” AZIONE POETICA
 |
| Tomaso Kemeny |
Le avanguardie e
le neo-avanguardie hanno teso ad abbagliare la tradizione per aprire nuovi
sentieri alle forme ad ai valori. Nella nostra epoca dell'Impero del Brutto non
è rimasto nulla da decostruire, devastare, ridicolizzare, distruggere. Ovunque
trionfa il vuoto intellettuale e formale, mentre il disgustoso, l'immorale e la
mancanza di talento vantano il proprio dominio. Non rimane che vivere secondo i
dettami di una “bellezza sovversiva” e lottare per la nascita di un mito in
grado di rivalutare-accettare di essere deboli-sconfitti in attesa di una
“impossibile” liberazione dall'Impero del Brutto fondato sulla corruzione
globalizzata. E' l'ora di rivalutare un destino che non sia volontà
trascendente e a noi esteriore, ma che invece sia una volontà-desiderio che sia
interno a noi. Se la cinica consapevolezza condanna il mondo alla perdita di
ogni capacità di creare il futuro, sia la “fede poetica” a garantire quella
sospensione dell'incredulità che è in grado di farci aderire
incondizionatamente a quelle “illusioni”, che secondo Ugo Foscolo, ci “fanno
camminare sulle stelle”, favorendo quell'appetito dell'impossibile e del
prodigioso che ci porta e porterà alla rivolta contro l'Impero del Brutto e
contro quelle insensatezze che fanno sprecare la vita a tutti i contemporanei.
Il
mito potrà nascere da serie di azioni poetiche propositive in grado di sfidare
la profonda stanchezza di un'epoca dovuta alle eclissi di quelle attese
utopiche fondamentali per le condizioni eroiche dell'essere umano che come
tale, fino dalle origini mitiche, da quando Prometeo s'immolò per concedergli
il “fuoco”, ha sempre teso al superamento del dato. Ed è ingiusto, tuttavia,
addebitare totalmente la spossatezza spiritual-culturale alle nostre società,
allo sconfinato Impero del Brutto in cui ci troviamo a vivere, poiché ognuno di
noi è, invece, responsabile della rinuncia a una vita vissuta all'altezza delle
possibilità umane, lasciandoci arruolare nella schiera dei “morti-viventi”.
Contro
il cinico buonsenso non si può che aspirare a una vita conflittuale con le
relazioni proposte-imposte dalla “realtà”, per essere pronti a contribuire alla
nascita di un mondo fondato sulle fulgide esigenze di una mitica bellezza
ancora ignota, metamorfica trasfigurazione della grande tradizione non del
tutto sradicata dal corpo di un Italia idealmente incoronata dallo splendore.
Dare forma a una bellezza ignota sarà realizzabile solo quando, come già intuì
Plotino nelle sue Enneadi, al di là
dell'identità e della differenza, le persone vivranno le esigenze metamorfiche
della bellezza oltrepassando i confini del noto. Chi vede il bello come altro
da sé, non contribuirà alla nascita trionfale del nuovo mito. (Per la
condizione metamorfica della bellezza, basti ricordare alcune sue apparizioni
storiche: la bellezza romanica, rinascimentale, barocca, romantica surrealista
ecc.). A 150 anni dall'Unità dell'Italia, sentendo l'improrogabile epifania
della futura nascita di un mito rigenerante, consapevole che nessun Dio, nessun
governo avrebbe mosso un dito contro l’Impero del Brutto, colsi la scintilla
nel vento per stilare il “Manifesto per l'Italia Unita nella Bellezza”,
invitando i cittadini ad arruolarsi come volontari per la conquista
dell'Infinito, l'Infinito venendo incarnato in Italia dal colle dell'Infinito a Recanati, nelle Marche,
cantato da Giacomo Leopardi. Giunsero messaggi di adesione da tutto il mondo di
poeti, artisti, filosofi, psicanalisti libertari e lacaniani, insegnanti,
galleristi, studenti e anche un sacerdote cattolico (Marco Lunghi) reduce dal
monte Sion. Dall'Uruguay arrivò il messaggio di Clemente Padin, uno dei padri
del mail-art. Erano messaggi di adesione alla battaglia perché l'Impero del
Brutto non avesse un dominio simbolico definitivo sul globo. Questi messaggi
furono, prima della spedizione dei “mille” (se non fosse stato mortale,
Garibaldi ci avrebbe condotto in modo inimitabile) a Recanati esposti
all'attenzione del pubblico presso “Gli eroici furori di Arte Contemporanea” di
Silvia Agliotti a Milano. La spedizione risulta documentata nella pubblicazione
Recanati: l'Italia Unita nella Bellezza
(17 marzo 1861 – 17 marzo 2011) a cura di Tomaso Kemeny, Arcipelago
Edizioni, Milano, 2011.
Ridano
pure di queste righe gli affossatori del desiderio dell'impossibile. Con Pascal
Picq ricordo che “la ricerca della bellezza risulta comune a
tutta l'umanità”. C'è da temere che l'Impero del Brutto ci transiti tutti
in un’epoca post-umana, in cui tutto avrà un prezzo e nulla un valore.
Una poesia-fiaba di Franco Manzoni
dedicata ai bambini ebrei morti nel lager di Terezin
FRANCO MANZONI
LA FARFALLA E IL TOPOLINO
ovvero sogni
bambini a Terezin
 |
| Franco Manzoni |
una
lampadina accesa
in
questa notte di serpenti
niente
serrature
si
potrebbe correre assieme
giocare
a nascondino
nel
gelo prigioniero
di
un topolino in gabbia
sotto
luce fissa febbre di fuga
quando
se ne andrà
l’ultimo
bacio dalle labbra
volerà
in alto oltre i confini
di
arcobaleni e bambini morti
di
pigiamini a righe stesi ad asciugare
partoriti
sullo spinato filo
in
quei silenzi che mai hanno volato
sarà
l’ultima farfalla gialla gialla
nata
su questo petto di stella
ci
penserà lei a raccontare
piangendo
rugiada
il
sapore idiota del male
quando
ci spaccano la faccia
a
suon di sberle tante
se
non facciamo il militare saluto
alla
razza padrona che usa lo sputo
sulle
teste rasate dei piagati piccini
segnando
a gesti il cammino
l’ombra
oscura della nostra strada
in
fila con la gavetta in pugno
per
uno spicchio di patata
quando
va bene o acqua
che
puzza di merda e serva
per
superare col respiro
un
altro giorno da raccontare
ho
visto con divelti occhi
il
mio compagno di nove anni impiccato
dimostrazione
per gli altri condannati
oh
il profilo delle sue ossa
disperate
sbriciolate un burattino
anche
lui come me gridava
cercando
la mamma che non c’è
più
non c’è più non c’è
l’albero
di sangue cresce
al
centro del nostro cuore si serra
nel
giardino inchiostro dei senza terra
lo
confesso oppresso dalla rabbia
sono
io quel topolino in gabbia
mentre
le guardie bevono uccidono
teschi
di piombo di risa scoppiano
stanotte
sognerò di scappare
mi
metterò a cavalcare
zitto
sulla farfalla gialla gialla
di
andarmene con lei verso il sole
a
lavarmi il sangue incrostato nel mare
mi
porterò dietro il cuscino di paglia
leggeri
leggeri la farfalla e il topolino
vinceranno
i pugnali neri
per
sentieri occulti sgusceranno via lontano
tenendosi
per mano nella penombra
fermeranno
pistole e mitra
alzeranno
una bandiera in alto
in
alto seppur ferita
si
sposeranno domani uscendo dal fango
si
uniranno con odore e saliva di stella
si
daranno carezze a non finire
dal
sudario faranno dei figli nel tepore
un
topolino giallo da tenere nel taschino
una
farfalla rosea e grigia lì vicino
A questa sponda d’isola remota
m’ha traghettato un’onda forte e tesa:
sulla distesa tiepida di sabbia
faccio morbido letto nelle chiare
notti di stelle.
Resto in trepida attesa di un segnale,
d’un messaggio sussurrato dal vento,
prima che il sole
svanisca oltre la linea del tramonto.
Sul masso di granito levigato,
all’ombra rarefatta delle palme,
traccio il quadro d’ogni giorno passato
e rimango adagiato anche per ore
a meditare
con pensieri che scorrono la vita,
contornano d’un velo di languore
i volti amati,
vagheggiano i misteri dell’eterno.
Può darsi che domani all’improvviso
dal silenzio mi chiami un’Alta Voce:
allora io dovrò –
senza esitare -
trovarmi preparato ad affrontare
l’ultimo viaggio
per l’infinito, inesplorato mare.
Con la speranza d’aver lasciato qui,
del mio passaggio,
un gesto dignitoso, un buon ricordo.
***
IL GRANO DI GIUGNO
Spighe gonfie di chicchi
e già bionde di sole
come onde si muovono
al soffiare
dei venti
piegandosi arruffate
per ritornare poi
quieto mare di giallo.
Affiorano qua e là
di tanto in tanto
le teste rosse dei papaveri:
fiammanti
pennellate
a creare con l’oro del grano
le impressioni eternate
dai quadri di Van Gogh.
***
PADRE, SE TU FOSSI
QUI
Padre, io da bambino mi credevo
troppo lontano e poco somigliante
a quel tuo tratto dolce ma deciso,
alla severità verso te stesso,
alla serenità nell’affrontare
istante dopo istante la tua vita.
Ma sempre ti ho tenuto poi vicino,
ho portato con me il tuo messaggio,
l’educazione che mi hai consegnato.
Se tu fossi qui adesso, in questo tempo,
ad osservare come vivo il mondo,
vedresti rispecchiati in me i valori
e gli ideali dei quali mi parlavi,
sentiresti da me tante opinioni
che tu affermavi spesso con fervore.
E percepiresti, dalla mia mano
che ti sorregge il passo e che ti guida,
la fierezza di un figlio per suo padre.
RINALDO CADDEO
SOGNO
 |
| Rinaldo Caddeo |
Una forma oscura s’è staccata dal disegno di un muro scrostato e ha cominciato a camminare per la città. E più cammina e più cresce fino a diventare un gigante: la testa, il collo, le spalle, sopra i tetti delle case, il busto e le gambe tra le strade. Con le mani prende i passanti, le automobili, i tram e li scaglia. Prende un cane. Il cane lo morde e lui lo schiaccia tra le dita, fino a fargli uscire gli occhi dalle orbite,
i denti dalle gengive.
Tutti fuggono terrorizzati
ma lui è un bambino, un gigantesco bambino, fatto di ciuffi di schiume di fumo
(unghie rabbie fiamme), che vuole solo giocare. E si alimenta con tutti gli
scarichi della città che lo fanno aumentare.
Solo una bambina non
scappa e lui gioca con lei senza farle del male. Lei lo fa entrare in camera
sua
e lui si riduce alle dimensioni di un bambino quasi normale.
e lui si riduce alle dimensioni di un bambino quasi normale.
Lei lo convince a
diventare ancora più piccolo. Lo fa entrare in una scatola e lo chiude dentro.
E lui esce soltanto la
notte per le vie della città a spargere paura, quando la bambina dorme.
Entra nelle case. S’infila per i cunicoli, le fessure, gli stipiti. Passa attraverso il naso, le palpebre,
le orecchie e imperversa facendo urlare la gente.
Entra nelle case. S’infila per i cunicoli, le fessure, gli stipiti. Passa attraverso il naso, le palpebre,
le orecchie e imperversa facendo urlare la gente.
Così tutte le notti.
Qualcuno si sveglia
pensando: «Ho fatto un sogno. È stato un bel sogno. Peccato che sia finito».
Qualcun altro, invece, si
sveglia pensando: «Ho fatto un sogno. È stato soltanto un brutto sogno.
Per fortuna la realtà non è così».
Per fortuna la realtà non è così».
Ma di giorno il sogno
rientra nella scatola per giocare con la bambina.
ARTURO SCHWARZ
L'ETICA SURREALISTA
Un luogo comune solidamente radicato nella sinistra, rivoluzionaria e non, vuole l’azione politica di Breton e dei suoi amici dilettantesca e superficiale. Per confutare il pregiudizio e documentare fino a che punto la loro attività fu ragionata e aderente alle necessità di una prassi autenticamente rivoluzionaria basta seguire la cronaca degli eventi. Si vede allora come il surrealismo, lungo l’arco di ben quarant’anni, sia stato autorevolmente presente in tutti i momenti chiave -piccoli o grandi che fossero- della storia contemporanea con prese di posizione chiarificatrici. Nessun altro movimento culturale può rivendicare una tale continuità di interventi politici, altrettanto lungimiranti e su un periodo di tempo così lungo. Il sogno a occhi aperti dei surrealisti non fece mai perdere loro di vista la realtà nella quale lottavano.
Il primo proclama del gruppo riprende una classica
rivendicazione del pensiero anarchico: “Aprite le prigioni. Sciogliete
l’esercito. Non esistono reati di diritto comune”. Vi si legge tra l’altro: “Le
costrizioni sociali hanno fatto il loro tempo. Niente, né la constatazione di
un fatto compiuto, né il contributo alla difesa nazionale potrebbero
costringere l’uomo a fare a meno della libertà. L’idea di prigione, l’idea di
caserma hanno oggi pieno corso; queste mostruosità non vi sorprendono più...
Non abbiamo paura di confessare che noi attendiamo, che noi auspichiamo la
catastrofe. La catastrofe consisterebbe nel persistere di un mondo in cui
l’uomo ha dei diritti sull’uomo. L’unione sacra dinanzi ai coltelli o alle
mitragliatrici: come fare appello più a lungo a questo argomento squalificato?
Restituite ai campi i soldati e i galeotti. La vostra libertà? Non c’è libertà
per i nemici della libertà. Non saremo complici dei carcerieri”[1].
La “Dichiarazione del 27 gennaio 1925”, stampata su
un volantino al quale fu data grande diffusione, redatta molto probabilmente da
Antonin Artaud, fu firmata dal gruppo surrealista al completo: Louis Aragon,
Antonin Artaud, Jacques Baron, J.-A. Boiffard, Joë Bousquet, André Breton, Jeaq
Carrive, René Crevel, Robert Desnos, Paul Eluard, Max Ernst, T. Fraenkel,
Francis Gérard, Michel Leiris, Georges Limbour, Mathias Lübeck, Georges
Malkine, André Masson, Max Morise, Pierre Naville, Marcel Noll, Benjamin Péret,
Raymond Queneau, Philippe Soupault, Dédé Sunbeam, Roland Tual.
Il documento è di grande importanza in quanto
precisa che il surrealismo non è una nuova scuola letteraria, ma un movimento
ideologico rivoluzionario:
“1. Non abbiamo niente a che vedere con la
letteratura. Ma, se necessario, siamo capaci, come tutti, di servircene.
“2. Il surrealismo
non è un nuovo o più facile mezzo di espressione, e neppure una metafisica
della poesia; è un mezzo di liberazione totale dello spirito e di tutto ciò che gli somiglia.
“3. Siamo ben decisi a fare una Rivoluzione.
“4. Abbiamo accoppiato la parola surrealista alla parola rivoluzione solo per dimostrare il
carattere disinteressato, distaccato e persino del tutto disperato, di questa
rivoluzione.
“5. Non pretendiamo di cambiare niente nei costumi
degli uomini, ma certo riteniamo di dimostrare la fragilità dei loro pensieri e
su quali assise instabili, su quali fondamenta abbiano stabilito’ le loro case
vacillanti.
“6. Lanciamo alla Società questo solenne
avvertimento: che faccia attenzione ai suoi errori, a ogni passo falso non la
mancheremo.
“7. A ogni svolta del suo pensiero, la Società ci
ritroverà.
“8. Siamo degli specialisti della Rivolta. Non c’è
mezzo d’azione che non siamo capaci di usare, se necessario.
“9. Diciamo più particolarmente al mondo
occidentale: il surrealismo esiste.
“– Ma cos’è dunque questo nuovo ismo che ci si appiccica?
”– Il surrealismo
non è una forma poetica.
“È un grido dello spirito che si rivolge verso se
stesso ed è ben deciso a distruggere disperatamente le sue catene, e se
necessario con martelli materiali!”[1].
 |
| Arturo Schwarz (Foto: Dino Ignani) |
La prima guerra mondiale, che ha fatto incontrare i
surrealisti, provoca in loro una presa di coscienza che determinerà tutta l’evoluzione
del movimento. “Questo macello ingiustificabile, quest’inganno mostruoso, è ciò
che mi ha persuaso che la parola scritta non doveva essere solamente strumento
per piacere, ma che piuttosto doveva aver presa sulla vita”[2]. Il prolungarsi del conflitto
non faceva che rendere più totale il rifiuto “degli imperativi e delle
costrizioni... che diventavano di giorno in giorno più cinici e
intollerabili... Mi aspettavo che la poesia, per sua essenza ferocemente ostile
a tutto ciò che avevamo patito, mi desse lo stimolo necessario a questa lotta”[3].
Questa prima presa di coscienza è di carattere
ancora generico. “In questo momento il rifiuto surrealista è totale,
assolutamente inadeguato a lasciarsi convogliare sul piano politico. Tutte le
istituzioni sulle quali si fonda il mondo moderno e che hanno avuto la loro
risultante nella prima guerra mondiale sono considerate da noi aberranti e
scandalose. Per cominciare, ci scagliamo contro tutto l’apparato di difesa
della società: esercito, ‘giustizia’, polizia, religione, medicina mentale e
legale, scuola... Ma per combattere con qualche speranza di successo è
necessario attaccarne la struttura portante, la quale, in ultima analisi, è di
ordine logico e morale: la pretesa ‘ragione’ di uso corrente, la quale ricopre
con un’etichetta fraudolenta il ‘buon senso’ più logoro, la ‘morale’
falsificata dal cristianesimo allo scopo di scoraggiare ogni resistenza contro
lo sfruttamento dell’uomo”[4].
Un altro conflitto, ora di carattere coloniale, vede
la Francia mandare un corpo di spedizione in Marocco per domare Abd el-Krim.
Questa volta la guerra è ancora più sporca, non si tratta della rissa tra
banditi che vogliono assicurarsi una parte maggiore del bottino, si tratta di
una guerra fatta per privare un popolo della sua libertà e della sua dignità,
una guerra per mantenere in schiavitù altri esseri umani. La protesta assume
per la prima volta un carattere politico. L’ “Appello ai lavoratori
intellettuali” è elaborato in collaborazione con il gruppo della rivista paracomunista
Clarté (Georges Altman, Jean Bernier,
Victor Crastre, Marcel Fourrier, Victor Serge ecc.) e con il gruppo
“Philosophies” (Georges Friedman, Henri Lefebvre, Georges Politzer ecc.). Vi si
afferma: “Turbati e disgustati dalle atrocità c ommesse da ambo le parti sul
fronte dell’Uergha, constatiamo che questi crimini sono di tutte le guerre. Ed
è quindi la guerra che bisogna disonorare... Proclamiamo, un’altra volta
ancora, il diritto dei popoli, di tutti i popoli, a qualsiasi razza
appartengano, a disporre di se stessi” (L‘Humanité,
2 luglio 1925).
André Breton commenterà: “In presenza di un fatto
così brutale, ripugnante, impensabile
[la guerra marocchina], l’attività surrealista sarà condotta a interrogarsi sui
suoi mezzi, a fissarne i limiti;
saremo costretti ad adottare un atteggiamento preciso, esterno a essa, per
continuare a far fronte a ciò che va al di là di tali limiti. Questa attività è
entrata ora nella sua fase ragionante. Sente improvvisamente il bisogno di
saltare il fossato che separa l’idealismo assoluto dal materialismo dialettico”[5].
È necessario precisare che nel 1925 la conoscenza da
parte dei surrealisti dei classici del marxismo era sommaria. Gli echi della
Rivoluzione d’ottobre cominciavano a malapena a raggiungere la Francia. E quanto
succedeva in quel momento in URSS, la battaglia dell’Opposizione di sinistra,
le posizioni di Trotskij ecc., era completamente ignorato. Breton ricorda: “In
Francia la polizia intellettuale è stata ben vigilante se queste idee hanno
impiegato tanto, quasi otto anni, per arrivare sino a noi! Sino al ‘25 è
notevole che la parola rivoluzione, in quello che può avere per noi di
esaltante, non evoca nel passato che la Convenzione e la Comune”[6].
A questo riguardo ricordiamo che, sino al 1925, gli
unici accenni dei surrealisti alla Rivoluzione d’ottobre sono fatti da Aragon.
Ma, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare dall’uomo che fu l’unico
surrealista a resistere per ben quarant’anni nel Partito comunista francese, i
suoi accenni sono spregiativi. Nel 1923 egli definisce il bolscevismo
“rispettabile, ma piuttosto ristretto”[7]. Nell’ottobre 1924,
all’indomani della morte di Lenin, Aragon, in un manifesto contro Anatole
France, definisce quest’ultimo “il letterato oggi acclamato sia da quel tapiro
di Maurras, sia da Mosca la rimbambita”[8]. Questa sortita gli viene
rimproverata da Bernier, amico di Aragon, sulla rivista Clarté. Aragon replica con ancor maggiore improntitudine: “La
rivoluzione russa? Lei non mi può impedire di rispondere con una alzata di spalle.
Dal punto di vista delle idee essa appare, tutt’al più, come una vaga crisi
ministeriale”[9].
Finalmente, nel novembre 1925, in risposta a un attacco di Drieu La Rochelle,
egli scrive. “Non voglio risponderti che non ho gridato: Viva Lenin! Lo sbraiterò
domani, visto che mi si vieta di farlo”[10].
Questa volta la misura è colma per Breton.
Nell’estate aveva letto il Lenin di
Trotskij. Le guerra del Rif gli aveva fatto maturare posizioni politiche più
precise. Una puntualizzazione della questione gli appare indispensabile. “Tra
noi, anche gli spiriti più estranei alla politica, vedevano, in questa
affermazione, ‘un pezzo di bravura’ indifendibile... C’è da credere che ciò mi
fosse rimasto sullo stomaco, se in quell’epoca fui indotto a riaprire
completamente il dibattito. L’occasione mi fu offerta da un resoconto
dell’opera di Trotskij su Lenin... Questo scritto ha segnato innegabilmente il
primo passo, un passo decisivo (benché si sia detto spesso in seguito che fu da
parte mia e da parte del surrealismo un passo falso) verso una migliore
comprensione delle idee e degli ideali di cui la rivoluzione russa era stata la
risultante... Tra noi, dicevo, lo spirito generale restò teso soprattutto verso
la realtà rivoluzionaria in modo da arrivarci con tutti i mezzi ed ad ogni
costo. E come se questa allusione al recente comportamento di Aragon mi
sembrasse ancora insufficiente, me la prendevo direttamente con lui
aggiungendo: ‘Libero Louis Aragon, di far sapere a Drieu La Rochelle, in una
lettera aperta, di non avere mai gridato Viva Lenin, ma che lo sbraiterà domani (sic) perché questo
grido gli viene impedito. Libero anch’io... di pensare che significa facilitare
il gioco dei nostri peggiori detrattori lasciar loro supporre che agiamo in
questo modo solo per sfida: Viva Lenin, al contrario, e solo perché è Lenin”[11].
La recensione da parte di Breton del volume di
Trotskij ha una influenza decisiva sul gruppo surrealista. “Mi è lecito dire
che godevo del necessario ascendente perché di colpo questa posizione fosse
adottata assai largamente tra i surrealisti e perché Aragon non vi trovasse
niente da ridire, che dico, ma fosse, anzi, il primo ad associarvisi”[12].
Per tornare al 1925, il volantino “La rivoluzione
innanzitutto e sempre” (21 settembre) è frutto della collaborazione tra i
surrealisti francesi, i gruppi dei surrealisti belgi attorno a Correspondance (Camille Goemans e Paul
Nougé), quello della rivista Clarté e
il gruppo “Philosophie”. Vi si legge:
“Ben consci della natura delle forze che attualmente
turbano il mondo, prima ancora di contarci e di metterci all’opera, vogliamo
proclamare il nostro assoluto distacco e in qualche modo la nostra
purificazione dalle idee che sono alla base della civiltà europea ancora assai
vicina, e così pure da ogni civiltà basata sui principi insopportabili di
necessità e di dovere.
“Più ancora del patriottismo, che è un’isteria come
un’altra, ma più vuota e più mortale di un’altra, ci ripugna l’idea di Patria,
che è veramente il concetto più bestiale e meno filosofico in cui si tenta di
far entrare il nostro spirito.
“Siamo certamente dei Barbari perché una certa forma
di civiltà ci disgusta.
“Dovunque regni la civiltà occidentale, tutti i
vincoli umani sono venuti meno, tranne quelli che hanno una ragion d’essere
nell’interesse, nel ‘duro pagamento in contanti’. Da più di un secolo, la
dignità umana è ridotta al rango di un valore di scambio. È già ingiusto che
chi non possiede sia asservito da chi possiede, ma quando questa oppressione
supera il quadro di un semplice salario da pagare e assume come esempio la
forma di schiavitù che l’alta finanza internazionale fa pesare sui popoli, è
una iniquità che nessun massacro riuscirà a espiare. Non accettiamo le leggi
dell’Economia e dello Scambio, non accettiamo la schiavitù del Lavoro e, su un
piano ancora più ampio, ci dichiariamo in istato di insurrezione contro la
Storia. La Storia è governata da leggi condizionate dalla viltà degli individui
e noi non siamo certo degli umanitari, in nessuna misura...
“Noi siamo la rivolta dello spirito; consideriamo la
Rivoluzione sanguinosa come la vendetta ineluttabile dello spirito umiliato
dalle vostre opere. Non siamo degli utopisti: questa Rivoluzione non la
concepiamo che in forma sociale. Se esistono in qualche luogo uomini che
abbiano visto levarsi contro di loro una coalizione tale che non ci sia nessuno
che non li disapprovi (traditori verso tutto ciò che non sia la Libertà,
ribelli di ogni genere, prigionieri di diritto comune), non dimentichino che
l’idea della Rivoluzione è la migliore e più efficace salvaguardia
dell’individuo”[13].
Ritroviamo le firme dei surrealisti assieme a quelle
di altri intellettuali in calce a una serie di appelli contro la dittatura e il
ricorso sistematico alla tortura in Polonia (L’Humanité, 8 agosto 1925); per protestare contro la persecuzione
del governo rumeno contro le minoranze etniche in Bessarabia (L’Humanité, 28 agosto 1925); per
solidarietà con il Comitato centrale d’azione che anima la protesta contro la
guerra del Rif (L’Humanité, 16
ottobre 1925); per denunciare le torture e la corte marziale in Ungheria (L’Humanité, 17 ottobre 1925).
Il momento di massima adesione e impegno dei
surrealisti nell’ideologia comunista è in una lettera del gruppo pubblicata su L’Humanité dell’8 novembre 1925. Vi si
legge tra l’altro: “Non c’è mai stata una teoria surrealista della rivoluzione.
Non abbiamo mai creduto a una rivoluzione surrealista... Noi desideriamo la
Rivoluzione, e quindi vogliamo i mezzi rivoluzionari. Nel qui e ora questi
mezzi da chi sono detenuti ed esercitati? Solo dall’Internazionale comunista, e
per la Francia dal PCF”.
Venendo al 1926, il testo politico più importante è
la plaquette “Legittima difesa”. Breton vi denuncia il pericolo di quello che
Kruscev chiamerà, quarant’anni più tardi, il culto della personalità:
“Continueremo nostro malgrado a fare delle riserve sull’abbandono completo a
una fede che, come ogni altra fede, presuppone un certo stato di grazia”. Vi si
critica il deplorevole livello teorico e politico del quotidiano del PCF: “Non
so perché dovrei astenermi ancora dal dire che L’Humanité – puerile, declamatorio, inutilmente cretinizzante – è un giornale
illeggibile e indegno della funzione educativa che pretende di svolgere nei
confronti del proletariato”. Il settarismo e il dogmatismo dei comunisti
francesi sono attaccati con uguale vigore: “Non posso capire come sulla strada
della rivolta ci siano una destra e una sinistra... Dico che la fiamma
rivoluzionaria si accende dove vuole e che non spetta a un piccolo numero di
persone, nel periodo di attesa che viviamo, stabilire che può accendersi qui o
là solamente”[14].
Nell’opuscolo dal quale abbiamo tratto il passo
sopra citato Breton riafferma la possibilità di conciliare la lotta
rivoluzionaria con le esigenze della ricerca intellettuale, che non deve
piegarsi agli imperativi politici: “Sul piano dei fatti nessun equivoco è
possibile da parte nostra: non c’è nessuno tra di noi che non si auguri che il
potere passi dalle mani della borghesia a quelle del proletariato. Intanto, non
è per questo meno necessario, secondo noi, continuare con le esperienze della
vita interiore, e ciò, ben s’intende, senza alcun controllo, neppure marxista.
Il surrealismo, del resto, non tende forse, al limite, a fare di questi due
stati un solo stato, facendo giustizia della loro presunta inconciliabilità
pratica, con tutti i mezzi, a cominciare dal più primitivo di tutti, il cui
impiego incontrerebbe difficoltà a essere legittimato se così non fosse:
intendo parlare del richiamo al meraviglioso?”
Nel 1927 si ha l’adesione per un breve periodo dei
surrealisti al PCF che però non impedisce a Breton e ai suoi amici di
stigmatizzare ogni passo falso dei comunisti francesi. Il volantino “Au grand
jour” (maggio) riporta la lettera al PCF di Louis Aragon, André Breton, Paul
Eluard, Benjamin Péret e Pierre Unik. I cinque, pur confermando la loro
adesione al partito, ne denunciano i due mali cronici. Da un lato l’assenza di
ogni libera discussione: “All’interno di un partito rivoluzionario e finché la
situazione non è insurrezionale, non ci possono essere buone ragioni per
privare qualcuno del diritto di critica, nei limiti in cui questo può
validamente essere esercitato”. Dall’altro, il processo di burocratizzazione
che ha già snaturato il PCF: “Ma intendiamo anche dire quanto sia penoso che
l’organizzazione del Partito comunista in Francia non gli consenta di
utilizzarci in un ambito in cui ci sia possibile realmente renderci utili e che
nessun’altra decisione sia stata presa nei nostri confronti oltre a quella di segnalarci
un po’ dovunque come persone sospette”[15].
Di André Thirion, molto vicino ai surrealisti in
quegli anni, c’è una testimonianza precisa sull’atmosfera politica nella quale
si muovevano Breton e i suoi amici: “I migliori tra gli intellettuali comunisti
degli anni ‘20, per i quali Marx e Lenin non erano solamente dei nomi, avevano
quasi tutti aderito alle tesi dell’opposizione trotskista, o si preparavano a
sottoscriverle. Questi uomini furono i primi membri del partito che Aragon e
Breton incontrarono, tra i quali vi era Marcel Fourrier, uno dei principali
redattori di Clarté. Breton apprezzò
subito la sua modestia, la sua gentilezza, il suo buonsenso... Già nel 1926
divenne un trotskista moderato, pur mantenendo dei contatti con il partito, ma
irriducibilmente ostile allo stalinismo. Fourrier presentò Boris Souvarine a
Breton. L‘influenza di questo spirito brillante – che aveva avuto rapporti
personali con tutti i grandi rivoluzionari d’ottobre, escluso sin dal 1923 dal
partito, redattore di Le Bulletin
Communiste, l’organo d’opposizione meglio scritto e più letto – ebbe un
peso decisivo nell’orientamento di tutti i surrealisti in favore delle tesi di
Trotskij... Victor Serge, entrato in contatto con quelli di Clarté, non deponeva neppure lui in
favore di Stalin. Vecchio anarchico, amico di Bonnot, di Garnier e di altri,
era stato processato, e con lui tutta la banda, nel famoso caso giudiziario.
Questo episodio lo valorizzava agli occhi dei surrealisti, tanto più che il suo
disinteresse aveva ricevuto una chiara consacrazione dalla Corte d’assise. Le
testimonianze di questi oppositori ebbero maggior peso dei commenti ufficiali
sulla crisi russa pubblicati dall’Humanité.
Ma ne11926, i trotskisti erano ancora tutti nel partito, considerato allora il
fulcro della rivoluzione. La solenne adesione di Aragon, Breton e alcuni altri
al Partito comunista, alla fine del ‘26, si realizzò in nome di Hegel, di Marx,
di Lenin e di Trotskij”[16].
Nel 1927 Artaud pone l’interrogativo: “Il
surrealismo stesso non è morto il giorno in cui Breton e i suoi seguaci hanno
ritenuto giusto di dover dare la loro adesione al comunismo e cercare sul piano
dei fatti e della materia immediata lo sbocco a un’azione che avrebbe potuto di
norma avere luogo solo nelle strutture intime del cervello?”[17]. Queste critiche sono
ingiustificate; si è visto con quanta coerenza Breton abbia sempre saputo
evitare sia il pericolo di un’adesione acritica a posizioni dogmatiche, sia
l’alibi artistico che giustifica il “superbo isolamento” nella torre d’avorio.
Del resto, lo stesso Artaud lo riconoscerà nel 1936, come ricorderò più avanti.
Quando Trotskij viene esiliato, nel 1929, Breton è
vivamente preoccupato per la sua sorte. Il movimento surrealista sta
attraversando una crisi. Egli si trova a combattere su due fronti, contro i
politici, come Naville, che rimproverano a lui e ai suoi amici di dare la
precedenza alle preoccupazioni letterarie, e contro i poeti, come Artaud, che
muovono il rimprovero opposto. Breton avverte la debolezza e la divisione degli
intellettuali progressisti, e vorrebbe riuscire a superare le divisioni per
esercitare un’azione più determinante. Il gruppo surrealista invia il 12
febbraio 1929 una lettera circolare a numerosi intellettuali. Dopo avere
affermato: “Un certo numero di noi si rifiuta di credere alla necessità, alla
fatalità di una dispersione dei nostri sforzi e alla eccessiva specializzazione
che ne deriva”[18],
chiede: “Ritiene che, tirate le somme..., la sua attività debba o no
restringersi, definitivamente o no, a una forma individuale?”.
 |
| Arturo Schwarz (Foto: Dino Ignani) |
In un’altra lettera si propone come tema di
discussione l’esame critico della sorte recentemente riservata a Leone
Trotskij. Naville, staccatosi dal gruppo un paio d’anni prima, è scongiurato di
dimenticare i disaccordi in nome del carattere della questione posta:
“Qualunque possa essere per lei il grado d’incisività di un’azione che si
sviluppa secondo altri schemi, non le potrà sfuggire che una sua astensione in
un simile frangente implica nei nostri riguardi un disimpegno tanto più
spiacevole in quanto sarebbe l’atteggiamento adattato da persone contro cui
l’abbiamo sempre vista lottare... Siccome ci è parso particolarmente indicato
che ognuno si pronunciasse su un fatto che non le è indifferente (la sorte
recentemente riservata a Leone Trotskij), non crede che, non foss’altro in
qualità di testimone, l’autore di La
révolution et les intellectuels dovrebbe essere presente?”[19].
Nonostante la questione non venga sollevata alla
riunione che si terrà a Parigi 1’11 marzo 1929 al Bar du Château, Breton non si
lascia sfuggire l’occasione per riferire le opinioni di Panait Istrati su
Trotskij: “Trotskij, o l’opposizione, è la riserva aurea della rivoluzione
russa; senza tale riserva, non so proprio come potrebbe esserci un progresso
rivoluzionario in Russia e nel mondo. Saremmo già al ristagno, all’immobilità.
Non può, d’altra parte, trattarsi di adottare questa concezione solo per
entusiasmo”[20].
La riunione si concluse con un nulla di fatto, Breton sente la necessità di
puntualizzare con un testo quanto non vi si è potuto chiarire. Stende il
“Secondo manifesto del surrealismo” che viene pubblicato nel numero del
dicembre 1929 de La Révolution
Surréaliste.
Ricordando le circostanze nelle quali il testo fu
elaborato, Breton scrive: “È proprio intorno al 1930 che le menti più aperte
avvertono il prossimo, ineluttabile ritorno della catastrofe mondiale. Al
diffuso smarrimento che ne risulta, non nego che si sovrappone in me
un’inquietudine di altro ordine: come sottrarre alla corrente, sempre più imperiosa,
lo scafo che avevamo, in pochi, costruito con le nostre mani, proprio per
risalire quella corrente?”[21].
Risalire la corrente, non solo degli avvenimenti
che, sul piano delle idee, minacciano sempre più l’integrità rivoluzionaria del
pensiero, ma anche della storia che trascina irresistibilmente il mondo verso
il 1939 – quella data che, nella sua lettera alle veggenti del 1925, la
sensibilità premonitrice di Breton aveva già vaticinato come l’anno d’inizio di
un altro conflitto mondiale: “Certe persone si dicono convinte che la guerra
abbia loro insegnato qualcosa; ne sanno, in ogni caso, meno di me, che so cosa
mi riserva l’anno 1939”[22].
In questa lotta impari, che lo vede isolato con
pochi altri, Breton ritrova in un solo uomo politico, Trotskij, le posizioni
che difende contro tutti gli altri. Quanto è in gioco è la giustificazione
dell’esistenza di un’attività creativa indipendente da imperativi politici. Vi
è di mezzo il concetto stesso di cultura. Si oppone una cultura sedicente
proletaria alla cultura le cui istanze rinnovatrici vengono tacciate di
piccolo-borghesi.
Nel “Secondo manifesto”, a conforto delle proprie
opinioni, Breton cita l’autore di Letteratura
e rivoluzione: “Le vaghe teorie sulla cultura proletaria, concepite per
analogia e per antitesi con la cultura borghese, risultano da paragoni tra il
proletariato e la borghesia, cui lo spirito critico è affatto estraneo… È certo
che, nello sviluppo della nuova società, verrà il momento in cui l’economia, la
cultura, l’arte avranno la massima libertà di movimento – di progresso… Ma a
questo arriveremo soltanto dopo una lunga e faticosa transizione, che sta
ancora interamente davanti a noi”[23].
Breton non ha mai pensato altrimenti e nel “Secondo
manifesto” riafferma: “Non credo alla possibilità di esistenza attuale di una
letteratura o un’arte che esprimano le aspirazioni della classe operaia. Se
rifiuto di crederci, è perché in periodo prerivoluzionario lo scrittore o
l’artista, di formazione necessariamente borghese, è per definizione inetto a
tradurle”[24].
Infatti, come si potrebbero difendere una letteratura e un’arte cosiddette
proletarie “in un’epoca in cui nessuno potrebbe vantarsi di appartenere alla
cultura proletaria per l’ottima ragione che quella cultura non ha ancora potuto
essere realizzata, nemmeno in regime proletario”[25]? La coincidenza di vedute
tra Breton e Trotskij su questi problemi è tanto più interessante da rilevare
in quanto in quegli anni Breton non conosceva, dello scritto di Trotskij Letteratura e rivoluzione, pubblicato a
Mosca nel 1923, che le poche pagine tradotte per il fascicolo Clarté del 10 novembre 1923.
Dal “Secondo manifesto” si evince che le
preoccupazioni di Breton non sono solo di ordine letterario. Egli segue “con
passione la lotta che si sta svolgendo alla testa dell’Internazionale”[26]. Per quanto riguarda il
Partito comunista francese, si chiede: “Come non essere terribilmente
preoccupati di un tale abbassamento del livello ideologico in un partito che
era sorto così brillantemente armato da due delle teste più solide del XIX
secolo?”[27].
Riafferma: “Non possiamo evitare di proporci nel modo più scottante la
questione del regime sociale sotto il quale viviamo, vale a dire
dell’accettazione o della non accettazione di quel regime”[28]. A quelli che potrebbero
avere ancora dei dubbi circa l’adesione del surrealismo al marxismo, egli
ripete: “Diamo un’adesione totale,
senza riserve, al principio del materialismo storico”[29].
La coincidenza di giudizi tra Breton e Trotskij
emerge nel commentare il suicidio di Majakovskij il 14 aprile 1930. Breton
difende la memoria del poeta contro gli sciacalli stalinisti dell’Humanité, che vedono nella sua scelta un
atto coerente con l’ideologia piccolo-borghese e una conferma conclusiva della
sua incapacità ad adattarsi ai dettami di una cultura “proletaria”. Breton
risponde che il dramma sociale e quello umano sono due drammi ben distinti.
Forse che un rivoluzionario non può innamorarsi? “Amare o non amare, ecco la
domanda alla quale un rivoluzionario dovrebbe poter rispondere senza esitare...
Non è ancora stato dimostrato che l’uomo, avendo raggiunto il più alto grado di
coscienza sociale (parlo del rivoluzionario), abbia la migliore difesa contro
il pericolo di uno sguardo di donna... Dopo tutto quest’uomo non ha pronunciato
un voto per il quale non debba più riconoscersi in quanto uomo. Questo bisogno
che possiamo avere della presenza di un essere a esclusione di tutti gli altri
costituisce forse una tara tale che quelli che non sentono questa necessità
hanno il diritto, ancora una volta da un punto di vista rivoluzionario, di
giudicare?... La vita entusiasmante del proletariato in lotta, la vita
stupefacente e fragile dello spirito in preda alle belve di se stesso, troppo
vano sarebbe da parte nostra voler fare un dramma solo di questi due drammi
distinti”[30].
Trotskij risponde sullo stesso tono: “L’annuncio
ufficiale del suicidio col linguaggio di un protocollo giudiziario redatto nel
‘segretariato’ si affretta a dichiarare che il suicidio di Majakovskij ‘non ha
nulla in comune con l’attività sociale e letteraria del poeta’. Il che equivale
a dire che la morte volontaria di Majakovskij non ha alcun rapporto con la sua
vita, o che la sua vita non ha avuto nulla in comune con la sua opera
poetico-rivoluzionaria, insomma significa trasformare la sua morte in
un’avventura di cronaca nera. Ciò è falso, inutile e sciocco! ‘La barca si è
infranta contro la vita quotidiana’ scrive, prima di morire, Majakovskij nei
versi sulla propria vita intima. Ciò significa che l’ ‘attività sociale e letteraria’
aveva smesso di elevarlo abbastanza sulla vita quotidiana per salvarlo dalle
insopportabili scosse personali”[31].
Breton rivendica per Majakovskij la capacità di
avere saputo stabilire un legame con la rivoluzione: “Amo senza conoscerli, e
cioè con piena fiducia, questi
manifesti di propaganda, questi proclami che ha redatto per esaltare, con tutti
i suoi mezzi, il trionfo della prima repubblica proletaria”[32]. E Trotskij all’unisono
riprende: “Majakovskij ha cercato un legame con la rivoluzione in modo più
coraggioso ed eroico di qualunque rappresentante dell’ultima generazione della
vecchia letteratura russa”[33].
A quelli che rinfacciano a Majakovskij di non avere
scritto un’opera d’arte proletaria, Breton risponde: “Torniamo a domandare:
mostrateci un’opera d’arte ‘proletaria’”[34].
Entrambi arrivano alle stesse conclusioni circa
l’inesistenza di un’arte proletaria, ma mentre Breton, da poeta, ne individua
la ragione al livello del dualismo dei sentimenti, Trotskij, da politico,
chiarisce l’altro aspetto della questione: “L’attuale ideologia ufficiale della
‘letteratura proletaria’ è fondata – nel campo artistico assistiamo allo stesso
spettacolo cui si assiste in quello economico – sulla completa incomprensione
dei ritmi e delle scadenze della maturazione culturale. La lotta per la
‘cultura proletaria’ – una sorta di ‘collettivizzazione totale’ di tutte le
conquiste dell’umanità nell’ambito del piano quinquennale – all’inizio della
Rivoluzione d’ottobre aveva il carattere di un idealismo utopistico, e proprio lungo
questa linea fu respinta da Lenin e dall’autore di queste righe. Negli ultimi
anni essa è diventata semplicemente un sistema di ingiunzioni burocratiche
all’arte e di devastazione dell’arte... Majakovskij fu non soltanto il
‘cantore’ ma anche la vittima di un’epoca di rottura, la quale, se forma gli
elementi della nuova cultura con una forza mai vista, lo fa pur sempre in modo
molto più lento e contraddittorio di quanto è necessario per lo sviluppo
armonico di un singolo poeta, o di una generazione di poeti che si consacrò
alla rivoluzione”[35].
Nonostante Trotskij avesse caratterizzato l’URSS
come uno Stato operaio degenerato, egli mantenne sino alla fine la validità
della parola d’ordine della sua difesa incondizionata in caso di attacco delle
potenze imperialiste. In risposta a un telegramma della primavera 1930,
ricevuto dall’Ufficio internazionale della letteratura rivoluzionaria di Mosca
circa la posizione dei surrealisti se l’imperialismo dichiarasse la guerra ai
Soviet, Breton assume lo stesso atteggiamento, e risponde: “Compagni se
imperialismo dichiara guerra ai Soviet nostra posizione sarà conformemente alle
direttive Terza Internazionale posizione dei membri Partito comunista francese.
Se riteneste possibile in tal caso un migliore impiego delle nostre facoltà,
siamo a vostra disposizione per missione precisa che esiga un uso diverso delle
nostre persone di intellettuali stop proporvi suggerimenti equivarrebbe
veramente a sopravvalutare la nostra funzione e le circostanze. Nell’attuale
situazione di conflitto non armato crediamo inutile attendere per mettere al
servizio della rivoluzione i mezzi che più particolarmente ci appartengono”[36]. Thirion commenta:
“L‘impegno era grande. Nella sinistra o nella estrema sinistra degli
intellettuali e degli artisti, non c’erano, all’epoca, altri esempi simili”[37].
È del 1930 un altro episodio che conferma quanto
Breton si sentisse legato a Trotskij. Aragon era stato mandato, con Georges
Sadoul, a Char’kov in rappresentanza del gruppo surrealista al secondo Congresso
internazionale degli scrittori rivoluzionari. Non è questa la sede per
descrivere il voltafaccia di Aragon che parte surrealista e torna stalinista.
Basti ricordare che in quell’occasione egli firmò con Sadoul una lettera
indirizzata all’Unione internazionale degli scrittori rivoluzionari, il I
dicembre 1930, in cui scrive tra l’altro: “Riteniamo di dover precisare che ci
collocheremo sempre entro il quadro del materialismo dialettico e che
respingeremo ogni ideologia idealista (soprattutto il freudismo). Neghiamo la
nostra solidarietà a qualsiasi ideologia confusionale concernente il
trotskismo. Consideriamo il trotskismo una ideologia socialdemocratica e
controrivoluzionaria. Ci impegniamo a lottare contro il trotskismo in ogni
occasione”[38].
Un Breton impietrito ricorderà: “E stata la prima
volta che ho visto aprirsi sotto i miei occhi quell’abisso che dopo di allora
ha assunto proporzioni vertiginose via via che si è riusciti a diffondere
l’idea impudente secondo cui la verità deve cedere il passo all’efficacia o che
la coscienza non ha diritto ad alcun riguardo come non lo ha la personalità
individuale, o che il fine giustifica i mezzi”[39].
Il 3 dicembre 1930 manifestazioni dei fascisti della
Gioventù patriottica e della Lega antiebraica portano al divieto di proiezione
del film L’âge d’or di Luis Buñuel e
Salvador Dalì. Il divieto segna il ritorno dei surrealisti alla politica
attiva. Essi pubblicano un opuscolo, “L’affare dell’Age d’or” (1931), che denuncia il caso e termina con le seguenti
domande: “Da quando in Francia non si ha il diritto di mettere seriamente in
questione la religione, i suoi fondamenti, i costumi dei suoi rappresentanti
ecc.? Da quando la polizia è al servizio dell’antisemitismo? Dal momento che
l’intervento della polizia era un’approvazione del pogrom della lega della
Gioventù patriottica, vuol essere un incoraggiamento all’instaurazione dei
metodi fascisti in Francia?... Il fatto che L’âge
d’or sia stato vietato costituisce un semplice abuso di potere, ancora una
volta, da parte della polizia, oppure è una prova dell’incompatibilità del
surrealismo con la società borghese? Come riconoscimento di questa
incompatibilità si deve considerare il fatto che, dopo che un gruppo di giovani
borghesi ha distrutto alcuni quadri surrealisti e rubato alcuni libri
surrealisti, dopo che i giornali borghesi hanno pubblicato una lettera
provocatoria firmata Le Provost de Launay e incitato alla repressione contro Le Surréalisme au Service de la Révolution
e al saccheggio della sede di questa rivista, la loro polizia abbia vietato un
film surrealista, così come vieta i film sovietici, così come la polizia di
Hitler ha vietato in Germania All’ovest
niente di nuovo?”[40].
A partire dalla primavera del 1931 si susseguono
quattro documenti, i primi due con titoli che si commentano da soli: “Non
visitate l’esposizione coloniale” (maggio) e “Primo bilancio dell’esposizione
coloniale” (3 luglio). “Al fuoco” inneggia alla ripresa delle lotte in Spagna:
“A partire dal 10 maggio 1931, a Madrid, Cordova, Siviglia, Bilbao, Alicante,
Malaga, Granada, Valenza, Algeciras, San Roque, La Linea, Cadice, Arcos de la
Frontera, Huelva, Badajoz, ]erez, Almeria, Murcia, Gijon, Teruel, Santander, La
Coruña, Santa Fé, ecc., la folla ha incendiato le chiese, i conventi, le università
religiose, distrutto le statue, i quadri che questi edifici contenevano,
devastato gli uffici dei giornali cattolici, cacciato tra le urla i preti, i
monaci, le suore, che passano in fretta le frontiere. Cinquecento edifici
distrutti per cominciare non chiuderanno questo bilancio di fuoco. Opponendo a
tutti i roghi una volta innalzati dal clero di Spagna la grande luce
materialista delle chiese bruciate, le masse sapranno trovare nei tesori di
queste chiese l’oro necessario per armarsi, lottare, e trasformare la
Rivoluzione borghese in Rivoluzione proletaria... Una chiesa, un prete che
possa officiare, sono altrettanti pericoli per l’avvenire della Rivoluzione.
Distruggere con tutti i mezzi la religione, cancellare persino le vestigia di
questi monumenti di tenebre in cui si sono prosternati gli uomini, annientare i
simboli che un pretesto artistico cercherebbe invano dl salvare dalla grande
collera popolare, disperdere il pretume e perseguitarlo nei suoi ultimi rifugi,
ecco quanto hanno intrapreso spontaneamente, nella loro comprensione diretta
dei compiti rivoluzionari le folle di Madrid, Siviglia, Alicante ecc. Tutto ciò
che non è violenza quando si tratta dello spauracchio di dio, dei parassiti
della preghiera, dei professori della rassegnazione, è assimilabile al
patteggiamento con l’innumerevole canaglia del cristianesimo che deve essere
sterminata... In Francia l’ampliarsi della lotta antireligiosa aiuterà la
Rivoluzione spagnola. Atei francesi, non tollerate che, in nome di un diritto
di asilo assolutamente fallace, la Francia, nonostante la separazione della
Chiesa dallo Stato proclamata nel 1905, consenta lo stabilirsi sul suo
territori di congregazioni che hanno lasciato la Spagna rivoluzionaria. È già
abbastanza che all’arrivo del re Alfonso si siano verificate le scandalose
manifestazioni di Parigi. Voi imporrete, con un’agitazione che saprà essere
degna dei magnifici fasci di scintille apparsi al di sopra dei Pirenei, il
rinvio dei religiosi verso la frontiera dove li aspetteranno molto presto i
tribunali di salute pubblica. Esigerete nello stesso tempo il rimpatrio insieme
con i loro confessori dei regali banditi che devono essere giudicati dai loro
sudditi di ieri, loro vittime di sempre. Farete delle vostre rivendicazioni di
solidarietà con gli operai e i contadini della Spagna in armi una tappa della
vostra lotta per la presa del potere in Francia da parte del proletariato che
solo saprà spazzare via dio dalla faccia della terra”[41].
Il 23 novembre 1931 compare su L’Humanité una lettera aperta all’ambasciatore della Cina a Parigi
per protestare contro la condanna a morte, dopo atroci torture, pronunciata dal
Kuomintang contro il sindacalista svizzero Ruegg e contro l’ergastolo inflitto
alla donna la cui unica “colpa” era di essere la moglie del condannato. Tra i firmatari, Aragon, Breton, René Clair, René Crevel, Eluard, André
Thirion.
Nel 1933, alle parole d’ordine genericamente
pacifiste dei comunisti francesi promotori del Congresso di Amsterdam-Pleyel
contro la guerra, i surrealisti oppongono una posizione classista. Dopo aver
ricordato quella di Lenin sul pacifismo piccolo-borghese, essi denunciano il
carattere equivoco dei promotori del congresso: “Lenin è sempre stato
avversario deciso, e non solamente durante la guerra, della parola d’ordine
‘pace’ lanciata in maniera astratta. Riteneva che una propaganda astratta della
pace ‘è capace solamente di seminare illusioni, di avere un’influenza
perniciosa sul proletariato, ispirandogli una fiducia umanitaria nei confronti
della borghesia e rendendolo zimbello della diplomazia segreta dei paesi
belligeranti’...”[42], “In risposta al
pacifismo ufficiale che trasforma gli angeli custodi della pace in ministri
della guerra, in risposta a quello che è il più vecchio degli slogan
capitalistici: Se volete la pace preparate la guerra, in risposta inoltre alla
falsa parola d’ordine di guerra alla guerra, noi diciamo: Se volete la pace
preparate la guerra civile”[43].
Il 16 febbraio 1933 esplode una caldaia alla Renault
di Billancourt, uccidendo nove operai e ferendone centocinquanta.
L’Associazione degli artisti e scrittori rivoluzionari (AEAR) pubblica una
dichiarazione collettiva contro “questo nuovo delitto dell’organizzazione messa
al servizio della guerra e del profitto capitalista”[44]. Tra i firmatari, Breton,
Crevel, Eluard e Péret.
Nel febbraio 1933 i nazisti danno fuoco al Reichstag
accusando del rogo i comunisti e dando così un pretesto a Hindenburg per
abrogare i diritti fondamentali sanciti dalla costituzione di Weimar. Il
decreto che mette fine alla repubblica prepara il terreno per la vittoria
(truccata) dei nazisti, che in marzo ottengono il 44 per cento dei seggi in
Parlamento. Per consolidarne il dominio Hindenburg firma un nuovo decreto che
autorizza Hitler a legiferare per quattro anni senza il controllo del
Reichstag.
L’AEAR e i surrealisti sono gli
unici gruppi di intellettuali che in Francia cercano di allertare l’opinione
pubblica. Nell’appello “Protestate!” essi avvertono che il risultato elettorale
in Germania è il prologo di un regresso della civiltà, della messa fuori legge
di ogni pensiero che non sia retrogrado, del ritorno al più cupo e feroce
antisemitismo da medioevo[45]. L’appello auspica un
fronte unico di lavoratori e intellettuali per lottare contro il terrore in
Germania e contro il Trattato di Versailles, le cui clausole inique hanno
favorito, se non provocato, l’ascesa del nazismo. In calce all’appello
ritroviamo i firmatari del testo precedente, ai quali si sono aggiunti Max
Ernst, Man Ray e Tanguy.
L’anno seguente, le giornate dal
6 al 10 febbraio 1934 segnano l’offensiva del fascismo francese. La reazione di
Breton e dei suoi amici è immediata: “È la sera stessa del 6 febbraio 1934,
cioè tre o quattro ore dopo il putsch fascista di cui alcuni di noi erano stati
a osservare il concreto sviluppo, chi sui grandi boulevards, chi nelle
vicinanze della pIace de la Madeleine, che, dietro mio suggerimento, si stabilì
di invitare a riunirsi subito il maggior numero possibile di intellettuali dl
tutte le tendenze decisi a far fronte alla situazione. Si trattava di fissare
immediatamente le misure di resistenza che potevano essere prospettate. Questa
riunione − che doveva durare tutta la notte − si concluse con la redazione di
un documento intitolato ‘Appello alla lotta’ che scongiurava le organizzazioni
sindacali e politiche della classe operaia a realizzare l’unità d’azione e si
pronunciava per lo sciopero generale. Questo appello veniva pubblicato il 10
febbraio, corredato di circa novanta firme”[46].
A causa del clima reazionario
instauratosi, e in seguito alle pressioni staliniste, Leone Trotskij, che era
arrivato in Francia nel 1933, dopo essere stato esiliato dalla Russia e aver
abbandonato la Turchia, è colpito da un mandato di espulsione. La risposta di
Breton è subitanea; mobilita un gran numero di intellettuali in Francia e all’estero
per protestare contro questo provvedimento e pubblica un volantino dal titolo
significativo “Il pianeta senza visti” (il titolo è anche quello dell’ultimo
capitolo dell’autobiografia di Trotskij) in cui sottolinea che la disposizione
è un ulteriore sintomo dell’involuzione reazionaria del regime: “L’espulsione
di Trotskij segna il punto di partenza di misure repressive contro gli
immigrati comunisti e prepara l’illegalità delle organizzazioni rivoluzionarie.
Già viene resuscitata la legge, che non fu mai applicata dopo il 1848, per
procedere contro i giornali rivoluzionari. Il singolare ‘governo di tregua’
imposto dal gesto di forza del 6 febbraio si afferma nemico risoluto della
classe operaia. Sul piano economico i decreti-legge provocano una recrudescenza
della disoccupazione, portano all’arresto o al licenziamento di centinaia di
militanti colpevoli di avere protestato contro la brutale riduzione dei loro
mezzi di sussistenza. Sul piano politico questo governo dà egualmente un’esatta
immagine di sé espellendo Trotskij, non senza organizzare intorno a lui la
provocazione; accetta così di rompere con le famose tradizioni ospitali del
nostro paese”[47].
La reazione non è meramente emotiva; come sempre Breton lega il caso singolo al
contesto storico: l’uno è il sintomo dell’involuzione dell’altro.
La piega che prendono gli avvenimenti
fa temere il peggio. Il 23 marzo 1935 i surrealisti firmano il manifesto del
Comitato di vigilanza degli intellettuali per mettere in guardia contro
qualsiasi ritorno all’unione sacra. L’unità d’azione delle masse reclamata dai
surrealisti viene strumentalizzata in funzione dell’unità degli organismi di
partito. Con preveggenza Breton e i suoi amici avevano già intuito a cosa
avrebbe condotto un tale governo. L’anno seguente la vittoria del Fronte
popolare in Francia darà il via al vergognoso tradimento della Repubblica
spagnola e preparerà gli animi alla capitolazione di Monaco.
Tre mesi più tardi, nel giugno del
1935, al Congresso internazionale per la difesa della cultura a Parigi, André
Breton, al quale viene negata la parola in seguito alle manovre delle
delegazioni sovietica e francese, chiarisce l’ambiguità politica del
riavvicinamento culturale franco-sovietico: “Se il riavvicinamento
franco-sovietico s’impone, è meno che mai il momento di rinunciare al nostro
senso critico: sta a noi controllare da vicino le modalità di questo riavvicinamento. Dato che la Francia borghese vi
è interessata, stiamoci attenti: in quanto intellettuali spetta a noi serbarci
più particolarmente diffidenti circa le forme che può assumere, nei confronti
dell’URSS, un riavvicinamento culturale”[48]. E Breton mette in
guardia “contro la piega che può prendere il riavvicinamento culturale
franco-sovietico dal momento che il governo borghese di questo paese ne fa del tutto esteriormente la propria causa, e
poiché abbiamo motivo di credere che esso si sforzerà di volgerlo contro di
noi. Vorrà usare il riavvicinamento per farci abbandonare le idee su cui
importava fino a questi ultimi giorni che i rivoluzionari si mostrassero
irriducibili. Si sforzerà, grazie al gioco degli scambi culturali, di attentare
al morale della classe operaia. Tutt’a un tratto, proprio mentre si stringe la
morsa di quelle contraddizioni che evidentemente non la risparmiano più degli
altri paesi capitalisti, tutt’a un tratto vediamo la Francia riabilitata, vediamo
il sig. Laval tornarsene con il suo piccolo certificato di credenziali
surrettizie. Ora la Francia potrà darsi le arie di sorella maggiore della
Repubblica sovietica, proprio così, delle arie protettive: non mancava altro
che questa maschera all’imperialismo francese per farsi ancora più insolente”.
Alle elucubrazioni patriottarde e
alla collusione delle classi difesa dall’Humanité
Breton oppone un’intransigente posizione di internazionalismo rivoluzionario: “Noi
surrealisti non amiamo la nostra patria. Nella nostra qualità di scrittori e
artisti abbiamo detto che non intendevamo in nessun modo respingere l’eredità
culturale dei secoli. È spiacevole che oggi si sia costretti a ricordare che si
tratta per noi di un’eredità universale che ci fa altrettanto tributari del
pensiero tedesco come di qualsiasi altro pensiero. Anzi, possiamo dire che
proprio nella filosofia di lingua tedesca abbiamo scoperto il solo antidoto
efficace contro il razionalismo positivista che continua a provocare qui i suoi
guasti. Questo antidoto non è altro che
il materialismo dialettico come teoria generale della conoscenza. Oggi come
ieri noi continuiamo a prendercela con il razionalismo positivista. Contro di
esso abbiamo intellettualmente combattuto e combatteremo ancora come contro il nemico nel nostro stesso paese. Restiamo
decisamente contrari a qualsiasi rivendicazione da parte di un francese del
solo patrimonio culturale della Francia, a qualsiasi esaltazione in Francia del
sentimento francese. Per parte nostra non intendiamo riflettere, nella
letteratura come nell’arte, il voltafaccia ideologico che si è manifestato
recentemente nel gruppo rivoluzionario di questo paese in seguito all’abbandono
della parola d’ordine: trasformazione della guerra imperialista in guerra civile”[49].
Nella conclusione Breton
chiarisce che, per i surrealisti, difendere la cultura “significa prima di
tutto prendere in mano gli interessi di quello che intellettualmente resiste a
un’analisi materialista seria, di quanto è vitale, di quanto seguiterà a dare i
suoi frutti. Non con dichiarazioni stereotipe contro il fascismo e la guerra
giungeremo a liberare per sempre lo spirito, come l’uomo, dalle antiche catene
che lo ostacolano e dalle nuove catene che lo minacciano. Ma con l’affermazione
della nostra incrollabile fedeltà alle capacità di emancipazione dello spirito
e dell’uomo, che di volta in volta abbiamo riconosciute e che lotteremo per far
riconoscere come tali. ‘Trasformare il mondo’ ha detto Marx; ‘cambiare la vita’
ha detto Rimbaud: per noi queste due parole d’ordine fanno un tutt’uno”[50].
Nel manifesto “Quando i
surrealisti avevano ragione” (1935), che segna la rottura definitiva tra il
gruppo surrealista e il Partito comunista, Breton e i suoi amici chiariscono
ancora una volta le ragioni della loro adesione a questo congresso e, tornando
sulla questione della difesa della cultura, affermano: “Il problema non può
essere quello della difesa e della conservazione della cultura. La cultura,
dicevamo, ci interessa solo nel suo divenire,
e questo divenire esige prima di tutto la trasformazione della società mediante
la rivoluzione proletaria”[51].
I surrealisti fanno notare come “il
Congresso internazionale per la difesa della cultura si è svolto sotto il segno
del soffocamento sistematico: soffocamento dei veri problemi culturali,
soffocamento delle voci non riconosciute come voci in capitolo... Dichiararsi
in disaccordo su questo o quel punto con la linea ufficiale del partito
significa non soltanto dare prova di un ridicolo purismo ma anche nuocere all’URSS,
voler strappare militanti al partito, offrire argomenti ai nemici del
proletariato, comportarsi ‘oggettivamente’ da controrivoluzionari... Andando
oltre gli insulti e i tentativi di intimidazione, continueremo noi stessi a
volerci intatti, e per questo, senza pretendere di guardarci in qualsiasi circostanza
dall’errore, a salvaguardare a tutti i costi la nostra indipendenza di
giudizio. Di questo diritto di cui fecero così largo uso i ‘rivoluzionari di
professione’ nella prima parte del XX secolo, conserviamo la rivendicazione
integrale per tutti gli intellettuali rivoluzionari con la riserva della loro partecipazione agli sforzi di coalizione che può
esigere la situazione presente, dominata dalla coscienza della minaccia
fascista... Sosteniamo che la libera affermazione di tutti i punti di
vista, che il confronto permanente di tutte le tendenze costituiscono il più
indispensabile fermento della lotta rivoluzionaria”[52].
Con lucidità estrema il manifesto
termina denunciando “il culto idolatra
con cui certi zelatori interessati si sforzano di legare le masse operaie non
soltanto all’URSS, ma anche alla persona del suo capo”, e la degenerazione dello
Stato sovietico: “Limitiamoci a registrare il processo di rapido regresso per
cui dopo la patria è la famiglia a uscire indenne dalla rivoluzione russa agonizzante
(che ne pensa Gide?). Laggiù non resta altro che restaurare la religione e −
perché no? − la proprietà privata perché sia finita con le più belle conquiste
del socialismo. A costo di provocare il furore dei loro turiferari, chiediamo
se vi sia bisogno di un altro bilancio per giudicare dalle loro opere un
regime, in particolare il regime attuale
della Russia sovietica e l’onnipossente capo sotto il quale quel regime sta
volgendo alla negazione radicale di ciò che dovrebbe essere e di ciò che è
stato. A quel regime, a quel capo, non possiamo che significare formalmente la
nostra sfiducia”[53].
In questo convegno dominato dagli
stalinisti le sole voci di dissenso furono quelle di Waldo Frank, André
Malraux, Boris Pasternak, Magdeleine Paz, Charles Plisnier e Gaetano Salvemini.
Si tentò perfino di impedire ai surrealisti di leggere la loro relazione,
prendendo a pretesto la risposta di Breton (uno schiaffo) a Ehrenburg, che nel
suo Visti da uno scrittore dell’URSS
aveva descritto i surrealisti come gente che “si rifiuta di lavorare: c’è chi è
occupato a divorare un’eredità, chi la dote della moglie... Il loro programma:
l’onanismo, la pederastia, il feticismo, e persino la sodomia”. Fu soltanto per
la mediazione di René Crevel e in seguito al suo suicidio che fu permesso a
Eluard di parlare, ma solo verso l’una del mattino e davanti a una sala quasi
vuota.
Nel settembre 1935 inizia il
breve periodo di collaborazione tra il gruppo de La Critique Sociale (diretta da Boris Souvarine, al quale si
uniscono Georges Bataille e i suoi amici) e quello del Surréalisme au Service de la Revolution. Da questa collaborazione
nascerà Contre-attaque, con Bataille
ispiratore. Il programma del gruppo sta già nel nome. Alla violenza reazionaria
è ora di rispondere con la violenza rivoluzionaria: “Violentemente ostili a
ogni tendenza, qualunque ne sia la forma, che s’impadronisca della rivoluzione
a vantaggio delle idee di nazione e di patria, ci rivolgiamo a tutti coloro
che, con ogni mezzo e senza riserve, siano pronti ad abbattere l’autorità
capitalista e quel prodotto della politica che sono le sue istituzioni... La
nostra causa è quella degli operai e dei contadini. Affermiamo come un
principio il fatto che gli operai e i contadini rappresentano non soltanto il
fondamento di ogni ricchezza materiale ma anche di ogni forza sociale. Quanto a
noi, intellettuali, andiamo accorgendoci che i lavoratori della terra e delle
fabbriche sono privati di qualsiasi possibilità di sviluppo umano da parte di
un’abbietta organizzazione sociale... Abbiamo potuto constatare che la reazione
nazionalista ha saputo utilizzare, in altri paesi, le armi politiche create dal
mondo operaio: intendiamo a nostra volta servirci delle armi create dal
fascismo”[54].
Per quanto riguarda la
prospettiva della vittoria del Fronte popolare alle elezioni dell’anno
seguente, i firmatari non si fanno illusioni: “Noi diciamo che attualmente il
programma del Fronte popolare, i cui dirigenti potranno probabilmente salire al
potere ma nel quadro delle istituzioni borghesi, è votato al fallimento. La
costituzione di un governo del popolo, di una direzione di salute pubblica,
presuppone un’inesorabile dittatura del
popolo armato”[55].
Viene prevista una serie di
fascicoli per approfondire questioni ideologiche e politiche. Tra i titoli
programmati figura l’ “Inchiesta sulle milizie, la presa del potere e i partiti”,
il cui contenuto viene riassunto in questi termini: “Un movimento entusiasta,
crescente, violento, di milizie del popolo, un movimento di ‘Volontari della
libertà’ − che sfugga al controllo sterilizzante dei partiti − questa è la
condizione fondamentale della presa del potere. Il potere apparterrà alla
rivoluzione quando le milizie armate offriranno a un gruppo di uomini usciti
dal Fronte popolare la base di un’autorità implacabile”[56].
Sono questi intellettuali, la cui
lucidità rivoluzionaria è pari solamente alla conferma che la storia porterà
alle loro previsioni, che i politici di professione e i burocrati della
rivoluzione accuseranno di mancanza di senso politico!
Nel 1936 la congiuntura internazionale
diventa esplosiva. Il 18 luglio in Spagna il generale fellone Franco si
ammutina e aggredisce la Repubblica: è il prologo della resa delle “democrazie”
occidentali alla peste bruna. In Francia la vittoria del Fronte popolare in
giugno non frena la corsa all’abisso. Lo stesso anno la Renania è rioccupata.
Quando l’eroica resistenza
spagnola viene tradita dal governo del Fronte popolare, sono ancora i
surrealisti ad avvertire che l’abbandono della Spagna repubblicana non può
essere che il preludio alla realizzazione del piano di egemonia mondiale dei
nazifascisti. Essi reclamano una decisa azione prima che sia troppo tardi: “Fronte
popolare! Organizza d’urgenza le masse! Costituisci, esercita, arma le milizie proletarie senza le quali non
sei che una facciata! È venuto il momento di mettere a profitto il vecchio
argomento dei tuoi avversari: l’affermazione concreta della forza è la prima
garanzia di sicurezza!”[57].
Nell’evocare questo periodo
Breton ricorderà la profonda risonanza che la guerra civile spagnola ebbe tra i
surrealisti, e l’immensa speranza che fece nascere tra loro. “Mai la lotta è
stata, in partenza, più circoscritta tra le forze dell’oscurantismo e dell’oppressione
da una parte e, dall’altra, tutto quello che poteva essere volontà di
liberazione, di emancipazione dell’uomo allo stato, per così dire, nativo. Nel
momento in cui lo stalinismo non aveva avuto ancora il tempo di allungare i
suoi artigli sul proletariato spagnolo e catalano, la situazione era meravigliosamente
chiara. Noi potevamo applaudire, senza riserve, indistintamente le vittorie
della F Al o del POUM, calcolare quotidianamente le loro possibilità di
compiere una rivoluzione che fosse la terza delle grandi rivoluzioni dei tempi
moderni e che fosse −chissà − la prima a non conoscere un Termidoro. È
abbastanza noto che cosa abbia potuto fare di tutte queste illusioni, di tutte
queste speranze l’intervento staliniano... L’iconografia mentale dei primi
giorni della rivoluzione spagnola conserva l’immagine di un Benjamin Péret che,
seduto dinanzi a una porta di Barcellona con il fucile in una mano, carezzava
un gatto sulle sue ginocchia”[58].
Il 3 settembre 1936 e il 26
gennaio 1937 André Breton prenderà posizione sui primi e sui secondi processi
di Mosca. Ne rimase così sconvolto che quindici anni dopo la sua indignazione
rimaneva intatta: “Non riesco a spiegarmi come oggi, anche con quel minimo di
coscienza che può sussistere, non ci si ribelli dinanzi alla sfida impudente
non dico a ogni sentimento di giustizia, ma addirittura al più elementare buon
senso, costituita dalla messa in scena di quei processi e dalle motivazioni
delle sentenze. Continuo a pensare che allora si è lasciata aprire la piaga più
spaventosa dei tempi moderni, fatalmente destinata ad aggravarsi. Si è
accettato una volta per sempre che la ‘ragione di Stato’ facesse strame dell’innocenza,
dell’onore e persino del diritto di certi uomini ai quali andava la gratitudine
di tutti. So bene che la guerra è passata, accentuando al massimo l’oblio. Non
per questo mi sorprendo e mi spavento meno osservando come, generalmente, si
sia passati sopra a questa mostruosa iniquità; come, agli occhi di tutti,
questa iniquità non discrediti e non insozzi chi l’ha commessa. Non ho niente
da ritirare alla protesta che ho elevato contro la sorte riservata ai vecchi
compagni di Lenin e le accuse prive di ogni attendibilità che preparavano da
lontano il colpo di piccone sul cranio di Trotskij”[59].
A un convegno di protesta contro
i primi processi di Mosca Breton legge una dichiarazione in cui afferma tra l’altro:
“Nella nostra qualità di intellettuali dichiariamo di considerare abominevoli e
inespiabili il verdetto di Mosca e la sua esecuzione. Neghiamo formalmente con
voi la giustizia dell’accusa che gli antecedenti degli accusati dispensano
persino dall’esaminare a dispetto delle pretese ‘confessioni’ della maggior
parte di loro. Consideriamo la messinscena del processo di Mosca come un’abbietta
operazione poliziesca che supera di gran lunga in ampiezza e portata quella che
si concluse con il cosiddetto processo degli ‘incendiari del Reichstag’. Pensiamo
che tali imprese disonorino un regime per sempre... Questo fatto ci illumina
definitivamente sulla personalità di Stalin: l’individuo che arriva fino a quel
punto è il grande negatore e il principale nemico della rivoluzione proletaria.
Dobbiamo lottare contro di lui con tutta la nostra forza, dobbiamo vedere in
lui il grande falsificatore dei nostri tempi − non solo si è dato a falsificare
il significato degli uomini ma anche quello della storia − e il più ingiustificabile
degli assassini... Salutiamo di nuovo la personalità, assolutamente al di sopra di ogni sospetto, di Leone Trotskij.
Reclamiamo per lui il diritto di vivere in Norvegia e in Francia. Salutiamo quest’uomo che è stato per noi,
indipendentemente dalle opinioni occasionali non infallibili che è stato portato a formulare, una guida
intellettuale e morale di prim’ordine, e la cui vita, dal momento che è
minacciata, ci è preziosa quanto la nostra”[60].
Si avrà un’idea di quanto
coraggiosa e isolata fosse la posizione di Breton e dei suoi amici quando
ricorderemo che, a questo convegno promosso dai dirigenti del Partito operaio
internazionalista, e cioè del partito trotskista, Breton poté esprimere il suo
pensiero solo per l’intervento di Victor Serge “che era appena sfuggito alle
prigioni russe e, trattenuto a Bruxelles, insisteva telegraficamente perché mi
fosse data la parola”[61].
Pochi mesi dopo, il 26 gennaio
1937, Breton torna a battersi per difendere l’onore rivoluzionario di Trotskij:
siamo giunti ai secondi processi di Mosca. Egli vede in questi procedimenti un
attacco mortale non solamente al socialismo in URSS, ma anche all’azione
rivoluzionaria in tutto il mondo, e in particolar modo alla rivoluzione
spagnola. Dopo aver dimostrato l’inanità delle accuse contro Trotskij, egli
mette sotto accusa tutta la politica staliniana degli anni Trenta. Con estrema
lucidità politica egli osserva: “Gli attuali processi sono, da una parte, il
prodotto delle contraddizioni che esistono tra il regime politico del
bonapartismo e l’esigenza di sviluppo di un paese come l’URSS che, nei
confronti di Stalin e della burocrazia e in contrasto con loro, resta uno Stato
operaio. D’altra parte questi processi sono la conseguenza immediata della lotta intrapresa in Spagna: si fa ogni
sforzo per impedire che una nuova ondata rivoluzionaria si riversi sul mondo;
il problema è di far fallire la rivoluzione spagnola così come si è fatta
fallire la rivoluzione tedesca e la rivoluzione cinese... Non lasciamoci
ingannare: le pallottole sulla scala di Mosca, nel gennaio del 1937, sono
dirette anche contro i nostri compagni del POUM... Dopo di loro si tenterà di
colpire i nostri compagni della CNT e della FAI, con la speranza di farla
finita con quanto c’è di vivo, con quanto comporta una promessa di divenire nella lotta antifascista
spagnola”[62].
Poco più di un anno dopo Breton
parte per il Messico per incontrare l’uomo il cui pensiero politico e il cui
rigore morale egli ha ammirato e difeso sin dal 1925, e cioè sin dall’inizio
del periodo “ragionante” del surrealismo.
Nel periodo tra le due guerre il
Messico esercita una grande attrazione per gli intellettuali francesi. Durante
i sette anni della presidenza di Lázaro Cárdenas (1934-1940) il Messico è un’isola
democratica in un mondo che va alla deriva. L’asilo politico che Cárdenas
concede a Trotskij è una piccola, ma importante, manifestazione della
liberalità e dell’indipendenza di un governo − l’unico che abbia resistito al
ricatto stalinista concedendo ospitalità a Trotskij − che ha avuto il coraggio
di attaccare le due cause principali del sottosviluppo messicano espropriando
le compagnie petrolifere straniere e varando la riforma agraria.
Il viaggio di Breton in Messico
si situa, cronologicamente, tra quello di Artaud, che vi si reca nel 1936, e
quello di Péret, che vi si rifugerà nel 1940. Artaud, che si era allontanato
dal surrealismo nove anni prima non condividendo l’impegno politico che il
movimento assumeva, dichiarerà: “Sono venuto in Messico alla ricerca di uomini
politici, non di artisti. Ed ecco perché: sinora sono stato un artista, e cioè
un uomo guidato. Non si può infatti mettere in dubbio che dal punto di vista
sociale gli artisti sono degli schiavi. Ebbene, io dico che è ora che questo
cambi... Sono venuto in Messico a cercare una nuova idea dell’uomo”[63].
André Breton a sua volta
scriverà: “Nel mondo rimane almeno un paese in cui il vento della liberazione
non è caduto... Il Messico arde di tutte le speranze che sono state suscitate
via via in altri paesi: in URSS, in Germania, in Cina, in Spagna”[64]. Non sorprende se per
Breton il viaggio in Messico realizzava una delle grandi aspirazioni della sua
vita[65].
La sua visita fu preannunciata da
alcune lettere dalla Francia. Una di queste ci illumina sul clima di caccia
alle streghe scatenata dagli stalinisti francesi: “L’organizzazione staliniana,
derivata dalla AEAR, che si denominava Associazione internazionale degli
scrittori per la difesa della cultura e il cui organo a Parigi era la rivista Commune, si era preoccupata di farmi
precedere da una circolare spedita per posta aerea ai principali scrittori e
artisti messicani. Ne conservo ancora un esemplare. Firmata da René Blech ‘per
il segretario internazionale’, vi si leggeva in particolare: «André Breton ha
sempre preso posizione contro il Fronte popolare e a questo scopo (sic) si è
alleato con gli elementi politici più torbidi. La sua azione contro la
Repubblica spagnola ha assunto le forme più perfide...». Uno dei destinatari mi
fece vedere la lettera sin dal mio arrivo”[66].
Di carattere ben diverso fu la
risposta di Pierre Naville a Jan van Heijenoort, segretario di Trotskij, che
gli chiedeva un’opinione su Breton. Naville scrisse che Breton era un uomo
coraggioso, non contaminato dallo stalinismo[67].
Per andare in Messico Breton, la
cui situazione economica fu precaria per quasi tutta la vita, fu costretto a
chiedere una cattedra d’insegnante all’estero[68]. Il poeta Alexis Saint-Léger,
più conosciuto con lo pseudonimo di Saint-John Perse, allora alto funzionario
del Ministero degli esteri, e il dottor Henry Laugier, che capeggiava la
ricerca scientifica in Francia, lo aiutarono a ottenere un incarico dai servizi
culturali dipendenti appunto dal Ministero degli esteri. Dietro impegno di
tenere un certo numero di conferenze sulla letteratura e sull’arte dal tempo
degli enciclopedisti ai nostri giorni, Breton e sua moglie, Jacqueline Lamba,
ottennero i biglietti per la nave che doveva portarli in Messico.
Breton pensava che, quale
compenso per le conferenze che avrebbe tenuto, si sarebbe provveduto ad
assicurargli non solamente le spese del viaggio, ma anche, naturalmente, quelle
del soggiorno. All’arrivo in Messico, nel febbraio 1938, i coniugi Breton,
trovarono ad attenderli il pittore Diego Rivera e un funzionario dell’Ambasciata
francese. Jacqueline Lamba ricorda che, dopo i convenevoli, Breton chiese a
questo funzionario dove sarebbero stati alloggiati. Questi non ne aveva la
minima idea. Al che Breton disse che, non avendo i mezzi per pagarsi un albergo
− aveva in tasca solamente pochi franchi − e avendo invece i biglietti per il
ritorno, avrebbe preso la stessa nave, la sera stessa, per rientrare in
Francia. Era profondamente angosciato, turbato e furente. Intervenne Diego
Rivera: “Ma non c’è nessun problema! Starete con noi, siete nostri ospiti, ovviamente.
Trotskij mi ha anche chiesto di trasmettervi il suo invito. Vi aspetta domani”.
L’invito rivolto seduta stante,
per un incontro quasi immediato, dimostra quanto Trotskij fosse interessato
alla visita di Breton, nonostante questa avvenisse in un periodo molto
difficile per lui. Aveva appena ricevuto la notizia della tragica morte del
figlio Leon Sedov − probabilmente assassinato da sicari stalinisti in una clinica
parigina il 16 febbraio 1937 − nonché quelle del processo a Bucharin apertosi a
Mosca.
Breton ricorda con quanta
apprensione iniziò le discussioni con Trotskij sull’argomento che più l’aveva impegnato
sin dalla nascita del surrealismo. “Per anni, in materia di creazione
artistica, io ho difeso per lo scrittore, per il pittore, il diritto di
disporre di se stesso, di agire non conformemente a delle parole d’ordine
politiche, ma in funzione delle determinazioni storiche specifiche che sono
solamente di competenza dell’artista. Mi sono sempre mostrato irriducibile su
questo punto... Questa perseveranza da parte mia non implica che io non sia
stato portato a disperare qualche volta dell’esito della partita, a pensare che
l’incomprensione, la cattiva volontà fossero le più forti. Non ci hanno forse
abbastanza ripetuto, ai miei amici e a me, che quest’atteggiamento che a tutta
forza volevamo mantenere era incompatibile col marxismo? Qualunque fosse la mia
convinzione contraria, non potevo nascondere che vi era qui un punto
nevralgico, una ragione d’inquietudine che avevo visto troppo largamente
condivisa perché non fossi ansioso di sottoporla al compagno Trotskij. Posso
dire di averlo trovato massimamente aperto alla mia preoccupazione. Oh! non si
creda che noi si sia riusciti subito a capirci: non è uomo da darla vinta così
facilmente. Conoscendo abbastanza bene i miei libri, ha insistito per prendere
conoscenza delle mie conferenze e ha offerto di discuterne con me. Qua e là
sopraggiungeva tra noi qualche scaramuccia: quando incontrava un nome come
quello di Sade o di Lautréamont c’era una battuta d’arresto. Nell’ignoranza in
cui si trovava al loro riguardo, mi faceva precisare il ruolo che avevano giocato
per me ponendosi dal solo punto di vista giusto, dal punto di vista comune al
rivoluzionario e all’artista che è quello della liberazione umana”[69].
Date le premesse, fu possibile “giungere
a un accordo circa le condizioni che, da un punto di vista rivoluzionario,
dovevano essere riservate all’arte e alla poesia, affinché queste
partecipassero alla lotta emancipatrice, pur rimanendo interamente libere nelle
loro ricerche. Questa intesa si espresse in un testo pubblicato con il titolo Per un’arte rivoluzionaria indipendente
e si concluse con la fondazione di una ‘Federazione internazionale dell’arte
rivoluzionaria indipendente’ (FIARI). Benché Trotskij abbia voluto, per ragioni
tattiche, che al suo nome si sostituisse quello di Diego Rivera, quest’ultimo non
ebbe alcuna parte nella sua redazione”[70].
Se le quattro dense e bellissime
pagine del testo (il cui titolo, Per
un’arte rivoluzionaria indipendente[71], riassume già il
contenuto) sono talmente importanti, è perché esse rappresentano il punto d’incontro,
mai prima d’allora raggiunto, tra un rivoluzionario e un poeta, entrambi di
statura intellettuale non comune. In queste quattro pagine ritroviamo l’essenziale
delle idee difese da entrambi, ritroviamo le ragioni stesse della loro lotta.
Ma quello che è ancora più emozionante è il vedere come lo scontro dialettico
delle opinioni dell’uno e dell’altro abbia potuto dar vita a un testo dove
entrambi potessero riconoscersi, pur nella diversità delle rispettive
formulazioni originali, che ora troviamo arricchite dal comune apporto.
Rileggiamone il secondo
paragrafo: “In ciò che di individuale conserva nella sua genesi, nelle qualità
soggettive che mette in opera per dedurre un certo fatto che implica un
arricchimento oggettivo, una scoperta filosofica, sociologica, scientifica o
artistica appare come il frutto di un caso prezioso, cioè come una
manifestazione più o meno spontanea della necessità.
Non è possibile trascurare un simile apporto sia dal punto di vista della
conoscenza in generale (che tende a far sì che si sviluppi l’interpretazione
del mondo) sia dal punto di vista rivoluzionario (che, per arrivare alla
trasformazione del mondo, esige che ci si faccia un’idea esatta delle leggi che
ne governano il movimento); più particolarmente, non è possibile disinteressarsi
delle condizioni mentali in cui questo apporto continua a prodursi e, allo
scopo, non vigilare affinché sia garantito il rispetto delle leggi specifiche
cui è legata la creazione intellettuale”[72].
Ritroviamo in questo paragrafo l’idea
espressa da Breton sei anni prima quando scriveva: “Ogni errore nell’interpretazione
dell’uomo implica un errore nell’interpretazione dell’universo e costituisce
quindi un ostacolo alla sua trasformazione”[73]. Nel 1935, Breton aveva
affermato: “L’attività d’interpretazione del mondo deve continuare a essere
legata all’attività di trasformazione del mondo. Sosteniamo che compete al
poeta, all’artista, approfondire il problema umano sotto tutte le sue forme,
che è proprio la condotta illimitata del suo spirito ad avere in questo senso
una capacità potenziale di mutamento del mondo, e che una tale condotta − in
quanto prodotto evoluto della sovrastruttura − non può che andare a rafforzare
la necessità del mutamento economico di questi mondo”[74].
Di conseguenza la cultura deve
essere completamente autonoma dalla politica, “il bisogno di emancipazione
dello spirito non ha che da seguire il suo corso naturale per essere portato a
fondersi e a ritemprarsi in questa necessità primordiale: il bisogno di
emancipazione dell’uomo. Dunque l’arte non può, senza decadere, accettare di
piegarsi ad alcuna direttiva estranea e di riempire docilmente i quadri che
taluni credono di poterle assegnare, con fini pragmatici estremamente limitati.
Val meglio fidarsi del dono della prefigurazione che è l’appannaggio di ogni
artista autentico, che implica un inizio di superamento (virtuale) delle
contraddizioni più gravi della nostra epoca e orienta il pensiero dei contemporanei
verso l’urgenza dell’instaurazione di un nuovo ordine... L’idea che il giovane
Marx si era fatto del ruolo dello scrittore esige ai nostri giorni un richiamo
vigoroso. È chiaro che questa idea deve essere estesa, sul piano artistico e
linguistico, alle diverse categorie di produttori e di ricercatori. Lo
scrittore, egli dice, deve naturalmente guadagnare dei soldi per poter vivere e
per poter scrivere, ma non deve in nessun caso vivere e scrivere per guadagnare
dei soldi. Lo scrittore non considera affatto i suoi lavori come un mezzo. Essi sono dei fini in sé, sono così poco un mezzo per
lui e per gli altri che, al caso, egli sacrifica alla loro esistenza la sua
esistenza... La prima condizione della
libertà di stampa consiste nel non essere un mestiere. È più che mai
opportuno valersi di questa dichiarazione contro coloro che pretendono di
assoggettare l’attività intellettuale a fini estranei all’attività stessa e, in
dispregio a tutte le determinazioni storiche che le sono proprie, di
controllare in funzione di pretese ragioni di Stato i temi dell’arte. La libera
scelta di questi temi e l’assoluta non-restrizione per quanto riguarda il campo
della sua esplorazione costituiscono per l’artista un bene che egli è in
diritto di rivendicare come inalienabile. In materia di creazione artistica
importa essenzialmente che l’immaginazione sfugga a qualsiasi costrizione, non
si lasci imporre una falsariga sotto alcun pretesto. A coloro che ci
spingessero, oggi o domani, ad acconsentire che l’arte sia sottoposta a una
disciplina che consideriamo radicalmente incompatibile con i suoi mezzi, opponiamo
un rifiuto senza appello e la nostra volontà deliberata di far valere la
formula: ogni licenza in arte”[75].
Per concludere l’esame delle idee
chiave di questo manifesto ricordiamo che anche l’affermazione più politica in
esso contenuta (“riteniamo che compito supremo dell’arte nella nostra epoca sia
di partecipare coscientemente e attivamente alla preparazione della rivoluzione”[76]) è un leitmotiv nell’opera
di Breton; ad esempio nel 1935 scriverà: “L’arte autentica di oggi è legata all’attività
sociale rivoluzionaria; la prima, al pari della seconda, tende alla confusione
e alla distruzione della società capitalista”[77].
Appena rientrato in Francia,
Breton si lancia anima e corpo nell’attività per concretizzare i progetti
elaborati in Messico. Prima tra tutti, la creazione della FIARI, cioè la
Federazione internazionale dell’arte rivoluzionaria indipendente. Il manifesto
elaborato a Coyoacan viene subito stampato; a fine agosto è stato mandato alla
maggior parte degli intellettuali di sinistra. In seguito Breton mette in piedi
il Comitato francese della FIARI, i cui componenti sono Yves Allegret, André
Breton, Michel Collinet, Jean Giono, Maurice Heine, Pierre Mabille, Marcel
Martinet, André Masson, Henry Poulaille, Gérard Rosenthal, Maurice Wullens, e
cioè artisti, poeti, scrittori, filosofi, politici delle più svariate tendenze
aventi in comune una posizione rivoluzionaria non stalinista. La redazione e l’amministrazione
di Clé, l’organo della FIARI, è
presso Maurice Nadeau, mentre il gerente è Léo Malet. Il primo numero esce il I
gennaio 1939, ma per il precipitare della situazione politica non si andrà
oltre il secondo del febbraio successivo.
Nel disegno di Breton Clé avrebbe permesso di “stabilire una
discriminazione tra coloro che si associano alla posizione del manifesto del
Messico e coloro che, a scopi il più delle volte opportunistici, evitano d’impegnarsi
in questa direzione... Se l’attività della FIARI non esercita subito una
maggiore attrazione, bisogna imputarlo all’aggravarsi della situazione internazionale
a partire da Monaco. Nel comitato nazionale dell’organizzazione che formiamo,
benché siano riuniti i rappresentanti di varie tendenze rivoluzionarie non
staliniane, è ben lungi dal potersi realizzare l’unità organica indispensabile,
di modo che Clé si ferma al secondo
numero. Un tale insuccesso, in quel momento, si confonde con molti altri. Tutto
si svolge come se l’attività intellettuale nelle direzioni più diverse segnasse
un tempo d’arresto, come se lo spirito fosse già consapevole che nulla era più
in grado di far arretrare il flagello”[78].
Il volantino che annuncia la
pubblicazione del mensile ne precisa gli scopi e il programma riprendendo le
idee principali del manifesto elaborato a Coyoacan. “Qualsiasi tendenza
progressista in campo artistico viene condannata dal fascismo come una
degenerazione. Qualsiasi libera creazione viene dichiarata fascista dagli
stalinisti. Troppo numerosi sono gli intellettuali che, o per comodità
spirituale, o per docile faziosità, considerano e rappresentano la rivoluzione
sociale o come terminata o come irrealizzabile. E giunto il momento di
protestare contro il disconoscimento delle realtà che ci stanno intorno e del
determinismo che le regola. La rivoluzione sta scritta negli avvenimenti del
secolo. Essa avrà luogo a dispetto dei falsari e dei disfattisti che, appena
ieri, le giuravano fedeltà. Ma è necessario, proprio nella misura in cui essa è
ineluttabile, illustrarla, capirla e porre fine alle confusioni ideologiche
esistenti. In forza della cultura che rappresentano e dei movimenti affettivi a
cui obbedisce la loro vocazione, gli scrittori e gli artisti sono chiamati in
qualsiasi periodo prerivoluzionario a ricoprire un ruolo specifico che non
spetta a nessun altro rappresentare; infatti, la rivoluzione che vogliamo noi,
quella cioè destinata a ‘cambiare la vita’, destinata a ‘trasformare il mondo’,
ha diritto a un concorso che non sia improvvisato ma, al contrario, lungamente
meditato prima. Aggiungendosi alle opere del presente, le opere del passato
devono contribuire, con il loro potere emotivo, a elevare il tono
rivoluzionario indispensabile all’azione creatrice. A questa precisa funzione
intende dedicarsi la FIARI. Questa funzione rappresenta la ragion d’essere e d’agire
della FIARI. In questo senso Clé, il
bollettino della FIARI − al pari delle altre sue attività − servirà anche le
cause intimamente legate all’arte, alla rivoluzione, all’uomo. Contro tutte le
forze di repressione e di corruzione, siano esse fasciste, staliniste o
religiose, noi vogliamo: l’indipendenza
dell’arte − per la rivoluzione / la rivoluzione − per la liberazione definitiva dell’arte”[79].
L’editoriale del primo numero,
dal titolo significativo “Niente patria”, è un appello alla solidarietà con gli
immigrati stranieri fuggiti ai regimi totalitari e che la Francia si appresta a
riconsegnare ai loro boia: “Le ignobili campagne fatte sia sulla parola d’ordine
‘Francia destati’, sia su quella ‘la Francia ai francesi’ cominciano a dare i
loro frutti avvelenati. I decreti di maggio di Sarraut, certe disposizioni
incluse nei decreti-legge di novembre fanno entrare in vigore a spese degli
stranieri residenti in Francia, e specialmente degli emigrati politici, una
procedura scellerata, ispirata a quella dei paesi fascisti. Le misure di
repressione già prese e i preparativi d’internamento a cui assistiamo mostrano
che si va affermando una politica del terrore e del gesto di forza che tende
alla costituzione in Francia di un regime ‘autoritario’ e fra non molto
totalitario... Testimoniano del rapido contagio da cui sono presi i paesi ‘democratici’
trascinati, a dispetto delle considerazioni umane più elementari, a rinnegare
il principio d’asilo, per tanto tempo considerato sacro da loro... L’arte al pari dei lavoratori non ha patria.
Preconizzare oggi, come fanno non solo i fascisti, ma anche gli stalinisti, il
ritorno all’arte ‘francese’ significa opporsi alla conservazione di questo
stretto rapporto necessario all’arte, significa adoperarsi per la divisione e l’incomprensione
tra i popoli, significa fare opera premeditata di regressione storica. I nostri
compagni artisti stranieri sono oggi minacciati nella stessa misura dei nostri
compagni operai stranieri... Denunciamo nei decreti legge che prendono di mira
gli stranieri − indesiderabili per la borghesia reazionaria − il tentativo di
degradare in questo paese la persona umana creando una prima categoria di
uomini senza diritti e dignità legali, condannati a persecuzioni continue per
il solo fatto che, avendo opposto resistenza all’oppressione o sfuggito le
dittature disumane, non hanno più una ‘patria’ legale”[80].
Questo primo numero comprende
testi di André Breton, Jean Giono, Georges Henein, Maurice Heine, Ignazio
Silone ecc., e annuncia l’adesione alla FIARI di numerosi intellettuali tra i
quali Roger Blin, J.B. Erunius, Claude Cahun, Nicolas Calas, Michel Carrouges,
Michel Collinet, Marcel Duhamel, Roger Gilbert-Lecomte, Maurice Henry, Marcel
Jean, Simone Kahn (poi Simone Collinet), Pierre Mabille, Henri Pastoureau, Benjamin
Péret, Marceau Pivert, Charles Ratton, Yves Tanguy, André Thirion ecc. Le due
pagine centrali riportano alcune reazioni al manifesto di Coyoacán, sia quelle
negative di Roger Martin du Gard, Gaston Bachelard (motivata dall’isolamento
totale in cui lavorava), Paul Rivet, Michel Leiris, Robert Ganzo, Jean Painlevé,
sia quelle positive di Herbert Read, Victor Serge, André Marchand, Jef Last,
Francis Vian, Gaston Modot ecc. È doveroso ricordare i nomi di quei pochi
intellettuali che, in clima di terrorismo poliziesco, ebbero il coraggio di
dare la loro adesione a quest’iniziativa.
Nel secondo e ultimo numero di Clé, tra gli altri contributi, venne
pubblicata una lettera del 22 dicembre 1938 di Trotskij a Breton. Maurice
Nadeau, presso il quale aveva sede la redazione e l’amministrazione di Clé, ne commenta così la fine: “Non era
più il momento dell’arte, soprattutto dell’arte indipendente. Inoltre le
discussioni interne al gruppo surrealista (esclusione di Georges Hugnet a causa
della sua amicizia con Eluard che aveva rotto con il gruppo per riaccostarsi ai
comunisti) passarono disgraziatamente nella FIARI. Ci furono poi i ‘proletari’
come Marcel Martinet e Henry Poulaille, i quali scoprirono che i surrealisti
esercitavano un’influenza eccessiva sull’organizzazione invece di
controbilanciarla con un apporto equivalente, e restarono chiusi nelle loro
posizioni”[81].
Ormai siamo arrivati alla vigilia
della seconda guerra mondiale. Il 27 settembre 1938 il gruppo surrealista
pubblica una dichiarazione: “Né la vostra guerra né la vostra pace!”, dove sono
previsti non solo l’approssimarsi della guerra, ma anche la gigantesca
mistificazione tendente a far passare questo secondo conflitto imperialista per
una lotta tra democrazia e totalitarismo: “La guerra che si annuncia con un
moltiplicarsi e ripetersi di misure di sicurezza, la guerra che minaccia di
sorgere dall’inestricabile conflitto degli interessi capitalisti da cui è
travagliata l’Europa, non sarà la guerra della democrazia, non sarà la guerra
della giustizia, non sarà la guerra della libertà. Gli Stati che, per le
esigenze del momento e per quelle storiche, pretendono di servirsi di queste
nozioni come di documenti personali, hanno guadagnato la loro ricchezza e
consolidato il loro potere mediante sistemi tirannici, arbitrari e criminosi.
Le prove più recenti dell’infamia di questi Stati sono ancora vive nella
memoria collettiva. Hanno lasciato che l’Italia annientasse l’Etiopia perché
qualsiasi resistenza vittoriosa opposta all’invasore bianco avrebbe incoraggiato i popoli delle colonie a liberarsi
dalla morsa imperialista. Hanno rifiutato alla Spagna del luglio 1936 le armi
che aveva il diritto di chiedere loro e che le avrebbero permesso di
sconfiggere rapidamente il fascismo perché la vittoria dei lavoratori spagnoli
non doveva aprire al proletariato mondiale nuove prospettive rivoluzionarie.
Stanno consegnando la Cina all’imperialismo giapponese. Se le potenze
pseudodemocratiche si mettono oggi in movimento, lo fanno per difendere uno
Stato che hanno creato a loro immagine, uno Stato fondamentalmente capitalista,
centralizzato, poliziesco e statico. Tradita da ogni parte, dimentica della sua
funzione eversiva, la classe operaia si prepara a partecipare al salvataggio
del bottino di Versailles. In risposta a questo atteggiamento suicida,
dichiariamo che il solo problema che interessi l’avvenire sociale dell’uomo e
che è fatto espressamente per stimolare la sua lucidità e la sua energia
creatrice è quello della liquidazione di un regime capitalista che non riesce a
sopravvivere a se stesso, a superare i propri paradossi e i propri fallimenti
se non con le scandalose complicità della Seconda e della Terza Internazionale.
Sia con i colpevoli che con i loro complici, con i giustificatori della guerra
come con i falsificatori della pace, nessun compromesso è possibile. Alla folle
Europa dei regimi totalitari noi non contrapponiamo la vecchia Europa del
Trattato di Versailles, anche se corretto. A queste due Europe contrapponiamo,
in pace come in guerra, le forze destinate a ricreare l’Europa da cima a fondo
mediante la rivoluzione proletaria”[82].
È sintomatico che l’ultima presa
di posizione dei surrealisti, poco prima dello scoppio della guerra, nel luglio
del ‘39, sia una protesta contro l’arresto di tre militanti rivoluzionari, nel
quale i surrealisti vedono l’annuncio della soppressione di tutte le libertà. “Stiamo
bene attenti! L’incarcerazione di questi tre nostri compagni è solo un piccolo
saggio. Se riesce, è la fine anche delle poche libertà che ancora ci restano...
Invitiamo tutti coloro che non sono stati ancora colpiti da questo ignobile
contagio sciovinistico, tutti coloro che osano pensare liberamente, a unirsi a
noi per protestare contro gli scellerati decreti-legge che autorizzano lo stato
maggiore a far pesare fin da ora la sua dittatura facendo passare per un ‘attentato
alla difesa nazionale’, anzi per una operazione spionistica, l’azione di uomini
coraggiosi, dell’onestà e della lucidità dei quali rispondiamo noi. C’è di mezzo non la loro libertà, ma la
libertà di tutti”[83].
Durante il secondo conflitto
mondiale l’attività politica dei surrealisti continuerà in Francia, nell’Europa
occupata e negli Stati Uniti. Nel 1939 Breton, Char, Frederic Delanglade, Péret
e gli altri surrealisti ancora in Francia (Yves Tanguy e Nicolas Calas erano
partiti prima del 3 settembre) sono mobilitati.
Péret, scoperto dopo aver
costituito una cellula trotskista nell’esercito, è incarcerato nel 1940 a Rennes.
Dopo che il 16 giugno Pétain chiede l’armistizio, riesce a uscire dalla prigione
militare, il 22 luglio, pagando un riscatto di mille franchi ai nazisti.
Raggiunge Marsiglia da dove si imbarcherà per il Messico nel 1941. Qui, nella
prefazione per la sua Antologia dei miti,
leggende e racconti popolari d’America, egli narra le vicende della sua
prigionia[84].
Nel corso dell’inverno 1940-41 si
ritrovano a Marsiglia, alla Villa Air Bel allestita dal Comitato di soccorso
americano, i surrealisti francesi Breton, Char, Delanglade, Sylvain Itkine,
Masson e Péret, raggiunti da Bellmer, Brauner, Dominguez, Ernst, Hérold, Lam e
Victor Serge. Presto Breton, Ernst, Lam e Masson riescono a partire per gli
Stati Uniti. Char, Eluard e Itkine si uniscono alla Resistenza e quest’ultimo,
catturato a Parigi dalla Gestapo, morirà sotto atroci torture nel 1944.
A New York Breton continua l’attività
politica dai microfoni della radio della Francia libera. Pierre Naville mi ha
riferito che ricorda di aver sentito una trasmissione verso la fine del 1944
nel corso della quale, parlando col suo tono inimitabile del collaborazionista
LavaI, Breton diceva: “Laval recevra
douze pruneaux et c’est la première chose qu’il n’aura pas volé” (gioco di
parole: Laval riceverà dodici prugne − cioè pallottole − ed è la prima cosa che
non avrà rubato − cioè che si merita).
In Francia si forma nel settembre
1941 il gruppo “La Main à Plume”, animato a Parigi da Noël Arnaud, Jean-François
Chabrun, Paul Chancel e Christian Dotremont, in zona Nord da André Stil, in
zona Sud da Pierre Minne. Vi parteciperanno, con motivazioni diverse,
surrealisti dell’ultima ora, giovani simpatizzanti, militanti trotskisti e
comunisti, poeti e pittori: Adolphe Acker (trotskista, firma Adolphe Champ
oppure Paul Chancel i suoi contributi alle pubblicazioni del gruppo), Maurice
Blanchard (poeta), Christine Boumeester (pittrice), Victor Brauner (pittore),
Achille Chavé (poeta belga, già combattente nelle Brigate internazionali in
Spagna), Gérard de Sède (poeta, trotskista), Jean-Claude Diamant-Berger (partigiano),
Oscar Dominguez (pittore), Jean Ferry (cineasta e saggista), Aline Gagnaire (pittrice),
Emile Guikovaty (trotskista), Jacques Hérold (pittore), Georges Hugnet (scrittore,
espulso per indegnità morale nel 1943), Edouard Jaguer (poeta e saggista), J.V.
Manuel (Manuel Viola, poeta e pittore, trotskista), Marco Menegoz (poeta e
partigiano), Georges Mouton, Jean-Pierre Mulotte (partigiano), Henri Pastoureau
(poeta), Marc Patin (poeta), Régine Raufast, Robert Rius (poeta), Boris Rybak (poeta
e scienziato), Hans Schoenhoff (resistente), Gérard Schneider (pittore), Jean
Simonpoli (partigiano), Tita (Edita Hirschowa, pittrice), Raoul Ubac (pittore),
Gérard Vulliamy (pittore).
Molti tra questi cadranno durante
la guerra: Diamant-Berger (ucciso 1’8 1uglio 1944), Menegoz (fucilato a sedici
anni), Mulotte (fucilato a quindici anni), Patin (morto di stenti nel 1943),
Rius e Simonpoli (fucilati), Schoenhoff e Tita (morti in deportazione).
Tra l’agosto 1940 e il maggio
1944 il gruppo[85]
darà alle stampe più di trenta pubblicazioni e qualche volantino. Per sfuggire
alla censura nazista dei periodici ogni numero della rivista avrà un nome
diverso, pur uscendo sempre con la sigla fittizia delle “Editions de La Main à
Plume”. Nel 1941: La main à plume (agosto), Géographie nocturne (settembre) e Transfusion du verbe (dicembre); La conquête du monde par l’image (aprile
1942), Décentralisation surrealiste
(giugno 1943), Le surréalisme encore et
toujours (agosto 1943), Informations
surréalistes (maggio 1944). L’ultimo fascicolo previsto, Objet, non supera lo stadio delle bozze
di stampa.
Nella prima serie di Les Pages Libérées (1942-44) vengono
pubblicati testi di Noël Arnaud, Maurice Blanchard, André Breton (Pleine marge), J.F. Chabrun, Christian
Dotremont, Paul Eluard (Poésie et vérité),
Laurence Iché, Léo Malet, J.V. Manuel, Benjamin Péret (Les malheurs d’un dollar), Pablo Picasso, Robert Rius e Gérard de
Sède.
Il gruppo si disintegra in
seguito alle divergenze: i surrealisti fedeli al pensiero di Breton, per la
maggior parte trotskisti (Dalmas de Polignac, de Sède, Guikovaty, Hérold,
Daniel Nat, Rybak), e i militanti comunisti, quasi tutti stalinisti (Charles
Bocquet, Chabrun, Menegoz, Rius, Simonpoli e Stil). La rottura si definisce nel
corso di una riunione in casa di Jacques Hérold la sera del 18 maggio 1944[86].
Le prime quattro dichiarazioni
collettive del gruppo sono volantini pubblicati per stigmatizzare l’attività
letteraria collaborazionista di Jean Follain (13 marzo 1943), Léon-Paul Fargue
(28 marzo 1943), Paul Eluard (la lettera, in data 14 luglio 1943, inizia con “Vecchia
canaglia”, e lo qualifica “vegliardo imbecille” e “inqualificabile farabutto”)
e Georges Hugnet[87].
Quest’ultimo, già espulso dal gruppo surrealista nel 1939 per “disonestà
intellettuale”, ora li diffamava. Sappiamo dal volantino “Fait divers” (1943)[88] che Noël Arnaud il 6
ottobre prese a schiaffi questo “bottegaio”. Un’altra sonora correzione
infliggeranno al recidivo Hugnet, il 28 novembre 1962, Vincent Bounoure, Jéhan
Mayoux e Jean Schuster: l’individuo aveva prudentemente aspettato la morte di
Benjamin Péret per diffamarlo e insultarlo sul settimanale Arts[89].
Sempre nel 1943 un “papillon”
della serie Cartes à jouer du Quatre
vingt et un recita: “Se non siete PRETE, GENERALE, o STUPIDO, sarete
SURREALISTI!”[90].
Nel 1944 un testo riaffermava l’impegno
politico del movimento: “La Rivoluzione surrealista, per continuare a vivere,
deve alimentarsi alla fonte della Rivoluzione mondiale”[91]. A Londra Jacques Brunius
e E.L.T. Mesens, coraggiosamente, in piena guerra, pubblicano il lucido “Idolatria
e confusione” (1944)[92]; in epigrafe la frase del
dottor Johnson: “Il patriottismo è l’ultimo rifugio dei mascalzoni”, e quella
di Lautreamont: “Tutta l’acqua del mare non basterebbe a lavare una macchia di
sangue intellettuale”.
Brunius e Mesens denunciano il
servilismo e l’ignoranza di certi critici inglesi che ignorano gli scritti più
impegnati pubblicati dopo la disfatta francese, per glorificare invece la
pseudoletteratura patriottarda dei “poeti” cosiddetti “engagés” quali “Aragon
stalinista” con “le sue volgari poesie burlesche”[93]. Essi puntualizzano:
“Dal 1940 sono comparsi in
francese solo pochi testi di una qualche importanza. Tra questi in primo luogo:
“1. Lettre aux Anglais, di Georges Bernanos (Atlantica Editore, Rio de Janeiro).
“2. L’intervista di André Breton
a View al suo arrivo negli Stati
Uniti (n. 7-8, ottobre 1941).
“3. ‘Prolegomènes à un troisième manifeste du surréalisme ou non’, di André
Breton (VVV, n. 1, New York 1942).
“4. ‘Situation du surréalisme entre les deux guerres’, di André Breton
(VVV, n. 2-3, New York, 1943).
“5. La part du diable, di Denis
de Rougemont (Brentano’s, New York)...
“Nessuno di questi libri e
articoli ha fatto il benché minimo rumore in Inghilterra, neppure la Lettre aux Anglais, che per il suo
titolo meritava maggiore attenzione. Perché questo libro non è stato tradotto e
pubblicato in Gran Bretagna?...
“E di che cosa invece ci hanno
parlato gli eminenti critici inglesi? Delle volgari poesie scritte dallo
spirito di Jean Aicard che si firma Aragon; del Silence de la mer, un tipo di storia che i quotidiani francesi
pubblicavano già prima della guerra, e a proposito del quale c’è stata tanta
commozione solo per nasconderne la vuotezza desolante...
“Perché tutta questa agitazione
per generi di dubbio valore e il silenzio su quello che è realmente importante?
Senza dubbio è perché Bernanos, Breton e de Rougemont non glorificano i vari
conformismi alla moda in tempo di guerra e perché ridestano lo spirito critico”[94].
Breton torna a Parigi nella
primavera del 1946. Il suo primo intervento pubblico − un discorso, il 7
giugno, in difesa di Antonin Artaud al Teatro Sarah Bernhardt − gli dà l’occasione
di chiarire il carattere irrisorio di “ogni forma di engagement che stia al di
qua di questo triplice e indivisibile obiettivo: trasformare il mondo, cambiare
la vita, rifare da cima a fondo l’intelletto”[95].
L’anno seguente tira altre
stoccate contro l’engagement di molti intellettuali, per la maggior parte
stalinisti, spesso gli stessi che durante l’occupazione nazista, e prima che il
conflitto coinvolgesse l’URSS, incitavano a fraternizzare con il soldato
tedesco e a collaborare con il regime di Pétain: “L’ignobile parola impegno
[engagement], che è diventata alla moda durante la guerra, trasuda un
servilismo che fa orrore alla poesia e all’arte”[96].
Lo stesso anno ricorda il
concetto base del surrealismo: per trasformare il mondo bisogna prima
conoscerlo. E come possono trasformarlo coloro che tradiscono la verità e la
bellezza? Breton scrive: “Che aberrazione, che impudenza c’è nel volere ‘trasformare’
un mondo quando si fa così poco caso della necessità di interpretarlo in ciò
che ha di più permanente!”[97].
Nell’aprile 1947 viene anche
pubblicata la prima dichiarazione collettiva del gruppo surrealista
ricostituito. Tra i firmatari ritroviamo, oltre ai surrealisti “storici” Breton
e Péret, quelli attivi nel periodo tra le due guerre: Joë Bousquet, J.B.
Brunius, Arthur Harfaux, Maurice Henry, Marcel Jean, Pierre Mabille, Jehan
Mayoux, Maurice Nadeau, Henri Parisot, Yves Tanguy; alcuni tra i componenti de “La
Main à Plume”: Adolphe Acker, Jean Ferry e Henry Pastoureau; quelli del gruppo “La
Révolution la Nuit”: Yves Bonnefoy, Eliane Catoni, Jaroslav Serpan; e nuovi
venuti: Francis Bouvet, Jean Brun, Guy Gillequin, Jacques Halpern, Francis
Meunier, Henri e No Seigle.
Non hanno ancora aderito al
gruppo i giovani che firmeranno “per il movimento surrealista” l’ultima
dichiarazione[98],
con Breton, prima della sua morte: Philippe Audoin, Vincent Bounoure, Gérard
Legrand, José Pierre e Jean Schuster, e neppure quelli che saranno altrettanto
impegnati nell’attività collettiva: Jean-Louis Bédouin (a partire dall’autunno
1947), Jean Benoît (1959), Robert Benayoun e Ado Kyrou (1951), Claude Courtot
(1964), Radovan Ivsic (1956), Alain Joubert (1955), Annie Le Brun (1963), Joyce
Mansour (1953), Mimi Parent (1959), Jean-Claude Silbermann (1955), Toyen (che
dalla Cecoslovacchia, dove era stata tra i fondatori del gruppo surrealista nel
1934, arriva a Parigi, con Heisler, nel 1947) e Michel Zimbacca (1949).
La prima dichiarazione collettiva
del gruppo va situata nel clima politico dell’immediato dopoguerra, quando,
conniventi i comunisti al governo, si abiuravano gli ideali della Resistenza.
Le forze del colonialismo francese avevano represso con furore selvaggio le
istanze nazionaliste in Algeria (45.000 massacrati in seguito alla repressione
di una manifestazione dei braccianti del Setif), e in Madagascar (85.000 morti
tra il 1947 e il ‘48). Ora si trattava di condannare il tentativo di ridurre
nuovamente a colonia la Repubblica Democratica del Vietnam, la cui indipendenza
era stata proclamata da Ho Chi-minh il 29 agosto 1945. Con vigore e lucidità il
gruppo riconferma le proprie opzioni rivoluzionarie e internazionaliste:
“C’è la guerra in Indocina, una
guerra imperialista intrapresa in nome di un popolo che a sua volta è stato
appena liberato da cinque anni di oppressione, contro un altro popolo unanime
nel volere la libertà. Questa aggressione assume un grave significato. Da una
parte prova che niente è mutato: come nel 1919 il capitalismo, dopo aver
sfruttato tanto il patriottismo quanto le più nobili parole d’ordine di
libertà, intende ricuperare interamente il suo potere, restaurare la potenza
della sua borghesia finanziaria, del suo esercito e del suo clero e continua la
sua tradizionale politica imperialistica. D’ altra parte, prova che gli eletti
della classe operaia, malgrado la tradizione anticolonialista, che è stata uno
dei più fermi vettori del movimento operaio, con violazione flagrante del
diritto dei popoli all’autodecisione infinite volte proclamato, gli uni per
corruzione, gli altri per sottomissione cieca a una strategia imposta dall’alto
e le cui esigenze, sin d’ora illimitate, tendono a nascondere o a capovolgere i
veri moventi della lotta, accettano di assumere la responsabilità dell’oppressione
o di rendersene complici, nonostante una certa ambivalenza di atteggiamenti.
“Agli uomini che conservano un
rudimento di lucidità e di senso dell’onestà noi diciamo: è falso che si possa
difendere la libertà qui imponendo la
servitù altrove. È falso che si possa
condurre, in nome del popolo francese, una lotta tanto odiosa senza doverne
subire le drammatiche conseguenze. La strage organizzata scaltramente da un
monaco ammiraglio non tende che a difendere l’oppressione feroce dei capitalisti,
dei burocrati e dei preti...
“I surrealisti per i quali la
rivendicazione prima è stata e resta la liberazione dell’uomo, non possono
tacere dinanzi a un crimine tanto stupido quanto rivoltante. Il surrealismo ha
senso solo contro un regime dove tutti i membri solidali non hanno saputo trovare come dono di felice avvento che
questa ignominia sanguinosa; un regime che a mala pena non sprofonda nel fango
del compromesso e delle concessioni e che non è che un calcolato preludio per l’
edificazione di un prossimo totalitarismo.
“In occasione di questo nuovo
crimine, il surrealismo dichiara di non aver rinunciato a nessuna delle sue
rivendicazioni e meno che mai alla volontà di una trasformazione radicale della
società. Ma esso sa quanto siano illusori gli appelli alla coscienza, all’intelligenza
e persino agli interessi degli uomini, quanto siano facili su questo piano la
menzogna e l’errore e quanto le divisioni siano inevitabili: per questo il
campo che si è prescelto è al tempo stesso il più ampio e il più profondo,
commisurato a una vera fraternità umana. Esso è dunque qualificato per elevare
la sua protesta veemente contro l’aggressione imperialista e per rivolgere il
suo saluto fraterno a coloro che in questo stesso momento incarnano il divenire
della libertà”[99].
Questa dichiarazione e le due
seguenti (“Rottura inaugurale” e “A cuccia, i piagnoni di dio!”) esplicitano − e
il discorso è diretto in particolare alle nuove leve − le direttive
fondamentali che hanno caratterizzato la riflessione poetica e ideologica nel
periodo tra le due guerre, e cioè: internazionalismo, antistalinismo e
anticlericalismo.
“Rottura inaugurale” (giugno
1947) ribadisce l’autonomia del pensiero surrealista dai partiti, in primo
luogo da quello comunista, e persino dal trotskista, e conclude:
“È nella misura in cui chiede
alla rivoluzione di inglobare la totalità dell’uomo, di non concepirne la
liberazione da un angolo visuale particolare bensì sotto tutti gli aspetti
contemporaneamente che il surrealismo si dichiara il solo qualificato a gettare
sulla bilancia le forze di cui si è fatto l’indagatore e poi il conduttore meravigliosamente magnetico
− dalla donna-bambina allo humour nero, dal caso oggettivo alla volontà del
mito. Queste forze hanno come luogo di elezione l’amore incondizionato,
sconvolgente e folle che solo permette all’uomo di vivere in tutta la sua
ampiezza, di evolvere secondo dimensioni psicologiche nuove.
“Una volta indagate, una volta
messe in condizioni di unirsi e di esaltarsi reciprocamente, queste forze hanno
qualche possibilità di conciliare infine una finalità umana e la casualità
universale. Si iscrivono in margine, partecipano dei progressi delle discipline
più avanzate del nostro tempo cui dobbiamo una geometria non-euclidea, una
fisica non-maxwelliana, una biologia non-pasteuriana, una meccanica
non-newtoniana − discipline a loro volta solidali con una logica
non-aristotelica e in quella morale non-mosaica all’elaborazione della quale
facciamo appello imperiosamente per sventare l’invivibile.
“Non da ieri risuonano nelle
profondità dell’uomo la rivendicazione di Rimbaud nei confronti della vita, la
parola d’ordine di Marx nei confronti del mondo. Ma da quando l’esperienza
ragionevole e razionale della coscienza ha avuto il sopravvento sull’esperienza
appassionata dell’inconscio, cioè da quando l’ultimo dei miti si è
cristallizzato in una mistificazione deliberata, sembra perduto il segreto che
permetteva di conoscere e di agire − di agire senza alienare la conquista della
conoscenza. È ora di promuovere un mito nuovo capace di trascinare l’uomo verso
la tappa ulteriore della sua destinazione finale.
“Questa impresa è l’impresa
specifica del surrealismo. È il suo grande appuntamento con la Storia.
Il sogno e la rivoluzione sono
fatti per conciliarsi, non per escludersi. Sognare la Rivoluzione non significa
rinunciarvi, ma farla doppiamente e senza riserve mentali. Sventare l’invivibile
non significa fuggire la vita, ma precipitarvisi totalmente e senza ritorno.
“IL SURREALISMO È QUELLO CHE SARÀ”[100].
“A cuccia, i piagnoni di dio!”
(giugno 1948) denuncia i vari tentativi di strumentalizzare, a profitto del
cristianesimo, il pensiero di Rimbaud, di Lautréamont e persino di Sade. Vi si
osserva che “i cristiani d’oggi dispongono di argomenti presi in immondezzai
teologici abbastanza eterocliti da far fronte alle circostanze più diverse. In
queste condizioni, non essendovi la benché minima costanza nel linguaggio da
essi impiegato, a causa della loro fondamentale duplicità, ogni discussione è
impossibile. Del resto lo è sempre stata. E così, anche se l’idea di dio,
considerata in quanto tale, non riuscirebbe che a strapparci degli sbadigli di
noia, poiché le circostanze in cui questa idea interviene sono tali da
suscitare la nostra collera, gli esegeti non siano sorpresi di vederci
ricorrere ancora alle ‘grossolanità’ dell’anticlericalismo
elementare dove il Merde à dieu
iscritto sugli edifici del culto a Charleville resta l’esempio tipico. Il fatto
che i politici tra loro rinuncino all’anatema non basta perché noi rinunciamo a
quelle che chiamano bestemmie, apostrofi evidentemente prive ai nostri occhi di
ogni obiettivo sul piano divino, ma che continuano a esprimere la nostra
irriducibile avversione verso qualunque essere inginocchiato”[101].
Il colpo di forza perpetrato a
Praga il 26 febbraio 1948 dall’imperialismo moscovita ispira pagine amare a
Breton in cui tuttavia permane la fiducia nella capacità eversiva dell’uomo: “Niente
può far sì che la libertà, scoperta umana che è preesistita a Marx e che gli è
sopravvissuta, non mantenga teso, nell’angolo più buio del quadro, l’arco che
il mito vuole sia stato messo nelle nostre mani da Prometeo o da Lucifero.
Tutte le tirannie del passato e che verranno non intaccheranno questo fatto”[102].
Nel giugno 1950 giunge a Parigi
la notizia che Záviš Kalandra è stato condannato a morte dal tribunale di Praga
nel corso di un processo che ricalca fedelmente la prassi staliniana. Il
filosofo e storico Kalandra era un vecchio militante rivoluzionario; membro del
Partito comunista nel 1935, era stato tra gli organizzatori delle giornate
surrealiste a Praga. Dal 1939 Kalandra, arrestato dai nazisti, aveva passato
sei anni nei campi di concentramento di Ravensbruck e Sachsenhausen. Nel 1948
Breton aveva già scritto una lettera aperta a Paul Eluard[103] per chiedergli d’intervenire
e salvare l’uomo del quale erano stati amici e ospiti nel 1935. Gli ricordava
la posizione comune circa i processi di Mosca, e la nobile figura di Kalandra.
Invano, Eluard risponderà cinicamente: “Ho troppo da fare con gli innocenti che
gridano la loro innocenza per occuparmi dei colpevoli che gridano la loro
colpa”[104].
I surrealisti allertano l’opinione
pubblica e ottengono la firma di alcuni intellettuali abbastanza coraggiosi da
resistere al clima conformista, per reclamare, invano, al presidente della
Repubblica cecoslovacca la rinuncia all’esecuzione di Kalandra e dei suoi
coimputati (per la maggior parte resistenti ex surrealisti, denunciati da
Tristan Tzara secondo fonti attendibili). Tra i firmatari del telegramma, oltre
naturalmente ai surrealisti, vanno ricordati Georges Altman, Marcel Arland,
Dominique Aury, Simone de Beauvoir, Albert Béguin, Albert Camus, Jean Cayrol,
J.-M. Domenach, Georges Duhamel, Julien Gracq, Jean Grenier, Jean Hélion,
Michel Leiris, Maurice Merleau-Ponty, Pierre Monatte, Jules Monnerot, Jacques
Monod, Jean Paulhan, Magdeleine Paz, André Pieyre de Mandiargues, Jean-Paul
Sartre, Seigle, Roger Stéphane, Jules Supervielle, Charles Vildrac[105].
Nel 1951 la dichiarazione “Alta
frequenza” conferma l’apertura del movimento all’esoterismo, alle nuove
prospettive del dopoguerra, e rinnova l’esaltazione della libertà che si
esprime anche con il rifiuto dell’idea di un dio onnipotente:
“Né scuola, né cappella, il
surrealismo, molto più che un atteggiamento, è un’avventura nel significato più
aggressivo e più totale della parola. Avventura dell’uomo e del reale lanciati
l’uno dall’altro nello stesso movimento. Piaccia o no agli spiriti della
critica, seduti attorno a un tavolo, con le luci spente, per evocare la sua
ombra, il surrealismo continua a definirsi in relazione alla vita di cui ha
sempre esaltato le forze combattendone l’alienazione secolare.
“Il surrealismo non deve rassomigliare
alla lettera di quello che fu un tempo. Meno ancora alla caricatura che ne
propongono i suoi avversari...
“A chi si vuol far credere che la
degenerazione delle formazioni politiche tradizionali basta a rendere platonica
la nostra passione di libertà? I recenti avvenimenti di Spagna provano una
volta di più che l’assenza di parole d’ordine partigiane non impedisce al genio
rivoluzionario di scuotere ogni servitù, cominciando dall’assoggettamento
provvisorio della rivendicazione umana a un’ideologia regressiva, che regna
dispoticamente sulle moltitudini.
“Di fronte a questo flagello, più
che mai sosteniamo che le diverse manifestazioni di rivolta non debbono essere
isolate le une dalle altre, né sottoposte a un’arbitraria gerarchia, ma che
costituiscono le facce di un solo prisma. Per il fatto di permettere a questi
fuochi di colore diverso ma egualmente intensi di riconoscere in lui il
focolare comune, il surrealismo, con migliore cognizione di causa che per il
passato, si consacra al superamento dei principali conflitti che separano l’uomo
dalla libertà, cioè dallo sviluppo armonioso dell’umanità nel suo insieme e
nelle sue innumerevoli manifestazioni − dell’umanità infine giunta a un senso
meno precario del suo destino, guarita da ogni idea di trascendenza, liberata
da ogni sfruttamento.
“Per noi, non c’è bisogno di
dirlo, la religione giudaico-cristiana resta nel significato proprio del
termine la nemica ‘accanita’ dell’uomo, riesca o no a incorporarsi in ideologie
totalitarie. Con i suoi complici ‘lavoro-famiglia-patria’ dovrà tuttavia
chiudere la sua fabbrica di storpi e di cadaveri. Per farla finita con questa
religione, facciamo sistematicamente appello alle forze che tenta di soffocare nella
psiche umana.
“È a queste forze che si allea,
nella sua eterna disponibilità, la gioventù avida di tutto ciò che lotta contro
un utilitarismo ogni giorno più cieco. Sono queste forze che si uniscono e si
esaltano nell’amore, annunciando un’età dell’oro in cui l’oro non avrebbe età,
in cui il fiore dell’età, per vivere, farebbe ameno dell’oro. Sono sempre
queste forze che fanno della poesia il principio e la fonte di ogni conoscenza,
in opposizione permanente alla stoltezza (metafisica, politica ecc.) e alle sue
manifestazioni giornalistiche, radiofoniche, cinematografiche ecc.
“La volontà del surrealismo di
restituire all’uomo i poteri di cui è stato spogliato non ha potuto non indurlo
a indagare tutti gli aspetti della conoscenza intuitiva; in particolare quelli
abbracciati dalle dottrine esoteriche, il cui interesse è di svelare nello
spazio e nel tempo certi circuiti ininterrotti. Perciò prova ancor più
ripugnanza per tutto ciò che può apparentare certi sistemi ‘occulti’ a un
insieme di ricette di inginocchiamento e riafferma in proposito la sua
irriducibile ostilità verso qualsiasi fideismo”[106].
Con la “Dichiarazione preliminare”
(12 ottobre 1951) iniziava, sotto forma di “Billets surréalistes”, la
collaborazione regolare a Le Libertaire,
settimanale della Federazione anarchica:
“Surrealisti, noi non abbiamo mai
cessato di riservare alla trinità Stato-lavoro-religione un’esecrazione che ci
ha spesso condotti a incontrarci con i compagni della Fédération anarchiste’.
Questo accostamento ci conduce oggi a esprimerci sul Libertaire. Ce ne rallegriamo tanto più in quanto questa
collaborazione ci consentirà, pensiamo, di definire alcune delle grandi linee
di forza comuni a tutti gli spiriti rivoluzionari.
“Noi stimiamo che una grande
revisione delle dottrine si imponga con urgenza. Questa sarà possibile solo se
i rivoluzionari esamineranno assieme tutti i problemi del socialismo allo scopo
non di trovarvi una conferma delle proprie idee, bensì di farne sorgere una
teoria in grado di dare un impulso nuovo e possente alla Rivoluzione sociale.
La liberazione dell’uomo non potrebbe, se non vuole condannarsi a contraddirsi
subito, ridursi al solo piano economico e politico, ma deve estendersi anche al
piano etico (risanamento definitivo dei rapporti degli uomini fra loro). Essa è
legata alla presa di coscienza da parte delle masse delle loro possibilità
rivoluzionarie e a nessun costo può condurre a una società in cui tutti gli
uomini, sull’esempio della Russia, siano uguali nella schiavitù.
“Intransigenti come siamo col
sistema d’oppressione capitalistico, si esprima esso nella forma ipocrita della
‘democrazia’ borghese e odiosamente colonialistica o assuma l’aspetto di un
regime totalitario nazista o staliniano, non possiamo non affermare ancora una
volta la nostra ostilità di fondo nei confronti dei due blocchi. Come ogni
guerra imperialistica, quella che essi preparano per risolvere i loro conflitti
e annientare le volontà rivoluzionarie non è la nostra guerra. Da essa può
risultare solo un aggravarsi della miseria, dell’ignoranza e della repressione.
Solo dall’azione autonoma dei lavoratori noi ci attendiamo l’opposizione che
potrà impedirla e condurre alla sovversione, nel senso di rifacimento assoluto,
del mondo attuale.
“Questa sovversione, il
surrealismo è stato e rimane il solo a intraprenderla sul terreno sensibile che
gli è proprio. Il suo sviluppo, la sua penetrazione negli spiriti hanno messo
in evidenza l’insuccesso di tutte le forme di espressione tradizionali e hanno
dimostrato che esse erano inadeguate alla manifestazione di una rivolta
cosciente dell’artista contro le condizioni materiali e morali imposte all’uomo.
La lotta per la sostituzione delle strutture sociali e l’attività profusa dal
surrealismo per trasformare le strutture mentali, lungi dall’escludersi, sono
complementari. La loro unione dovrà affrettare l’avvento di un’éra libera da
ogni gerarchia e da ogni costrizione”[107].
In verità Le Libertaire aveva già iniziato a ospitare testi surrealisti sin
dal 22 maggio 1947, quando venne pubblicata la prima dichiarazione collettiva
del dopoguerra, “Libertà è una parola vietnamita”. Tra il 17 giugno e il 20
novembre 1952 uscirono altri trentuno testi, tra i quali due discorsi di
Breton: quello pronunciato alla Mutualité
(21 ottobre 1949), dove, dopo aver ribadito la profonda affinità tra
surrealismo e anarchia, viene commentato il programma del movimento “Cittadino
del mondo” lanciato da Gary Davis; e quello a Wagram (6 marzo 1952) in difesa
dei sindacalisti condannati a morte da Franco.
A questo proposito Breton fu
costretto a scrivere una “Precisazione” (16 maggio 1952):
“Vari giornali (Combat, Paris-Presse ecc.) hanno riprodotto la scorsa settimana il testo di
un telegramma diretto al papa e così concepito: «Sollecitiamo supremo
intervento presso capo Stato spagnolo per impedire esecuzione dei sindacalisti
di Barcellona condannati a morte». La prego di consentirmi di dire ai nostri
amici del Libertaire che, benché il
mio nome compaia fra i firmatari del telegramma, io non ho mai firmato tale
testo e ne disapprovo formalmente l’iniziativa, che parte dagli uffici del Franc-Tireur.
“Trattandosi di salvare cinque
sindacalisti spagnoli, mi sarei astenuto dal protestare pubblicamente se, come
mi fu assicurato telefonicamente il giorno dopo, i promotori dell’iniziativa
avessero creduto di poter usare, senza chiedere l’autorizzazione, i nomi di tutti coloro che, alla manifestazione di
Wagram, avevano preso la difesa dei condannati. Essendo stati omessi, fra
questi, i nomi di Georges Altman, di Jean-Paul Sartre e di Ignazio Silone,
mentre si facevano precedere gli altri da quello di un prete che non si era
manifestato sino allora (e, a quanto pare, non aveva trovato appoggio presso il
suo superiore gerarchico!), stimo che si sia abusato del mio.
“È ovvio che io non avrei mai
pensato né acconsentito a indirizzare una supplica al papa, personaggio a cui
personalmente nego ogni autorità spirituale e che, in tutta la mia vita, non ho
mai visto impegnato a usare i poteri che detiene per compiere il minimo atto di
giustizia o di ‘carità’.
“L’esecuzione avvenuta venerdì
scorso, dei nostri cinque compagni di Barcellona, dimostra ancora una volta che
l’appello in questione era del tutto ridicolo e sottolinea, per coloro che
ancora avessero dubbi in proposito, la criminale collusione fra il Vaticano e
Franco”[108].
Tra gli interventi pubblicati da Le Libertaire ricordiamo l’importante
testo teorico di Péret, “La révolution et les syndicats” (in sei puntate nel 1952:
26 giugno, 10 e 24 luglio, 7 e 21 agosto, 4 settembre); la dichiarazione
collettiva “Una protesta giustificata” (29 marzo 1951)[109] per denunciare il
tentativo di riabilitare in extremis la Chiesa spagnola.
Si è detto che furono trentuno i
testi pubblicati in Le Libertaire; a
questi si aggiunge un uguale numero di “Billets surrealistes”[110] di Jean-Louis Bédouin,
André Breton, Adrien Dax, Guy Doumayrou, Georges Goldfayn, Adonis Kyrou, Gérard
Legrand, Benjamin Péret, José Pierre, Bernard Roger, Jean Schuster, Jacqueline
Sénard-Duprey e François Valorbe.
Nell’impossibilità di riprendere
anche solo i più notevoli, mi limito a citare i passi principali da “La claire
tour” di Breton:
“Nello specchio nero dell’anarchia
il surrealismo si è riconosciuto per la prima volta, prima ancora di definirsi
a se stesso e quando ancora non era che una libera associazione fra individui
che rifiutavano spontaneamente e in blocco le costrizioni sociali e morali del
loro tempo...
“Perché in tale momento non poté
aver luogo una fusione organica fra elementi anarchici propriamente detti ed
elementi surrealisti? Venticinque anni dopo sono ancora qui a chiedermelo. Non
c’è dubbio sul fatto che l’idea di efficacia, che doveva essere lo specchietto
per allodole di tutta quest’epoca, ha deciso altrimenti. Quello che poté essere
considerato il trionfo della rivoluzione russa e l’avvento di uno Stato operaio
comportò un grande mutamento nelle prospettive.
“La sola ombra sul quadro − ombra
che si sarebbe poi precisata macchia indelebile − era l’annientamento dell’insurrezione
di Kronstadt, il 18 marzo 1921. I surrealisti non riuscirono mai a dimenticare
del tutto. Non è però meno vero che, attorno al 1925, solo la Terza
Internazionale sembrava in possesso dei mezzi per trasformare il mondo. Si
poteva credere che i segni di degenerazione e di regresso già facilmente
percepibili nell’Est fossero ancora scongiurabili. I surrealisti vissero allora
nella convinzione che la rivoluzione sociale estesa a tutti i paesi non potesse
mancare di promuovere un mondo libertario (alcuni dicono un mondo surrealista,
ma è la stessa cosa). Tutti, in principio, dettero lo stesso giudizio, compresi
quelli (Aragon, Eluard ecc.) che, in seguito, sono scaduti dal loro primo
ideale al fine di farsi una carriera invidiabile (agli occhi degli uomini d’affari)
nello stalinismo...
“Sappiamo bene quale impietoso
saccheggio è stato fatto di queste illusioni, durante il secondo quarto di
questo secolo. Per una spaventosa ironia, al mondo libertario che molti
sognavano si è sostituito un mondo in cui è di rigore l’obbedienza più servile.
Un mondo in cui all’uomo sono negati i diritti più elementari e dove l’intera
vita sociale ruota attorno al poliziotto e al carnefice. Quando un ideale umano
arriva a questo colmo di corruzione, il solo rimedio è quello di ritemprarsi
nella grande corrente sensibile dove esso ha avuto origine, di risalire ai
principi che gli hanno permesso di costituirsi. E al termine stesso di questo
movimento, oggi più necessario che mai, che si incontrerà l’anarchismo ed esso
solo − non più la caricatura che ce ne viene presentata o lo spauracchio in cui
esso è stato trasformato…”[111].
In Arcane 17[112], uno scritto redatto
durante gli anni dell’ultimo conflitto mondiale, Breton per la prima volta
esprime dubbi sulla via proposta dai marxisti-leninisti per giungere alla
liberazione dell’uomo. Egli è scosso dalla sterile esperienza di quindici anni
di lotta accanto alla sinistra, sia pure non stalinista, ma comunque marxista.
Questi anni gli hanno fatto constatare quanto i militanti, non solo di questa
sinistra, siano sordi alle rivendicazioni che non siano sociali. L’unico uomo
politico che aveva capito il carattere insopprimibile delle rivendicazioni dell’uomo
come individuo, e non come un’entità astratta indissolubilmente legata alla
massa, era stato assassinato quattro anni prima. Breton torna allora al suo
primo amore, torna alla grande corrente del pensiero libertario, alle fonti, al
socialismo utopico di Fourier[113].
Rievoca l’emozione che provò, a
diciassette anni, all’apparire delle bandiere nere in una dimostrazione
popolare: “Ritroverò sempre per la bandiera rossa, vergine da ogni simbolo o
insegna, lo sguardo che ho potuto avere a diciassette anni, quando, durante una
manifestazione popolare, alla vigilia dell’altra guerra, le ho viste spiegarsi
a migliaia nel cielo basso di Pré Saint-Gervais. E tuttavia − sento che, a dir
la verità, non vi posso far niente − continuerò a fremere più ancora all’evocazione
del momento in cui, in tratti poco numerosi e ben circoscritti, questo mare
fiammeggiante era rotto dallo spiegamento di bandiere nere”[114].
Poi il suo ricordo va ancora più
lontano, alla sua infanzia: “Non dimenticherò mai la distensione, l’esaltazione
e la fierezza che mi causò, una delle prime volte che da ragazzo mi condussero
in un cimitero − fra tanti monumenti funerari deprimenti o ridicoli − la
scoperta di una semplice tavola di granito scolpita a lettere maiuscole rosse,
con la superba massima: NÉ DIO NÉ PADRONE. La poesia e l’arte conserveranno
sempre un’inclinazione per tutto ciò che trasfigura l’uomo in questa ingiunzione
disperata, irriducibile che, di quando in quando, l’uomo assume il rischio
derisorio di imporre alla vita. E che al di sopra dell’arte, della poesia, lo
si voglia o no, batte una bandiera volta a volta rossa e nera”[115].
Una mostra d’arte americana al
Musée National d’Art Moderne di Parigi, dove una sala intera era riservata a
Siqueiros, provoca la protesta “All’assassino!” (23 maggio 1952), scritta da Péret
e firmata congiuntamente dal movimento surrealista, dalla Federazione
anarchica, dall’Unione operaia internazionale, dal Gruppo di lotta
rivoluzionaria (Spagna) e dal Partito comunista internazionalista (trotskista):
“David Alfaro Siqueiros è uno stalinista militante da lunga data. Lo vediamo
partecipare alla guerra di Spagna nella brigata di Lister ‘di sinistra memoria’
(Victor Serge). Tornato in Messico dopo la sconfitta spagnola, la notte del 24
maggio 1940 dirige un assalto contro la residenza di Leone Trotskij... Arrestato
il 4 ottobre seguente dal generale Sánchez Salazar, Siqueiros fu rimesso in
libertà provvisoria su cauzione nell’aprile del 1941 e fuggì in aereo il 5
maggio, grazie alla complicità di Pablo Neruda, allora console generale del
Cile in Messico; quest’ultimo fu sospettato anche di aver permesso agli stalinisti
di travestirsi da poliziotti nel suo domicilio... Rientrato in Messico nel 1947,
dopo un soggiorno di sei anni in Cile, Siqueiros dichiarò al giornale messicano
Excelsior, il 23 maggio 1947: «Non ho
mai negato e non negherò mai la responsabilità che mi compete in questo affare
(l’assalto del 24 maggio 1940 e l’assassinio di Robert Sheldon Harte), pur
affermando che ho agito da franco tiratore. Devo rilevare che considero la mia
partecipazione uno degli onori più grandi della mia vita». A quest’epoca il
dossier del suo affare era già stato trafugato dagli stalinisti. David Alfaro
Siqueiros non può essere che un sicario della polizia (NKVD). Egli è stato
recentemente vari mesi dietro la cortina di ferro. La sua presenza in un’esposizione
e il posto che gli è concesso si spiegano unicamente con gli interessi politici
degli organizzatori. La sua partecipazione a quest’esposizione, peraltro
mirabile, costituisce una provocazione che è importante denunciare. Essa è
inammissibile sotto ogni punto di vista e ci costringe a elevare la più
vibrante protesta”[116].
Stalin muore il 5 maggio 1953,
nel coro unanime di lodi sperticate che si eleva da sinistra (il rapporto
Kruscev filtrerà in Occidente solo tre anni dopo); una delle rare note dissonanti
è quella di Breton. L’inchiesta promossa dal supplemento letterario di un
quotidiano parigino sul tema “Quale volto Stalin assumerà nella storia” (14
marzo 1953) provoca questa risposta: “Che cosa aggiungere di più che già non
sia noto a tutti? Le mani lorde del sangue dei suoi compagni di lotta migliori,
il segreto di un mezzo infallibile per strappar loro a un tempo l’onore e la
vita, l’insigne attentato contro il Verbo, che è consistito nel pervertire
sistematicamente le parole portatrici di ideali, la doppiezza e il terrore
eretti a sistema di governo: io non vedo che cosa, neppure con l’aiuto dell’oblio,
unito all’inclinazione duratura delle masse per i destini individuali
spettacolari, potrà controbilanciare tutto questo”[117].
Il 1956 è un anno denso di
avvenimenti drammatici. In Francia, alle elezioni legislative di gennaio, l’estrema
destra poujadista conquista 52 seggi superando i comunisti (50 seggi). In
febbraio Kruscev legge al XX Congresso del PCUS il “rapporto segreto” destinato
a scuotere dalle fondamenta l’impero sovietico. Il 23 ottobre i servizi segreti
francesi, fedeli ai metodi banditeschi di tali organismi, dirottano l’aereo che
riportava in Algeria Ben Bella e alcuni esponenti del Fronte di liberazione
algerino e arrestano tutto il gruppo. Lo stesso giorno scoppia la sollevazione
popolare in Ungheria. Ernö Geroe chiede l’intervento sovietico e viene
sostituito a furor di popolo da Imre Nagy. Il 4 novembre Budapest è occupata
dai russi, mentre il 5 le truppe franco-britanniche prendono Porto Said. La
voce surrealista si fa sentire puntualmente per chiarire la reale portata di
questi avvenimenti.
Le elezioni politiche in Francia
del gennaio 1956 danno la vittoria alle sinistre ma portano anche all’Assemblea
nazionale 52 deputati poujadisti. Pierre Poujade, che aveva fondato il 23
luglio 1953 l’Unione di difesa dei commercianti e artigiani, è di fatto un
burattino dell’estrema destra e ne fa proprie le istanze più reazionarie. Cade
così il governo del radicale Faure, che aveva messo termine alla positiva
esperienza di Pierre Mendès-France, durata solo setti mesi e diciassette
giorni. Il socialista Guy Mollet diventa il primo capo di sinistra di un
governo della Quarta Repubblica. Governerà per sedici mesi, adottando però la
politica di centro destra del suo predecessore, così che la crisi del maggio
1958 segna la fine della Quarta Repubblica e il ritorno del generale de Gaulle.
Questi verrà investito dal presidente René Coty il 29 maggio 1958 capo del
governo, e il 28 settembre nasce la Quinta Repubblica, presidente de Gaulle.
Attenti alla situazione politica
non soltanto internazionale, i surrealisti, il giorno dopo il successo dei
poujadisti, diffondono il volantino “Limite di sicurezza” (21 gennaio 1956): “Il
risultato delle elezioni ci preoccupa realmente
solo nella misura in cui per la prima volta siedono a Palais Bourbon più di
cinquanta deputati che non è esagerato definire fascisti. Sostenuti da tutta la
stampa nazista di Parigi, un’accozzaglia di ubriaconi, di lottatori da fiera,
di teppisti da drogheria, di macellai abituati a dare un colpo alla bilancia e
a circolare nel sangue, si apprestano a governarci con l’aiuto di alcuni
microcefali della facoltà di diritto. Questi ladri patentati non si limitano
ormai a gridare ‘Al ladro!’, secondo una tecnica sperimentata. Già pretendono
di instaurare la discriminazione razziale tra i francesi e di resuscitare la
stella gialla... Se non facciamo attenzione, domani saranno le strade di Parigi
a trasformarsi in un terreno di caccia all’uomo. Domandiamo dunque al Comitato
d’azione degli intellettuali contro la repressione nell’Africa del Nord, che,
secondo le parole di Jean Cassou, costituisce il più importante raggruppamento
che si sia visto dopo il ‘36, di delegare senza distinzione di opinioni
politiche o di altro genere un Comitato
d’azione contro il fascismo e il colonialismo, di organizzare un
boicottaggio sistematico della finanza poujadista e di non attendere che la
violenza più bassa e più cinica abbia il sopravvento per ‘mettere in guardia’
una opinione pubblica completamente disorientata”[118].
Nel corso del XX Congresso del
PCUS (14-25 febbraio 1956) Kruscev legge l’ormai famoso “rapporto segreto”,
mentre in aprile scioglie il Kominform. Questi avvenimenti ispirano la
redazione di “È la volta delle livree sporche di sangue” (12 aprile 1956), la
più importante dichiarazione collettiva dopo “Rottura inaugurale” (1947). Il
testo è redatto da Jean Schuster in collaborazione con André Breton (al quale
se ne deve il titolo). Dopo aver riaffermato i principi ispiratori dell’attività
politica surrealista si invita la base del PCF a scacciare i quadri:
“Piaccia o no alla critica
letteraria borghese, alla critica filosofica più o meno bene intenzionata e a
tutta la critica politica cosiddetta ‘di sinistra’, il surrealismo si inserisce
nella storia con la preoccupazione di assumere lo sviluppo rivoluzionario del
pensiero sino alle sue più estreme e più svariate conseguenze.
“Nel suo quadro storico
specifico, questo pensiero è condizionato ai nostri giorni dalla necessità di
levarsi contemporaneamente contro lo sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo
in regime capitalista o non capitalista e contro lo sfruttamento dello spirito
da parte di un preteso razionalismo che le più recenti posizioni scientifiche
basterebbero a infirmare. Qualunque siano, in queste condizioni, le
vicissitudini cui è esposto un tale pensiero, nei suoi rapporti necessari con l’azione
rivoluzionaria, il surrealismo si prefigge lo scopo di mantenere e di esaltare
il contenuto latente, permanente, della rivoluzione...
“Il surrealismo rivendica una
concezione realmente dialettica della
rivolta individuale, negazione,
feroce e illimitata che trasmuta in coscienza rivoluzionaria positiva: la seconda è, dunque, di
continuo preservata dalla prima da ogni intristimento burocratico, il che, su
un piano superiore di sintesi, le consente di porre dinanzi a se stessa la
critica negativa della rivoluzione compiuta. In virtù di questa concezione il
surrealismo resta il polo della vigilanza verso tutti gli attacchi contro la
rivoluzione, sia come idea che come fatto.
“Da vent’anni il surrealismo
prova che una opposizione irriducibile allo stalinismo non si accompagna
necessariamente a un abbandono dell’obiettivo rivoluzionario e che, al
contrario, questo obiettivo esige una tale opposizione come garanzia morale...
“Nel 1935, un manifesto
intitolato ‘Du temps que les surréalistes avaient raison’ esprimeva la sfiducia
più totale verso il regime cosiddetto ‘sovietico’ e verso il suo capo. Questa
sfiducia, ci affrettiamo a dirlo, Stalin stesso si adoperò a trasformarla in un
sentimento più preciso nel corso degli anni successivi.
“L’assassinio, dopo i simulacri
di processi che si conoscono, dei primi compagni di Lenin, il massacro di
quelli della FAI, della CNT e del POUM che, in Ispagna, tentarono di liberare
il proletariato mondiale, infine il vile, immondo colpo di piccone che sfondò
il cranio di Trotskij: questa serie di delitti basterebbe a fare dell’istigatore
la figura più abietta della Storia.
“Nel 1956, tre anni dopo la sua
morte, si strappa il velo che, usando le tecniche della religione, permetteva
di rappresentarlo agli operai pazientemente mistificati come il contrario di
quello che era, come la guida ‘geniale’ dell’umanità, il continuatore di
Lenin... a proposito del quale Trotskij riferiva nel 1924 il seguente aneddoto:
‘In un congresso dei Soviet si vide salire alla tribuna un rappresentante
abbastanza noto di una sette religiosa, un comunista cristiano (o qualcosa del
genere) assai abile e scaltro, che immediatamente intonò un’antifona in onore
di Lenin, definendolo paterno e che ci nutre. Mi ricordo che Vladimir
Ilič, seduto alla tavola del bureau, alzò la testa, si volse leggermente e
disse a mezza voce, in tono furente verso noi che eravamo i più vicini: ‘Che
cosa sono queste porcherie?’.
“Gli intellettuali staliniani
hanno esteso d’un altro buon tratto i limiti di queste ‘porcherie’; hanno
dimostrato per primi che certi spiriti contenevano una vera e propria cloaca e
che bastava loro avere la lingua abbastanza duttile per diffondere in tutte le
direzioni le loro emanazioni pestilenziali. Peccato che la morte abbia
strappato prematuramente al nostro disgusto, come alla tremante confusione in
cui si rifugerebbe oggi, colui che, tra tutti loro, manifestò in questo tipo di
esercizi le doti più sicure, benché tra le più tardive, come dimostra questa ‘poesia’
[si tratta di ‘Joseph Staline’ di Paul Eluard, pubblicata dall’Humanité 1’8 dicembre 1949]:
E Stalin per
noi è presente per domani
E Stalin
scioglie oggi la disgrazia
La fiducia è
il frutto del suo cervello d’amore
Il racemo
ragionevole, tanto è perfetta
Grazie a lui
viviamo senza conoscere autunno
L’ orizzonte
di Stalin rinasce sempre...
Stalin
ricompensa i migliori degli uomini
E restituisce
ai loro lavori la virtù del piacere...
La vita e gli
uomini hanno eletto Stalin
Per
rappresentare sulla terra le loro speranze senza limiti.
“Non è che un pezzo scelto tra
gli altri, ‘a tutta prova’ dal punto di vista del servilismo, cioè
vergognosamente controrivoluzionari. Pubblicati nella stampa operaia, ahimè,
solo il proletariato d’Europa non li ha sentiti come insulti a quella che fu la
sua intelligenza. Ciò nonostante, noi surrealisti ci rifiutiamo di credere che
la classe operaia, che dal giugno 1848 sino alla disfatta di Spagna del 1939,
quando dovette cedere dinanzi alle forze coalizzate del fascismo, della Ghepeu
e della finanza internazionale, ha dato tante prove della sua volontà di
trasformare il mondo nel senso esclusivo della libertà, possa più a lungo
affidare il suo destino a una cricca poliziesca.
“Dovremmo arrenderci a una così
lugubre evidenza solo se, per assurdo, in un lasso di tempo molto breve i
militanti di base del partito ‘comunista’ francese, aiutati da giovani
intellettuali che, col favore del nuovo orientamento, vi siano entrati con le mani pulite, non rovesciassero i
dirigenti attuali, a tutti i livelli della gerarchia del partito − in
particolare se non scacciassero dalla loro comoda tribuna giornalistica gli
Aragon, Wurmser, Triolet, Stil, Kanapa, Courtade e altri cani di meno nobile
pedigree, tutti apologisti stipendiati e complici dei crimini di Stalin.
“Compagni comunisti, i vostri
capi vi hanno tradito, hanno speculato sulla miseria spirituale che la società
vi lascia troppo spesso in retaggio; hanno canalizzato la vostra rivolta verso
l’adorazione religiosa; hanno smussato, se non spezzato la vostra volontà
rivoluzionaria, schernito la vostra speranza − pertanto sono divenuti alleati
dei capitalisti, vostri sfruttatori diretti; sono riusciti a pietrificarvi,
parlandovi di Mosca come si parla ai cristiani del paradiso; oggi voi sapete
che non c’è paradiso in nessun luogo, né sulla terra né altrove; sapete che la
rivoluzione non ha ‘salvatore supremo’, ma può avere un carnefice. Compagni, i
vostri capi esitano − loro, così abili a compiere le svolte − sembrano
disorientati da quella che dipende da voi che sia l’ultima, quella della
verità. Esigete, nelle cellule, la discussione libera e immediata, partendo dal
XX Congresso, sulla revisione della Storia del Partito con la riabilitazione
dei pretesi traditori come prima conseguenza, a cominciare dalla
riabilitazione, e solenne, del
compagno inseparabile di Lenin, dell’organizzatore dell’Esercito rosso, del
teorico della rivoluzione permanente, del compagno Leone Trotskij; destituite i
funzionari e i burocrati sottoposti a Thorez, che si è autoproclamato ‘il
miglior discepolo di Stalin’; estirpate dalla classe operaia il veleno
staliniano che l’ha paralizzata”[119].
Nell’ottobre 1956 la sollevazione
di studenti e operai in Ungheria riporta al governo l’antistalinista Imre Nagy.
Le truppe sovietiche invadono il paese il I novembre, mentre Imre Nagy annuncia
l’uscita dal Patto di Varsavia. La reazione sovietica non si fa attendere: il 4
novembre i russi occupano Budapest. Nagy e alcuni suoi ministri si rifugiano
nell’Ambasciata jugoslava (sarà rapito con un inganno da Kadar e poi processato
e fucilato il 17 giugno 1957). L’intervento militare sovietico porta al potere
Janos Kadar che si assume il compito di riportare l’ordine nel paese. I
surrealisti diffondono il volantino “Ungheria, sole che sorge” (novembre 1956).
Come sempre, i loro penetranti commenti li portano a mettere in evidenza (e
sono forse gli unici a farlo) l’identità di intenti delle forze reazionarie sia
occidentali sia sovietiche:
“La stampa mondiale dispone di
specialisti per ricavare le conclusioni politiche dei recenti avvenimenti e
commentare la soluzione amministrativa con cui l’ONU non mancherà di sanzionare
la sconfitta del popolo ungherese. Quanto a noi, ci spetta proclamare che il
Termidoro, il giugno 1848, il maggio 1871, l’agosto 1936, il gennaio 1937 e il
marzo 1938 a Mosca, l’aprile 1939 in Ispagna e il novembre 1956 a Budapest
alimentano lo stesso fiume di sangue che, senza possibilità di equivoco, divide
il mondo in padroni e schiavi. L’astuzia suprema dell’epoca moderna consiste
nel fatto che gli assassini di oggi hanno assimilato il ritmo della storia.
Ormai la morte poliziesca, in Algeria come in Ungheria, opera in nome della
democrazia e del socialismo:
“Esattamente trentanove anni fa l’imperialismo
franco-britannico tentava di accreditare la propria versione interessata della
rivoluzione bolscevica, facendo di Lenin un agente del Kaiser; lo stesso
argomento è usato oggi dai pretesi discepoli di Lenin contro gli insorti
ungheresi, confusi, nel loro insieme, con i pochi elementi fascisti che,
inevitabilmente, si sono dovuti infiltrare tra di loro. Ma in periodo
insurrezionale il giudizio morale è pragmatico: FASCISTI SONO COLORO CHE
SPARANO SUL POPOLO. Nessuna ideologia resiste dinanzi a questa infamia: è
Gallifet stesso che ritorna, senza scrupoli e senza vergogna, in un carro
armato con la stella rossa.
“Tra tutti i dirigenti ‘comunisti’
mondiali solo Maurice Thorez e la sua banda continuano cinicamente la loro
carriera di cocchi della Ghepeu che ha davvero la pelle dura se sopravvive alla
carogna di Stalin.
“La sconfitta del popolo ungherese
è la sconfitta del proletariato mondiale. Qualunque sia l’aspetto
nazionalistico che hanno dovuto assumere la Resistenza polacca e la rivoluzione
ungherese, si tratta di un aspetto congiunturale, determinato innanzitutto
dalla colossale e forsennata pressione di quello Stato ultranazionalista che è
la Russia. Il principio internazionalista della rivoluzione proletaria non è in
causa. La classe operaia era stata dissanguata totalmente nel 1871 dai
versagliesi di Francia. A Budapest, di fronte ai versagliesi di Mosca, i
giovani − ribelli all’addestramento staliniano al di là di ogni speranza − le
hanno trasfuso un sangue che certamente determinerà il corso della trasformazione del mondo”[120].
Torniamo per un attimo al 1955:
in novembre viene fondato il “Comitato d’azione degli intellettuali francesi
contro il proseguimento della guerra in Africa del Nord”, al quale ben presto
aderiscono più di seicento militanti di tutte le correnti politiche della
sinistra (comunisti e loro simpatizzanti, marxisti anti-stalinisti, sartriani,
cristiani, anarchici e surrealisti). Sin dalle prime sedute si ha una
sfaldatura tra le posizioni rivoluzionarie dei surrealisti e loro simpatizzanti
e degli anarchici (sostegno dell’insurrezione algerina) e quelle “pacifiste”
dei comunisti e dei cristiani.
Il 15 dicembre, nel corso di un’
“assemblea generale”, viene avanzata la richiesta di mettere all’ordine del
giorno l’intervento sovietico a Budapest. Gli staliniani, sostenuti dai
sartriani (J.P. Pontallis, Pouillon, M. Péju), tentano di bloccare la proposta.
Ma una mozione presentata da Claude Lefort, Dionys Mascolo ed Edgar Morin è adottata
a larga maggioranza[121].
Un editoriale per Le Surréalisme, Même riporta il testo
della mozione: “Il comitato condanna il rapimento dei capi del FLN da parte del
governo francese e l’aggressione imperialista contro l’Egitto; condanna l’intervento
sovietico in Ungheria e il rapimento di Nagy; difende senza riserve e in tutti
i casi il diritto dei popoli all’autodeterminazione. Ci auguriamo di vedere gli
intellettuali sovietici premere sul loro governo contro la sua aggressione.
Esigiamo dal nostro che applichi in Africa del Nord i principi che pretende di
far applicare in Ungheria; che metta termine agli arresti, alle torture, ai
massacri e alla cosiddetta pacificazione”[122].
Per rimanere in argomento
ricordiamo che i surrealisti furono tra i promotori della “Dichiarazione sul
diritto all’insubordinazione nella guerra d’Algeria”, più nota come “Dichiarazione
dei 121”, in un’epoca (settembre 1960) in cui i firmatari si esponevano a
pesanti sanzioni giuridiche.
Mi sono soffermato altrove sulla
straordinaria preveggenza di Breton. Nel 1942 egli allude a una “scoperta
spettacolare... nel campo della fisica”[123]. Nel 1945 la prima
attuazione della scoperta che avrebbe dovuto aprire all’umanità l’era dell’abbondanza
è una terrificante minaccia per la sua stessa sopravvivenza. Breton commenta un
anno dopo: “La conoscenza scientifica della natura non può avere alcun pregio
ameno che non possa essere ristabilito il contatto con la natura attraverso le
vie poetiche e, oserò dire, mitiche. Va da sé che ogni progresso scientifico
compiuto nel quadro di una struttura sociale difettosa non fa che andare a
svantaggio dell’uomo, che contribuire ad aggravarne la condizione”. Nelle
circostanze attuali, invece, “lo stretto dovere degli intellettuali è di
denunciare i progressi di una follia omicida che non ha più limiti... L’uso
dell’energia atomica, in quanto conquista irrevocabile dell’uomo, lo
immobilizza, lo lascia interdetto al crocevia di due strade, una delle quali
porta al suicidio sul piano collettivo, l’altra al più insperato benessere”[124].
Passano altri due anni, e nel
1948 Breton affida tutte le sue speranze di salvezza alla “trasformazione del
mondo, certamente più necessaria e urgente che mai, ma che, data la minaccia
comune che pesa su tutti gli uomini, chiede di essere ripensata da cima a fondo”,
e aggiunge: “una tale fine del mondo, sorta a seguito di un passo falso dell’uomo,
imperdonabile perché più decisiva dei precedenti... non è la nostra”[125].
Questo è il contesto che
determina la pubblicazione, dieci anni dopo, nel febbraio 1958, dell’appello “Smascherate
i fisici − Vuotate i laboratori”. Con pungente lucidità vi si afferma:
“Nulla, assolutamente nulla, oggi
distingue la Scienza da una minaccia di morte permanente e generalizzata. La
questione si pone entro i seguenti termini: si tratta di sapere se la scienza
saprà assicurare il benessere all’uomo o condurlo alla sventura, poiché ormai è
evidente che ha cessato d’essere un mezzo per diventare un fine. La fisica
moderna ci ha promesso, ci ha dato, e ci promette ancora, come suoi tangibili
risultati, cataste di cadaveri. Fino a ieri, davanti a conflitti tra nazioni,
davanti alla possibile distruzione di una civiltà, noi reagivamo secondo i
nostri criteri politici e morali abituali. Ma oggi ci troviamo davanti a una
specie umana votata alla distruzione completa per l’impiego cinico di bombe
nucleari..., per le devastazioni dovute alle ricadute che intanto riverberano
effetti imprevedibili sulla meteorologia e sulla base biologica della specie
data la deliberata rincorsa dei governi nelle esplosioni sedicenti
sperimentali, con la copertura dei ‘fini pacifici’. In queste condizioni il
pensiero rivoluzionario vede le sue attività ridotte ai minimi termini, per cui
a ritemprarsi deve risalire alle sorgenti della rivolta e, oltre un mondo
capace solo di nutrire il proprio cancro, ritrovare gli impulsi preconsci del furore.
“Non è quindi a un atteggiamento
umanistico che ci richiameremo. Se la religione è stata a lungo l’oppio dei
popoli, la Scienza è ormai prossima a rilevarne la funzione. Le proteste contro
la corsa agli armamenti, che certi fisici oggi si compiacciono di levare, al
più ci illuminano su un loro complesso di colpa che, sia ben chiaro, è uno dei
vizi più infami dell’uomo. Il petto che ci si batte troppo tardi, la cauzione
data dai tristi belati del gregge che ha armato la mano del macellaio:
conosciamo questo ritornello. Il cristianesimo e i suoi specchi deformanti che
sono le dittature poliziesche ci hanno già abituati...
“Basta con la teologia della
Bomba! Organizziamo la propaganda contro i ricattatoti del sedicente pensiero
scientifico. E nell’attesa di far meglio incominciamo a boicottare le
conferenze dove si celebra l’atomo; sonori fischi ai film che addormentano o
indottrinano l’opinione pubblica; scriviamo ai giornali e alle istituzioni
pubbliche per protestare contro la pletora di articoli, reportages e
trasmissioni radiofoniche dove si celebra spudoratamente questa nuova colossale
impostura”[126].
Le ultime tre prese di posizione
dei surrealisti, prima della morte di André Breton, sono sulla Polonia, sulla
collusione poliziesca franco-spagnola e su Cuba.
Nel marzo del 1959 il III
Congresso del POUP polacco annullava la risoluzione del 1948 che condannava
Gomulka. In maggio, al Congresso degli scrittori sovietici, si levarono le
prime critiche al grigiore e al servilismo di certi letterati. Questi tenui
segni di risveglio, e a un tempo la constatazione che la Francia non è più la
custode di una tradizione emancipatrice − e quindi non ha più lezioni da dare a
nessuno −, improntano il “Messaggio dei surrealisti agli intellettuali polacchi”
(4 giugno 1959): “Sfidando la repressione, voi siete riusciti a contenere un
potere colossale, padrone assoluto della metà del mondo. Gli intellettuali
francesi non sono capaci di mettere in discussione un potere ridicolo,
anacronistico, tronfio d’una grandigia irreale, ma nella sua essenza non meno
intollerabile di quanto era in concreto quello che vi opprimeva. Voi avete
rischiato tutto, la vostra libertà e la vostra stessa vita. Gli intellettuali
francesi non rischiano null’altro che la loro meschina tranquillità, ma neanche
quella sono disposti a rischiare. Da come stanno andando le cose, tra qualche
mese, l’arciaccademico André Malraux verrà a farvi conferenze sulla cultura
francese. Sappiate fin da ora che questa cultura esiste solo al passato, perché
una cultura muore là dove la coscienza diserta. Non leggete alcuna amarezza in
queste parole. Quello che conta, quello che ci aiuta a vivere, è il fatto che,
oltre il nostro povero paesaggio di miserie morali, voi, l’intellettualità del
più oppresso dei popoli, continuate a prevalere sulle forze della morte. Vi dovevamo
questo saluto fraterno”[127].
“La via iniqua” (8 febbraio 1963)
stigmatizza il gesto di de Gaulle, pronto a consegnare a Franco i repubblicani spagnoli
in esilio in cambio di attivisti dell’OAS. “Così il terrore su scala
internazionale, ancora una volta, minaccia i sopravvissuti dell’ultima grande
insurrezione che ha fatto scricchiolare durevolmente le vertebre di un pianeta
che tende a intorpidirsi in un sonno mortale... Quale che sia l’attenzione al
nostro discorso, noi siamo ben risoluti a levare contro questa infamia una
protesta solenne per fedeltà a ideali che ognuno oggi sembra impegnato a
degradare ad aneddoti pittoreschi o commossi ricordi. C’è un altro
sopravvissuto della guerra di Spagna che merita la nostra particolare
attenzione. È André Malraux, che, dal giorno in cui è diventato ministro, ha
taciuto davanti alle torture in Algeria, davanti alla repressione delle
attività anticolonialiste, davanti al massacro un anno fa, alla fermata del métro
di Charonne, di nove lavoratori parigini ad opera della brigata speciale di
polizia di Frey-Papon. Quante volte tacerà ancora? La ‘sinistra’ per parte sua
continuerà a deplorare sotto voce che una così bella ‘intelligenza’ abbia
creduto di dover cedere al fascino imperioso del Generale, continuando nell’elogio
al ‘nostro’ in ogni occasione? Nel solco fangoso battezzato V Repubblica
diventa purtroppo sempre più facile la contabilità di quelli che non si
insozzano”[128].
L’ultima dichiarazione
collettiva, “L’esempio di Cuba e la rivoluzione” (estate 1964), è un canto di
speranza. Nella rivoluzione cubana i surrealisti credono di scorgere le
premesse per quella trasformazione dell’uomo e della società tanto a lungo
auspicata:
L’ordine economico-politico di
impronta occidentale, che oggi regge il mondo, non ha solo articolato relazioni
sociali fondate sullo sfruttamento dell’uomo, ma ha prodotto anche una
struttura mentale capace di assimilare, a profitto di questo ordine, tutto
quanto gli si oppone, e di occultare per lungo tempo tutto quanto gli resiste
irriducibile.
“Oggi, e forse in modo più lucido
e coerente, il surrealismo lotta per portare alle estreme conseguenze
rivoluzionarie le conquiste già acquisite. Il surrealismo non si propone di
definire l’uomo che verrà; e neanche di delineare il paesaggio del futuro
paradiso. Quello che persegue è che l’uomo di domani sia diverso dall’alieno d’oggi.
“Una vera rivoluzione deve
trasformare l’individuo nella sua totalità sociale e individuale. Non è
sufficiente abbattere le strutture capitaliste e mettere al potere un’altra
classe, se poi questa esercita il potere secondo precetti ereditati dal regime
precedente: il culto del lavoro, l’amore sacrificato alla moltiplicazione della
specie, l’esaltazione dei capi, la burocratizzazione dell’artista ridotto a
propagandista. Un’autentica rivoluzione non ha nulla da temere dall’esercizio
del libero pensiero, né da un’attività artistica sgombra di settarismi. Una Rivoluzione che difende la libertà di
creazione può essere anche una Rivoluzione senza Termidoro.
“Nella rivoluzione cubana, nell’ammirabile
insurrezione della Sierra Maestra, nella lotta del popolo cubano per la sua
libertà e nell’opposizione degli intellettuali e artisti cubani a ogni
dogmatismo, il surrealismo saluta un movimento fratello.
“Secondo proprie forze e
circostanze, anch’esso operando nella direzione di una liquidazione dei valori
ideologici e morali del capitalismo, e per una rinascita radicale dell’intelletto
e della sensibilità, il surrealismo si proclama solidale con gli artisti
rivoluzionari cubani, che lottano per lo stesso obiettivo in un contesto ben
più violento e pericoloso.
‘“IL SURREALISMO SI È SEMPRE
VOLUTO CATALIZZATORE DI RIVOLTE, E IN QUESTA ASPIRAZIONE C’È COINCIDENZA CON
QUANTO SI PROPONE, NELL’AMBITO POLITICO, L‘ESEMPIO CUBANO. L’AMBIZIONE DEL
SURREALISMO È DI DIVENTARE IL FILO CONDUTTORE TRA I MOMENTI SEPARATI DELLA
RIVOLUZIONE E DI PERMETTERE IL LORO SUPERAMENTO. PER UNA DETERMINAZIONE NON
EQUIVOCA ALL’INTERNO DEL PROCESSO, USANDO COME TERMINE DI RIFERIMENTO DEL METRO
DI PROGRESSO LA CAPACITÀ DEL DESIDERIO DI ESSERE POTENZIATO. L’AMORE E LA
POESIA SOGLIE DELLA CASA INFINE ABITABILE”[129].
BIBLIOGRAFIA
Il riferimento
bibliografico rimanda alla traduzione italiana ogni volta questa sia
disponibile
Apollinaire, Guillaume
1913 Les Peintres cubistes, Eugène
Figuière, Paris
Bonnet, Marguerite
1975 André Breton.
Naissance de l'aventure surréaliste, Corti, Paris, 2a ed. rivista e
aumentata, 1988
Breton, André
1924 "Manifeste du Surréalisme", in Manifestes du Surréalisme, J.J. Pauvert,
Paris, 1962; trad, it, in Manifesti del
Surrealismo, Einaudi, Torino 1966
1925 Lettre
aux voyantes in Breton 1924, trad it: Lettera
alle veggenti
1927
Introduction au discours sur le peu de
réalité, Gallimard, Paris
1928 Le
Surréalisme et la peinture, Gallimard, Paris, 3a edizione rivista 1965,
trad. it. Il Surrealismo e la pittura, Marchi,
Firenze 1996
1928a Nadja,NRF,
Paris; trad. it. Nadja,, Einaudi,
Torino 1977
1930 "Secondo Manifesto del Surrealismo",
in Breton 1924
1932
Les Vases communicants, Editions des
Cahiers Libres, Paris
1935 "Situazione politica del
Surrealismo", in Breton 1924
1935a
"Note sur une collaboration" in Cahiers
d'art (Paris), n°5-6, p.137
1937
L'amour fou, Gallimard, Paris; trad.
it. L'amour fou, Einaudi, Torino 1980
1942
"Situation politique du Surréalisme entre les deux guerres" in La clé des champs, Editions du
Sagittaire, Paris 1953
1947 "Comète surréaliste" in Breton 1953
1947a Arcane17
[seguito da] entè d'ajours, Sagittaire,
Paris; trad. it. Arcano 17, Guida
editore, Napoli, 1985
1947b "Interview de Dominique Arban", in
Breton 1952 ed. fr.
1948
"Interview d'Aimé Patri", in
Breton, 1952 ed. fr. 1952
1952
Entretiens, NRF, Paris, trad. it. Storia del Surrealismo, Schwarz, Milano 1960
1952a
"La Claire tour" in Breton 1953
1953
La clé des champs, Editions du
Sagittaire, Paris 1953
1953a
"Du Surréalisme en ses œuvres vives", in Breton 1924, ed. francese
1956
"Le Surréalisme et la tradition" in
Breton 1970
1962
"Entretien avec Madeleine Chapsal" in Breton 1970
1970 Perspective
cavalière, a cura di Marguerite Bonnet, Gallimard, Paris
1988 Œuvres
complètes, a cura di Marguerite
Bonnet con la collaborazione di Philippe Bernier, Étienne-Alain Hubert e José
Pierre, vol. I°, Gallimard, Paris
Feuerbach, Ludwig Andreas
1839
Contribution à la critique de Hegel,
in Manifestes philosophiques, textes
choisis, Presses Universitaires de France, Paris 1960
1841 L'essence
du christianisme, F. Maspero, Paris 1968; trad. it. L'essenza del cristianesimo, , Feltrinelli, Milano 1971
Freud, Sigmund
1923 Trois
Essais sur la théorie de la sexualité (1905), trad. fr. NRF, Paris 1923; trad. it. Tre saggi sulla teoria della
sessualità,
Mondadori, Milano
Fourier,
Charles
1816
"Le Nouveau monde amoureux", in Œuvres
complètes, vol. VII, Éditions Anthropos, Paris 1967; trad. it. Il nuovo mondo amoroso, 2 vol:, ES, Milano 1999
Hegel,
Friedrich
1807 Phänomenologie
des Geistes; trad. fr. La Phénoménologie de l'Esprit, 2 vol., Aubier, Paris 1939-41; trad. it. Fenomenologia dello spirito, 2 vol., La
Nuova Italia, Firenze, 1967
-
Vorlesungen über die Philosophie der Religion; trad. fr. Leçons sur la
Philosophie de la religion, Vrin, Paris 1954-59; trad. it. Lezioni sulla filosofia della religione, Zanichelli, Bologna 1974
Lautréamont (Isidore Ducasse)
1870
Les Chants de Maoldoror in Œuvres complètes, NRF, Paris 1971; trad.
it. I canti di Maldoror, Einaudi, Torino 1944
Levi, Eliphas (Alphonse-Louis Constant)
1955-56 Dogme et rituel de la haute magie,
Éditions Niclaus, Paris 1960
Péret,
Benjamin
1956 "Le noyau de la comète" in Anthologie
de l'amour sublime, Albin Michel, Paris, trad. it. La cométa del desiderio,
Arcana, Roma 1980
Rank, Otto
1928 Le traumatisme de la naissance, Payot,
Paris; trad. it. Il Trauma della nascita,
Guaraldi
Reverdy,
Pierre
1918 "L'Image" in Nord-Sud (Paris), n° 13 (marzo) ripreso in Œuvres complètes. Nord-Sud, et al, Flammarion Paris, pp. 73-75
[2] Breton, “Entretien avec Madeleine Chapsal”, in L’Express (Paris), 9 agosto 1962,
ripreso in Perspective Cavalière,
Gallimard, Paris 1970, p. 208.
[4] Breton, “La claire tour”, in Le Libertaire (Paris), 11 gennaio 1952, p. 2, ripreso in La clé des champs, Editions du Sagittaire,
Paris 1953, pp. 272-73.
[5] Breton, Qu’est-ce
que le surréalisme?, R. Henriquez, Bruxelles 1934, p. 12.
[8] Aragon, “Avez-vous déjà giflé un mort?” (ottobre 1924), in Maurice Nadeau, Storia e antologia del surrealismo, Mondadori, Milano 1972, p. 183.
[9] Aragon, lettera del 25 novembre 1924, in Clarté, dicembre 1924, ibid., p. 187.
[10] Aragon, risposta a Drieu La Rochelle, in La Nouvelle Revue Française, settembre
1925, p. 381.
[13] “La revolution d’abord et toujours” (1925), in Nadeau, Storia..., cit., pp. 213-14.
[16] André Thirion,
Révolutionnaires sans révolution, R. Laffont, Paris 1972, pp. 125-26.
[17] Antonin Artaud, “A la grande nuit”, in Nadeau, Storia..., cit., pp. 246-47.
[21] Breton, “Prière d’insérer pour Seconde manifeste du surréalisme” (1946), in Breton, Manifesti del surrealismo, Einaudi,
Torino 1966, p. 53.
[22] Breton, “Lettre aux voyantes” (1925), ibid., p. 127.
[23] Leone Trotskij, “Révolution et culture”, in Clarté, 1 novembre 1923, cit. da Breton nel “Secondo manifesto
del surrealismo”, ibid., 91.
[30] Breton, “La barque de l’amour s’est brisée contre la vie courante”
(luglio 1930), in Poìnt du jour
(1934), Gallimard, Paris 1970, pp. 73-74, 83.
[31] Trotskij, “Il suicidio di Vladimir Majakoskij” (1934),
in Letteratura e rivoluzione,
Einaudi, Torino 1973, p. 520.
[32] Breton, “La barque…”, cit., p. 81.
[36]
Breton, telegramma a Mosca, in Nadeau, Storia..., cit., pp. 276-77.
[37] Thirion, Révolutionnaires…, cit.,
p. 277.
[39] Breton, Storia...,
cit., p. 150.
[42] “La mobilisation contre la guerre n’est pas la paix”
(1933), in Nadeau, Storia..., cit., pp. 328-29.
[44] Feuille Rouge (Paris), n. 1 (febbraio
1933), p. 1, in Tracts surréalistes et
déclarations collectives (1922-1939), a cura di José Pierre, Le Terrain
Vague, Paris 1980, vol. I, p. 238.
[47] “La planète sans visa” (1934), in Nadeau, Storia..., cit., pp. 341-42.
[48] Breton, “Discours pour la défense de la culture” (giugno
1935), ibid., pp. 366-67.
[51] “Du temps que les surréalistes avaient raison” (1935), ibid., pp. 371-72.
[54] Risoluzione di “Contre-attaque”, ibid., pp. 381-83.
[56] “Enquête sur les milices, la prise du pouvoir et les partis”,
“Les Cahiers de Contre-attaque”, “Prière
d’inserer”, ibid., p. 385.
[57] “Neutralité? Non-sens, crime et trahison” (20 agosto
1936), ibid., p. 402.
[58] Breton, Storia...,
cit., p. 161.
[60] Breton, “Dichiarazione al convegno ‘La vérité sur le
procès de Moscou’” (3 settembre 1936), in Nadeau, Storia..., cit., pp. 402-3.
[61] Breton, Storia...,
cit., p. 162.
[62] Breton, “Dichiarazione a proposito dei secondi processi
di Mosca” (26 gennaio 1937), in Nadeau, Storia...,
cit., p. 407.
[63] Antonin Artaud, “Ce que je suis venu faire au Mexique”,
in El Nacional (Messico), 5 luglio
1936, ripreso in Œuvres camplètes
d’Antanin Artaud, Gallimard, Paris 1971, tomo VIII, pp. 257, 260.
[64] Breton, “Souvenir du Mexique”, in Minotaure (Paris), n. 12-13 (maggio 1939), pp. 31-32.
[67] Pierre Naville, Trotskij
vivant, Julliard, Paris 1962, p. 100.
[68] Per rievocare
gli aspetti meno conosciuti delle visite di Breton a Trotskij, mi sono basato
sugli appunti da me presi nel 1955 nel corso di una serie di conversazioni con
Breton su quest’argomento, nonché su alcune conversazioni registrate su nastro
nel novembre del 1972 con Jacqueline Lamba, all’epoca moglie di Breton, che lo
accompagnò nel suo viaggio in Messico; con Jan van Heijenoort, allora
segretario di Trotskij in Messico; con Pierre Naville, fiduciario di Trotskij
in Francia; e Marguerite Bonnet, amica di Natalia Sedova Trotskij e di André
Breton, incaricata di amministrare l’eredità letteraria di Leone Trotskij,
autrice di un’opera fondamentale sul giovane Breton (André Breton − Naissance de l’aventure surréaliste, Corti, Paris 1975)
e curatrice dell’edizione critica delle sue Œuvres
complètes, Gallimard, Paris 1988.
[71]
“Pour un art révolutionnaire indépendant”, in
Leone Trotskij, Letteratura, arte,
libertà, Schwarz Editore, Milano 1958, pp. 111-16, qui ripreso
integralmente nell’antologia dei saggi.
[73] Breton, Les vases
communicants, Cahiers Libres, Paris 1932, p. 153.
[74] Breton, “Discours pour la défense de la culture”, in
Nadeau, Storia..., cit., p. 371.
[77] Breton e Eluard, intervista a Halo Noviny (Praga), 14
aprile 1935, in Nadeau, Storia..., cit., p. 360.
[79]
“Prière d’insérer” per Clé, in Nadeau, Storia...,
cit., pp. 417-18.
[81] Nadeau, Storia...,
cit., p. 160.
[82] “Ni de votre guerre, ni de votre paix” (27 settembre
1938), ibid., p. 417.
[83] “A bas les lettres de cachet” (luglio 1939), ibid., p. 423.
[84]
Verrà pubblicata in anteprima, a cura di Breton,
in La parole est à Péret, Editions
Surréalistes, New York 1943, pp. 29-39.
[85]
Il nome deriva da una frase di Rimbaud: “La mano
a penna vale la mano ad aratro” (Une
saison en enfer).
[86]
Per un resoconto della questione vedi l’eccellente
ed esauriente Michel Fauré, Histoire du
surréalisme sous l’occupation, La Table Ronde, Paris 1982, pp. 399-424.
[89] Per i particolari della questione vedi De la part de Péret, a cura
dell’Association des Amis de Benjamin Péret, Paris 1963.
[91] Adolphe Champ (pseudonimo di Adolphe Acker), “Trajectoire
de la liberté”, in Informations
Surréalistes, maggio 1944, foglio unico, in Tracts..., cit., pp.
20-21.
[92]
“Idolatry and Confusion” (1944), trad. it. a cura
di Livio Maitan e Tristan Sauvage (Arturo Schwarz), in Jean-Louis Bédouin, Storia del surrealismo dal 1945 ai nostri giorni,
Schwarz Editore, Milano 1966, pp. 247-53.
[95] Breton, “Hommage à Antonin Artaud” (7 giugno 1946), in La clé des champs, cit., p. 84.
[96] Breton, “Seconde arche”, ibid., p. 109. Vedi anche, su questo argomento, Benjamin Péret, Le déshonneur des poètes (1945),
Pauvert, Paris 1965, ripreso qui quasi integralmente alle pp. 209-11.
[97] Breton, “Signe ascendant” (30 dicembre 1947), in La clé des champs, cit., pp. 235-37.
[98] “Ni aujourd’hui, ni de cette manière” (19 aprile 1966),
in Tracts..., cit., pp. 250-52.
[99] “Liberté est un mot vietnamien” (aprile 1947), in Bédouin,
Storia..., cit., pp. 253-55.
[100]
“Rupture inaugurale” (21 giugno 1947), ibid., pp. 255-63. Questa dichiarazione
raccoglie un elevato numero di firme: Adolphe Acker, Sarane Alexandrian,
Maurice Baskine, Hans Bellmer, Joë Bousquet, Francis Bouvet, Victor Brauner,
André Breton, Serge Bricianer , Roger Brielle, Jean Brun, Gaston Criel, Antonio
Dacosta, Pierre Cuvillier, Frédéric Delanglade, Pierre Demarne, Matta Echaurren,
Marcelle et Jean Ferry, Guy Gillequin, Henry Goetz, Arthur Harfaux, Jindrich
Heisler, Georges Henein, Maurice Henry, Jacques Hérold, Marcel Jean, Nadine Kraïnik,
Jerzy Kujawski, Robert Lebel, Pierre Mabille, Jehan Mayoux, Francis Meunier,
Robert Michelet, Nora Mitrani, Henri Parisot, Henri Pastoureau, Guy Péchenard,
Candido Costa Pinto, Gaston Puel, René Renne, Jean-Paul Riopelle, Stanislas
Rodanski, N. e H. Seigle, Claude Tarnaud, Toyen, Isabelle e Patrick Waldberg,
Ramsès Younane.
[101] “A la niche les glapisseurs de dieu” (14 giugno 1948), ibid., pp. 266-69.
[103] Breton, “Lettre
ouverte à Paul EIuard” (13 giugno 1950), ibid.
, pp. 235-37.
[104] Eluard citato da Louis Pauwels, “Des ‘salauds’ parmi les
poètes”, in Combat (Paris), 21 giugno
1950.
[105] Il testo del telegramma fu pubblicato su Combat, 17-18 giugno 1950, poi ripreso
in Tracts..., cit., p. 50.
[106]
“Haute fréquence” (24 maggio 1951), in Bédouin, Storia..., cit., pp. 269-71.
[107]
“Déclaration préalable”, in Le Libertaire (Paris), 12 ottobre 1951, ripreso in Arturo Schwarz, Breton Trotskij e l’anarchia, Multhipla,
Milano 1980 (I ed., Savelli, Roma 1974), pp. 177-78.
[108] Ibid., pp. 183-84.
[109] In Tracts...,
cit., pp. 101-2.
[110]
Pubblicati tra il 12 ottobre 1951 e l’8 gennaio
1953, sono stati raccolti, insieme con altri testi surrealisti usciti su Le Libertaire, nell’antologia Surréalisme et anarchie, a cura di José
Pierre, Plasma, Paris 1983.
[112] Breton, Arcane 17
(1944), Sagittaire, Paris 1947.
[114]
Breton, Arcane
17, cit., p. 20.
[117]
Breton, “Staline dans l’histoire”, in Figaro Littéraire (Paris), 14 marzo
1953, ripreso in ibid., p. 191.
[118]
“Côte d’alerte” (21 gennaio 1956), ripreso in Bédouin,
Storia..., cit., pp. 271-72.
[119] “Autour des livrés sanglantes!” (12 aprile 1956), ibid., pp. 273-77.
[120] “Hongrie, soleil levant” (novembre 1956), ibid., pp. 277-78.
[121]
Precisazioni date da Schuster, in Tracts..., cit., p. 376.
[122]
Editoriale in terza di copertina di Le Surréalisme, Même (Paris), n. 2
(primavera 1957).
[123] Breton, “Situation du surréalisme entre les deux guerres”
(1942), in La clé des champs, cit., p. 67.
[124] “André Breton nous parle”, intervista con Jean Duché, in Le Littéraire (Paris), n. 29 (5 ottobre
1946) e n. 30 (12 ottobre 1946), ripreso in Schwarz, Breton Trotskij..., cit.,
pp. 158 sgg.
[125] Breton, “La lampe dans l’horloge”, cit., pp. 117, 119.
[126] “Demasquez les physiciens. Videz les laboratoires” (18
febbraio 1958), in Tracts..., cit., pp. 172-73.
[127]
“Message des surréalistes aux intellectuels
polonais” (4 giugno 1959), in Front
Unique (Milano), n. 2 (inverno 1960), pp. 1-2; registrato su nastro, il
testo è stato diffuso due volte dalla radio polacca e pubblicato dal periodico Plastyka di Cracovia.
[128] “La voie inique” (8 febbraio 1963), in Tracts..., cit., pp. 219-20.
[129] “L’exemple de Cuba et la révolution” (estate 1964), in La Brèche (Paris), n. 7 (dicembre 1964),
pp. 103-104.
Cinque riflessioni
sulla Bellezza
 |
| Arturo Schwarz (Foto: Dino Ignani) |
1.
la bellezza mi si rivela
nella libertà dei suoi cappelli
nel cielo del suo sguardo chiaro
nello specchio delle sue labbra
nel volo lento del suo seno
nel suo sesso di luna scura
nel sole del suo corpo nudo
nella sua luce permanente
che fa nascere i sogni folli
in un giorno sempre chiaro
***
2.
la sua bellezza
fa girar la testa
e girar il mondo
e girar il cielo
e i mari tutti
girano i giorni
ma fermo l’amore
e il girasole
ebbro quando passa
più bella del cielo
si volta verso di lei
***
3.
la maestà del Danubio
che guardo dalla finestra
i colori della notte
il giardino di mimosa
il planare dell’aquila
il volo della farfalla
lo stupore dell’albero
il profumo della rosa
il cuore dell’orchidea
il cielo all’imbrunire
e la notte con le stelle
arricchiscono la vita
e ci fanno respirare
il soffio dell’universo
ma la gioia di vivere
è il dono dell’amata
perché la sua bellezza
reinventa l’esistenza
e permette di capirne
la verità e lo scopo
***
4.
il poeta ricostruisce il mondo
alla misura dei suoi sogni
e l’esistenza a quella dei
desideri
l’immortalità non è più lunga
della nostra vita diceva Éluard
credo pensasse che soltanto
l’amore
possa sconfiggere la morte
l’amore che colora il mondo degli
amanti
di tutte le sfumature
dell’arcobaleno
è il ponte aereo tra la terra e il
cielo
specchio dell’unione carnale e
spirituale
grazie amatissima mia compagna
la tua bellezza mi ha fatto
scoprire
l’unica via verso l’eternità
***
5.
scrive il poeta John Keats
la bellezza è verità e la
verità bellezza
questa è l’unica cosa che sappiamo
ed è tutto quanto sia necessario sapere
per me la verità è anche libertà
mentre la donna è bellezza e conoscenza
come stupirsi allora se quanto ho
sempre perseguito
sia proprio l’amore la conoscenza
e la libertà?
Arturo Schwarz

"Odissea" è grata al poeta Giulio Stocchi che nonostante la sua drammatica
situazione di salute, come si può leggere in questa tremenda lettera agli amici
che ci ha fatto pervenire, non ha voluto far mancare la sua voce per il I anniversario
dell'edizione in Rete del giornale. E' proprio con questo scritto di Stocchi che apriamo
la pubblicazione dei 100 testi d'autore per "Odissea".
L'altezza del
gioco. Ai miei amici
 |
| Giulio Stocchi |
Amici miei
carissimi, molti di voi ancora non sanno quello che mi sta capitando.
Vi scrivo solo adesso -e vi prego di perdonare il mio
ritardo- perché solo ora ho chiaro ciò che intendo fare. Mi è stato
diagnosticato un tumore maligno al colon.
I medici dicono che qualora non fossi operato mi
resterebbero sei mesi di vita, un anno al massimo.
Vi confesso che ho esitato molto sul da farsi. Ma poi un
ulteriore esame ha rivelato l'assenza di metastasi, per cui ho deciso di rischiare
l'operazione, che avverrà nei prossimi giorni.
Vi scrivo da questa casa di Corso Magenta a Milano che
molti di voi conoscono e hanno frequentato negli anni della nostra allegria,
delle nostre cene, delle nostre canzoni, dei nostri progetti... anni e anni,
una vita, che abbiamo condiviso, spesso vedendoci, ma sempre col calore del
vostro affetto, con l'intelligenza delle vostre lettere... e ognuno di voi
ricordo e ad ognuno di voi vorrei rivolgermi per dirvi il grazie che meritate,
con le parole che siano all'altezza di ciò che mi avete donato.
Ma in questo periodo, scandito dall'andirivieni di camici
bianchi, in questo universo di aghi, di fiale, di siringhe, di visi che spii
con ansia, cercando di indovinare il verdetto da cui può dipendere la tua
sorte, insomma in questo incubo, le parole, che un tempo danzavano, si
trascinano come me sfinite sulla pagina. E allora preferisco tornare fra voi
raccontando una giornata di dieci anni fa, una riflessione in pubblico, -alla
quale forse alcuni avranno assistito- in cui, ragionando su un libro appena
pubblicato, discorro del mio lavoro e della mia vita.
Se avrete la pazienza di leggere le pagine che vi accludo
in calce, tornerete ad ascoltare la voce che non solo di me parla, ma dei
sogni, delle speranze, degli ideali che ci hanno accomunati.
Sono passati dieci anni da allora e tante cose sono
cambiate.
Ma se avremo saputo restare fedeli allo spirito che ci
animava, vi accorgerete che non ci siamo fatti travolgere dal vento cattivo del
clima che oggi attorno a noi ci insidia:
Ci siamo cioè amati.
E questa è la ricchezza che ci siamo porti reciprocamente
in dono.
Giulio Stocchi
(Milano, 24 Giugno 2014)
*** ***
L’altezza del gioco
di Giulio Stocchi
 |
| Giorgio Luzi e Giulio Stocchi |
Io
innanzitutto vi ringrazio per la vostra presenza qui. Questa sera farò un
discorso tenendomi
prevalentemente ai margini del testo, un po’ fuori dal
corpo del libro, perché ritengo che tante volte
allontanarsi un poco da un edificio permette di coglierne
l’architettura complessiva.
Quindi parlerò prevalentemente in prosa, come un novello
Monsieur Jourdain, con degli echi che verranno dall’interno delle stanze di
quella costruzione che è il libro. Vi prego di avere pazienza nell’ascoltarmi,
e se vi sembrerà che all’inizio la prenda alla lontana e un poco divaghi,
vedrete che poi i fili del discorso, se avrò la capacità di mantenere il filo
del discorso, andranno a convergere al fuoco di una conclusione che mi preme molto
e che riguarda proprio il titolo del libro, L’altezza del gioco. Questo che vi
farò è un discorso che è un po’ un bilancio sul mio lavoro di poeta e un poco
anche sulla mia vita, la quale vita non è molto più interessante di quella di
voi che mi state ascoltando. Ma vedo qui molti miei amici, con i quali abbiamo
condiviso lunghi tratti di vita, sentimenti, amori, e per questo penso che
ricordare certe cose, certi ideali anche che ci hanno accomunati, e che forse
ci uniscono ancora, può essere interessante per tutti quanti noi.
Vedo qui alcuni miei vecchi compagni di scuola, con cui
siamo stati addirittura bambini insieme, amici con i quali ho condiviso
esperienze importanti, il papà e la mamma del mio grande e indimenticato
compagno, Roberto Franceschi, ucciso purtroppo dalla polizia nel ’73… E quindi
mi trovo, per così dire, nella condizione privilegiata di uno scrittore che
parla alla platea dei suoi personaggi reali, perché di voi anche si tratta nel
libro di cui cercherò di parlarvi.
Come vi dicevo mi terrò un pochettino, soprattutto sulle
prime, ai margini del libro, sul limitare di quelle “soglie” che un semiologo
francese, Gérard Genette, ha magistralmente analizzato nel suo libro omonimo, Soglie, pubblicato una quindicina di
anni fa da Einaudi.
Le soglie del libro che cosa sono? Sono quelle che
Genette chiama il “paratesto”, tutto quello che
accompagna e che presenta il testo, e cioè la copertina,
le note di copertina, la dedica, l’introduzione, che, nella tassonomia un po’
astrusa dei semiologi, Genette definisce il “peritesto”, per distinguerlo dai
discorsi che sul testo si fanno, recensioni, articoli di giornale, conferenze,
comunicazioni orali, come quella che io vi sto facendo in questo momento, che
appartengono al cosiddetto “epitesto”. Allora il lettore va in libreria, prende
questo libro, e vede che è stato scritto da un certo Giulio Stocchi, si
intitola L’altezza del gioco, con una
conversazione di Massimo Bonfantini, e delle fotografie di Fulvio Magurno, che,
presumibilmente, è anche l’autore della foto di copertina. Ora in un libro, in
ogni libro, non solo in questo, quello che più colpisce immediatamente, come un
biglietto da visita, è il nome dell’autore, nel mio caso Giulio Stocchi. E un
lettore diciamo così ingenuo, più avvezzo ad assistere a spettacoli televisivi
che a leggere libri, dovrebbe immediatamente sgomberare il campo da una
ipotesi, che pure è suggestiva e squisitamente letteraria, e immaginare che il
Giulio Stocchi che ha scritto questo libro non sia il personaggio della fiction
televisiva intitolata Vivere, che è
andata in onda su Canale 5,
il quale mio omonimo immaginario Giulio Stocchi,
interpretato da Beppe Convertini, è un ragazzo molto bello, molto giovane, di
trent’anni, che ha una professione, beato lui, molto remunerata, fa l’operatore
televisivo, e con questa sua professione ha modo di andare in paesi esotici, di
avere avventure mirabolanti, e ripetuti commerci carnali con fanciulle
splendide.
Sgomberato il campo da questa ipotesi, e restituitomi al
mondo reale, che per certi versi è molto più banale di quello della patinata
fiction televisiva, un lettore un po’ attempato, e forse milanese, potrebbe
associare il nome dell’autore, Giulio Stocchi, a quel ragazzo che andava in
piazza, tanti anni fa, a urlare le sue poesie.
Che cosa ne sanno
Mister Plant e
mister Andrews
che cosa ne sanno
i signorini della
City
di quanto pesa la
pietra
che il pomeriggio
lungo
di chi è senza
lavoro
trascina?
Le leggi del
mercato
dicono costoro…
Forse qualcuno di voi ricorderà… Ma anche chi non avesse
udito la voce di quel ragazzo in piazza, leggendo le note di copertina del
libro, verrebbe a sapere che Giulio Stocchi è un signore in età, nato nel 1944,
il quale ha studiato filosofia e recitazione e ha incominciato la sua
“carriera” di “poeta pubblico” nel 1975. E da allora, e per molti anni, i suoi
palcoscenici, dice la nota di copertina, sono state le piazze, le
manifestazioni popolari, le fabbriche occupate e adesso i suoi palcoscenici
sono diventati i teatri, le aule universitarie e le sale di conferenza.
Leggendo la nota di copertina che riguarda specificamente
il libro, L’altezza del gioco, il lettore viene a sapere che questo libro è la
continuazione ideale di un libro che l’autore ha scritto tanti, tanti anni fa,
nel 1980, intitolato Compagno poeta.
A questo punto un ipotetico lettore berlusconiano
lascerebbe il libro sullo scaffale, nauseato dalla puzza di comunismo che
quella parola, compagno, evoca. Chi avesse la pazienza invece di andare avanti
vedrebbe che il libro è stato pubblicato dalla Casa Editrice Einaudi.
E allora potrebbe fare una riflessione e pensare che come
i palcoscenici dell’autore si sono per così dire ristretti, passando dalle
piazze, dalle fabbriche occupate e dalle grandi manifestazioni popolari alle
aule universitarie e alle sale di conferenza, così anche i suoi orizzonti
editoriali si sono rimpiccioliti passando
dalla casa editrice più prestigiosa italiana, l’Einaudi,
a una piccola, per quanto coraggiosa, casa editrice, e letteralmente isolata
proprio perché si trova in Sardegna, la Cuec, la Cooperativa Universitaria
Editrice Cagliaritana.
Però questa impressione di nobiltà decaduta, sarebbe
controbilanciata dalle altre note di copertina, da cui il lettore verrebbe a
sapere che personaggi di spicco, come Massimo Bonfantini, il quale è professore
universitario, fondatore del Club Psòmega, che unisce artisti, filosofi e
scienziati nello studio del pensiero inventivo, e di cui anche l’autore fa
parte, colui che ha introdotto e diffuso il pensiero di Peirce in Italia, e un
fotografo, più volte premiato, come Fulvio Magurno, che ha illustrato libri di
poeti tanto più importanti di me, come Eugenio Montale, questi due personaggi
si sono occupati dell’autore. E quindi tornando alla copertina, per restare
sempre sulle soglie del libro, il nostro ipotetico lettore, con i dati che ha a
disposizione, e osservando magari con più attenzione la copertina stessa con
questo libro spalancato di fronte al mare, e sul retro di copertina, ma
appartenente alla stessa foto, la nave che va, potrebbe concludere che esiste
un tale Giulio Stocchi, che appartiene proprio alla realtà e non è quel
personaggio immaginario, televisivo, che abbiamo visto, il quale Stocchi è
stato, e forse è ancora di sinistra, un tempo molto più famoso di quanto non sia
oggi, ma che gode ancora di qualche credito perché Bonfantini e Magurno si
occupano di lui, il quale Stocchi ritiene esista un gioco cui attribuisce una
importanza, una rilevanza, una altezza, una nobiltà, una eccellenza e che
questo gioco, presumibilmente, non è lo scopone scientifico, data la
professione dell’autore, ma è qualcosa che ha a che fare con i libri, con il
mare e con il viaggio per mare. Il lettore colto, però, di fronte a questo
titolo, L’altezza del gioco, non
potrebbe fare a meno di ricordare un libro famoso negli anni immediatamente
successivi al secondo dopoguerra, scritto alla fine degli anni ’30 da uno
storico olandese, il famoso libro di Huizinga intitolato Homo ludens. Huizinga ritiene che il gioco sia non solo precedente
la cultura per le ragioni che vedremo, ma addirittura sia la matrice di tutto
l’edificio della cultura umana perché, secondo Huizinga, dal gioco nascono il
diritto, la poesia, l’arte, la filosofia, lo sport, la guerra e così via…
Senza voler discutere le tesi di Huizinga, quello che a
me interessa è vedere come mai il gioco preceda la cultura: perché, dice
Huizinga, sia i cuccioli degli animali che i cuccioli degli uomini giocano. Il
gioco si radica nella nostra stessa animalità; il gioco accomuna i cuccioli
degli animali e i cuccioli degli uomini in quanto con il gioco entrambi
apprendono delle regole di comportamento. I cani fanno finta di combattere,
giocano alla guerra, per apprendere le regole del combattimento, e al tempo
stesso il ruolo che la società canina attribuirà ai due contendenti, a seconda
che uno vinca o perda, senza mordersi, appunto facendo finta. I cuccioli degli
uomini spesso giocano per dominare le loro paure. Esiste un gioco che si è
svolto sotto gli occhi di uno spettatore di eccezione.
C’era una volta, tanti, tanti anni fa, un bambino, il
quale aveva legato un filo ad un rocchetto. E il bambino, tenendo il capo del
filo, faceva rotolare questo rocchetto e gridando Fort! –il bambino era di
lingua tedesca- , gridando Via!, il bambino faceva scomparire il rocchetto
dietro a un mobile. Poi, sempre tenendo il capo del filo, il bambino, gridando
Da!, Qui!, tirava il rocchetto a sé, facendolo ricomparire. E da questo gioco
di comparsa e di scomparsa, il bambino mostrava di provare un grandissimo
piacere. Osservando il piccolo Ernst, questo è il nome del bambino, suo nonno,
Sigmund Freud, arrivò alla conclusione che il bambino traesse tanto piacere da
questo gioco perché riusciva a controllare l’ansia che provava nella realtà per
la scomparsa, per l’assenza, della sua mamma. Cioè il bambino, in una
situazione convenzionale che è il gioco, e facendo finta che il rocchetto fosse
la sua mamma, ne controllava la sparizione e la ricomparsa e controllandola
riusciva a dominare la propria ansia. Ci sono dei casi in cui un poeta usa dei
nomi propri così come il piccolo Ernst usava del suo rocchetto, cioè per trarre
a sé una presenza. E infatti, sempre sulle soglie del libro, nella prima pagina
bianca, ancora prima del titolo, voi potreste leggere una dedica: “A Deborah
Strozier”, questo è il nome proprio, e in corsivo “perché fu nel tuo deserto
l’acqua”. Ora, il corpo tipografico denuncia subito che
questo “perché fu nel tuo deserto l’acqua” è
probabilmente un verso di una poesia che forse si trova
all’interno del libro e con questo il lettore apprende l’esistenza di una
persona buona e gentile, com’è la mia compagna Deborah, che l’autore considera
come il bene più prezioso, come l’acqua nel deserto… Non solo, ma il lettore
viene rassicurato sulla fra virgolette “normalità” dell’orientamento sessuale
dell’autore. E anche questo vuol dire qualcosa, perché se avessi per esempio
scritto: “A Massimo Bonfantini, perché fu nel tuo deserto l’acqua”, l’ipotetico
lettore berlusconiano, o semplicemente benpensante, avrebbe buttato via il
libro pensando “Non solo cose da comunisti, ma addirittura da culattoni!”.
Ma il lettore viene anche a sapere che l’autore è stato
in un qualche deserto, probabilmente un deserto di sentimenti, dato che dedica
il libro a una donna. Però il lettore culturalmente addestrato, con una memoria
sua culturale, potrebbe ricordare la nota massima paolina: “Vox in deserto clamantis”.
La voce di chi grida nel deserto. Chi mi conoscesse, o avesse letto le note di
copertina, potrebbe identificare le poesie che il ragazzo gridava tanti, tanti
anni fa in piazza, con il grido dei profeti e il deserto con una certa sordità
che l’autore attribuisce alla società in cui vive.
Se poi il lettore, oltre ad essere colto e dotato di una
memoria culturale, fosse anche, come Bonfantini e tanti altri qui presenti, un
semiologo, sentendo parlare di deserto non potrebbe non ricordare l’analisi che
Riffaterre nel suo La semiotica della
poesia, compie del poemetto di Théophile Gautier, In deserto, mostrando come vox clamantis sia l’ipogramma, cioè ciò
che la poesia sottintende, non dice esplicitamente, il buco, come dice
testualmente Riffaterre, attorno al quale ruota la ciambella della poesia, ma
che fa della voce che nel poemetto di Gauthier parla un grido di angoscia nel
deserto della vita…
Si creano cioè, come vedete, delle attese, delle ipotesi
di lettura, che il libro dovrà confermare o smentire. Perché faccia questo,
bisogna addentrarsi un pochettino nel libro, cosa che farò entrando in quello
che è l’ingresso del libro, l’introduzione, cioè quello che Borges definiva il
vestibolo del libro, in cui il futuro lettore si aggira ancora incerto se poi
entrare nell’edificio principale dell’opera.
Vestibolo che io però preferirei definire l’iconostasi
del libro. L’iconostasi è nelle basiliche paleocristiane e bizantine il luogo
che dà adito allo spazio dove vengono custoditi gli arredi sacri, i
tabernacoli, le ostie consacrate. Dove cioè c’è la presenza del sacro e del
mistero. E questo per sottolineare una cosa che noi tendiamo a dimenticare
della lettura e del libro, cioè il carattere magico-sacrale della lettura:
quando noi apriamo un libro ci affacciamo su uno spazio ignoto, un mondo in cui
si aggirano quelle ombre che sono i personaggi della finzione letteraria, a cui
noi conferiamo esistenza investendole del nostro immaginario, sacrificando
loro, per così dire, il nostro sangue, così come Ulisse faceva nell’ XI libro
dell’Odissea quando sacrificava il
sangue degli animali perché le ombre dei morti parlassero; un mondo, quello del
libro, in cui parla sempre una voce assente, il più delle volte la voce di uno
scomparso, che spesso sale da un abisso di secoli, e qualche volta addirittura
nel libro risuona la stessa voce di Dio, quando si aprono i libri sacri
dell’umanità. Questo noi tendiamo a dimenticarlo, ridotti
come siamo alla figura di clienti, di acquirenti. Noi spesso ci plachiamo, ci
accontentiamo di comprarlo, il libro, e spesso lo usiamo come un oggetto di
arredamento. Per parlare del nostro amato Presidente del Consiglio Berlusconi,
lui si vanta di non avere avuto il tempo, da vent’anni, di leggere un libro
–posto che sia capace di farlo- perché è troppo impegnato a lavorare per il
bene del paese. Eppure voi avrete visto che nei comizi televisivi con cui ci
affligge, ha sempre cura di usare dei libri come di oggetti di arredamento,
mettendoli in bella mostra dietro di sé, libri spesso di quella Casa Editrice
Einaudi, cioè la casa editrice di quei comunisti che Berlusconi detesta.
Ma se noi abbiamo dimenticato questo, gli Antichi avevano
ben presente questo carattere magico-sacrale della lettura, tant’è vero che
Platone nel Fedro mette in scena quel
gustosissimo dialogo fra il dio Teuth, che ha inventato la scrittura e quindi
la possibilità della lettura, e il faraone Thammus:
“Io ti porto un grande farmaco”, dice Teuth al faraone,
“un grande rimedio contro la smemoratezza degli uomini, perché gli uomini
leggendo potranno ricordare quello che hanno detto e fatto”. E il faraone acconsente:
“E’ vero, Teuth, tu mi porti un grande farmaco”. Però giocando sul doppio
significato che il termine farmakon ha in greco, “mi porti un grande veleno,
perché gli uomini impigriranno nella lettura e non eserciteranno più la
memoria”.
Come al solito Platone ci fa vedere due lati della cosa,
con una verità in ciascun lato. Io stesso che ho preparato questo discorso che
vi sto dicendo, ho rifiutato di scriverlo, perché avevo paura di impigrirmi nella
traccia scritta. E così ho continuato per giorni a scrivermelo, a ripeterlo nella
testa e facendomi passare per matto, andando in giro per le strade senza
accorgermi che spesso muovevo le labbra ripetendolo ad alta voce. Ma nello
stesso tempo aveva ragione Teuth, perché la scrittura è il farmaco, il rimedio
più grande ed efficace che l’uomo abbia inventato perché la voce di chi un giorno
ha parlato risuoni ancora. La prima voce che parla nel libro,
nell’introduzione, e parla non un giorno qualsiasi, ma, guardate un po’ il caso,
parla il 20 marzo del 2003, cioè il giorno di inizio di quella sciagurata guerra
che gli psicopatici della Casa Bianca hanno scatenato contro l’Iraq, la prima
voce è quella calda e profonda di Massimo Bonfantini. Il quale Bonfantini mi
rivolge una domanda semplice, svagata, apparentemente addirittura banale. Una domanda
cioè socratica… -“Eh, Socrate,
quell’uomo sublime, che parla di zoccoli, di asini, di contadini, di cose
comuni, di gente che va al mercato”, dice Alcibiade nel Simposio, parlando del
suo amore Socrate-.
Perché la semplicità è per così dire la cifra del
discorso socratico: la domanda socratica è la più semplice – “Tì estì?”, Che
cos’è questo? Che cos’è il giusto? Che cos’è il bello?-. E Bonfantini mi
chiede: “Ma come ti è venuto in mente di fare il poeta?”-. Una domanda
semplicissima. E se l’arte del dialogo, come diceva Platone nella VII Lettera,
consiste nello sfregare le parole per produrre quella scintilla che ci
restituisca nel suo splendore l’idea, il lampo prodotto dalle parole di
Bonfantini mi ha restituito non un’idea, ma l’immagine di me stesso bambino,
quindi nell’età dei giochi, chino su un foglio a giocare per la prima volta con
le parole nella prima poesia che avessi mai scritto. In realtà ne avevo scritte
altre di poesie, ma questa, scritta verso i nove, dieci anni, era accompagnata
da quella sensazione fisica di vertigine, di travolgimento, di rapimento che
avrei sempre ritrovato in vita mia ogni volta che mi fossi accinto a scrivere
una poesia. Una sensazione talmente forte, la prima volta che mi si presentò,
che può essere paragonata solo alla sensazione che il ragazzino o la ragazzina,
giocando distrattamente col proprio corpo senza sapere bene che cosa fa, prova,
masturbandosi, quando avverte per la prima volta il piacere.
E allora rispondevo a Bonfantini: “La poesia non mi è
venuta in mente, mi è entrata in corpo”. E da allora non mi avrebbe mai più
abbandonato. Quando una delle poche copie del libro che avevo a disposizione
l’ho data a Stajano, regalata, lui mi ha scritto mostrandosi ammirato per la mia
“fissazione”. Cioè per la mia lunga fedeltà a quel primo gioco con le parole.
E che cosa facevo con quel primo gioco con le parole?
Parlavo di un mazzo di carte, cioè, guarda caso, di uno strumento con cui si
fanno tanti giochi:
“Una volta nella
spazzatura
trovai un mazzo di
carte
sporche, stracciate
fra la segatura…”
E poi il bambino immaginava di raccogliere questo mazzo
di carte e di metterlo “fra un portacenere e un fermacarte”. E seguiva questa
improbabile ascesa sociale del mazzo di carte, che doveva concludersi con una
catastrofe perché il fermacarte dice al povero mazzo “torna coi pari tuoi nella
spazzatura!”. E non solo: la poesia di questo bambino di nove, dieci anni aveva
una conclusione gnomica:
“Se sei di bassa
condizione
non tentare di
andare in alto
ché oggi il
fermacarte
mi dié una gran lezione!”.
Per la prima volta con il gioco delle parole, io mettevo
per iscritto quello che avevo appreso, quello che mi era stato insegnato. Ed
era quello che tutta la mia vita futura, e di gran parte di quelli della mia
generazione, avrebbe dovuto confutare alla radice, ritenendo ingiusto,
ritenendo sbagliato, ritenendo iniquo, quello steccato che vuol dividere gli
uomini in due categorie, in due specie: coloro che stanno in alto e coloro che stanno
in basso, non appena io, e tanti altri della mia generazione, avessimo compreso
che le carte che hanno in mano quelli che stanno in basso e quelli che stanno
in alto, sono carte diverse nel gran gioco della società, e quindi questo gioco
è in origine truccato, i giocatori, quelli che stanno in basso e quelli che
stanno in alto, sono sfalsati da un dislivello, da uno squilibrio, da quella
che io chiamo una “storpiatura” che riguarda ogni aspetto della nostra vita
collettiva e individuale. Una storpiatura che nella sua figura sociale ci viene
incontro con la faccia dello sfruttamento, e nella sua faccia individuale, cioè
quella che riguarda ognuno di noi, senza
differenze, dominanti e dominati, l’immiserimento
antropologico di cui tutti siamo vittime, è l’inautenticità, cioè il fatto che
siamo in qualche modo tutti noi esuli a noi stessi, in un certo qual modo
proscritti dalla terra, dalla patria, delle nostre aspirazioni più profonde,
costretti come siamo a indossare ogni giorno la maschera che ci consente di
adempiere al ruolo che un gioco sociale, profondamente truccato, ci impone.
Ruolo e regole, che poi secondo me si riducono a una sola, seguire le leggi del
mercato che quel lontano ragazzo denunciava in piazza tanti anni fa, quelle
leggi che ci vogliono, e ci riconoscono, unicamente come cose o proprietari di cose.
Così che gli uni sono condannati a guadagnarsi, come si dice, la vita, e cioè a
venderla per arricchire altri, i quali, a loro volta, si aggirano nell’immenso
supermercato di cui sono padroni e, specchiandosi nella merce e identificandosi
con essa, perdono se stessi. Ed ecco allora, in questo libro, riaffiorare le
voci e i volti di quelli che stanno in basso e di quelli che stanno in alto che
ho avuto modo di conoscere nella mia esistenza o di immaginare nel mio lavoro
di poeta. Quasi che quella prima poesia bambina, Il mazzo di carte, mi avesse,
per così dire, destinato, o forse condannato, a decifrarne per tutta la vita le
figure che allora non ero stato in grado di comprendere o avevo travisato, secondo
quanto mi era stato insegnato. E sono allora, nel libro, le figure
agghiaccianti del potere, di quelli che hanno
corrotto, rubato,
istupidito,
inebetito,
devastato e ucciso:
gridano ordine
e intendono
silenzio
la democrazia è
salva
dicono
e rosicchiano
intanto
E le voci e i volti di quelli che dal potere sono stati travolti, perché ne sono diventati vittime:
al letto dunque
verranno legati
e perché non
possano
troncarla coi denti
dalle narici
una cannula di
gomma
verrà introdotta
fino allo stomaco
e una soluzione
altamente nutritiva
immessa nel corpo e
attraverso
le vene anche
O le voci e i volti di quelli che sono diventati vittime
del potere perché se ne sono fatti complici:
dicono
che avendo votato
come avete
votato
ed essendovi per di
più
abbandonati ad urla
scomposte
d’entusiasmo
vi siete da voi
stessi
posti fuori
dal Sindacato
“il nullismo non
paga”
Dicono
E le voci e i volti di quelli che a quel potere hanno
pervicacemente resistito:
e da sempre
considerati
fiato
e sudore
considerati
quelli
che ci si ingrassa
al tempo
dell’abbondanza
e che in tempi
di crisi
si scaccia
noi
uomini
tuttavia
e non
numeri
da allineare
in colonna
o bestie
trascinate
dove
la vita
l’appendono
per affittarla
ad ore
E ancora, le voci che mi abitano, i miei, per così dire,
personaggi interiori. La voce dello smarrimento:
è questa sofferenza
l’unica dignità
l’unico emblema
questa pioggia
sottile
che cade
questa insistenza
E la voce della
speranza:
bella da niente
che sarai regina
sarai luna
sarai stella
e il vento ti
porterà
via
E la voce della
solitudine:
gli orologi delle
cucine
dove l’uomo solo
distrattamente
mangia
fra un muro di
piastrelle
e una notizia
fissando gli occhi
lungo le infinite
parallele
di un rancore senza
ricordi
e poi
scuotendo la testa
mormorando
come ubriaco
le stesse parole
per tenersi
compagnia
o sentirsi
disperatamente
vivo
e quindi
alzandosi
fra i piatti
sporchi
E la voce della
solidarietà:
canterà l’allodola
pazza
e i continenti
disancorati dai banchi sottomarini
andranno a spasso
per il corso della storia
mettendo l’abito
buono dell’eguaglianza
e della libertà
E la voce e i volti delle donne amate, quelle che sono
state il conforto di intere stagioni della vita:
ma renderai grazie
alla dolce
che sostenne nel
limite del tempo
il passo che
indugiava
perché fu nel tuo
deserto l’acqua
E la voce e i volti delle donne incontrate a caso, quelle
che sono state forse il sollievo di una notte:
e poi
le strade della
notte
Margherita che
scendi le scale
nel tuo delirio di
sogni
e bicchieri
stringendoti morti
bambini
fra i denti
e parlando
parlando
parlando
E poi ancora Calcante, Ulisse e gli ulissiadi, su cui tra
poco tornerò… E infine, in questo libro, la voce e i volti di coloro che mi
sono stati maestri, quelli che mi hanno aiutato a decifrare le figure di quel
mazzo di carte. Personaggi noti e meno noti: Franco Fortini, da tutti
conosciuto, Renato Boeri, neurologo di fama, che è stato il fondatore di
Psòmega insieme a Bonfantini, lo stesso Bonfantini, i membri di Psòmega qui
presenti che sono citati uno per uno, che tanto mi hanno insegnato, il mio
grande amico scomparso, Nino Jomini, e ancora Livia Rokah, Uri Avneri, Corrado
Stajano e tanti, tanti altri, una folla, in questo libro, di personaggi, rievocati
in prosa e, più spesso, in versi, in poesia. Però la poesia è un gioco che ha
delle regole ben precise, che ha dei meccanismi molto oliati, esatti, precisi, come
un orologio. Ed ecco allora nel libro anche aprire per così dire le porte dell’officina
della poesia, per cercare di mostrare come si scrive una poesia, quali ne sono
le leggi, che poi, secondo me, si riducono a una: quel particolare rapporto fra
suono e senso che vige in poesia, per cui a un certo punto nel libro posso dire
che “la poesia vive nella passione, o, per meglio dire, è la passione per il
corpo sonoro della lingua che essa stessa è e cieco di fronte al quale corpo il
poeta smarrisce il proprio dono, perde, come si dice, l’ispirazione, e in
quanto poeta tace”.
Ecco, ma allora mi direte: “accidenti, Fortini, Calcante,
Ulisse, la poesia, la prosa, le donne… Ma come hai fatto a mettere ordine in
tutto questo guazzabuglio? Qual è il gioco, quali sono i meccanismi, quali sono
gli ingranaggi di questo libro?”.
Il libro è diviso in 18 sezioni, capitoli, lasse,
chiamatele come volete, 6 in prosa e 12 in poesia. Si tratta quindi di quello che
tecnicamente si chiama un prosimetro, un genere di cui la Vita nova di Dante è,
nella nostra letteratura, l’esempio più illustre. La stesura di questo libro mi
ha impegnato circa 6 mesi, dall’estate del ’99 al gennaio del 2000. Avevo
davanti una massa sterminata di materiali che coprivano più di trent’anni di
lavoro: canti di un poema che risale agli anni ’69-’73, le poesie di agitazione,
le poesie di lotta, le poesie di riflessione, di amore, brani in prosa,
racconti, analisi e così via…
Come ho fatto? Ho usato quello che ho imparato da
Pudovkin, il grande regista russo. E cioè il sistema del montaggio, proprio in
senso cinematografico. Pudovkin, ne La settima arte, diceva che niente è più
lontano dalla realtà di quello che pensa il profano. Cioè il film non è il
seguito, il susseguirsi, dei fotogrammi che il regista gira. Il regista gira un
sacco di materiale, poi alla moviola prende un fotogramma, lo isola dal suo contesto,
lo incastra, lo incolla, lo cuce a un altro fotogramma, prende un altro fotogramma
lo incastra agli altri due e crea quelle che Pudovkin chiama “le frasi di
montaggio” che entrano a fare parte, che costituiscono le articolazioni del
discorso del film. Io ho fatto la stessa cosa: ho preso per dire un canto del poema,
scritto nel ’70, ho visto se si adattava per affinità di argomento o per ritmo,
o in vista del discorso che volevo fare, con una poesia successiva, ho cucito
il canto e la poesia con un’altra poesia, e ho creato una sezione in poesia.
Questa sezione l’ho poi accostata, cucita, incollata a un racconto in prosa e
così via, creando le mie “frasi di montaggio”. E per descrivere questo lavoro
ci vengono ancora una volta utili gli
Antichi, perché i Greci definivano questo lavoro di
calettatura harmottein, un termine che descrive il lavoro con cui un falegname
unisce, incastra i pezzi di legno che formeranno il suo mobile, e con un
curioso slittamento semantico da quell’ harmottein è derivata la parola
armonia. Ecco, quello che io mi proponevo era di creare uno spazio armonico,
una specie di partitura in cui potessero risuonare con assoluta precisione la
polifonia di voci che c’è in questo libro e che permettesse di presentare, di fare
scomparire e di riprendere i temi di questa sinfonia che è in un certo senso il
libro. Sono così nate quelle 18 sezioni che vi dicevo, ognuna delle quali ha un
titolo e ognuna delle quali è introdotta da una citazione: la prima sezione,
intitolata Agli estremi confini, è introdotta da una citazione presa
dall’ultima lassa del libro, intitolata L’allodola pazza, e via via tutte le
sezioni sono introdotte da una citazione presa dalla sezione precedente in modo
da ribadire con questo filo ideale l’unità del libro e, soprattutto, legare la
prima e l’ultima sezione, che sono due profezie, la profezia di Calcante e la
profezia dell’Allodola pazza. E tra queste due profezie si stende lo spazio che
io ho voluto, che ho ambito a costruire, in cui avessero agio di volteggiare,
per così dire, quelle figure, come in una coreografia che disegna il gioco, la
danza della fantasia su questo palcoscenico ideale che è il libro. Il gioco
della fantasia… Tra gioco e arte ci sono molte affinità, ma assolutamente una
differenza essenziale: il gioco è l’apprendimento di regole già date, regole di
comportamento per imparare a conoscere se stessi, a dominare le proprie paure,
a muoversi nella società…. La poesia e l’arte si spalancano sull’ignoto: sono
la ricerca della verità in una lingua convenzionale. L’ignoto… Ma allora qual è
il simbolo più abusato dell’ignoto che il mare? Ed ecco il mare, presente in
tante poesie e che costituisce per così dire l’orizzonte di queste voci:
amore fu di vento
che mi spinse
all’unica ricerca
verso il largo
di una terra che
l’immagine confonde
Ecco, le fotografie di Fulvio Magurno, che costituiscono
una sezione, una specie di libro fotografico
all’interno del libro, illustrano magnificamente questo
viaggio. E soprattutto la fotografia di copertina di Magurno è magistrale per
esprimere quello che il libro intende essere, con queste poche pagine davanti all’immensità,
queste poche righe di una piccola sapienza strappata all’ignoto, e sull’ignoto
una nave che va. E mi piace pensare che questa nave sia la nave di Calcante, di
Ulisse e degli ulissiadi. Ma perché Ulisse?
e giunti agli
estremi confini
si fece avanti
Calcante
con occhi di lustro
vento
ghiacciati dal
sonno notturno
Uomini mi sentite?
Ascoltate compagni
l’ultima parola
e la voce della
notte:
Solo nell’ora
infinita dell’alba
riprenderà il
viaggio
Perché il viaggio che Ulisse deve riprendere è il viaggio
verso la patria. Ulisse vuole tornare in patria. La patria… Quello che Ernst
Bloch, il filosofo tedesco a me tanto caro, definisce alla fine del suo capolavoro,
Il principio speranza: “La patria… Ciò che a tutti riluce nell’infanzia e dove
nessuno ancora è stato”. A tutti riluce nell’infanzia: cioè la tenerezza, la
dolcezza, il calore, il gioco, la magia, quello che pensavamo che a noi fosse
destinato e fosse la nostra patria, per poi apprendere nel corso dell’esistenza
che il mondo è una cosa tanto diversa, piena di spigoli taglienti, feroce nelle
sue divisioni, livido nei suoi bagliori, una giungla non un giardino. E allora
questa che abbiamo intravisto nell’infanzia diventa una terra lontana, “una
terra che l’immagine confonde”, ma dove Ulisse vuole tornare. La terra dove gli
uomini avranno cessato di obbedire alle leggi che li vogliono cose o
proprietari di cose, dove gli uomini saranno presso se stessi come in patria.
Dove cioè saranno liberi. Ecco, questo è il viaggio di Ulisse come io lo intendo
in questo libro, e questo libro è quindi la mappa di un viaggio che l’umanità,
o parte dell’umanità, continua a fare ad ogni generazione verso una sua possibile
liberazione.
E ancora, fra mappa ed arte ci sono delle grandi
affinità, perché la mappa e l’arte sono due modelli: la mappa è il modello che
costruiamo per spostarci nella geografia del nostro pianeta; l’arte è il
modello che noi costruiamo per addentrarci, per muoverci, nella geografia del
nostro immaginario, per scoprirne degli aspetti nuovi, e per tornare alla
realtà con occhi nuovi e arricchiti da quell’esperienza. E’ quella che i
teorici chiamano “la funzione modellizzante” dell’arte: plasmare il nostro
immaginario. Nel caso della poesia questo avviene nella cornice di un gioco in
cui ha modo di dispiegarsi il dono del canto, un dono sulla cui origine io
francamente non so dirvi niente, però in questa ignoranza sono in buona compagnia,
perché Aristotele nella Poetica
diceva che il dono del poeta è ciò che non può essere derivato da altri, non
può cioè essere né appreso, né insegnato. Ciò che però so è che il canto nella
poesia è l’articolarsi del gioco della voce, o delle voci, che nella poesia
risuonano. Ma allora, a ben sentire, dietro quella voce o quelle voci, come in
un effetto di riverbero, è ancora la voce sottile di quel bambino del primo
novecento, il piccolo Ernst: Fort-Da… Fort-Da, Via-Qui… Via-Qui…
Io quando sarò
andato via, quando non ci sarò più, sarò qui, in questo libro. Questa è la
grande scommessa dell’arte: sottrarre una voce e un volto al flusso del tempo.
Quando l’arte vince la sua scommessa, quando l’artista vince la posta del
gioco, la voce e i volti sono salvi, sono lì. Basta pensare ai monumenti della nostra
tradizione letteraria, per cui ancora oggi possiamo dialogare con Platone,
sorridere con Orazio, penare d’amore con Petrarca, fantasticare con Don
Chisciotte e Cervantes, disperarci con Leopardi e via, via con tutti gli autori
che il canone occidentale ci ha tramandato. E allora adesso, avviandomi alla
conclusione ed entrando per la prima volta nel cuore del libro, permettetemi di
congedarmi da voi, e ringraziandovi anche per l’attenzione con cui avete seguito
tutto questo, recitandovi nove quartine che sono al tempo stesso una
dichiarazione di poetica, un atto d’amore verso la poesia, e in un certo qual
modo un testamento. Nel libro queste quartine formano una sezione intitolata La gloria di Dio, e con questa dizione
io, che non sono credente, intendo indicare appunto il miracolo della voce
umana che si sottrae alla frana del tempo, la caduta della sabbia nella
clessidra, che tutti ci inghiotte. Ma “Gloria di Dio”
anche per indicare e ricordare il carattere e la natura
etimologicamente religiosi dell’arte e della poesia, perché la voce che l’arte
salva è la voce che religat e religit, che lega e che tramanda, cioè che lega i
presenti ai passati e ai venturi, tramandandone il volto. Che sconfigge cioè la
morte. E questa è quella che propriamente è l’altezza del gioco:
cristallo in
trasparenza di parola
a questa altezza si
conduce il gioco
stella d’assenza
astro che ruota
contro la notte
abbiamo aperto il fuoco
la gloria di dio la
casella vuota
perché lo sguardo
venga messo a fuoco
il tempo che
s’avvolge alla sua spola
di queste sfere
calibrando il gioco
ecco il teatro di
carta e la sua nota
a questa guerra non
si va per gioco
il giro esatto
della mola la vita
che è marchiata a
fuoco
la musica ferma la
giostra immota
su questo foglio dove tutto è in gioco
fiamma cha avvampa
in una rosa sola
è la brace in cui discorre
il fuoco
qui risplende la
moneta ignota
prima che strida la
civetta è l’ora
voce inattesa che
consola
scaverai di ora in
ora
vento perfetto eco
che vola
per fermare per sempre l’ora
luce sottratta alla
sua mota
il lampo breve che
fissasti ora
luna di divinante
gota
armonia ti sarà signora
grido travolto
nella gola
nei versi dove avrai dimora
obolo che tenebra
immola
nel canto tuo che
non dimora
notte che a fuoco
le sue lame arrota
contro il passo della nera signora
teorema di beltà
che ti innamora
l’avvento che sogna
la viola
dietro il paesaggio
che la neve invola
a questa altezza
che la morte ignora
LAURA MARGHERITA VOLANTE
AFORISMI
- Per prendere vie non sbagliate bisogna prima conoscere
quelle sbagliate
- Giusto o sbagliato? esiste il non sbagliato dal momento
che nessuno si può arrogare il diritto di decidere cosa è giusto...
- All’ "Ammazziamo il gattopardo" preferisco
"ammazziamo il tempo...". I gattopardi sono già morti, siamo
circondati da sciacalli.
- Depositi bancari: ingrassare la banca per dimagrire a
vista
- Deculturizzazione. Qualsiasi arte non risolve se prima
non si rimuove la causa
- Con la racchia non è mai una pacchia...
- Gli intelligenti si ritrovano anche senza incontrarsi
mai
- La vita è bella quando il teatro è dentro l'anima e non
il teatro a prenderti la vita
- Furbizia degli stolti è il non pensare che ci possa
essere qualcuno intelligente discreto e prorompente di idee
- Ignoranza dilagante non genera né belli né geni.
Bellezza e intelligenza sono
figli della conoscenza
- Narciso deve morire della propria immagine dissociata
per ritrovare il sé negato del proprio Ego
- Quando la vita ti mette di fronte a prove e le superi,
la sua fiaba è a lieto fine, di contro...sono cazzi tuoi!
- Global... tutto mondo è paese oggi diventa tutto paese
è mondo senza radici
- Staffetta: quando non si passa la palla il giuoco si
ferma
- Cultura e arte sono diventati il linguaggio dei vecchi
- Bisogna affidare l'Italia ai giovani talentuosi e non
'figli di papà': i grandi vecchi allora saranno un faro e i corrotti a riposo!
- Usi e Costumi: ieri si leggevano i libri di Agatha
Christie, oggi si seguono i gialli in diretta
- La crisi genera disuguaglianza: i ricchi in vacanza
alle Maldive, i poveri alle isole pedonali
- Chi sale d'importanza...la fa sempre cadere dall'alto
- Se non si cerca l'essenza prima o poi è lei a
trovarti...
- Sindrome di Icaro? I miraggi sociali producono falliti…
alimentano il senso di onnipotenza con caduta a picco
- Chi è molto profondo non riesce ad arrivare in
superficie
- Immaturità. Si può venire alla luce senza nascere mai
- Esercizio del potere è di chi pone condizioni a chi si
dà incondizionatamente.
-
L'estremizzazione sociale dei comportamenti inibisce la capacità di assumersi
gli oneri di scelte esistenziali
- Il ponte di Messina è un sacco senza fondo e senza mani
- La violenza del silenzio. Chi sta sempre zitto non solo
non rischia, ma induce gli altri a sentirsi in colpa senza capire il perché
- Ipocondria: vivere da malati per morire sani
- Chi non vuole perdere la faccia la mette sempre in
primo piano
- Il sogno più coraggioso è riuscire a realizzare una via
normale
- L'uomo nasce con il diritto di essere felice, ma con il
dovere di rendere felice la donna
- Meglio 10 uomini delusi di una donna infelice
- L'Amore vive su cime elevate anche se tempestose
- La gabbia è di chi non sa evadere...
- Si può essere dolci e spalmabili come la Nutella, ma
con il retrogusto amaro
- I comportamenti restano scolpiti nel tempo, le parole
volano per cadere nel vuoto
- Intelligenza è leggerezza mai banalità
- Crisi economica. I soldi ci sono ma hanno il vizio di
partire per la tangente
Usi e costumi:
- Stronz o strong?
io strong e tu?
- Prima uno faceva le sveltine... oggi un altro fa le
svoltine...
- Persino l'indignazione suscita risate tanto tutto è
paradossalmente ridicolo
- Unire l'utile al dilettevole. Sempre utile a qualcosa o
a qualcuno. E' il dilettevole che mi sfugge...
- Quando si dà il Bene la luce se ne va con esso e il
lume resta nel silenzio della solitudine
ORNELLA FERRERIO
AFORISMI
 |
| Ornella Ferrerio |
1.Ma, sarà vero che esiste – davvero – il vero?
2.Forse, se la mente si impenna è perché ha galoppato troppo.
3.Non c’è nulla da fare: la vita va vissuta in modo vivo.
4.Che cosa triste fare tappezzeria nel grande ballo della vita.
5.Ma davvero è il
colmo ridere da soli, disperatamente?
6.Devi tacere, se vuoi che il silenzio ti ascolti.
7.E’ quasi commovente la grande utilità dei numeri.
8.Certe coppie vivono come quelle delle casette segnatempo:
raramente escono insieme.
9.Che lavoro
estenuante sparire, ogni giorno, dentro
la propria recita.
E’ faticoso calcare le scene del mondo.
10.Quante volte
si chiede, al proprio letto,
l’elemosina del sonno?!
11.Alcuni momenti della vita assomigliano
a un viaggio faticoso, dove si parte con
piedi pesati e si torna con ali di piombo.
12.Ho proprio
l’impressione che, al destino,
gli fa proprio un
baffo di tante tragedie.
13.Chissà quante storie potrebbero
raccontare le ore misteriose del sonno!
14.Per fortuna ci sono tanti ponti
per attraversare la poesia.
15.Il poeta abita e indossa la poesia.
16.E’ la capacità di sopportare
la solitudine che può rendere
imperituro un amore.
17.Il nostro silenzio può essere la parola degli altri.
18.Il passare degli anni costringe a farsi bastare gli affetti.
19.Forse esiste la gelosia di Dio.
20.Martin, eroe di otto anni, ha difeso
la sorella sedicenne da uno stupratore, che
lo ha ucciso, colpendo ripetutamente
il suo viso minuto.
Mi viene da dire: santo
subito!
21.Un pensiero,
aggiustando la sveglia:
che gioia, il tempo può ancora continuare!
22.Il più grande mistero dell’anima è l’anima.
23.Quanto dolore
suscita la fame di tutto negli occhi
di certi bambini!
24.Ho perso una parola. Chissà, forse era fatale…
25.La curiosità è vitale per conoscere e sapere.
A volte, però, può fare molto
male.
26.Di questi
tempi, la parola più enunciata,
scritta, temuta, sussurrata o urlata, invocata, offesa
e vilipesa è: LAVORO.
***
HAIKU
Sole nascente
nel reame del niente.
Faro del nulla.
Cielo e mare.
Due lune lucenti.
Doppia la notte.
Pioggia silente.
Una stella nascosta.
Suono di luce.
Foglie d’ottobre
bruciavano nel loro
stesso colore.
Nuvole basse
dissetano i prati.
E’ nuova vita.
Perle di cielo.
Come giunchi spezzati
guizzi sul tetto.
Grida sul monte.
Gli echi conoscono
ogni dolore.
Sole sul bosco.
Tremolio di foglie.
Occhi di luce.
Ci sono spine.
Farfalle al lavoro.
Rose di maggio.
Inazzurrare.
Il sogno del glicine
nel pergolato.
E’ primavera.
Cip, cip anche sul verde
panno del poker.
Buio di notte
che inventa le stelle
senza la
Luna.
Nebbie dal mare.
Anche l’onda più alta
modera l’urlo.
Una eclissi.
Corruzione cosmica.
Luna e Sole.
Manto di neve
come velo di sposa.
Cima del monte.
Rondini a nord
si perdono adesso.
Climi mutati.
GRAZIELLA POLUZZI
AFORISMI
 |
| Graziella Poluzzi |
Il voto in
Italia è spesso vissuto come un 'mi piace' su facebook. Non si sceglie un
programma politico, ma un personaggio; 'mi piace' perché è ricco, energico, di
mondo, sa sempre galleggiare. Un voto dato a pelle sul calore della pelle del
prescelto, ma poi l'esito ricadrà su tutti noi nel modo in cui saremo
governati.
PDL: sistema politico ispirato alle televisioni. E'
costituito da un potente trasmettitore centrale e tanti ripetitori riceventi e
replicanti.
La TV è un po' come il bosco della favola 'Cappuccetto
Rosso': può attirare e sedurre, ma ci sono molte insidie nascoste.
L'occhio sedotto dall'immagine, domina il cervello, la
funzione visiva predomina sugli altri sensi e ci condiziona nel profondo.
Sono tante le donne masochiste presenti, passate e
future, ma l'etimologia della parola risale a un raro caso maschile, Leopold
Von Sacher Masoch: è una palese invasione di campo.
La solitudine è come l’aceto: poche gocce danno sapore,
troppe inacidiscono il gusto della giornata.
La lentezza è un indugiare nel fare ciò che piace,
rilassare il corpo e la mente: così si fertilizza il terreno in cui germoglia
l'estro del creativo.
Gli orologi ci martellano con i loro 'tic-tac-tic-tac-tic-tac'
veloci e inclementi, senza tregua ci ricordano che i minuti sfuggono da tutte
le parti.
In fondo al vaso di Pandora rimase solo la speranza, ma
la speranza umana è illimitata.
PIER LUIGI AMIETTA
L’emozione di apprendere
 |
| Pier Luigi Amietta |
La mia
personale esigenza, rispetto all’espressione “formazione emotiva” mi fa sentire
come inderogabile e prioritario definire il piano semantico e concettuale sul
quale l’espressione si colloca. Di conseguenza, la questione ci porta
immediatamente agli elementi costitutivi di questo sintagma.
Anzitutto, il
significato assunto, negli anni più recenti, del termine “formare”.
È ormai
pacifico che formare non vuol dire semplice trasferimento di saperi e, meno che
mai - superati i sogni di onnipotenza dei formatori degli anni Sessanta - imprinting
ideologico, ma il loro esatto contrario, vale a dire due cose: la prima, far
crescere nella persona la voglia di
cercare per meglio comprendere, l’entusiasmo di scoprire per vedere più chiaro,
la curiosità e l’interesse a porre nuove relazioni tra le cose; la seconda, creare le condizioni perché
la persona sviluppi quella libertà
mentale capace di sfuggire alle insidie di tutti i dogmatismi.
Il che, se si
vuole, è ciò che distingue la propaganda dall’educazione: la propaganda vuole far
passare sull’altro i propri valori, l’educazione lo aiuta a realizzare i suoi.
Il che,
ancora, vuol dire creare le premesse e
le condizioni perché la prima cosa possa
davvero realizzarsi e non restare un’edificante utopia.
In
definitiva, “formare” equivale sia a far crescere l’intelligenza, sia a
stimolare la voglia di apprendere. In più occasioni – da formatore, e dunque da
fonte non sospetta – ho dichiarato, e lo confermo, che nessuna formazione può
valere a lungo (o valere, semplicemente), se non diventa rapidamente
auto-formazione.
Questo ci
porta al centro del nostro discorso: infatti, se formare vuol dire far crescere
l’intelligenza (uso ostinatamente il singolare, per le ragioni di cui fra
breve), “formare emotivamente” c’induce preliminarmente ad affrontare la
questione se esista – e se sì, con quali accezioni – un’intelligenza emotiva,
che è il primo punto che vorrei affrontare, anche perché su questo binomio ha
costruito la sua notorietà lo psicologo Goleman e consolidato il loro fatturato
una pletora di golemanini in sedicesimo.
Il secondo punto
sarà: se, in che modo e fino a che punto, un’emozione
(che è cosa diversa dall’emotività e sta all’emotività come la sensibilità sta
alla commozione) possa giovare all’apprendimento.
Il terzo
punto di nostro interesse è se sia possibile (e come) valutare, se non
misurare, questo tipo di apprendimento.
1. Si può apprendere senza emozione?
La prendo un
po’ alla lontana, ma arriverò rapidamente al cuore del problema.
Negli ultimi
decenni del secolo scorso, gli studi sulla vita mentale hanno avuto una
diffusione notevole, forse maggiore del loro progresso reale.
Tra gli
autori che, a distanza di dieci anni l’uno dall’altro, hanno dato un
apprezzabile contributo a questi studi due vanno subito citati perché, sia pure
non occupandosi degli stessi temi che in modo tangenziale, hanno tra loro una
affinità indiretta rispetto al problema dell’intelligenza. Si tratta di Howard
Gardner e di Daniel Goleman che, a distanza di dieci anni l’uno dall’altro,
hanno pubblicato i lavori per i quali sono più noti: il primo, nel suo libro più celebre, “Frames of mind - the theory of multiple intelligences”,
tradotto in “Formae mentis – saggio sulla pluralità dell’intelligenza”; il
secondo con la sua fin troppo nota “Emotional
intelligence”, diventato, nella versione italiana “Intelligenza emotiva”.
Entrambi gli
autori hanno un grande merito e, a mio modo di vedere, una altrettanto grande
responsabilità.
Il merito è
di aver proseguito nell’esplorazione di quel pianeta, tuttora molto misterioso
che è costituito dal funzionamento della nostra testa, dei rapporti
cervello-pensiero (intesi come rapporti tra organo e funzione) e, più
generalmente, della vita mentale. Esplorazione difficile, faticosa, viziata
dall’aporia dell’autoreferenzialità, ossia da quella sorta di peccato originale
per cui la spiegazione di un sistema avviene necessariamente adoperando lo
stesso sistema che dev’essere spiegato. Ciononostante, è degno della massima
attenzione qualunque sforzo sia compiuto, attraverso la ricerca, per saperne di
più sulla sola cosa che ci distingue dai vegetali.
La
responsabilità (si badi bene, non la
colpa) è quella di aver generato – quasi
involontariamente, mi sento di sostenerlo – due micidiali equivoci e, per
gemmazione spuria dalla loro ricerca originale, una colluvie di studi
successivi che non soltanto non hanno saputo chiarire gli equivoci, ma, chi più
chi meno, li hanno aggravati.
Il “quasi” è
dovuto ad alcune affermazioni “fuori giri”, potremmo dire in gergo motoristico,
che questi equivoci hanno potuto indurre.
§ Howard Gardner, per primo: nel suo
entusiasmo classificatorio ha parlato di “nove forme di intelligenza, del tutto
autonome tra loro”, usando un
aggettivo di troppo, “autonome”, appunto. E qui il Frames del titolo originale la dice lunga sullo sforzo di
evidenziare, per inquadramento e delimitazione, tali supposte autonomie. Ora,
poiché “l’autonomia” origina da operazioni mentali di tipo categoriale e non di tipo
osservativo (vale a dire - in termini più semplici – che è una categoria
mentale e non qualcosa che si vede con gli occhi) è evidente che parlare di
forme di intelligenza, intese come veri e propri modelli mentali del tutto
autonomi fra loro è insieme una gratuità e una petizione di principio, dovuta
al più classico degli errori epistemologici, noto come “fisicalismo”, che
consiste nel crede di “trovare” un significato nello stesso momento in cui
invece lo si attribuisce. Infatti, basta
attribuire non importa a che cosa leggi proprie per farlo diventare autonomo. Insomma,
l’errore consiste nell’attribuire alla funzione di un organo le stesse leggi
che Kant, parlando di autonomia, applicava alla morale, per poi validare questa
attribuzione ipotizzandone addirittura un substrato biologico, ovviamente del
tutto impossibile da dimostrare.
Vi sono
almeno due riprove delle difficoltà che sorgono sostenendo questa posizione:
- la prima è
che lo stesso Gardner, una volta completata la sua tassonomia, ha dovuto
riconoscere l’esistenza, oltre alle sue “nove intelligenze”, anche di un numero
indefinito (e, ovviamente) indefinibile di “intelligenze personali”1,
secondo la sua stessa formulazione; con ciò riconoscendo implicitamente non
solo di non aver affatto completata la classificazione, ma che questa
non è in alcun modo completabile;
- la seconda
(e di questa sì c’è un riscontro anatomo-fisiologico) è che in caso di lesioni
cerebrali gravi del cervello, che ne compromettano la funzione di una zona, si
assiste molto spesso al subentro di altre zone del cervello in funzione
vicariante di quella compromessa: il che contraddice contemporaneamente sia
l’idea dell’autonomia, sia l’idea di un substrato biologico deputato in via
esclusiva ad una funzione.2
Altro – e ben
più condivisibile – sarebbe il partire da una visione olistica
dell’intelligenza (intesa come capacità di porre rapporti), per poi riconoscerne
differenti possibili settori d’applicazione, questo, oltre ad essere ben noto,
è addirittura un’ovvietà.
§ Daniel Goleman, per secondo – e siamo in medias res, come si dice – parlando
di “intelligenza emotiva” ha generato il secondo equivoco: Goleman, come
Gardner, ha applicato al termine “intelligenza” un aggettivo (“emotiva”) che
non solo è di troppo, ma è addirittura tautologico.
Senza mai
affermarlo esplicitamente, il lavoro di Goleman suggerisce, un po’
ambiguamente, l’idea di un’intelligenza, quella “emotiva”, per l’appunto (o di
una “passione”, o di una “memoria sensitiva”), separata e distinta
dall’intelligenza tout court. Cosa che, se fosse così – come
sembrano credere, al punto da scriverlo, i tanti Goleman in sedicesimo3
che, dopo di lui, più realisti del re, hanno
intonato il coro dell’intelligenza emotiva – sarebbe davvero singolare.
Vorrei
allontanare da me il sospetto di nominalismo: il binomio “intelligenza
emotiva”, anche se resta vago e impreciso, è perfettamente accettabile, come lo
sono “emozione”, “affetto”, “sentimento”, ecc., quando designano certe
tipologie di pensieri. Altrettanto lo sono i termini “affetti” e “affettività”,
“sensibilità ed emotività”, quando designano la caratteristica di certe persone
a lasciarsi visitare più di frequente della media da quelle tipologie di
pensieri.
Fuori da
questi casi, si tratta di un errore di tipo
“fisicalista” (ecco la “parentela” tra Gardner e Goleman), nel senso già detto:
ritenere “esistente” di per sé, con caratteristiche autonome proprie oggettive riscontrabili - e quindi suscettibile di
essere “scoperto”, come se si trattasse di un oggetto fisico (per es. un fungo)
- qualcosa che è invece e in ogni caso
identificabile col pensiero o, se volendo proprio essere puntuali, con una
delle sue tante caratteristiche. Il fatto che esistano alcune situazioni esterne – accadimenti, condizioni di vita, ecc. -
e alcuni contenuti di pensiero che, in
certe persone (e non in altre, ecco l’errore fisicalista!) influiscono sul
battito cardiaco, sul circolo del sangue e sul ritmo del respiro e inducono
alcune reazioni vagali - rossore, sudorazione, ecc. - comunemente definite come
“emotive”, non toglie loro in alcun modo il carattere di pensieri, ossia di operazioni
mentali, in ciò del tutto simili ad altre che non hanno particolari
influenze sul sistema nervoso periferico o che, restando le stesse, in altre
persone non inducono proprio un bel niente.
Di
conseguenza, mi sembra che nulla autorizzi a parlare di una “intelligenza
emotiva”, come se si trattasse di qualcosa di autonomo rispetto
all’intelligenza tout court:
nessuna “emotività” può darsi, se non è
generata prima da un pensiero, altrimenti non potremmo mai distinguere le
lacrime della cipolla da quelle per la morte di un amico; ciò è confermato,
oltretutto, dal fatto che vi sono notoriamente situazioni che generano
contenuti di pensiero in grado di influire in senso emotivo su alcune persone,
mentre lasciano del tutto indifferenti altre: una formula matematica può
emozionare uno e far sbadigliare un altro.
Qual è il
problema che sorge? È che, ovviamente, una volta accettato che il pensiero
emozionale è fenomeno autonomo rispetto a quello “non emozionale”, non c’è più
limite alle conseguenze e implicazioni: l’emozione diventa una disciplina, che
si può insegnare come l’algebra e altre amenità di questo genere; si arriva infatti
(parola di Goleman) a parlare di “alfabetizzazione emotiva”4
2. Quanto l’emozione facilita
l’apprendimento?
A questo
punto, possiamo riproporci la domanda iniziale: se l’emozione
sia utile all’apprendimento e con quali implicazioni metodologiche e didattiche.
E ancora, domanda non peregrina:
quali emozioni influiscono positivamente
e quali negativamente sull’apprendimento?
Quanto al
“se”, la mia risposta è: in prima approssimazione, certamente l’emozione è
utile all’apprendimento e può esserlo anche moltissimo. Dico “in prima
approssimazione”, perché in realtà dovremmo metterci d’accordo su almeno una
cosa: di che tipo di apprendimento stiamo parlando. Senza arrivare alla
nomenclatura di Umberto Galimberti5 probabilmente un po’ pletorica,
visto che ne elenca e definisce addirittura trentuno diverse forme, dovremo almeno focalizzare il discorso
sull’apprendimento cognitivo complesso, ossia quello che coinvolge funzioni
mentali superiori, come la percezione e l’intelligenza, riferite all’umano
adulto intellettualmente normodotato; e,
magari, distinguere l’apprendimento in praesentia da quello a distanza, che
presentano problemi di natura psicologia molto diversa, come è stato dimostrato
anche di recente.6
Ma sappiamo, in
ogni caso - è un dato acquisito della psicologia cognitiva, nonché confermato
dall’esperienza empirica di ciascuno di noi - che:
§ qualsiasi contenuto d’apprendimento si
fissa di più, meglio e più a lungo se è
accompagnato da un’emozione: una nozione appresa in clima di forte tensione emotiva
non si dimentica più;
§ certe situazioni e particolari pensieri (le cosiddette fantasie o
rappresentazioni) sono in grado di attivare alcuni circuiti fisiologici che,
una volta attivati, generano direttamente altri pensieri, che chiamiamo
“emozioni”. Per inciso, in questo caso, il “percorso” delle operazioni mentali
è più lungo, sia pure di tempuscoli: ecco perché si fa prima a pensare alla
data di nascita di Dante che a un amore perduto;
§ nell’attività didattica, occorre
adoperarsi il più possibile per favorire nei discenti questa tipologia di
pensieri, privilegiando naturalmente quelli utili agli effetti
dell’apprendimento. Sembra evidente, allora che il formatore capace di
suscitare emozioni (intese, ovviamente, come quelle favorevoli
all’apprendimento, ossia suscettibili di una valutazione positiva dello stimolo)
dispone, a parità di contenuti e di ogni altra capacità, di una chance
ulteriore tutt’altro che secondaria. Il
che risulterà in ogni caso molto più facile se questi particolari pensieri sono già patrimonio del formatore, così
da poterli comunicare (mai più adeguato di questo il significato di “mettere in
comune”) al discente. Per chi avesse avuto la fortuna di assistere a lezioni di
Luigi Pagliarani o di Silvio Ceccato non occorre aggiungere altro. E cito solo due
grandi morti, per evitarmi complicazioni “politiche”, ma potrei citare anche
alcuni vivi. Non molti, per la verità.
Sappiamo tutti
quanta parte di questo vi sia nelle metodologie di “empowerment” e anche di
“self-empowerment”7, perché sappiamo quanto sia facile entusiasmare
se si è entusiasti, motivare se si è motivati, commuovere se si è commossi.
Non c’è
alternativa a questo, a meno di non essere grandi attori, cosa che non è tra le
competenze medie dei formatori, per bravi che siano. Vittorio Gassman era un eccellente formatore (lo ha
dimostrato col suo Laboratorio di Teatro) perché era un grandissimo attore, ma
è evidente che non può costituire un modello trasferibile; Gigi Proietti è, a sua volta, un eccellente formatore. Ma va detto che, in entrambi i casi – anche
per diretta testimonianza di coloro che hanno frequentato le “botteghe di
teatro” dei due nominati, pur tanto distanti tra loro, per molti aspetti non
secondari - l’apprendimento passava attraverso una carica emotiva enorme,
addirittura difficile da reggere, in qualche occasione.
Ma, teatro e “formattori”8 a parte: da quanto
ho potuto ricavare, in quasi trent’anni di frequentazione di aule e di
formatori, mi pare che vi siano almeno altri due fattori-stimolo che contribuiscono a suscitare “emozioni
d’apprendimento”:
- il primo è quando il formatore, mentre
ti apre un orizzonte concettuale “ti fa sentire” intelligente, ossia alza il
livello di autostima del discente;
- il secondo è quando il formatore ti dà
un modello interpretativo semplice di fenomeni complessi: ossia ti fa capire
chiaramente non soltanto di averti consegnato la chiave di una porta che ti
appariva ostinatamente blindata, ma anche il passepartout per tante altre
simili porte.
Quali sono le
emozioni più favorevoli all’apprendimento.?
Tutte le
emozioni, in teoria, possono stimolare
l’apprendimento, in quanto generano motivazione, magari ad uscire da uno stato
d’ansia. In pratica, più che sulla gelosia, sull’ansia o addirittura sulla
paura che (anche senza considerare le implicazioni sadiche) hanno il grave
difetto di far cessare l’apprendimento –
se non addirittura determinarne la rimozione
- non appena cessa lo stimolo ansiogeno o pauroso, credo che siano la gioia e lo stupore (della scoperta e della conquista, in particolare) le
emozioni sulle quali anzitutto il formatore dovrebbe puntare.
Ma anche la
“drammatizzazione “ (le virgolette sono d’obbligo) e l’umorismo che ne è il più
felice antidoto, l’atteggiamento di gioco e quello di teatro (il famoso “animus theatrandi” degli antichi), sono
situazioni che – mediamente – risultano idonei a rendere gradito
l’apprendimento, a fissarlo in modo durevole e, non di rado, a superare
idiosincrasie mentali.
Non mi sembra
un caso, a questo proposito, che sia nata a Bologna (anzi neo-nata, visto che
esiste da pochi mesi) un’Associazione di promozione sociale, la TIA , che si pone come
obiettivo primario, cito testualmente dallo Statuto “scoprire il piacere di
apprendere”.
3.
La “formazione emotiva” si può
valutare?
Se dovessimo
semplicemente rinviare a quanto appena detto, e cioè che ben difficilmente
l’apprendimento si determina e si fissa senza un minimo di coinvolgimento
emotivo del discente (ma, prima ancora, del docente), la risposta sarebbe pleonastica,
non diversa in quanto equivarrebbe a rispondere alla domanda se la formazione tout court si può valutare.
Ma la
questione è più fine – e la soluzione più complessa - per il fatto che, all’interno
del problema di cui ci occupiamo, occorre fare una importante distinzione:
§ un conto è valutare gli effetti di natura qualitativa (quindi,
anche la componente emotiva generata
da un qualsiasi intervento formativo,
ossia la mobilitazione di energie psichiche determinatasi a valle della
formazione);
§ altro conto è valutare, rispetto ai
risultati ottenuti, quanta parte abbia
avuto una formazione di cui la componente dominante sia stata di natura
emotiva.
Infatti:
- nel primo caso, non è affatto escluso che una formazione
puramente tecnica possa dare risultati “qualitativi”
di natura emotivo-energizzante: si pensi al caso di una formazione all’uso di
strumenti o programmi software particolarmente sofisticati e all’entusiasmo
ri-motivazione del soggetto che è ora in grado (mentre prima non lo era) di
fare il suo lavoro con molta più efficacia e meno fatica di prima. Sarà
cresciuta l’autostima, ma anche l’efficienza della prestazione
(misurabilissima);
- nel secondo caso, la formazione può esaurire
i suoi effetti visibili, di natura
emotiva “in corso d’opera” (ossia durante l’intervento), ma – proprio perché
nessuna emozione può essere mai separata dal pensiero, come detto a sazietà -
essa può lavorare nel vissuto del formato producendo, ovviamente in tempi
variabili secondo la natura dell’attività svolta – effetti anche
tecnico-pratici (misurabilissimi)
È evidente,
perciò, che il panorama si complica e la risposta non può essere sbrigativa.
In effetti, parlando
dei risultati di una formazione emotiva, ossia di un ambito che è squisitamente
di processo – anche a prescindere dalla reale volontà/decisione delle
organizzazioni, sempre dubbia, di
investire risorse per un tal genere d’inchiesta - il compito rimane arduo.
Naturalmente,
il problema non è nuovo, ma l’impressione che si ricava dalla letteratura
esistente è che i casi (comunque pochi) in cui si è voluto procedere a
valutazioni della formazione di tipo qualitativo, ricadano nel primo caso,
mentre non sono a mia conoscenza ricerche specifiche sul secondo: infatti, di
norma, ci si limita a valutare (quando si valutano) gli effetti di natura quantitativa
(attraverso parametri) o qualitativa
(attraverso indicatori prefissati) dell’intervento formativo effettuato, ma non
ci si preoccupa affatto di verificare quanta
parte - nel determinare quegli
effetti - abbia avuto la carica emotiva
della formazione erogata. In ogni caso, e per la verità, resta dubbia la reale
utilità per le organizzazioni di una ricerca siffatta, che sarebbe per contro
di indubbio interesse in sede epistemologica.
Ciò premesso,
possiamo ricordare che, oltre alla docimologia formativa, che può dare i suoi
validi contributi, esistono - e non da
oggi - vari modelli e strumenti per una valutazione
(che non mi stancherò mai di distinguere dalla “misurazione”9) e
che, volendo10, potrebbero essere utilmente applicati a situazioni formative che
riguardino anche il secondo dei due casi sopra citati.
Ricordo che da
tempo modelli di valutazione di programmi di formazione psico-sociale e
socio-affettiva sono stati studiati a messi a punto da vari autori, anche se –
per la verità - di estrazione prevalentemente
psico-pedagogica, applicabili a programmi scolastici curricolari più che
formativi in senso organizzativo. Ne cito alcuni: Ardizzone e Grasso, che nel
1984 hanno presentato un loro Modello delle Relazioni-Oggetto (MRO) e, come
strumento di analisi, hanno scritto addirittura un Manuale ad hoc11.
Neresini, nel
1992, ha
fornito una classificazione delle dimensioni da valutare e i relativi indicatori di processo12.
Il tema è stato toccato anche a proposito di empowerment di gruppo (A. Putton,
1999) e di self empowerment (Bruscaglioni-Gheno, 1999).
Uno strumento
tuttora utilizzabile è sicuramente quello noto come “Matrice Interformazione”,
che, fin dal 1989 – e, successivamente, nella versione riveduta (1996) fornisce
gli indicatori, i misuratori, i parametri di processo e gli strumenti di
rilevazione, distinguendoli chiaramente da quelli di contenuto, per la
valutazione separata, ai diversi livelli
(didattico, On The Job e di Sovrasistema) dei cambiamenti di tipo
socio-affettivo. Vi si distinguono, in particolare, a livello didattico e On
The Job: gli atteggiamenti ed altri fattori di processo e i vissuti interni
(intrapsichici).13
È chiaro che i risultati della formazione, misurazione-quantità-oggettività e,
rispettivamente, valutazione-qualità-soggettività
dei dati cui riferirsi sono in misura proporzionale inversa, secondo che da
valutare siano fattori di contenuto o fattori di processo: intendo dire, in
termini più semplici, che gli indicatori di efficacia saranno tanto più oggettivi
quanto più si tratti di valutare risultati quantitativi e tanti più soggettivi
quanto più si tratti di valutare risultati qualitativi.
Ma
sbaglierebbe chi ritenesse che questi ultimi siano di carattere aleatorio: una
volta chiarito quali sono gli indicatori dei risultati attesi (intesi, in
parole semplici come ciò che il
committente andrà a vedere /osservare /valutare, a valle dell’intervento
formativo, qualunque cosa sia e la cui presenza-assenza mi farà ritenere che
l’intervento sia stato, o non, efficace), la natura soggettiva-qualitativa di
questa valutazione avrà l’identico peso (e l’identica attendibilità) per il
committente di qualsiasi altra misurazione quantitativa.
È del tutto
evidente che i diversi committenti-osservatori abbiano degli osservati
completamente diversi: non esiste un unico risultato (né una sola efficacia)
dell’intervento formativo valido erga
omnes. Si può anzi arrivare al risultato, paradossale soltanto in
apparenza, che uno stesso esito formativo possa essere considerato ottimo da
una certa committenza e pessimo da un’altra; non intendo parlare di potenziali
committenze in organizzazioni diverse, che sarebbe un’ovvietà, perché è
scontato che ciò accada.
Intendo
riferirmi a quanto accade, all’interno di una stessa organizzazione, quando una
committenza è effettiva e un’altra potenziale: l’effetto di self-empowerment, che può aumentare
l’autostima e quindi la propensione a scegliere la libera professione, può
essere voluto dalla committenza ufficiale (in relazione a un obiettivo di
ristrutturazione e alleggerimento dell’organico) e come deleterio dal Sindacato
che conta le teste e paventa il “drop out”.
Ecco perché –
qualora si sia determinati a valutare l’efficacia di un intervento formativo
- è assolutamente cruciale concordare
preliminarmente gli obiettivi; ma soprattutto, avendo riguardo al fine della
valutazione, gli indicatori del
risultato atteso. E (in una visione sistemica dell’organizzazione, dove
agiscono molteplici attori, ciascuno con un suo potere di influenzamento) la
valutazione, va fatta ovviamente in funzione dei risultati attesi dalla
committenza reale, ma non può permettersi di ignorare del tutto anche le attese degli stakeholders che possano costituire una “committenza virtuale”.
5. Un vecchio equivoco (diamo alla
formazione, anche emotiva, ciò che è
della formazione)
Pur nutrendo
la massima considerazione per chi, nelle organizzazioni - avendo attribuito
alla relativa posta in bilancio - investimenti cospicui in formazione,
legittimamente ne richiede un riscontro; pur comprendendo appieno le ragioni di
chi, spingendosi oltre, reclama un preciso ritorno sull’investimento formativo
(il famoso ROI della formazione), vorrei evidenziare un aspetto metodologico
che di norma il committente – in ciò, di solito, sostenuto strenuamente dal
tesoriere – non considera con sufficiente attenzione.
Credo utile
un esempio tratto da altro campo, quello della pubblicità. Spesso, anche per esperienza professionale diretta, ho
sentito dire - in perfetta buona fede - che la pubblicità serve a far vendere
il prodotto, probabilmente sotto la suggestione del vecchio adagio popolare che
la “pubblicità è l’anima del commercio”. Possiamo concordare che si tratti
dell’anima, ma non del corpo. Fuori metafora, la pubblicità è uno strumento di
comunicazione e di conseguenza, se ne voglio valutare l’efficacia lo debbo fare
– in prima battuta – in termini di
comunicazione (valida o non): occorre verificare, cioè, se il messaggio è
stato capito, accettato, interiorizzato. Se lo è stato, la pubblicità è stata
efficace; se la curva delle vendite non è cresciuta in proporzione, dovremo
probabilmente cercarne le cause in una delle (molte) altre variabili del mix di
marketing, che tra l’altro è diventato negli ultimi anni estremamente
sofisticato14:
Analogamente,
la formazione è uno strumento di apprendimento: dunque se ne voglio valutare
l’efficacia lo debbo fare – in prima battuta – in termini di apprendimento (avvenuto o non).
Che poi la
derivata seconda (il prodotto si è
venduto di più? La produttività è aumentata?) interessi al committente più
della derivata prima, è comprensibile, ma questo interesse non può essere, per
definizione, il solo criterio per
valutare l’esito della formazione.
In ogni caso,
non è possibile dimenticare – e certo non lo è per chi scrive - che stiamo
parlando di “apprendimento degli adulti che lavorano nelle organizzazioni”,
secondo la classica definizione AIF e che tra le preoccupazioni maggiori dei
formatori dovrebbe esserci quella di aiutare questi adulti a formulare e
gestire processi decisionali non certo meccanici, aridi e deprivati di ogni
componente emotiva, ma almeno coerenti e funzionali al ruolo che occupano.
Altrimenti è soltanto istinto e biologia, e allora in questo modo anche le
amebe “decidono”. Per tropismo, dicono gli esperti.
Dunque, la
mia personale posizione riguardo ai fattori emozionali come promotori e
catalizzatori d’apprendimento, potrebbe riassumersi così: poiché sappiamo bene
che possono esistere migliaia di pensieri (ossia un’intelligenza) senza
emozioni, ma non può esistere una sola emozione senza intelligenza, allora ben vengano l’emozione e anche la formazione emotiva. Purché
intelligente.
Note
1.
Cfr: Gardner, H.: Frames of mind - the theory of multiple
intelligences”, tit. It.
“Formae mentis – saggio sulla pluralità dell’intelligenza”, Milano, Feltrinelli,
1987, pp. 258 e segg.
2.
Gardner,
è bene evidenziarlo, si crea in proposito un elegante “alibi” epistemologico,
sostenendo che “Nel corso normale degli eventi le intelligenze interagiscono fra loro [sic!], e vengono
costruite l’una sulla base dell’altra, a cominciare dall’inizio della vita”
(cfr. Gardner, op. cit. p. 299). Il corsivo al verbo è mio.
3.
Magari
surrettiziamente, presentando le credenziali della Scuola di Palo Alto, in
incontri e convegni “mordi e fuggi”:
cfr. il Convegno Passione, Innovazione e
Valore (Milano, 21 novembre 2005, Teatro Litta), con interventi dai
contenuti emblematici e problematici, come “Incontrare la passione” o “Memoria
emotiva e memoria sensitiva”
4.
Cfr. Goleman, D.: Emotional intelligence, tit. It. “Intelligenza
emotiva”, Milano, BUR, 1999. Nel contesto (cfr. p. 391), D.G. c’informa, oltre
che dell’origine di questa espressione, anche su background scientifico originario (curioso,
a dir poco) del suo lavoro: «Per la prima volta ho sentito l’espressione
“alfabetizzazione emozionale” in bocca a Eileen Rockefeller Growald, allora
fondatrice e presidente dell’Institute for the Advancement of Health. Fu quella
conversazione casuale che stimolò il mio interesse e fornì la cornice alle
indagini che finalmente sono sfociate in questo libro.»
5.
Cfr.
Galimberti, U.: Dizionario di psicologia,
UTET, Torino, 1992, pp. 85-86
6.
V.
Fata, A.: Gli aspetti psicologici della
formazione a distanza, AIF-Franco Angeli, Milano, 2004; anche per quanto
riguarda gli strumenti di valutazione, sullo stesso tema la distinzione, è stata fatta con sufficiente chiarezza: v.
Prezza, Smeralda, M.P., Matteoni, A.:”Valutazione a distanza di interventi di
educazione sessuale realizzati nelle scuole mede superiori”, in AA.VV., Psicologia di comunità oggi. Progetti,
ricerche, esperienze, Napoli, Magna editrice, 1996.
7.
V.
M. Bruscaglioni e S. Gheno: “L’empowerment degli operatori della scuola”, in Empowerment e scuola: metodologie di
formazione nell’organizzazione educativa, Carocci, Roma, 1999, pp. 49 e
segg.)
8.
Cfr.
Rago, E.: L’arte della formazione -.
Metafore della formazione esperienziale, F.Angeli, 2004, pp. 271 e segg.;
Amicucci, F. La formazione fa spettacolo,
Il Sole24Ore,2004, pp. 103-109
9.
Il
problema è annoso, ma già chiaramente individuato da: Cantin, S.:
La Mesure
normative et la Mesure Criteriée
10. Personalmente – in
ciò purtroppo confortato dalla prassi e dalla verifica sul campo - e restando salve le solite lodevoli
eccezioni, continuo ad avere molti dubbi sulla motivazione e reale volontà
delle organizzazioni ad investire fondi per la valutazione della formazione che
non sia a livello didattico, per le ragioni già ampiamente esposte in altra
sede: v. P.L. Amietta: Valutare la
formazione: problemi aperti e problemi da chiudere, in: Infelise, L. (a
cura di -) “La formazione in impresa: nuove frontiere in Europa, Franco Angeli,
Milano, 1994, pp. 423 e segg.
11. V. Ardizzone, M.,
Grasso M. : MRO, modello delle relazioni
Oggetto – frasi da completare per adolescenti, Organizzazioni Speciali,
Firenze, 1984
12. V. Neresini. F.: La valutazione come processo, Ministero
dell’Interno, 1992
13. Cfr.: Amietta, P.L. –
Amietta, F. (a cura di-), Interformazione: Valutare
la formazione, pp. 109-122 e passim, Milano, Unicopli, seconda edizione,
1996.
14. V. Raimondi, Marketing del prodotto-servizio – Integrare tangibile
e intangibile per offrire valore al cliente, Hoepli, Milano, 2005
*** ***
OMM IN GIARDIN
Vedi da la finestra del mè studi
el portinar, angiol custòd del verd
de la mia cà, di roeus e del pitòsfor.
El lavora content…e me domandi
‘se l’è ch’el ghe ved dent in ‘sto tocchell
de verd, in ‘sto girell per paisan
nostalgich de la terra. Omm senza sogn?
No, no, pensi el contrari, mì hoo capii:
per on’ora, ogni dì, lù s’en impippa
del gatt del ragionatt, de la ruera,
de la posta, de l’amministrador.
Per on’ora, ogni dì, lù el torna a cà.
E quell meter quadraa condominial
per lù (forza incredibil del penser)
l’è quell praa grand del sò mond de bagaj,
sotta l’argin del Po, l’è la “soa” terra,
la terra di sò vecc. El rest l’è… nient.
El loeugh dove se sta l’è minga “noster”
perché l’è scritt inscì in on quai canton.
E allora quel freguj de giardinett
per lù l’è la pianura del sò fiumm,
la terra di sò vecc, quella che gh’ha
per confin domà l’erba, i pobbi e ‘l ciel.
UOMO IN GIARDINO
(Traduzione letterale)
Vedo dalla finestra del mio studio
il portiere, angelo custode del verde
di casa mia, delle rose e del pitosforo.
Lavora contento…e io mi chiedo
cosa ci trova in questo pezzettino
di verde, in questo girello per contadini
nostalgici della terra. Uomo senza sogni?
No, no, penso il contrario, l’ho capito:
per un’ora, ogni giorno, lui se ne infischia
del gatto del ragioniere, della spazzatura,
della posta, dell’amministratore.
Per un’ora ogni giorno, lui torna a casa.
E quel metro quadrato condominiale
per lui (forza incredibile del pensiero)
è quel gran prato del suo mondo di bambino,
sotto l’argine del Po, è la “sua” terra,
la terra dei suoi vecchi. Il resto è…niente.
Il posto dove stiamo non è “nostro”
perché così sta scritto da qualche parte.
E allora quella briciola di giardinetto
per lui è la pianura del suo fiume,
la terra dei suoi vecchi, quella che ha
per confine soltanto l’erba, i pioppi e il cielo.
MARIA CARLA BARONI
OMAGGIO A MILANO
Navigli anni ’50
Tristi le vie
lungo i canali morti
della mia città
file di neri barconi
in attesa
colonnato deforme di gru.
Posso togliermi
la maschera dell’allegria.
 |
| Naviglio (Foto di Livia Corona) |
Tipologie edilizie
milanesi
Lucenti grattacieli a spirale
cascine cadenti nella pianura
armonia di palazzi anni venti
quartieri popolari dolenti.
 |
| Grattacielo (Foto: Livia Corona) |
Le cascine rosse
Grandi tetti di tegole rosse
su travature d’antico legno
e imponenti piloni di mattoni
larghi lembi d’un utero aperto
ad accogliere la vita del quartiere.
LIVIA CORONA
OMAGGIO FOTOGRAFICO A MILANO












.JPG)
.JPG)


.JPG)
.JPG)







.jpg)


.JPG)